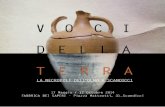Viva-voce will take place on 27, 29, 30 & 31 March 2022 (Not ...
Voce e voci in Paolo Nori
Transcript of Voce e voci in Paolo Nori
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società
Corso di laurea in Lettere
VOCE E VOCI IN PAOLO NORI
Relatore: Prof. Paolo Briganti
Correlatore: Prof. Giulio Iacoli
Laureanda:
Francesca Fontana
Anno Accademico 2013 - 2014
3
Indice
0. Un concetto, una premessa, un’introduzione p. 5
1. A PROPOSITO DELLA LINGUA
1.1. Una presentazione 11
1.2. Scrittura per parentesi e mimesi del parlato 13
1.3. Dall’intermittenza dell’esordio alla domesticazione 15
1.4. Sulla costruzione della voce (e oltre) 18
2. ELEMENTI CHE TENGONO IL FILO
2.1. Per esempio, dei luoghi 23
2.2. Delle coincidenze 27
3. DALLA VOCE A: LE VOCI
3.1. Alcune premesse 33
3.2. Uno sguardo e un ragionamento 35
3.3. Delle voci: a partire da Learco 38
3.4. Delle voci oltre Learco (e di ciò che rimane) 41
3.5. Un respiro e si conclude 47
Bibliografia 51
Ringraziamenti 53
5
0. Un concetto, una premessa, un’introduzione
La serendipità è cercare un ago in un pagliaio
e trovarci la figlia del contadino1.
Questa tesi si è mostrata fin dall’inizio una sfida, e non solo a livello
personale. Paolo Nori è uno scrittore contemporaneo o, come dice lui, uno
che ha scritto un mucchio di libri. Nato a Parma nel 1963, dopo il diploma
in ragioneria (e l’esercizio della professione in Algeria e Iraq), ha
conseguito una laurea in letteratura russa (1995). Ha iniziato a scrivere nel
1996 “per disperazione”2 ma il suo vero debutto è datato 1999, anno di
pubblicazione di Le cose non sono le cose – presso la piccola casa editrice
Fernandel, di Ravenna. Da allora la sua produzione conta oltre trenta libri,
tra romanzi, fiabe e discorsi. Si capirà dunque come un primo limite venga
dalla contemporaneità combinata alla prolificità dell’autore preso in esame.
Se sul primo aspetto ci si può ritenere abbastanza fortunati perché oggi
disponiamo già di qualche studio e di qualche ragionamento monografico
sull’autore, al secondo aspetto va aggiunto che Nori è, come vedremo, un
autore complesso, enigmatico, un autore che gioca con tutto e nel quale si
riscontra una rete di rimandi, nessi e associazioni non sempre facile da
districare. Se di molte cose parleremo dopo, possa servire come esempio
unico di un atteggiamento – oltre che di una tendenza al “metaromanzo” in
lui sempre viva – quel “paragrafino” di La banda del formaggio (2013):
Adesso, io, non lo so di preciso, non è che sono sicuro, però mi viene da dire,
così, a occhio, a sentimento, che questi numeri qua, questi paragrafini che
cambiano, 1, 2, 3, 4, 5, che cambian così che sembra che non ci sia tanto una
regola, ecco, io di preciso anche se non lo so, però secondo me, la regola non c’è.
1 Così come l’ha descritta nel 1976 il ricercatore biomedico americano Julius H. Comroe, Jr –
http://it.wikipedia.org/wiki/Serendipità/. 2 M. D’Orazio, Paolo Nori: uno stile “semplice”, tesi di laurea, Università di Parma, a. a. 2008/2009,
relatore Paolo Briganti, p. 11.
6
Io, questi numeri qua, 1, 2, 3, 4, 5, li metto così, per i critici, perché abbiano
almeno qualcosa da fare, con questo libro qua, quando esce, ammesso che esca,
vale a dire spiegare il senso di questi numeri qua, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se vogliono. Se
no è anche lo stesso3.
Di più, Nori non è certo un autore di facile lettura:
Voglio scrivere una cosa dove quello che scrive è uno che tiene un blog, che si
potrebbe pensare che è la stessa cosa che scrivo da vent’anni, di scrivere cose
dove il protagonista è uno che scrive, che è vero, però quello che scrive scrive dei
romanzi, nelle cose che ho scritto negli ultimi vent’anni, invece questo nuovo
scriverebbe in un blog, che è una cosa un po’ diversa, secondo me; per esempio a
me, in questi anni, un po’ di gente che mi ha detto Guarda, i tuoi romanzi, io, non
riesco a leggerli, c’è stata, cioè di gente che ha avuto il coraggio di parlarmi dei
miei romanzi come se io un po’ mi dovessi vergognare, di loro, invece del blog,
non c’è stato nessuno che mi ha detto che il blog era brutto, come anche delle
poesie che non ho mai scritto, a pensarci adesso, mi han sempre detto che eran
bellissime, quelle poche volte che qualcuno me ne ha parlato, dei gran
complimenti che mi è venuta voglia di mettermi a scrivere delle poesie, un paio di
volte4.
È un autore che, dunque, richiede un approccio in qualche modo diverso
sia che ci si ponga come semplici lettori sia che si abbia una qualche
intenzione critica (come nel nostro caso). Richiede che si entri anzitutto – o
che ci si provi perlomeno – entro specifici “modelli di funzionamento”,
richiede una certa elasticità, richiede un lavoro che sia per associazioni, ma
che desista da quella tendenza a confinare e classificare tipica della critica
tradizionale. Ma ciò che forse più di tutto richiede Nori è che la sua opera
non sia letta sempre e solo come una sorta di “autobiografia sotto
copertura”.
A tal proposito, prima di proseguire, credo sia necessaria una riflessione.
Pur non approfondendo la questione, che richiederebbe uno studio
specifico ed esclusivo, è giusto a mio parere riconoscere che, come dice
Baricco:
Negli ultimi venti, venticinque anni il mestiere dello scrittore è molto
3 Paolo Nori, La banda del formaggio, Milano, Marcos y Marcos, 2013, p. 40. 4 Dal blog: www.paolonori.it/delle-cose-diverse/.
7
cambiato perché è molto cambiato il campo da gioco in cui lui si trova ad esibirsi:
quello che abbiamo ora non ha nessun paragone con quello che esisteva in Italia
negli anni Cinquanta, Sessanta o Settanta. […] È successo che il gesto di per sé
complesso – ma poi alla fine molto semplice – di scrivere un libro e pubblicarlo
oggi sia diventato un fatto molto più articolato: noi lavoriamo con un pubblico
ampio che ha molte più possibilità di avvicinare lo scrittore, direttamente o
indirettamente attraverso i media. Effettivamente – questo vale soprattutto per
quelli più giovani di me, ma anche per la mia generazione – ci sono molti ambiti
espressivi che un tempo non erano nemmeno previsti per uno scrittore: è risultato
abbastanza naturale, se non istintivo, andare a visitare i nuovi territori che si
aprivano tutt’intorno. Così lo scrittore va in televisione, scrive articoli per i
giornali, recita in teatro. […] Insomma il suo habitat si è moltiplicato nel giro di
pochissimi anni5.
Se Baricco è uno scrittore molto diverso da Nori e ha adottato, al
riguardo, diverse “tecniche di sopravvivenza”6 rispetto al nostro Autore, va
detto che ha qui pienamente espresso una condizione attuale comune a
molti, e anche a Nori. Non solo perché lui stesso ha moltiplicato il proprio
habitat: “gli piace leggere ad alta voce, raccontare varie cose sul suo blog,
su alcuni giornali e qualche volta in televisione”7, nonché a teatro e in giro
per eventi; di questi, in particolare il blog a mio parere si configura come
primo canale, social e mediatico, nel quale l’autore racconta cose
quotidianamente (e che forse un domani potrà essere oggetto di studio
‘letterario’, chissà). Tale condizione credo renda impossibile condurre
un’osservazione critica che sia troppo ancorata alla “tradizione” perché
porta in gioco molte cose altre – per esempio, una commistione della lingua
(volontaria o no) con tutto ciò che può essere detto linguaggio social; vale a
dire un linguaggio che sia, per esempio, immediato e semplice,
estremamente comunicativo a prescindere da che cosa comunica. Oltre a
questo, tale condizione comporta che l’estrema facilità con cui è oggi
possibile avvicinare un autore faccia crollare qualsiasi barriera – di tempo,
5 Da un’intervista per Wuz: www.wuz.it/articolo-libri/476/intervento-baricco.html. 6 Sempre dall’intervista: “Tutto questo rappresenta qualcosa di nuovo, non avevamo dei maestri in questo
tipo di tecnica di sopravvivenza”. 7 Dalla nota di copertina che si trova in fondo a La banda del formaggio, Milano, Marcos y Marcos, 2013.
8
spazio, intelligenza critica e discrezione8. Da qui l’autore si trova quasi
sempre a non poter essere più solo autore, perché troppo forti e rapidi sono
i rimandi alla sfera privata – da parte del pubblico e anche della stessa
critica – e perché questo crollo direi “sociologico”, perché già radicato, di
ogni barriera confonde, destabilizza e, se non controllato, può essere
‘pericoloso’ e fuorviante. Questa riflessione nasce da un’esigenza che
riguarda in generale gli autori del nostro tempo; nel caso di Nori, poi, mi
pare che le difficoltà legate alla “sopravvivenza” siano rinvenibili anche
nelle stesse opere. Da qui è facile forse comprendere perché sembra vi sia
quasi un accanimento, a ogni approccio con Nori, su quello che è stato
definito come “autobiografismo”. E se l’autore fa parte di quei “più” che –
come dice Baricco nell’intervista già citata – riescono a continuare “in
questo gesto molto solitario, molto duro, che è lo scrivere” ed è dunque
anche lui un rappresentante “della forza, della solidità di quelli che nel
nostro paese fanno questo mestiere”, è probabile che la questione “quanto
c’è di Nori in Nori” sia stata da lui presa come un gioco (non in senso
negativo, ma a indicare quella componente che è in lui caratterizzante).
Vale a dire che, oltre a quanto vedremo in seguito, più che negare i
riferimenti autobiografici, la sua posizione sia volutamente “tra il sì e il
no”: un Nori che si scopre, ma mai del tutto, che è sincero oppure no, che
dice cose sue oppure no, sicché questo oscillare fra nascondimento e
svelamento oggi è quasi una scelta – o un “difetto del carattere” che vien
così e va bene, anche.
Fatta questa premessa, che ritenevo necessaria, lascio spazio a ciò che
conta, cioè la tesi, che vuol essere un ragionamento e con la quale ci siamo
proposti di indagare nell’opera di Nori – e, in particolare, guardando al
8 È altresì tipica del nostro tempo una propensione a entrare nel privato altrui, quasi fosse lecito e
necessario, specie se l’altro si può ritenere – a qualsiasi grado – una “celebrità”.
9
Nori narratore – il senso di quella che si presenta come una sorta di
“monovocità” nella “plurivocità” (da qui il titolo Voce e voci in Paolo
Nori). Ed è una tesi che, posso dire, ha preso direzioni che non avremmo
detto “mai, ma mai, ma mai mai mai mai mai”.
11
1. A PROPOSITO DELLA LINGUA
1.1. Una presentazione
I primi tempi che pubblicavo dei libri, quando mi invitavano a dei convegni,
tutte le volte poi mi trovavo lì che provavo a organizzare un discorso a braccio,
che è bello, vedere uno che parla a braccio solo che io, nella mia testa, io sono uno
che lavora per parentesi, cioè quando comincio un ragionamento quando sono a
metà mi viene in mente una cosa che magari non c'entra tanto che però mi
interessa e allora apro una parentesi e ci vado dietro […]9.
Questo è l'incipit di un post apparso sul blog dell'autore nel quale
racconta, col suo solito piglio ironico, delle difficoltà che incontra quando
si tratta di parlare a braccio. Nello spiegarci perché preferisce scriversi
prima le cose da dire quando è chiamato a parlare a un pubblico, ci dice un
po' come funziona la sua testa; e io ho scelto di partire da qui perché,
quando l'ho letto, mi sono detta: ecco, esatto, questo rende l'idea. Prima di
trovare questa auto-definizione, in qualche modo geniale, non riuscivo a
trovarne una che potesse dare l'idea di quello che un lettore si trova ad
affrontare nell'incontro con Nori, ossia quel monologare continuo, quello
star dietro alle associazioni mentali, ora attribuite a un personaggio ora a un
altro. Allora direi così: quella di Nori è una scrittura per parentesi. È come
se i romanzi di Nori fossero costruiti anzitutto da questo processo mentale
ma anche, allo stesso tempo, per riprodurre questo processo mentale, per
trasmetterlo al lettore. Questo, insieme ad altri elementi che vedremo nel
corso di questa presentazione “linguistica” della voce, forma quell'originale
modus narrandi del nostro autore che porta in sé e con sé pregi e limiti, e
che tanto destabilizza lettori e critici, giornalisti e italianisti.
9 www.paolonori.it/mmmmmmmmmm/.
12
L'ho chiamata presentazione “linguistica” perché per prima cosa tenterò
di illustrare alcune caratteristiche prettamente linguistico-formali seguendo
anzitutto l'indagine filologica di Marcello D'Orazio10 che, pur essendo del
2009 quindi limitata alle opere che l'autore ha scritto sino a quell'anno,
illustra molti dei tratti tipici e propri del linguaggio di Nori che ritroviamo
anche nelle opere successive. D'Orazio, con la sua analisi minuziosa,
permette infatti di scandagliare tali aspetti e notarne evoluzioni,
trasformazioni, variazioni. Partendo da definizioni semplici come quella di
registro informale e linguaggio “oralizzante” ricerca e individua, con il
supporto critico di Berretta e Calaresu11, quali fenomeni di simulazione del
parlato sono messi in atto da Nori, e come. Vista l'accuratezza del suo
studio, oltretutto fatto di rimandi precisi e ricco di esempi, riporterò le sue
riflessioni e conclusioni brevemente, evitando però una re-immersione vera
e propria nelle opere già da lui attraversate12 e quindi, di fatto, in qualche
modo sorvolando su molti particolari e approfondimenti interessanti che vi
sono compresi. Piuttosto sarà utile, anche ai fini della nostra riflessione,
rimanervi agganciati per capire cosa è successo dopo, sempre dal punto di
vista linguistico-formale, guardando da vicino alcuni romanzi pubblicati
dopo il 2008.
10 M. D'Orazio, Paolo Nori: uno stile “semplice”, tesi di laurea, Università di Parma, a. a. 2008/2009,
relatore Paolo Briganti. 11 Cfr. M. Berretta, Il parlato italiano contemporaneo, in AA.VV., a cura di L. Serianni e P. Trifone,
Torino, Einaudi, 1994, Vol. II; Cfr. E. Calaresu, Quando lo scritto si finge parlato. La pressione del
parlato nello scritto e i generi scritti più esposti: il caso della narrativa, in AA.VV., Aspetti dell’italiano
contemporaneo, a cura di Klaus Holker, Munster, Lit Vergal, 2005. 12 Quindi da Le cose non sono le cose (1999) a Pubblici discorsi (2008).
13
1.2. Scrittura per parentesi e mimesi del parlato13
Il primo fenomeno rilevato da D'Orazio è quello di simulata assenza di
pianificazione, riscontrabile nei testi noriani e che conduce la sua analisi a
questa prima valutazione:
La lettura del testo, fin dalle prime battute, ci dà l'impressione di flusso
spezzettato, frammentario, sintatticamente disunito, scisso in piccoli blocchi
semantico-sintattici, accostati fra loro senza troppa attenzione alla coesione
(almeno a primo acchito). Viene in questa maniera evocata la microprogettazione
del parlato canonico: il parlante costruisce pezzo dopo pezzo il proprio discorso,
aggiungendo progressivamente delle informazioni, senza ricorrere ad una meditata
pianificazione del testo […]. Allo stesso modo, lo scrittore simula il linguaggio
parlato rievocandone l'elaborazione in tempo reale14.
Valutazione che ho riportato quasi per intero perché rimanda in qualche
modo a ciò che io ho definito scrittura per parentesi, e perché è non solo
condivisibile ma decisamente caratterizzante e molto frequente anche nel
Nori extra-romanzo – ossia quello del blog, quello dei discorsi, quello dei
reading. Una manipolazione linguistica che si serve in primis di un uso del
tutto personale della punteggiatura – che spazia da periodi lunghissimi,
ininterrotti e pieni di virgole (perfettamente coerenti al procedere per
parentesi) a periodi segmentati da veri e propri punti, nelle prose più
incisive15. E una manipolazione linguistica che utilizza diversi stratagemmi
retorici quali: l'anacoluto e l'epanalessi, la dislocazione a destra e quella a
sinistra, le “frasi scisse” e l'ellissi. Questi elementi sono spesso e
13 Inteso da D'Orazio come: “uso specifico, variazionale, della lingua”. Interessante è anche la definizione di Giuseppe Antonelli di una linea narrativa, da lui chiamata “neo-neostandard”, che è caratterizzata da un
ampio e completo ricorso alle forme dell'oralità: perché nel caso in cui volessimo classificare Nori in
qualche modo, credo potrebbe essere funzionale. - M. D'Orazio, Paolo Nori: uno stile “semplice”, cit., p.
22. 14 M. D'Orazio, Paolo Nori: uno stile “semplice”, cit., p. 25. 15 Interessante, a tal proposito, quanto dice Camilla Tomassoni per spiegare questo particolare uso in
termini di “cortesia per il lettore”: “Derogando in larga misura, infatti, da un uso normativo di
punteggiatura, Nori sembra disporre i segni d'interpunzione per sottolineare, quasi esclusivamente, i
movimenti intonativi da compiere durante la lettura” - C. Tomassoni, Il progetto letterario di Paolo Nori,
tesi di laurea, Università di Bologna, a. a. 2009/2010, relatori A. Bertoni e S. Colangelo.
14
variamente combinati fra loro e, alle volte, tendenti a una sovrabbondanza
che – riprendendo D'Orazio – ci riporta a quella micro-progettazione del
parlato e, allo stesso tempo, veicola un ritmo insistente, cadenzato dalle
particelle pronominali e non.
Sfrutto quest'ultima osservazione per porre due punti fermi che, a mio
parere, sono variabili ma fissi, verso i quali tutto si riconduce e dai quali
tutto parte: una scrittura per la resa del parlato e una scrittura per la resa del
suono (o, meglio, della cadenza). Se si tengono a mente questi due punti,
sarà più facile comprendere i casi di abbreviazioni (aferesi e apocopi) o
quelli di abbassamento modale dei verbi; sarà più facile comprendere l'uso
del discorso indiretto libero, di sovente riportato fuor di virgolette, così
come tutti quei segnali discorsivi che ci elenca D'Orazio (ma anche altri) –
come gli “allora” e i “comunque”, i “cioè” e gli “ecco”16. E sarà più facile
spiegare l'uso intenso del “che polivalente”, sul quale con Nori ci si
sofferma sempre perché è in lui costante “prediletta”. Il “che polivalente”,
del quale è indubbia la duttilità funzionale e al quale si può a ragione
attribuire, nel caso di Nori, un “ruolo di amalgama del tessuto che dà luogo
a una segmentazione del flusso” che ne rinforza la ritmicità, è altresì
appartenente a un linguaggio molto social17. Tornando a D'Orazio, è giusto
rinvenire la presenza di giri di frase e trottole sonore, queste ultime
costruite attraverso un gioco combinatorio dei diversi elementi retorici,
attraverso l'uso tutto particolare della punteggiatura e il ricorso occasionale
alle figure di suono. Preferisco però superare tutto questo perché, assunto
ciò che abbiamo detto, è ben facile scorgere un intento vivificante della
16 Da Nori, al riguardo (http://www.paolonori.it/ecco-allora-insomma/): “Ecco. Allora. Insomma. Alle
elementari, mi ricordo, mi dicevano sempre che non si comincian le frasi né con Ecco, né con Allora, né
con Insomma. E, niente. Allora per quello, io, adesso, faccio così. Non perché pensi che sia bello, per un
difetto del mio carattere”. 17 Riprendendo quanto accennato in introduzione.
15
prosa di Nori: questo intendevo con resa del parlato, che per di più è un
parlato regionalmente connotato, e con resa della cadenza, che sembra
vincere in resistenza rispetto a una resa del suono che attribuirei più alla
prima produzione. Se su certi dettagli qui accennati si potrà tornare in
seguito, valga come esempio di quanto detto la frase-motivetto costruita da
Nori in Diavoli:
Un due tre, un due tre, in macchina, mettere in moto, andar verso casa, che è
vicina, anche questa è fatta18.
E valga come chiarificazione quanto dichiarato dallo stesso Nori, in
un'intervista, a proposito della ripetizione (altra “prediletta”):
Non credo di essere particolarmente attratto da questa figura retorica, credo
piuttosto che questa figura retorica sia una di quelle che usiamo di più quando
parliamo. […] A Parma qualcuno entra in un bar e dice “Son stato a Reggio, son
stato”. Questo modo di parlare, con tante ripetizioni è una cosa che in prosa non è
accettata. […] La ripetizione è una figura fonica molto potente, e allora perché
dobbiamo privarci di tutto questo?19
1.3. Dall'intermittenza dell'esordio alla domesticazione
[…] Questa prosa all'inizio stenta a mettersi in moto; ha la batteria a terra; la
devi parcheggiare in discesa, la sera, per avere qualche speranza la mattina dopo;
e c'è sempre il rischio che il motore si ingolfi o, come si dice, “batta in testa”: che
ti lasci per strada sul più bello, a bestemmiare nella polvere […]20.
Le cose non sono le cose (1999), sin dal titolo votato al registro
informale21, viene paragonata a una macchina dal funzionamento
intermittente perché, pur mostrando già diversi elementi morfo-sintattici
18 Paolo Nori, Diavoli, Torino, Einaudi, 2001, p. 51. 19 Intervista dal sito Booksblog, sezione ‘Festivaletteratura di Mantova’ - www.booksblog.it. 20 A. Cortellessa, rec. a Le cose non sono le cose, in ‹‹L'indice››, maggio 2000. Riutilizzo, per convinta
adesione, la citazione di Cortellessa già impiegata da D’Orazio. 21 “Secondo Testa, la parola cosa costituirebbe una “parola-sostanza”, “vero mot-clef” del parlato; allo
stesso modo, per Berruto, tale lessema sarebbe da ricondurre, a causa del suo significato estremamente
generico, alla ridotta variatio lessicale, tipica del parlato” - M. D'Orazio, Paolo Nori: uno stile
“semplice”, cit., p. 60.
16
tipici di Nori e della sua mimesi fonica, D'Orazio rileva nel complesso
un'acerbità stilistica, che spiegherebbe la presenza di diversi registri
linguistici, di “scarti” compositivi, e soprattutto la penuria dei tratti
specificatamente noriani, di cui s'è detto prima. Pur essendone innegabile
l'importanza, anche solo perché romanzo d'esordio, mi sento di concordare
con D'Orazio quando dice:
[…] se, in tutte le opere a seguire, la lingua dell'io narrante riesce a inglobare,
a informare di sé, tutte le parti, e le voci, presenti nel romanzo (eccetto piccoli
contrappunti dall'effetto parodico), in Le cose non sono le cose, al contrario, tale
amalgama risulta meno convincente […]22.
Senza temere l’azzardo − e pur riconoscendo al romanzo il ruolo di
apripista, sia per Learco Ferrari, protagonista nonché (primo) alter ego
dell'autore per ben sette romanzi, sia della voce che andiamo conoscendo −
questa prosa si mostra faticosa e affaticante. Arriverà però una rivalsa
(sempre linguistica, ché fino ad ora di questo stiamo parlando) pochissimo
tempo dopo con il secondo romanzo, che funge da vero e proprio sequel23,
Bassotuba non c'è (1999):
Il generico abbassamento diafasico, riscontrato nel romanzo precedente, si
avvia, pertanto, verso una più convinta stilizzazione formale: l'antiretorica
destrutturazione della lingua (si intende, di una certa lingua), ottenuta attraverso
“forme elaborate di assimilazione verbale della realtà”, conduce alla formulazione
di un linguaggio personale ed espressivo, coerente con il personaggio
rappresentato, con la sua caratterizzante umanità24.
Linguaggio nel quale permangono e sono anzi considerevolmente
presenti anacoluti e dislocazioni, frasi segmentate e ripetizioni, apocopi e
giri di frase, onomatopee e uso modale dei verbi. E, di più, linguaggio che
si sviluppa e che assume a poco a poco una sua identità propria, come
22 M. D’Orazio, Paolo Nori: uno stile “semplice”, cit., p. 62 23 Per questa particolare definizione del secondo romanzo e, in qualche modo, della configurazione del
“ciclo di Learco” rimando a R. Capozzi, Paolo Nori's chatting: novels about nothing, «Rivista di studi
italiani», Anno XX, n° 1, Giugno 2002, pp. 237-260. 24 M. D'Orazio, Paolo Nori: uno stile “semplice”, cit., p. 64.
17
sembra testimoniare lo stesso autore – sempre per mezzo di Learco Ferrari
– nel successivo romanzo, Spinoza (2000):
Che io ciò provato, gli dicevo, a cominciare a scrivere il quarto in un modo
diverso, mi saltava una cosa disgustosa, dal tanto che era finta. Quando ho scritto
il primo romanzo, gli dicevo, alla fine ero contento soprattutto di un fatto, che
avevo trovato una voce. Avevo trovato una voce narrativa, gli dicevo, e adesso
questa voce mi piace e io continuo a usarla, gli dicevo. E il fatto che tu mi dica Sì,
fa ridere, ma è uguale al secondo, è come se tu mi dicessi Sì, mi fa piacere che mi
telefoni, ma la prossima volta che chiami, chiamami con un'altra voce25.
È contento Learco-Nori di questa voce: pur essendo un percorso del tutto
in progress, pur essendoci state nel tempo variazioni e contrazioni,
esasperazioni e ridimensionamenti, è molto consapevole del fatto che la sua
voce va costruendosi un'identità linguistica forte, e ce lo dice. D'altra parte
la stessa consapevolezza è una caratteristica di Nori, acquisita certamente
col tempo e con una continua riflessione sul suo scrivere libri, sulla lingua,
sulla letteratura; sarà opportuno affrontare in seguito, separatamente, un
discorso su questo e terminare adesso questa esplorazione. Ché, per dir la
verità, restringerò in una prima conclusione, che possa valere perlomeno
nei termini che mi sono proposta e a partire dall'indagine che mi ha guidato
sino a ora: se, infatti, D'Orazio riconosce nella produzione tra il 2006 e il
2008 una stabilizzazione nelle forme − più asciutte e cristalline,
stilisticamente meno dense, più ariose − la stessa è rinvenibile nelle opere
successive. In particolare ciò che D'Orazio dice di romanzi come Grandi
ustionati e Si chiama Francesca, questo romanzo − rispettivamente del
2001 e del 2002 − ossia che gli pare che la prosa favorisca “una narrazione
[…] che ha il tempo di sedimentarsi nella coscienza del lettore”, credo sia
qualcosa che si può riconoscere anche e più negli ultimi romanzi come
risultato di una domesticazione della lingua, che come tutti i tipi di
domesticazione richiede del tempo.
25 Paolo Nori, Spinoza, Torino, Einaudi, 2000, pp. 72-73.
18
Riporterò per ora solo un piccolo esempio di lingua “addomesticata”:
E la mia paura, da allora, era che mi succedesse una cosa che diceva sempre
Paride, che uno si aspettava chissà che cosa, invece succedeva chissà niente26.
Da qui, quasi di rimando e prima di procedere oltre, parte di quanto ha
scritto Luigi Grazioli in un articolo in occasione dell'uscita de La banda del
formaggio (2013): articolo nel quale ha utilizzato una metafora usata come
abbiamo visto dallo stesso Nori e che mi sembra faccia capire bene sia
quale tipo di rapporto si può instaurare con Nori, sia la forza della voce-
lingua come continuum:
Altri giorni invece, di storie, anche se quasi tutto lo è, non ne vuoi proprio
sapere, e quello che vuoi è proprio e solo una voce, con quel timbro, quelle pause,
quella cadenza, un marchio d’origine […]. È come telefonare a un amico. Che
puoi star senza per un bel po’, ma a volte ti vien voglia di vederlo, o almeno
sentirlo. E allora gli telefoni. Niente video-chiamate o chat: telefono. Che tu lo sai
magari come sta, pensi di saperlo: cioè, l’ultima volta stava benissimo e non si
capisce perché adesso debba stare male... mica voglio fare il menagramo... lo sai,
lo so, come sta, ma insomma, qualcosa gli sarà pure capitato... anche che gli è
capitato che non gli è capitato niente, non so se mi spiego […]27.
1.4. Sulla costruzione della voce (e oltre)
Se fino a questo momento ho cercato di illustrare alcuni fatti linguistici,
penso sia necessario, prima di cambiare e allargare in un certo senso la
visuale, fare un passo indietro e − contemporaneamente, mi verrebbe da
dire, qualche passo in avanti − guardando a tutti quegli elementi e fattori, a
tutte le influenze e gli interessi che hanno concorso alla costruzione di una
lingua che si pone, dichiaratamente, come antiletteraria, semplice, concreta.
Dico “dichiaratamente” perché Nori, pur non amando troppo le
classificazioni, non lo ha mai nascosto e anzi vi riflette e offre spunti
26 Paolo Nori, Siamo buoni se siamo buoni, Milano, Marcos y Marcos, 2014, p. 59. 27 L. Grazioli, Autori che leggo o rileggo, «Doppiozero», 19 settembre 2013 – www.doppiozero.com.
19
interessanti da sempre, in maniera più o meno velata, nei suoi discorsi28 e
nelle interviste, direi ogniqualvolta ha occasione (o voglia) di intervenire in
merito; nei romanzi, poi, riflessioni di questo tipo si configurano come veri
e propri giochi metaletterari e “transtestuali”29, resi spesso ancor più
efficaci dalla tipica vena ironica e umoristica del Nori.
Si veda intanto quanto dice, per mezzo di Learco Ferrari, a proposito di
un fantomatico romanzo, «L'uomo vitello»:
[…] L'hai letto? Mi chiede, Ho letto la prima pagina e c'erano l'aria turbinante
del crinale, due poiane in caccia che remigavano controvento in cerca di uno
scorcio incauto e un uomo che prendeva a seguire con gli occhi le nuvole filanti.
Queste cose esistono solo nei libri di questa gente che piace a te, Anna30.
La sua (ormai) “presa di posizione poetica” è riconducibile al suo essere
traduttore e ad alcune esperienze formanti, alle influenze provenienti dalla
Russia e a quelle provenienti dall'Emilia, agli incontri e al quotidiano31; e,
ultimo ma non ultimo, a quello spirito autocritico che da sempre e
variamente ripropone nei romanzi e che spesso si combina all'oscillare
perpetuo fra i ripensamenti e il gioco32. Tutto questo però, oltre che
facilmente reperibile online e nelle parole dell'autore, è stato già affrontato
da D'Orazio e, successivamente, ancor più da Camilla Tomassoni (che si è
laureata nel 2010 con una tesi specialistica su Il progetto letterario di Paolo
Nori, una tesi ricca di spunti interessanti a questo proposito, ma non solo).
Preferisco quindi rimandare al suo lavoro, ché val la pena dire è stato scelto
da Cortellessa per la sua antologia, Narratori degli Anni Zero (2011).
28 In particolare, quelli che poi sono andati a comporre Pubblici discorsi fungono da saggi letterari veri e propri. 29 Termine ripreso da D'Orazio che a sua volta lo desume da Genette (cfr. G. Genette, Palinsesti, Torino,
Einaudi, 1997, p. 4). 30 Paolo Nori, Le cose non sono le cose, Ravenna, Fernandel, 1999, p. 64. 31 Dalla letteratura russa in sé alla coincidenza che in Russia esiste fra scritto e parlato; dalla rivista «Il
Semplice» (di Feltrinelli) alla letteratura dei “semicolti”; da Cavazzoni, Celati e Cornia, a Benati,
Malerba, Gianolio – e altro ancora. 32 Gioco che a questo livello si configura in termini di camuffamenti e combinazioni e può essere
considerato oltretutto in ultima analisi “studio delle possibilità plastiche della lingua” (cfr. M. D’Orazio,
Paolo Nori: uno stile “semplice”, cit., p. 52).
20
A rendere la collocazione “ideologica” del nostro autore basterà quanto
detto da Nori per presentare la sua Scuola elementare di scrittura emiliana,
giunta quest'anno alla tredicesima edizione ed emblema di quella lingua
che col tempo è diventata, in tutto e per tutto, una scelta:
[…] a chi partecipa a questa scuola sarà chiesto di lavorare su una lingua
concreta, regionale, anche grossolana, una lingua dove i personaggi difficilmente
dicono Cribbio o Poffarbacco, e più facilmente dicono Per la Madosca, o Zio
campanaro, o una qualsiasi delle infinite esclamazioni che vengon dal cuore che si
sentono o si sentivano in giro fino a pochi anni fa33.
Questa è la conclusione di un intervento, fatto per l’editore Zanichelli,
che per la lunghezza ho preferito non trascrivere qui ma cui rimando perché
buona sintesi di quello che è il risultato di un percorso. Nello stesso
intervento l’Autore spiega anche la sua propensione per una lingua
regionale, ossia dei più: perché fatta “dei sostrati particolari di quel posto
lì” e perché è “nella maggior parte dei casi, una lingua comprensibile a tutti
e carica di un'espressività che con l'italiano italiano è molto difficile
ottenere”. E questo, che si lega al “marchio d'origine” e a quanto
esploreremo dopo, mi serve da aggancio per spiegare cosa intendevo per
resa della cadenza. Se infatti è innegabile e, ancora una volta, non certo
velato, il rapporto di Nori con la musica e il suo interesse per il suono della
lingua, la voce odierna di Nori mi pare meno votata alla ritmicità e meno
disponibile al ludismo sonoro dell'autore: mi pare, invece, che se permane
una musicalità negli ultimi romanzi sia questa da attribuire all'essere
emiliano e all'essere Nori, dunque da intendere sia in termini di scelta e di
resa, sia in termini di appartenenza e riconoscibilità.
Una nota “lessicale”: Luigi Matt, nel suo Avventure e disavventure della
lingua34, parlava di una vera e propria ossessione manifesta dell'autore per
33 Dal blog di Dizionaripiù, spazio online di cultura linguistica della Zanichelli – www.zanichelli.com. 34 L. Matt, Avventure e disavventure della lingua: la narrativa di Paolo Nori, in AA. VV., Lingua italiana
d'Oggi, a cura di M. Arcangeli, Roma, Bulzoni Editore, 2005, vol. II, p. 116.
21
le parole, “viste come uno strumento privilegiato di conoscenza, come il
tramite principale del mondo”. Non discutendo di questa affermazione, che
utilizzo anche per introdurre quell'ossessività dalla quale nemmeno Nori
sembra essere esente – come vedremo – la supero per far spazio,
direttamente, a uno sguardo che direi piuttosto sempre incuriosito dalle
parole e dalla lingua, stupito e capace di stupirsi. È bellissima, in proposito,
quella parte di Siamo buoni se siamo buoni nella quale si dà spazio a una
riflessione che, già apparsa nelle pagine di La banda del formaggio, trova
qui il suo sviluppo “parodico-soft”:
[…] Che negli articoli dei giornali, avevo pensato, se uno era ricco, era
sempre sfondato, se aveva la barba, era sempre folta, se c'era un fuggi fuggi, era
generale, se si parlava di acne, era giovanile, se si parlava di tecnologie, erano
nuove, se c'era un nucleo, era familiare, se c'era un'attesa, era dolce, se c'era una
marcia, era funebre, oppure nuziale, se c'era un andirivieni, era continuo, se c'eran
delle chiacchiere erano oziose, se c'era un errore, era fatale, se c'era un delitto era
efferato, se c'era un'impronta era indelebile, se c'era una fotografia era in bianco e
nero, oppure a colori [...]35.
35 Paolo Nori, Siamo buoni se siamo buoni, cit., p. 93.
23
2. ELEMENTI CHE TENGONO IL FILO
2.1. Per esempio, dei luoghi
Come dice Matt nel suo saggio:
Si può dire che la lingua è nel ciclo di Learco Ferrari uno degli strumenti
privilegiati; anzi, si giunge ad avere l’impressione che essa sia un vero e proprio
personaggio, di cui si seguono le avventure e le disavventure36.
E se questo è vero non solo per il cosiddetto “ciclo di Learco” ma anche
per i romanzi che vengono dopo, non è soltanto la particolarità del
linguaggio e dello stile di Nori a rendere la sua voce così riconoscibile. Ci
sono anche altri elementi, infatti, che formano questa voce nelle voci, che
sembra essere sempre la stessa: elementi che ho classificato in quattro
“categorie”, che andrò proponendo e che sono fra loro fortemente
interconnesse – al punto che l’una è rimando dell’altra, l’una è
sovrapponibile all’altra – elementi che spiegano il termine “monovocità”
utilizzato in introduzione, e che da sempre, continuamente, alimentano le
discussioni volte a capire quanto c’è di autobiografico in Nori, quanto forte
sia la sua tendenza a una sorta di “autobiografismo”:
Quasi tutta la gente che mi parla delle cose che scrivo, sono quasi tutte
convinte che sono autobiografiche, le cose che scrivo. C’è una mia amica, si
chiama Cristina, quando le racconto delle cose della mia vita lei mi dice Lo so.
Oppure mi dice No, non è vero. Non ti ricordi cosa dicevi in Spinoza? mi dice. Io
di solito non mi ricordo […]37.
Una tendenza che, seppur vera, va anche necessariamente superata.
36 L. Matt, Avventure e disavventure della lingua: la narrativa di Paolo Nori, in AA. VV., Lingua italiana
d'Oggi, a cura di M. Arcangeli, Roma, Bulzoni Editore, 2005, vol. II, p. 119. 37 Paolo Nori, Si chiama Francesca, questo romanzo, Milano, Marcos y Marcos, 2011, p. 9.
24
Un primo elemento è la “regionalità”: quella che pervade la lingua, certo,
come abbiamo avuto già modo di osservare, a seguito di una precisa idea
autoriale, in favore di una resa della cadenza, in virtù anche di una
“vocazione emiliana alla melodia”38; ma anche quella che pervade gli spazi
in cui si muovono (o si sono mossi) i personaggi delle storie di Nori. Se,
infatti, le coordinate temporali sono perlopiù sfumate, messe in secondo
piano, talvolta praticamente assenti – anche solo per il protagonismo del
monologare o, se preferite, del raccontare a una sola voce – quelle spaziali
rimandano sempre, comunque, a certi contesti (regionali, cittadini,
situazionali) e molto spesso a luoghi dell’Autore, a quei luoghi che sono
proprio i suoi. I diversi racconti si snodano fra autobus e treni, case e
quartieri, stazioni e ospedali, e hanno riferimenti sempre fissi appartenenti
a quella fetta d’Emilia compresa fra due poli che sono le città di Nori:
Parma e Bologna – seguite da Casalecchio di Reno, dove Nori da un certo
momento in poi (non ci è dato saperlo e non è importante) si è trasferito39.
Fanno sempre da sfondo e pertanto i contorni possono essere più o meno
delineati e le immagini che ne vengono fuori possono essere più o meno
nitide. Se ne può avere un tratteggio rapido o una descrizione precisa ma
possono anche fungere da spunto aneddotico, metaforico e umoristico,
come avviene con Carpi in Siamo buoni se siamo buoni40, o nascondersi
dietro a nomi altri, come avviene in I malcontenti (2010). In quest’ultimo,
infatti, accade che una riconoscibilissima Bologna venga chiamata Baden-
Baden; e accade lo stesso per le altre città che, assieme a lei e
38 Cfr. C. Tomassoni, Il progetto letterario di Paolo Nori, tesi di laurea, Università di Bologna, a. a.
2009/2010, relatori A. Bertoni e S. Colangelo, p. 19. 39 Una nota di precisazione: Casalecchio di Reno segue i due poli che sono rimasti tali sin dal ciclo di
Learco perché, come detto, arriva dopo sia nella vita di Nori – che attualmente vi risiede – sia nei suoi
romanzi; in particolare, direi che viene messa a fuoco con Ermanno Baistrocchi, a oggi ultimo “io
narrante” e alter ego. 40 Citarne solo una parte sarebbe sbagliato perché il racconto di Cianuro (è lui che parla) merita di essere
letto per intero quindi: Paolo Nori, Siamo buoni se siamo buoni, cit., pp. 124-128.
25
coerentemente, entrano in questo gioco (all’apparenza puramente)
nominale41, d’altra parte in qualche modo riconosciuto e chiarificato in
termini di intenti dallo stesso “io narrante”, Bernardo detto Bernardo
Provenzano42:
Perché, per esempio, dopo avere osservato, non so, mettiamo il caso che c’è
una città che si chiama, per dire, Tommaso, e voi, dopo avere osservato, con la
massima attenzione della quale siete capaci, quel che succede a Tommaso, e dopo
aver raccontato, senza inventare nulla, quel che si vede a Tommaso per come
l’avete visto nelle vostre rètine e nel vostro cervello, e per come l’avete odorato
con i vostri nasi, e per come l’avete tastato con le vostre superfici tattili, se voi
dopo tutto ciò prendete quel che avete scritto e, non so, per esempio, cambiate il
nome della città e invece di Tommaso la chiamate, non so, Baden-Baden, vi
accorgerete che la realtà che avete descritto, che andava per un verso, tutto d’un
tratto si mette a andare per il verso contrario43.
Una dichiarazione, quella di Bernardo, che potrebbe far luce anche su
altre questioni, come quelle relative alle voci e ai personaggi nonché quelle
relative alla dimensione noriana del gioco (non soltanto nominale) sulle
quali si tornerà in seguito. Sempre da I malcontenti due esempi, prima di
procedere oltre, che si legano sia a quanto detto sia alla presenza non
presenza del dialetto in Nori:
Più passava il tempo, mi aveva raccontato Nina, più mi cresceva un malumore
che sembrava che dovesse spaccarmi la pelle, ero così piena della mia ansia, ero
così preoccupata del mio ritardo, ero così infastidita dai discorsi della signora e
dall’odore del vino e quant’altro, che stavo per scoppiare a piangere, zio
imberlato. Ma sei di Karlsruhe?, le avevo chiesto io. Son di Karlsruhe, mi aveva
detto lei.44
Era la prima volta, con me, che Nina lasciava andare il suo accento di
41 Oltre a Baden-Baden e Karlsruhe, sono altre le città che compaiono con nomi di altre città, tutte tedesche. Se le due citate hanno in comune con le corrispondenti italiane disposizione geografica e fiume
(Reno), le altre analogie (se vi sono) sono di più difficile comprensione; Amburgo, per posizione,
potrebbe essere Milano e Ratisbona – nonostante si dica “in Sardegna” – potrebbe essere Ravenna, e via
dicendo. Resta il fatto che riscontrare tali somiglianze “geografiche” è un fatto curioso che dimostra
quanto sia forte la sua giocosa tensione verso una ricerca esponenzialmente infinita di nessi e associazioni
possibili.
42 Non è l’io narrante a presentarsi come Bernardo Provenzano, si presenta solo come Bernardo: è il suo
vicino Gianni – ribattezzato Gianni Morandi dal protagonista – a chiamarlo così. 43 Paolo Nori, I malcontenti, Torino, Einaudi, 2010, pp. 64-65. 44 Paolo Nori, I malcontenti, cit., p. 84.
26
Karlsuhe. Di solito usava con me un italiano di cortesia, mi dava del tu, ma usava
una lingua come se mi desse del lei, che non si capiva neanche da che parte
dell’Italia veniva, come se non avesse una vera e propria lingua madre, come se
non avesse fatto una specie di scuola di recitazione, invece quella volta lì, Zio
imberlato, mi aveva detto, era di Karlsruhe45.
Qui, come altrove, il dialetto compare per interiezioni nel mezzo di
discorsi, quasi a dover soltanto connotare geograficamente e
“empaticamente” i diversi personaggi cosicché, in un Nori ben lontano
dall’essere scrittore dialettale, possiamo scorgere comunque un interesse
sempre vivo per tali espressioni e per ciò che rappresentano o significano.
Se gli esempi, degli usi come dell’interesse dell’Autore, sono moltissimi e
sparpagliati lungo tutto l’intero corpus, si vedano al proposito due delle
tante spiegazioni che Nori offre, volentieri e a suo modo, anche in favore di
una sorta di “accessibilità universale”46:
La Mirca, il fatto che lei dicesse Fichi dipendeva dal fatto che lei era di
Parma, e Fichi era un modo elegante di dire una cosa che dicevano a Parma che
non era, di per sé, elegantissima, che è una cosa che mi rendo conto in questo
momento che è un po’ imbarazzante anche scriverla, ma è imbarazzante perché
adesso io sto scrivendo a Casalecchio di Reno e dire Figa, a Casalecchio di Reno,
sembra di essere volgari, invece, a Parma, dire Figa, non è volgare, perché Figa, a
Parma, non è esattamente la Figa, cioè noi di Parma, anch’io, son di Parma, e a
Parma, noi, Figa, non è che intendiamo proprio la figa, no, non è una sineddoche,
è un intercalare, noi figa lo usiamo come intercalare, non so, se c’è caldo, noi a
Parma diciamo «Figa, che caldo», oppure, se c’è freddo, noi a Parma diciamo
«Figa, che freddo», oppure se non c’è né caldo né freddo, noi a Parma diciamo
«Figa, che tempo», e la gente un po’ più colta un po’ più educata come la Mirca,
invece di Figa loro dicono Fichi che è un eufemismo, come si dice47.
[…] uno dei problemi di questi libri è che ci son delle espressioni, come Mo
mama, che uno di Parma capisce benissimo cosa vogliono dire, uno che non è di
Parma secondo me fa fatica forse è bene provare a tradurla, Mo mama, che questo
libro non è destinato solo ed esclusivamente ai parmigiani, è destinato anche agli
altri, se vogliono, solo che tradurre Mo mama, ecco Mo mama è una di quelle
tipiche espressioni che si dice che sono intraducibili, perché tradurla, non so, si
45 Paolo Nori, I malcontenti, cit., p. 86. 46 Vale a dire: a testimonianza di quella “volontà di farsi capire da tutti i lettori”, di cui si è parlato, che
Camilla Tomassoni ha definito “capitale” e che secondo lei – ma da quanto abbiamo visto forse anche
secondo Nori – viene ancor prima dell’intento mimetico (cfr. C. Tomassoni, Il progetto letterario di Paolo
Nori, cit., p. 24). 47 Paolo Nori, Siamo buoni se siamo buoni, cit., p. 36.
27
potrebbe dire che vuol dir Mamma mia, ma Mamma mia è una cosa che si può
dire anche sull’onda dell’entusiasmo «Mamma mia, che bello!», e invece «Mo
mama che bello» è una cosa che non si può dire perché Mo mama è
un’esclamazione che ha un carattere prevalentemente negativo, uno quando dice
Mo mama di solito scuote la testa […]48.
2.2. Delle coincidenze
Vi è però un secondo elemento che ancor di più assimila Nori ai suoi
personaggi: è tutto ciò che si può genericamente chiamare “bagaglio di
vita”, da cui l’Autore attinge e che si ripropone fra le voci, e nel quale sono
compresi studi, mestieri, esperienze e anche specifici riferimenti culturali49.
Anzitutto i vari “io narranti” sono tutti scrittori o, come dice Nori, scrivono
tutti dei libri. Ma ricorrono, fra un romanzo e l’altro, la laurea in letteratura
russa, il diploma in ragioneria, il mestiere di editore; e poi, ancora, il
trasferimento da Parma a Bologna, una figlia, due fratelli, un padre, una
nonna. E se quanto detto finora può essere comunque mosso da una volontà
“accomunante”, ossia dall’intenzione di rappresentare ogni volta, di per sé,
una categoria di persone – gli emiliani, i traduttori, gli editori, gli scrittori,
chi si è trasferito, chi si è lasciato, chi ha una figlia e così via – è importante
notare che l’opera omnia di Nori si dirama per corrispondenze e analogie,
più o meno esplicitate, che legano la biografia di Nori a quella che di volta
in volta attribuisce ai suoi personaggi. D’altra parte – l’ho già accennato –
quanto c’è di autobiografico in questo autore è una cosa che si chiedono in
tanti, continuamente e a ragione. A ragione perché, pur mascherate, tali
48 Paolo Nori, Siamo buoni se siamo buoni, cit., p. 198. 49 Con questo intendo, non tanto il background culturale che sottende la poetica di Nori, quanto dei
rimandi specifici ed espliciti che l’Autore stesso inserisce nelle opere. Fra gli altri: I malcontenti, cit., p.
80.
28
corrispondenze e analogie sono presenti sin dal principio50 e col tempo,
probabilmente anche a seguito di e in reazione a un tale dibattito in merito,
ciò che è cambiato mi pare sia il rapporto dell’Autore con la questione. Dal
mascheramento iniziale all’insofferenza espressa variamente e più volte,
come accade in Siam poi gente delicata, Bologna Parma: novanta
chilometri, che è anche l’unico romanzo autobiografico “manifesto”51:
Allora con gli altri, anche se son miei amici, quando sento per esempio un
mio amico dire che lui vive tra Salerno e Napoli a me viene da scrivere, sul
quaderno che mi porto sempre dietro quando vado in giro per strada, Paolo Nori,
nato a Parma nel 1963, vive tra l’uscio e l’assa. E a questo punto l’italianista dirà
Aaaah, ma allora qui non c’è Learco Ferrari, non c’è Learco Ferrari. […] Gli
italianisti, la cosa che gli interessa, a loro, dei libri, se c’è dentro Learco Ferrari o
se c’è fuori Learco Ferrari. Cioè adesso la letteratura italiana, la cosa importante,
se c’è Learco Ferrari o non c’è Learco Ferrari […]52.
E da qui sino all’accettazione, che forse spiega il carattere esplicito e
palese di certe ultime analogie come, significativamente:
E qualcuno mi aveva aperto un mio profilo su Wikipedia che cominciava
dicendo «Ermanno Baistrocchi, scrittore parmigiano, bolognese d’adozione,
autore della Banda del formaggio» e finiva così: «Il 24 marzo 2013 è investito da
una moto presso Casalecchio di Reno (dove risiede) e viene ricoverato in gravi
condizioni all’Ospedale Maggiore di Bologna». Che uno lo leggeva poteva
pensare che io ero ancora ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Maggiore di
Bologna, lo diceva Wikipedia. Che io ci avrei aggiunto magari «Adesso sta bene».
Però non ero capace di trafficare con Wikipedia, non ce lo aggiungevo53.
Per quel che riguarda invece le corrispondenze nominali e intertestuali,
tre su tutte: Renzo, che è padre di Learco e padre di Bernardo, Gea, l’amica
di Bernardo ma anche di Ermanno Baistrocchi, e Togliatti, il nomignolo
50 Indimenticabili i nomi fittizi utilizzati in Le cose non sono le cose, come i: Cretinetti e Confetto,
Montatori e Zeffirelli. 51 P. Lejeune, Il patto autobiografico, Bologna, Il Mulino, p. 27. 52 Paolo Nori, Siam poi gente delicata, Bologna Parma: novanta chilometri, Roma-Bari, Laterza, 2007, p.
78. 53 Paolo Nori, Siamo buoni se siamo buoni, cit., p. 76;
e www.paolonori.it; http://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Nori
29
che sia Learco sia Ermanno danno alle rispettive donne (che nominalmente
non coincidono)54.
Sempre sul piano dell’intertestualità si colloca il quarto e ultimo
elemento cui voglio accennare, ossia tutto ciò che ho definito come: il
riuso. È frequente, infatti, in Nori ritrovare cose già lette in suoi romanzi
precedenti. Alle volte questo si manifesta in termini di “sviluppo di idee”
come accade anche a Ermanno Baistrocchi, che sviluppa in termini nuovi,
più coerenti o più discreti, qualcosa già apparso in altra forma – come
capita con quella divagazione sul «Fichi» dell’amica Mirca Barigazzi55 o
con l’invettiva contro “quel giornalista della Canaglia”56, entrambe apparse
già in La banda del formaggio e riprese poi in Siamo buoni se siamo buoni.
Altre volte se ne ha invece una ripresa vera e propria, quasi letterale ma
con diversa attribuzione; ripresa che può riguardare e dunque mettere in
gioco direttamente gli “io narranti”, come accade per esempio con una
poesia:
[…] Solo, allora, scrivevo delle poesie. Nelle mie poesie esprimevo la gioia di
vivere. Ne avevo scritta una che si intitolava Non è una brutta vita. Diceva:
Passo nel tempo cercando
filo da torcere,
e quando lo trovo lo torco,
e quando l’ho torto,
Ne cerco57.
[…] Quand’ero un ragazzo avevo scritto una specie di poesia, una delle
pochissime cose che avevo scritto prima della Banda del formaggio e diceva,
quella specie di poesia: «Passo nel tempo cercando filo da torcere, e quando lo
trovo lo torco, e quando l’ho torto ne cerco». Ecco, l’Emma, una delle cose belle
che aveva, è che era una promessa, continua e inesauribile, di filo da torcere58.
54 Ho limitato queste corrispondenze al piano dell’intertestualità per scelta, non perché non vi possano
essere corrispondenze con la vita di Nori ma perché credo sia giusto darsi dei confini “di discrezione”
invalicabili. 55 Paolo Nori, La banda del formaggio, Milano, Marcos y Marcos, 2013, p. 132. 56 Paolo Nori, La banda del formaggio, cit., p. 175. 57 Paolo Nori, Bassotuba non c’è, Milano, Feltrinelli, 2009, p. 63. 58 Paolo Nori, Siamo buoni se siamo buoni, cit., p. 185.
30
Oppure può riguardare voci altre, che interagiscono con gli “io narranti”
o di cui questi ci parlano, come per esempio avviene con ciò che Ermanno
ci dice sul Bandierino, che si configura proprio come Learco e in due
occasioni (e in due opere diverse, anche se continue), di cui una:
[…] quello lì era un periodo, proprio, mi stavo lasciando un po’ andare, mi
scappava ogni tanto anche una scoreggina nei momenti più impensati, in riunione,
o in fila al self service, mi stavo riducendo come il Bandierino, che il Bandierino
(non si chiama Bandierino, il Bandierino non esiste) è l’unico autore parmigiano
che abbiam pubblicato, solo un libro, sembrava così simpatico, a leggerlo, era così
noioso, di persona, così puntiglioso, ha voluto far tutto lui, anche la quarta di
copertina, e in quarta di copertina ci ha scritto una cosa, perché lui, in quel libro lì,
cioè non lui, il protagonista, che però era una proiezione, era lui, era il Bandierino
(non si chiamava così) aveva una malattia che si chiamava bombardite che faceva
continuamente delle scoregge e in quarta di copertina, che l’aveva voluta a tutti i
costi far lui, ci aveva scritto «Io, delle volte, andare in giro per strada, mi sembra
di essere una macchina per far le scoregge» e io, quel periodo lì, prima di
mettermi a correre, quanti anni avrò avuto?, cinquantasei anni, mi sembra che
avevo imboccato la strada che nel giro di poco mi trasformavo in una specie di
Bandierino, com’era pignolo, il Bandierino59.
Una nota prima di proseguire: quest’ultima operazione viene spesso non
solo pienamente riconosciuta – in tanti e vari modi che caratterizzano gli
stessi racconti - ma viene persino giustificata in virtù di una precisa idea
che l’Autore ha su tutto ciò che è montaggio e costruzione delle proprie
59 Paolo Nori, La banda del formaggio, cit., p. 42.
31
opere. In merito, fra le altre, vale come dichiarazione d’intenti chiara anche
se implicita quel post del giugno 2012 in cui, citando Viktor Šklovskij,
Nori scriveva:
Il mondo è frutto di montaggio. L’abbiamo scoperto quando abbiamo
cominciato a incollare una pellicola cinematografica. Lo hanno scoperto persone
venute da fuori: medici, scultori, pittori, attori; essi si sono accorti che sentimenti
diversi si potevano esprimere con pezzi identici, ma montati diversamente. Lev
Kulešov creò un’intera teoria; egli dimostrava come un pezzo di pellicola che
fissava un’espressione del volto potesse narrare dolore, fame, felicità. Il mondo è
prodotto di montaggio, il mondo è concatenato. I pensieri non esistono isolati60.
Ed è proprio a partire dal montaggio di Lev Kulešov che Camilla
Tomassoni inizia, nel paragrafo dedicato, le sue precise osservazioni su
tutto ciò che sta dietro le opere di Nori e specie su quel montaggio, che “si
rende indispensabile, come un’azione disciplinante e ordinante dello
scrittore-demiurgo”. Ne riporto qui alcuni passaggi significativi:
Nel caso di Nori l’intreccio viene ottenuto a posteriori, quando il materiale è
già stato raccolto ed è pronto ad essere configurato in un sistema significante. […]
se l’autore non parte da una creaxione ex nihilo, ma da una chora di materiali
informi appuntati nei taccuini (e magari trascritti al computer), accade che il
riutilizzo di uno stesso pezzo per progetti diversi possa rivelarsi manovra
significativa e proficua61.
Voglio dire, in altre parole, che la ricollocazione di brani più o meno identici
in progetti diversi assolve in Nori ad una ricerca semantica, come se ad ogni testo
si riconoscesse una vita autonoma pronta a manifestarsi in forme diverse a
seconda del terreno in cui la si colloca62.
Se era giusto e necessario perlomeno accennare a queste tematiche
“strutturali”, il riuso come tutti gli altri “elementi” si apre a ulteriori
osservazioni senza perdere la funzione di “legante”.
Visti questi esempi, che sono solo alcuni di numerosissimi, e
riconosciuto che le opere di Nori si sono costruite e si costruiscono su una
serie vastissima di nessi e rimandi, è necessario ora guardare a quelle che
60 www.paolonori.it/non-esistono/. 61 C. Tommasoni, Il progetto letterario di Paolo Nori, cit., p. 60. 62 C. Tommasoni, Il progetto letterario di Paolo Nori, cit., p. 61.
32
sono invece le voci messe in gioco da Nori. Valga come prima risposta in
merito alla questione dell’autobiografismo quanto ha affermato lo stesso
Autore in un’intervista:
La propria faccia uno ce l’ha, non deve sforzarsi di cancellarla, mi viene da
dire63.
Ché potrebbe essere semplicemente così – oppure no.
63 Da Altervista: http://isiti.altervista.org/paolo-nori-il-blog-la-propria-faccia-e-le-nuove-uscite.
33
3. DALLA VOCE A: LE VOCI
3.1. Alcune premesse
A quanto si è detto e a quanto si dirà, si aggiunga quel che ha osservato
Cesare Segre oltre vent’anni fa e che costituisce un assunto valido anche
nel caso di Nori:
I romanzieri si sono pure resi conto in modo sempre più netto che le barriere
tra voce dello scrittore e voci dei personaggi, le gerarchie di attendibilità fra
discorso diretto e indiretto, sono una finzione rispetto a una materia narrativa che
è tutta, ed esclusivamente, dello scrittore. Ecco allora che i registri linguistici
possono scambiarsi entro e fuori dei discorsi diretti, che narrazione e discorso
riportato possono mescolarsi e alternarsi, che si affermano nuovi tipi di discorso,
come il monologo interiore e il flusso di coscienza. L’orchestra che il narratore
dirige è composta di una sola voce infinite volte rifratta: la sua64.
Più in generale l’analisi di Segre può servire da supporto critico anzitutto
perché si muove, come la nostra riflessione, a partire dal concetto di
“plurivocità”; tale concetto rimane sia nell’indagine di Segre sia nella
nostra ben lontano e distinto da quello di “polifonia”. Serva a chiarire
quest’ultimo punto ciò che ha detto Romano Luperini, nella sua recensione
a Intrecci di voce e in riferimento a I Malavoglia:
Sul piano teorico, essa può essere utile ai fini di una tipologia del romanzo
moderno: per esempio, "I Malavoglia" sono, a mio avviso, un romanzo plurivoco
ma non polifonico perché le voci che vi si alternano sono numerosissime e vario e
fittissimo è il loro intreccio, mentre il tono della narrazione e il punto di vista
restano monodici, costanti, unitari riflettendo dall'interno un mondo chiuso e
autosufficiente, totalmente impossibilitato ad aprirsi alla pluridiscorsività di
universi linguistici, sociologici e ideologici diversi dal proprio e a farli reagire con
quello diverso, di un narratore (o, tanto meno, di un autore) a esso estraneo65;
64 C. Segre, Intrecci di voci. La polifonia nella letteratura del Novecento, Torino, Einaudi, 1991, p. 5. 65 R. Luperini, rec. a Intrecci di voci, in «L’indice», maggio 1992.
34
Un ragionamento che, pur partendo da un’analisi altra (quella di Segre) e
da un’opera lontanissima dai romanzi di Nori (I Malavoglia), si inserisce
bene anche nel nostro discorso e mostra come sia possibile individuare
affinità teorico-critiche proprie della letteratura del Novecento. Prima di
passare a un’osservazione diretta delle nostre voci, un’ultima nota
riguardante il discorso indiretto libero, modalità diegetica prediletta da Nori
al punto da essere quasi l’unica modalità diegetica ‘possibile’:
Punto di partenza classico […] è il discorso indiretto libero, in cui i registri, le
esclamazioni, i riferimenti di tempo e di luogo (i deittici) possono essere quelli dei
locutori, mentre responsabilità e contesto appartengono all’enunciatore […]66.
Se il discorso di Segre prosegue, a noi basta questo dal momento che in
Nori il cosiddetto enunciatore responsabile è quello che di volta in volta
viene scelto come “io narrante”: “io narrante” che si forma a partire da un
processo di contaminazione – ossia quello che Segre definisce come una
sorta di mescolanza autore-personaggio – e che sembra assumersi in tale
processo anche tutta una serie di responsabilità autoriali, come quelle che
riguardano l’altro processo di contaminazione, che sta dietro invece al
secondo tipo di voci presente nei romanzi di Nori, e che consiste nel:
[…] far propri i discorsi di singoli personaggi, riferendoli indirettamente ma
conservandone, in parte, le tonalità linguistiche e persino le prospettive (uso dei
deittici, delle esclamazioni, ecc.)67.
Quest’ultimo è un procedimento frequente in Nori, seppur subordinato
sempre alla primarietà della voce narrante, che è quasi sempre una. Ossia le
voci messe in gioco come tali e autonome sono quelle dei personaggi scelti
di volta in volta come “io narranti” e alter ego, e questo dipende anche
soltanto dalla scelta di uno specifico modus narrandi (che è quello che
abbiamo visto); ma è tramite loro e tramite un lavoro complesso fatto di più
66 C. Segre, Intrecci di voci. La polifonia nella letteratura del Novecento, cit., p. 5. 67 C. Segre, Intrecci di voci. La polifonia nella letteratura del Novecento, cit., p. 4.
35
operazioni – fra cui, appunto, un certo procedimento e il ricorso al discorso
indiretto libero – che vengono messi in gioco gli altri personaggi.
Conseguenza di questo è che le loro voci assumono una posizione
differente rispetto a quella delle prime, meno autonoma perché riferita, più
o meno importante a seconda dei casi, sempre a servizio della voce prima e
non sempre destinata a sviluppi ulteriori68. Avviene così che la decodifica,
facilitata dalle istruzioni della “voce prima”, risulti comunque più
complessa e sempre ambigua.
Ma, d’altra parte, complessità e ambiguità69 tornano e torneranno sempre
con Nori perché fanno parte di quel gioco e di quei meccanismi che
l’Autore mette in atto, della “regione a cavallo tra il sì e il no” che sempre
sceglie:
[…] È un modo per tagliar fuori il problema della verosimiglianza, è un modo
per farla finita col narratore onnisciente, è un modo per far nascere continuamente
nel lettore la domanda ‘Chissà se è vero?’, domanda che a me viene sempre
quando leggo qualcosa che mi piace che mi sembra abiti sempre in una regione
che sta a cavallo tra il sì e il no, e poi c’è dell’altro70.
3.2. Uno sguardo e un ragionamento
È in gioco la situazione stessa del romanzo, in rapporto col mutare della
concezione del personaggio, anzi del soggetto in generale. La regolamentazione
delle voci nella polifonia romanzesca, per esempio, non è più osservata, dopo la
68 Si veda al proposito il caso di Cianuro, personaggio secondario in Siamo buoni se siamo buoni, del
quale Nori dice: “mi sembra che potrebbe venirne fuori uno il cui protagonista sarà Cianuro” (www.paolonori.it); non sappiamo, a oggi, se sarà così ma sappiamo che, rispetto ad altri personaggi
secondari, l’io narrante Ermanno lascia alla sua voce spazi importanti già in questo romanzo, in linea con
la ‘sensazione’ espressa da Nori in quest’intervista. 69 Da Nori (www.paolonori.it/non-e-un-problema/): “C’è stato un filosofo, del quale ho letto recentemente
un’intervista, che ha dato la definizione forse più bella che abbia mai sentito della fotografia. Ha detto:
«La fotografia non è un problema, la fotografia è un enigma, perché il problema ha una soluzione e
l’enigma è un problema che non ha soluzione». Non è una definizione, è probabilmente un gioco di parole
per non definire, però all’interno di questa definizione di enigma io mi ritrovo pienamente” (cfr. Luigi
Ghirri, Lezioni di fotografia, Macerata, Quodlibet 2010, p. 24). 70 Dall’Introduzione a: A. Puskin, Umili prose, traduzione e cura di Paolo Nori, Milano, Feltrinelli, 2006.
36
decadenza e il discredito del narratore onnisciente. Meno spesso che in passato ci
si azzarda a riferire sui pensieri del personaggio, frequentemente la sua stessa
autonomia è messa in forse. La realtà inventata appare enigmatica e nebbiosa,
mutilata, e l’impegno non si applica più a descriverla, ma ad afferrarne qualche
brandello o a mostrarne i riflessi nella percezione, anch’essa oscillante, dello
scrittore71.
Prima di abbandonare Segre mi sono permessa di riportare questa sua
osservazione perché, come le altre, offre spunti interessanti e può indicare
strade atte a individuare radici comuni di una letteratura difficile da
confinare com’è quella a noi contemporanea. Senza approfondire questioni
altre e ponendo il focus su Nori, bisogna necessariamente sbarazzarsene ma
allo stesso tempo si può conservare, per esempio, la messa in forse
dell’autonomia dei personaggi72 – e, come vedremo successivamente,
anche ciò che Segre dice della realtà rappresentata nel romanzo. Se si parla
spesso di voci e meno di personaggi, infatti, è perché i personaggi di Nori
sembrano non riuscire nemmeno ad averla questa autonomia, sembra che in
qualche modo sia loro preclusa. Mi pare vi sia in Nori uno sforzo uguale e
contrario a quello che si riconosceva in Pirandello:
Il mio sforzo supremo deve consistere in questo: di non vedermi in me, ma
d’essere veduto da me, con gli occhi miei stessi ma come se fossi un altro:
quell’altro che tutti vedono e io no73.
Un’alterità su cui Nori insiste ancora oggi, come testimonia quanto ha
detto di recente in un incontro, per la rassegna cremonese ‘Sei autori in
cerca di personaggi’74:
[…] Va be’ ma nei video io, non sono mica io, quello dei video: io leggo le
71 C. Segre, Intrecci di voci. La polifonia nella letteratura del Novecento, cit., p. 5. 72 Non vale invece per Nori quanto Segre dice sui pensieri dei personaggi, perché nel caso del nostro
Autore i pensieri sono invece materia prima, riferimento costante, via di comprensione, caratterizzazione;
si veda quanto dice a proposito di Learco Ferrari in un’intervista uscita per Repubblica e ripresa
dall’Autore nel suo blog (www.paolonori.it): “Ho smesso perché era diventato un impaccio, era come se
mi obbligasse a star dentro dei pensieri che non eran più quelli intorno ai quali giravano le storie che
volevo raccontare”. 73 L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila, Garzanti Editore, Milano, 1993, p. 19. 74 La rassegna non si propone di indagare questi temi specifici pertanto, nel nostro caso, si tratta di una
fortunata coincidenza.
37
cose che scrive Learco Ferrari, cioè che dice Learco Ferrari, e quindi io, quando
leggo, la mia voce è quella di Learco Ferrari, per forza. Ma nella mia vita privata è
tutta un’altra cosa, mi vien da dire. […] nei libri che ho scritto, sia quelli lì, i primi
con Learco Ferrari, sia quelli dopo, dove Learco Ferrari non c’è, l’io narrante –
quello che dice io dentro il libro – è uno che... io capisco perché si può confondere
facilmente con me, e che però non sono io. Anche perché se io raccontassi la mia
vita, è una vita insignificante, cioè io non faccio una vita romanzesca. Invece
Learco Ferrari e gli altri anche… loro sì, fanno una vita romanzesca, non è che gli
succeda chissà cosa però gli succedono delle cose, pensano e vedono delle cose
che io credo valga la pena di raccontare in un romanzo, ecco; se dovessi invece
scrivere un’autobiografia, non la scriverei perché… non avrei proprio materiale75.
Senza fare paragoni azzardati (e inappropriati) alle volte sembra vi sia
una sorta di conflitto uguale e contrario a quello pirandelliano, tanto che
Nori appaia davvero quasi come un autore in cerca di personaggi:
personaggi, i suoi, che vengono individuati, chiamati in causa, messi in
gioco, che potrebbero anche raggiungere un’autonomia ma non vi riescono
mai del tutto perché non vengono mai lasciati veramente liberi d’essere
altro dall’autore-regista e dalla voce madre e neppure dal montaggio e dalla
narrazione in cui si muovono. Certo, bisogna riconoscere il “carattere di
irripetibilità di ogni configurazione esistenziale”; è vero quel che dice Ugo
Cornia nel prologo a Vite sbobinate e altre vite di Alfredo Gianolio:
[…] c’è qualcosa nelle nostre vite singolari, cioè nelle vite che ognuno di noi
normalmente fa tutti i giorni, che per sua virtù propria ha il potere di sbalestrare
ogni discorso. Nei fatti noi, quasi tutti, non siamo altro che delle collezioni
ambulanti, una collezione di cose in bilico dove ci sta dentro un po’ di tutto, un
po’ di prati, pioppeti, lavori, hobby, nuvole, carriole del nonno, automobili,
mamme76.
Ed è vero anche per gli stessi personaggi di Nori ma, oltre a quanto già
detto, la loro caratterizzazione è pressoché ridotta al minimo se non per
75 L’intervista, che ho cercato di riportare e trascrivere in maniera pressoché letterale, è stata condotta dai
ragazzi di ‘Controtempo’ all’interno dell’incontro dedicato a Nori, nel contesto dell’ultima edizione di
‘Sei personaggi in cerca d’autore’ (19 settembre 2014): la si trova per intero in video su Youtube al canale
di Gian Carlo Storti (www.youtube.com). 76 U. Cornia, La bellezza delle vite singolari, prologo a A. Gianolio, Vite sbobinate e altre vite, Sassuolo,
Incontri Editrice, 2007. Riutilizzo, per convinta adesione, la citazione di Cornia già impiegata da Camilla
Tomassoni, nell’ambito di un discorso più ampio relativo alla vicinanza di Nori a quella che più volte è
stata definita “avanguardia emiliana” e che comprende Cornia, Gianolio ma anche Celati, Zavattini,
Cavazzoni, etc.
38
quel che si evince a partire da loro comportamenti e manie, ossessioni e
abitudini, e – ultime ma non ultime, appunto – dalle loro stesse voci: ciò
che esprimono, come lo esprimono e quale linguaggio utilizzano. Per
questo vanno guardati sì, in virtù della loro unicità, come parti che valgono
in sé e di per sé e, soprattutto, per i “modelli di funzionamento” e i modi di
sentire che si portano dietro; ma per procedere poi oltre e andare a vedere
quanto l’uno può seguire l’altro, quanto ciascun personaggio e ciascuna
voce possano essere state in questi ultimi quindici anni e, con tutta
probabilità, potranno essere anche domani: uno, nessuno e centomila.
3.3. Delle voci: a partire da Learco
Learco Ferrari è, come abbiamo già detto, il primo io narrante e alter ego
di Nori, col quale non solo ha esordito ma ha percorso un cammino che
copre lo spazio di sette romanzi. Forse per questo viene tirato sempre in
ballo, ancora oggi, o forse perché in lui e nel suo racconto alcune
caratteristiche come ossessività e manie, egocentrismo e autoreferenzialità
vengono portate al massimo livello. Caratteristiche che sono proprie di un
dato “modello di funzionamento” e che, pertanto, pervadono la voce del
personaggio, una voce che ben si presta anche a una sperimentazione
linguistica scatenata e a tratti indomabile. Learco è “quello che non ce la
fa”, che si muove nel mondo incerto e in attesa, che vive anche di atti
mancati e cose non dette, che riesce a controllare meno e gestire meno una
vena polemica che spesso lo induce a invettive accese, perlopiù in solitaria,
e che lo ha indotto pure a quell’ “affanculaggio” post-laurea. È un
personaggio che si lascia andare con difficoltà, che si concede raramente di
dar spazio all’emotività: un’emotività che è ancora acerba e ingestibile,
39
poco riconoscibile, che – se emerge – emerge per impulsi e voci altre o
come segno di una generica condizione di stanchezza e insofferenza, non si
sa bene dovuta a che cosa77.
Esemplare a riguardo Bassotuba non c’è, storia di un abbandono in cui a
esternare una sofferenza vera e propria è soltanto la gatta Paolo:
Mi dispiace per il gatto. Io, da solo, non basto per farlo giocare. Il gatto la
sente, un po’, la mancanza di Bassotuba78.
Il gatto non mangia. Gli trovo una marca che gli va bene, il giorno dopo non
gli piace già più. Niente. Mi tocca buttarla via mezza, la roba per il gatto. Provo a
spiegarglielo, che è un momento difficile. Oh, gli dico, non sei mica il gatto di
Barilla, cosa ti credi. Neanche una piega. Ha il iatto pieno di roba, viene in camera
a miagolare che ha fame. Paolo, Paolo, cosa ti è successo, che prima mangiavi con
appetito? Proprio adesso che ci sono le ristrettezze, ti metti a fare i capricci. È
inutile che fai i capricci, tanto Bassotuba non torna. Bassotuba ha trovato un altro
gatto, da starci insieme. Te, ti ha lasciato. È inutile che miagoli, dovevi pensarci
prima. Prima non le dicevi mai niente, sempre a cacciare le mosche. Non le facevi
mai le fusa. Te la sei cercata, caro il mio Paolo, adesso è tardi. Eh sì, ti tocca stare
con me. E stare con me, bisogna portare pazienza. Che vedrai che tra un po’ di
tempo, se mi van bene due o tre cose, altro che scatolette, che ti do da mangiare.
Emmental. Ricotta. Latte a fiumi. Ti compro anche la carne di topo, se vuoi. Però
devi portare pazienza, altro che Miao miao. Che io ci metto del tempo, a fare le
cose. Che io, all’inizio, faccio fatica ad abituarmi […]79.
Mentre Learco, per esempio:
[…] Non sei mica in un film, avrei dovuto dire. Non sei mica in un film, che
puoi usare le parole dei film. Invece non ho detto niente. Sarebbe stato meglio se
avessi detto Non sei mica in un film, vè. Che se eravamo in un film, io le sapevo
le cose da dirti. Io ti avrei detto, se eravamo in un film: Cristo, piccola, perché usi
sempre delle parole così dannatamente precise? E tu ti saresti girata e te ne saresti
andata, la gonna blu svolazzante, intorno alla gonna svolazzamenti di pezzetti di
carta bianca pulita che svolazzano nei film quando la protagonista femminile dice
Addio e il protagonista maschile dice Cristo, piccola, perché usi sempre delle
parole così dannatamente precise? e la protagonista femminile si gira e se ne va, la
gonna blu svolazzante e intorno alla gonna eccetera eccetera.
Ma tu, avrei dovuto dire, non sei mica vestita di blu. Se eri vestita di blu,
potevi anche essere in un film, invece sei vestita di nero, sei. Quindi non sei mica
77 Si vedano, per esempio, le prime pagine di Bassotuba non c’è, Milano, Feltrinelli, 2009. 78 Paolo Nori, Bassotuba non c’è, cit., p. 30. 79 Paolo Nori, Bassotuba non c’è, cit., p. 74.
40
in un film. Quindi non puoi parlare con le frasi di quelle dei film. Allora adesso ci
pensi. E cerchi di trovare una frase adeguata, se proprio vuoi andar via, avrei
dovuto dire. Che io, avrei dovuto dire, non discuto mica del fatto che vai via, no.
Ci mancherebbe che voglio parlare del fatto che vai via. Non sia mai. Solo: il
modo. Potresti dire, per esempio, avrei dovuto dire, Ti saluto. Ti saluto, avrei
dovuto dire, stempererebbe il dramma. Che a me mi sembra che per te è un po’ un
dramma andartene da questo appartamento. Sì, avrei dovuto dire. Dev’essere
proprio un dramma, per te. Soprattutto se consideriamo con chi vai a stare. Un
sociologo allievo di Vattimo.
Allora mi sa che sarebbe rimasta, Bassotuba80.
Learco è, sì, come dice Nori nell’intervista rilasciata alla Tommasoni:
[…] un personaggio che entra nel mondo ed è stupefatto da quello che si vede
intorno. Finita l’università ha deciso di provare a scrivere, a fare lo scrittore, di
uscire dagli ambienti chiusi come il mondo universitario o l’impresa, di evitare
queste due strade, non so come dire, ferrate, queste tramvie che gli si aprirebbero
davanti, e di andare incontro alle cose, per strada, nei bar, dove capita, senza
rotaie, allo stato brado, in un certo senso, e le cose che vede, anche quelle
minuscole, a lui fin da subito sembrano stupefacenti81.
Ma più che lo stupore per il mondo, che come vedremo e come dichiara
lo stesso Nori è presente anche in Ermanno Baistrocchi82, è quello “stato
brado” che caratterizza Learco e il suo modo di sentire, dunque di
funzionare: che, va detto, è un modo di sentire tipico di una certa fase della
vita e anche di una certa fascia d’età nonché in generale di un modus
vivendi proprio di quei periodi in cui succede che ti piombino addosso delle
cose (che sono e che no) senza però avere ancora la capacità di pensarle
compiutamente ed elaborarle. E, difatti, accade che Learco Ferrari – che è
oggi qualcosa di lontano – venga a un certo punto abbandonato. Complice
forse l’insistenza di molti nell’accostamento personaggio-autore, insistenza
80 Paolo Nori, Bassotuba non c’è, cit., pp. 22-23. 81 C. Tommasoni, cit., p. 104. 82 “Dopo l’incidente facevo le stesse cose di prima, sia nel lavoro che nella vita, ma erano cose alle quali
non ero più abituato, ed erano tutte un po’ stupefacenti, anche prendere un autobus (e, a pensarci, se in
ospedale mi avessero chiesto Cosa vuoi fare quando esci?, io avrei risposto Prendere un autobus). E come
Ermanno, il protagonista di questo libro, avevo l’impressione che quel che facevo tutti i giorni, dal
mattino quando mi svegliavo alla notte quando andavo a letto, fosse estremamente importante e mi
sbagliavo, perché io faccio una vita insignificante, ma era uno sbaglio che avrei voluto continuare a
sbagliarmi finché stavo al mondo” – dall’intervista, già citata, per Repubblica, come detto ripresa nel blog
di Nori (www.paolonori.it).
41
che toglie autonomia a entrambi, condannandoli a una fissità che è per
l’uno incapacità di essere personaggio perché sempre estensione di Nori e
per l’altro incapacità di slegarsi da quel personaggio, la cui voce risuona
ancora oggi. Complice l’impaccio generato dai pensieri e anche dalla stessa
voce di Learco che, come dice lo stesso Nori:
[…] è una voce che attira talmente tante attenzioni su di sé che l’attenzione
nei confronti della storia si sfarina. Per lo meno io non ci riesco, ho provato due o
tre volte, niente83.
E complice, infine, la necessità di trovare personaggi che di volta in
volta corrispondano come già detto a pensieri e modi di sentire84, figli degli
stessi “modelli di funzionamento” ma in balia dei cambiamenti propri di
ciascuno e di ciascuna vita. Come, d’altra parte, riconosce lo stesso Nori
quando dice:
Adesso, invece, più o meno è la stessa cosa, però con una differenza, forse, e
cioè che pian piano, crescendo, credo sia arrivata a prevalere la stupefazione per
se stessi. Io ho quasi cinquant’anni, e anche i protagonisti dei libri che scrivo
ormai hanno quasi cinquant’anni, qualcuno anche di più, e sia a me che a loro
succedono delle cose che non avrei, non avrebbero, mai detto85.
3.4. Delle voci oltre Learco (e di ciò che rimane)
Nella costruzione dei personaggi intervengono naturalmente esigenze
autoriali, come quelle espresse da Nori:
Dopo, mi sembra, negli ultimi due romanzi, di aver lavorato di più sulla
trama.
Nei primi libri, c’era una frase, e da lì saltava fuori il romanzo, senza nessuna idea
di trama a priori. Era come liberare un personaggio, con una sua voce, e mandarlo
a sbattere contro il mondo per vedere che direzioni prendeva. Questo mi piace
83 C. Tommasoni, Il progetto letterario di Paolo Nori, cit., p. 105. 84 Ricorrerà spesso quel “modi di sentire”, già apparso in precedenza, ma si potrebbe parlare di
apprensioni, percezioni, stati d’animo: vale insomma come sunto di tutto ciò che riguarda la relazione ‘fra
spirito e mondo’, soggetta per Nori come per tutti, ai cambiamenti che vita ed esperienze ti impongono. 85 C. Tommasoni, Il progetto letterario di Paolo Nori, cit., p. 105.
42
ancora, però sono anche sicuro, come dicevo prima, che uno possa fare tutto con
la scrittura, quindi non è che o si lavora con la trama o si lavora senza trama.
Certo è che quando si prova a lavorare sulla trama, come sto facendo io adesso,
dopo è difficile mettere tanta luce sulla voce del protagonista. […] Allora adesso
sto provando a lavorare su una voce un po’ meno vistosa e quando arrivano delle
voci forti come quella di Benito, bisogna trovare il modo di inserirle nella
macchina narrativa. Io ho cercato di costruirle attorno un romanzo, una cornice86.
Ma più che la trama, senza dubbio progressivamente più presente, mi
pare che la cornice venga fuori anche perché i personaggi del dopo-Learco
si mostrino maggiormente in grado, rispetto al primo alter ego, di prestare
attenzione e di ascoltare: emerge una curiosità nei confronti dell’altro e del
mondo che impone un’osservazione che tenga a bada quella tendenza alla
misantropia tipica di tutti i personaggi di Nori e che può vestire, come tale,
varie forme. Se Ermanno conduce da solo sia il proprio racconto sia quello
di Paride e, poi, di Cianuro come un investigatore alle prese con messaggi
criptati, indagini e misteri, il Bernardo di I malcontenti rifugge nelle storie
di Nina e Giovanni (ma non solo), osservandole con contegno e
discrezione, al più fungendo – come se il ruolo gli fosse stato attribuito – da
confidente:
Quella era una coppia, Giovanni e Nina, che, non si capisce il motivo, mi
avevano preso come confidente, forse perché non mi conoscevano. Non sapevano
che ero io, di solito, stupefatto dal mondo, a prender la gente come confidenti, a
telefonare di notte, e al mattino, ai miei amici, e alle mie amiche, e a chiedere
conto di come andavan le cose: Perché van così? Perché il tale con me si è
comportato in quel modo? Perché quell’altro non mi ha invitato a quell’altra cosa?
Gli ho fatto qualcosa di male? Mi son comportato male? O mi son comportato
bene? Dimmi che mi sono comportato bene, per cortesia.
Ma per loro, che non sapevano niente, di me, e che avevano una quindicina di
anni in meno, di me, io ero tutta un’altra cosa, ero una cosa bianca che la potevan
riempire di quel che volevano, e metterci dentro quel che volevano, come una
scatola grossa dove metti dentro tutto quello che non ci sta in casa87.
86 C. Tommasoni, Il progetto letterario di Paolo Nori, cit., pp. 104-105. 87 Paolo Nori, I malcontenti, cit., pp. 7-8.
43
Bernardo si sente come un contenitore entro cui buttare un po’ “tutte le
cose che non potevano stare di sopra, nel loro [appartamento]”, compresi
anche i malumori:
[…] i malumori che si sono installati nella tua vita, nel senso anche concreto,
del termine, in quella parte del corpo che si chiama vita che unisce tronco e gambe
dove uno ha l’impressione che si installino i malumori e dove uno sente, ma
chiaramente, quando si staccano, e volano via, come delle farfalle, io mi ricordo
chiaramente una volta, quando è successo, come delle farfalle, via, c’era una
donna e non c’era poi più, via88.
Malumori che Bernardo conosce e da cui non è esente ma che, non
trovando una scatola entro cui esser gettati e nemmeno un “centro
d’elaborazione”89, vengono costantemente silenziati – specie se vi è
possibilità di non essere da loro risucchiati ma si può fuggire altrove, in
altre vite – e risuonano di tanto in tanto, nella solitudine del protagonista:
[…] Ecco, per me, in quel periodo lì, avere una persona che quando mi
vedeva era contenta di vedermi, avere una persona che era contenta di vedermi
veramente, era per me la cosa più bella che mi potesse succedere. Ma a parte la
bambina di quattro anni, che con tutto che era la bambina di quattro anni viveva
da un’altra parte, in un altro mondo, in un’altra famiglia, con un altro ordine, con
degli altri colori, con delle altre idee, con delle altre abitudini, con un altro
dialetto, con un’altra alimentazione e con degli altri mezzi di locomozione, a parte
la bambina di quattro anni, io, se mi toglievano le telefonate e la radio si sarebbe
potuto dire tranquillamente che ero solo al mondo, e se qualche volta aprendo la
porta di casa sembrava che fossi di buonumore, dipendeva da una di quelle cose lì,
la bambina di quattro anni, il telefono, oppure la radio, ma era poi raro90.
Bernardo come personaggio in grado di esprimere, come gli altri, una
condizione. Bernardo che nel marasma emotivo da cui non riesce a liberarsi
– e in cui si inseriscono le difficoltà che incontra quando pensa di scrivere
un saggio sul padre Renzo – trova un po’ di respiro solo nella “fuga” e
nella bambina di quattro anni. Bernardo che, in qualche modo, mostra una
88 Paolo Nori, I malcontenti, cit., p. 8. 89 Come l’ipotetico “centro di elaborazione del lutto” che Bernardo si immagina: Paolo Nori, I
malcontenti, cit., p. 11. 90 Paolo Nori, I malcontenti, cit., p. 19.
44
maturità “affettiva” – forse anche relazionale91 – maggiore rispetto al
lontano Learco ma minore rispetto al successivo Ermanno Baistrocchi – e
che, per questo, ho scelto come punto intermedio fra i due. Perché se vi
sono esigenze propriamente autoriali, ciò che s’è detto in termini di
curiosità e propensione all’ascolto fa parte di un più ampio percorso
“emotivo” che sembra segnare il corpus di Nori e, conseguentemente, le
voci che in esso si muovono92. Ermanno Baistrocchi è, in questo senso, un
buon traguardo. È in lui che risuonano, come interiorizzate però, quelle
voci altre che tormentavano Learco, quelle voci che stavano nella sua testa
e che continuamente lo rimproveravano, lo assillavano; quelle voci che si
presentavano come tali ma anche nelle vesti dell’angelo Karmelo in
Bassotuba non c’è o di diavoli nell’omonimo Diavoli93:
[…] una certa bastiancontrarite, anche quella ero contento che non era
scomparsa e si faceva vedere anche quando ero da solo e c’eran delle mattine che
mi svegliavo e dopo che avevo apparecchiato il mio ufficio mi veniva da
chiedermi «Ma cosa vuoi scrivere? Ma chi ti credi di essere, a voler scrivere? Ma
non ti rendi conto che sei solo una merda?»94.
È Ermanno, poi, che trova una prima risposta possibile a quelle domande
che assillavano Bernardo riguardo l’essere buoni e l’essere invidiosi – se
per la prima può bastare anche il titolo, Siamo buoni se siamo buoni, a
proposito di invidia:
91 Se si pensa, per esempio, a quella vena polemica che Bernardo dice di aver imparato a tenere a bada o a
quel aspettare che passi “la voglia di sbattere la testa contro il muro” – Paolo Nori, I malcontenti, cit., p.
72. 92 E che conseguentemente condiziona la lingua, come aveva già riconosciuto in qualche modo D’Orazio
(cfr. M D’Orazio, Paolo Nori: uno stile “semplice”, cit., p. 65). Ne è un buon esempio anche la citazione
riportata in fondo al paragrafo – che, se scritta diversamente, probabilmente sarebbe risultata pur sempre
emozionale e emozionante ma meno ‘carica’ e forte, come invece è. 93 Quelle voci che ricordano molto anche le voci di Malerba, un autore che fa parte di quei “padri
emiliani” di Nori ma col quale ho l’impressione vi sia una relazione (a livello autoriale) un po’
“conflittuale”. 94 Paolo Nori, Siamo buoni se siamo buoni, cit., p. 76. Da questa citazione si evince per altro un altro
ritorno – assieme a quello dello “stupore per il mondo” – qui detto della “bastiancotrarite” ma
assimilabile a quella vena polemica, forte in Learco Ferrari e sempre tenuta a bada in Bernardo.
45
[…] ma sull’invidia mi sembrava di avere imparato due cose, primo, a
riconoscerla, l’invidia, e a dirmi: Ecco, stai attento che in questo momento ti ha
punto. Secondo, a ripetermi una frase, dentro la testa: E se un invidioso sapesse
come ci si sente bene a non esser più invidiosi, per invidia non sarebbe più
invidioso95.
Di più, è con lui che si dà maggior spazio e riconoscimento alle
emozioni e agli affetti, forse in virtù di quel nuovo stupore per le cose del
mondo, venuto a seguito dell’incidente96; uno spazio e un riconoscimento
che sono nuovi, che animano le pagine di questo romanzo con pensieri
dedicati ed espressi senza vergogna alcuna. Ed è qualcosa che avviene
proprio adesso, proprio nell’ultimo romanzo, e che diventa anche
comprensione di qualcosa che nell’Ermanno pre-incidente era ancora
incompiuto:
Ma il problema, secondo me, non era mica quello. Di problemi ce n’erano
tanti, per esempio il fatto che io avevo ancora un foglietto, appiccicato sopra
l’armadio, vecchio di ventidue anni, dove c’era un cuore, indaco, e intorno c’era
scritto: «Papà, ti volio». E ogni volta che lo guardavo mi veniva da ricordarmi
delle cose che forse sarebbe stato meglio non ricordarmele. Come io e Daguntaj,
in un bar, al Meloncello, le seggiole di fòrmica di quando ero piccolo, ci tenevamo
per mano, e aspettavamo che arrivasse il toast per Daguntaj e Daguntaj mi cantava
una canzone che aveva scritto lei e che diceva: «Non ti devi vergognare, l’amore è
una cosa normale»97.
E da qui, infine, è con lui che sembra essere portata a primo compimento
– fra le altre cose – l’elaborazione di un lutto: se, infatti, anche i personaggi
che lo hanno preceduto si sono confrontati più volte con l’argomento, è in
Ermanno che esso emerge senza vergogna, senza reticenza alcuna, come
prima presa di coscienza ed elaborazione di una perdita (quella di un padre)
che, più di tutte, è destinata a rimanere in qualche modo insoluta e con la
quale si può solo tentare di convivere; e più in generale è con lui che, nella
95 Paolo Nori, Siamo buoni se siamo buoni, cit., p. 84. 96 Ci si riferisce all’incidente che ha colpito Ermanno Baistrocchi che, come abbiamo visto quando si
parlava di analogie, coincide con quello avuto da Nori. 97 Paolo Nori, La banda del formaggio, cit., p. 19.
46
meraviglia dello stupore che caratterizza l’ultima opera e ricopre affetti e
cose del mondo, si scopre che è possibile vivere ricordi ed emozioni, che
non è facile ma è possibile, e che si può addirittura parlarne; che a molte
cose semplicemente si sopravvive – e magari vale la pena, allora, guardare
che succede e che è successo. Riporto quasi per intero il cosiddetto
“pezzetto sul sacro” che va a chiudere Siamo buoni se siamo buoni e col
quale, a oggi, Nori – tramite Ermanno – ci ha lasciato:
«Quello che manca nelle nostre, come dire, vite, si fa fatica anche a
pronunciarle, queste parole, La mia vita, per non parlare della morte, La mia
morte, La morte di mio babbo, e anche La morte, da sola, ti vien da pensare che
quello che manca, forse, a parte le autorità […] è la figura del sacro, ma non
quello che c’è dentro la testa, che lì ciascuno ha la propria testa, che per uno è la
patria, per uno è la famiglia, per uno è la legge, per uno è la libertà, per uno è Dio,
quanto spazio prende Dio, nei tuoi discorsi, tu non parli dei discorsi, parli delle
vite, dei nostri momenti, quando il mondo, si fa fatica a pronunciarla, questa
parola, Mondo, quando il mondo ti dà una botta, come se ti dicesse che esiste,
come se ti tirasse fuori dai tuoi pensieri, come se ti tirasse la giacca, se tu avessi
una giacca, e ti si manifestasse, nel senso che è lì, e c’era anche prima, e tu te l’eri
scordato, e ti accorgi che suona, il rumore delle sfere, che delle volte si va a
nascondere in cose minuscole, in momenti che non l’avresti mai detto, come
quando stendi il bucato, e poi esci e torni a casa e senti odore di sapone di
Marsiglia, o come quando hai un computer nuovo e stai caricando il programma
di scrittura, o come quando sei in giro, in centro, con tua figlia, e ti volti a vedere
se è dietro di te e la vedi e ti vien da pensare ‘Ma com’è bella’, o come quando
firmi un contratto di allacciamento del gas, o quando vedi che gli alberi sono
diversi e pensi ‘L’autunno ha cambiato il giardino’. Tutte le volte che ti svegli che
hai fame. Quando senti qualcuno che sta attento a quello che dice. Quando ti
rammendi le tasche della giacca. Quando si beve il primo vino dell’anno, hai
vent’anni, e sembra un succo di frutta, sì e no cinque gradi. Quando stai per
lasciare l’appartamento nel quale hai abitato tre anni, fai l’ultimo giro e trovi il
mozzicone di candela che avevi usato il primo giorno che c’eri entrato, che non ti
avevano ancora attaccato la corrente. Quando stai stendendo i panni e ti sorprendi
a cantare. Quando sei in giro, al mattino, per il centro, e tutti i posti in cui devi
andare sono ancora chiusi, e entri in un bar, e ti ci fermi mezz’ora, e ci trovi una
folla di pensionati che gira intorno ai quotidiani come i bambini, con la bella
stagione, intorno alle altalene dei giardini pubblici. Quando tuo babbo ti chiama
Ligera, hai tre anni, e tu pensi che voglia dire cravatta, e sei contento che tuo
babbo scherza con te. Quando esci da lavorare, hai sedici anni, hai fatto otto ore in
un prosciuttificio, e adesso vai a casa, e sei così contento che ti strapperesti i
capelli. Quando sei sulle spalle di tuo nonno, e fate una gara di corsa, e tu e tuo
nonno vincete, e tu eri il più piccolo e non vincevi mai. Quando su per una salita,
sull’Appennino, è notte, hai ventisei anni, sei a piedi, per mano a una ragazza, e
47
voltate l’angolo della strada e c’è un mare di lucciole, e non è normale, tutte
queste lucciole, dev’esser successo qualcosa. Quando tagli il pane, certe volte.
Quando sei da solo, e ti apparecchi. Quando parli e ti sembra di sentire la voce di
tuo babbo, che è morto da ventidue anni»98.
3.5. Un respiro e si conclude
Ti lascia un po’ così Ermanno Baistrocchi, senza respiro, quando dal
niente ti catapulta in quel pezzetto lì che si configura come un’esplosione
(a mio parere bellissima) di cose che prima sono state piuttosto sempre
trattenute e allo stesso tempo – mi verrebbe da dire – come una
dichiarazione esplicita di qualcosa che sembrerebbe sottendere l’intera
produzione di Nori e che sintetizzerei così: ‘non lascio mai niente e
nessuno indietro99’. Senza parlare di autobiografismo, abbiamo visto come
ogni cosa rimandi all’altra e come ogni personaggio non sia del tutto altro.
Dunque, superando per un attimo tutto ciò che risponde a precise intenzioni
autoriali di uno scrittore-regista com’è Nori, è inevitabile se si guarda
all’intera produzione dell’Autore avere la sensazione di trovarsi di fronte a
tanti Nori e anche, contemporaneamente, a uno stesso Nori che
semplicemente cambia, come tutti, il proprio atteggiamento nei confronti di
tutto ciò che è vita. Non si tratta cioè di indagare quanto vi sia di
autobiografico ma di constatare come, tramite una voce che è quella di Nori
e non può essere diversamente, si riproponga un’esplorazione del sé in
chiave nuova, diversa, attuale, lontana da intenti introspettivi o psicologisti:
98 Siamo buoni se siamo buoni, cit., pp. 213-215. 99 Un qualcosa che potrebbe ricondursi anche ai giri di frase e alle trottole sonore, così come a certe
presenze all’interno del testo: per esempio, quella bambina di quattro anni per Bernardo che si inserisce –
quasi a spezzare e tenere insieme – in una narrazione che dovrebbe essere altra (quella di Giovanni e
Nina, quella del festival dei Malcontenti).
48
l’esplorazione di un sé che vive, sente, vede, aspetta, soffre e che, come
tutti, è costretto a farlo anche quando fa “fatica a tenerci dietro”. Ciò che a
noi lettori è concesso è vedere dunque, tramite i suoi personaggi e tutte le
voci in gioco, nonché tramite i nostri occhi e le nostre di voci, quali e
quanti siano i “modelli di funzionamento” possibili – perlomeno secondo
l’esperienza dell’autore o ciò che di questa esperienza lo ha colpito. Ciò
che a noi lettori è richiesto, invece, mi pare sia simile a ciò che Bion indica
all’analista che si pone in ascolto del paziente:
Ho dato questo suggerimento: scarta la tua memoria, scarta il tempo futuro del
tuo desiderio; dimenticali entrambi, sia quello che sapevi sia quello che vuoi, in
modo da lasciare spazio ad una nuova idea. Forse sta fluttuando nella stanza in
cerca di dimora un pensiero, un’idea che nessuno reclama100.
Porci sempre “senza memoria” ossia non essere condizionati – nel nostro
caso – da un atteggiamento che cerca di inquadrare Nori, a ogni opera e a
ogni personaggio, attraverso il suo passato, personale o letterario; non fosse
altro che per rispondere a quella “necessità di orientarsi di nuovo nello
spazio e nel tempo101”. E anche perché forse, d’altra parte, è ciò che fa la
stessa voce nelle voci, quasi a portare avanti quell’eco pirandelliano:
Io non l'ho più questo bisogno, perché muoio ogni attimo, io, e rinasco nuovo
e senza ricordi: vivo e intero, non più in me, ma in ogni cosa fuori102.
100 C. Neri, A. Correale, P. Fadda, Letture Bioniane, Roma, Borla 1987, p. 252. 101 Da Nori (www.paolonori.it/questo-carico-di-gia-vissuto-e-gia-visto): “In fondo in ogni visitazione dei
luoghi portiamo con noi questo carico di già vissuto e già visto, ma lo sforzo che quotidianamente siamo
portati a compiere, è quello di ritrovare uno sguardo che cancella e dimentica l’abitudine: non tanto per
rivedere con occhi diversi, quanto per la necessità di orientarsi di nuovo nello spazio e nel tempo” (cfr. L.
Ghirri, Pensare per immagini, Milano, Electa 2013, p. 224). 102 L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila, cit., p. 225.
49
E non è facile, mi vien da dire, se ripreso fiato e lasciato Ermanno
Baistrocchi, viene quasi naturale cercare Bernardo per potergli dire, se
fosse possibile: ecco, così, il saggio su Renzo, secondo me, è perfetto.
51
Bibliografia
di Paolo Nori:
Le cose non sono le cose, Ravenna, Fernandel, 1999.
Bassotuba non c’è, Roma, DeriveApprodi, 1999; Milano, Feltrinelli, 2009 (edizione
utilizzata).
Spinoza, Torino, Einaudi, 2000.
Diavoli, Torino, Einaudi, 2001.
Si chiama Francesca, questo romanzo, Torino, Einaudi, 2002; Milano, Marcos y
Marcos, 2011 (edizione utilizzata).
Gli scarti, Milano, Feltrinelli, 2003.
Siam poi gente delicata, Bologna Parma: novanta chilometri, Roma-Bari, Laterza,
2007.
Pubblici discorsi, Macerata, Quodlibet, 2008.
I malcontenti, Torino, Einaudi, 2010.
La banda del formaggio, Milano, Marcos y Marcos, 2013.
Scuola elementare di scrittura emiliana per non frequentanti con esercizi svolti,
Mantova, Corraini, 2014.
Siamo buoni se siamo buoni, Milano, Marcos y Marcos, 2014.
Il blog di Paolo Nori (www.paolonori.it).
Bibliografia critica
M. Berretta, Il parlato italiano contemporaneo, in AA.VV., a cura di L. Serianni e P.
Trifone, Torino, Einaudi, 1994, Vol. II., pp. 239-270.
E. Calaresu, Quando lo scritto si finge parlato. La pressione del parlato nello scritto e i
generi scritti più esposti: il caso della narrativa, in AA.VV., Aspetti dell’italiano
contemporaneo, a cura di Klaus Holker, Munster, Lit Vergal, 2005.
R. Capozzi, Paolo Nori's chatting: novels about nothing, «Rivista di studi italiani»,
Anno XX, n° 1, Giugno 2002, pp. 237-260.
A. Cortellessa (a cura di), Narratori degli Anni Zero, Roma, Edizioni Ponte Sisto, 2011.
52
M. D'Orazio, Paolo Nori: uno stile “semplice”, tesi di laurea, Università di Parma, a. a.
2008/2009, relatore Paolo Briganti.
G. Genette, Palinsesti, Torino, Einaudi, 1997.
P. Lejeune, Il patto autobiografico, Bologna, Il Mulino, 1986, pp. 5-55.
L. Matt, Avventure e disavventure della lingua: la narrativa di Paolo Nori, in AA. VV.,
Lingua italiana d'Oggi, a cura di M. Arcangeli, Roma, Bulzoni Editore, 2005, vol. II,
pp. 113-141.
C. Segre, Intrecci di voci. La polifonia nella letteratura del Novecento, Torino, Einaudi,
1991, pp. 3-11.
C. Tomassoni, Il progetto letterario di Paolo Nori, tesi di laurea, Università di Bologna,
a. a. 2009/2010, relatori A. Bertoni e S. Colangelo.
su Nori online:
Altervista (http://isiti.altervista.org).
Booksblog (www.booksblog.it).
«Doppiozero» – www.doppiozero.com.
Youtube (www.youtube.com).
Wuz, il social dei libri (www.wuz.it).
Zanichelli, blog, sez. Dizionaripiù (www.zanichelli.com).
Altro:
A. Gianolio, Vite sbobinate e altre vite, Sassuolo, Incontri Editrice, 2007.
C. Neri, A. Correale, P. Fadda, Letture Bioniane, Roma, Edizioni Borla, 1987.
L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila, Garzanti Editore, Milano, 1993.
A. Puskin, Umili prose, traduzione e cura di Paolo Nori, Milano, Feltrinelli, 2006.
53
A mia nonna Gina che, per lei,
il fatto che io mi laurei
è una cosa grande, grandissima.
Ringraziamenti
Grazie anzitutto al professor Briganti, che mi ha presa per come sono, facendo i conti
con la mia “problematicità” ma senza mai abbandonarmi, e che, in estrema sintesi, ha
reso possibile tutto questo.
Grazie ai miei “professori per sempre”, Umberto e Fabrizio, che mi hanno rimesso in
piedi quando tutto questo era diventato qualcosa che pensavo quasi non potesse
succedere mai, ma mai, ma mai mai mai mai mai.
Grazie a mia madre, che si è stancata troppo ma mai abbastanza.
Grazie a mio fratello, che si è fatto forte e coraggioso per tutti.
Grazie alla mia famiglia, nel senso più stretto e più ampio del termine.
Grazie a tutti coloro che mi hanno incoraggiato, che hanno creduto in me quando non
ero più in grado di farlo e anche a quelli che hanno soltanto incrociato le dita.
Grazie ai compagni di questo viaggio che, seppur termina per ciascuno in tempi diversi,
non è mai in solitaria.
Grazie agli amici di sempre e anche a quelli di un po’, anche a quelli ogni tanto.
Soprattutto grazie alla “banda Tropicana”, a quelle amiche che con me hanno raccolto
tutti i pezzi e che ci sono sempre, ognuna a suo modo, ciascuna meravigliosamente.
E ciò che c’è di buono in questo ritardo è che posso dire quel che non avrei potuto:
quell’immenso grazie a Mattia, che mi ha fatto scoprire che l’amore è bello quando c’è.
Grazie anche a Ermanno e Paolo che, con quel pezzetto lì: ci sei dentro anche te, papà.
































































![16-enteghal va fibr nori [www wikipower ir]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63195d5dbc8291e22e0f1139/16-enteghal-va-fibr-nori-www-wikipower-ir.jpg)

![VOCI DAL PASSATO PER L’OGGI L’ANGELO [DEL SIGNORE] ALLA PISCINA DI BE¯THZATHA´/BE¯THESDA´ DI GERUSALEMME (GV 5,3B-4) E LA ‘GUERRA DEI SEI GIORNI’ (5-10 GIUGNO 1967)](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63452beb6cfb3d4064098ef6/voci-dal-passato-per-loggi-langelo-del-signore-alla-piscina-di-bethzathabethesda.jpg)