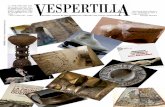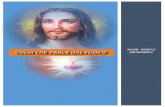Voci dal passato per l'oggi...
Transcript of Voci dal passato per l'oggi...
Marcello Del VerMe
VOCI DAL PASSATO PER L’OGGI: L’ANGELO[DEL SIGNORE] ALLA PISCINA DI BETHZATHÁ /
BETHESDÁ DI GERUSALEMME (GV 5,3B-4)E LA ‘GUERRA DEI SEI GIORNI’ (5-10 GIUGNO 1967)
ESTRATTO
da
NON SOLO VERSO ORIENTESTUDI SULL’EBRAISMO
IN ONORE DI PIER CESARE IOLY ZORATTINI
STORIA DELL’EBRAISMO IN ITALIASTUDI E TESTI XXX
Diretta da
PIER CESARE IOLY ZORATTINI
NON SOLO VERSO ORIENTESTUDI SULL’EBRAISMO
IN ONORE DIPIER CESARE IOLY ZORATTINI
I
a cura di
MADDALENA DEL BIANCO COTROZZI
RICCARDO DI SEGNI e MARCELLO MASSENZIO
con la collaborazione di
MARIA AMALIA D’ARONCO
FIRENZE
LEO S. OLSCHKI EDITOREMMXIV
STORIA DELL’EBRAISMO IN ITALIASTUDI E TESTI XXX
Diretta da
PIER CESARE IOLY ZORATTINI
NON SOLO VERSO ORIENTESTUDI SULL’EBRAISMO
IN ONORE DIPIER CESARE IOLY ZORATTINI
I
a cura di
MADDALENA DEL BIANCO COTROZZI
RICCARDO DI SEGNI e MARCELLO MASSENZIO
con la collaborazione di
MARIA AMALIA D’ARONCO
FIRENZE
LEO S. OLSCHKI EDITOREMMXIV
Tutti i diritti riservati
CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI
Viuzzo del Pozzetto, 8
50126 Firenze
www.olschki.it
Collana diretta daPIER CESARE IOLY ZORATTINI
Comitato scientifico
Roberto Bonfil (The Hebrew University, Jerusalem)Maddalena Del Bianco Cotrozzi (Universita di Udine)
Benjamin Ravid (Brandeis University, USA)Giuliano Tamani (Universita di Venezia)
VOLUME PUBBLICATO CON IL PATROCINIO E IL CONTRIBUTO DI
Universita degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Umane,Fondazione CRUP, Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia onlus,
Comunita Ebraica di Trieste, Comunita Ebraica di Padova,Comunita Ebraica di Ferrara, Igea e Gordon Hector - Londra,Associazione per lo Studio dell’Ebraismo delle Venezie - Udine
ISBN 978 88 222 6356 8
Comunita Ebraica di Padova
Comunita Ebraica di Trieste
Comunita Ebraica di Ferrara
INDICE
TOMO I
Presentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. IX
Non solo verso Oriente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » XI
Bibliografia di Pier Cesare Ioly Zorattini . . . . . . . . . . . . . . . . . » XVII
CHETRO DE CAROLIS, a PCIZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1
ANTICHITA E MEDIO EVO
SILVIA CASTELLI, Philo’s Legatio between rethoric and history: allu-sions to the Jews of Rome in Philo’s Embassy to Gaius . . . . » 5
MARIA AMALIA D’ARONCO, Giuditta eroina anglosassone . . . . . . » 19
MARCELLO DEL VERME, Voci dal passato per l’oggi: l’angelo [del Si-gnore] alla piscina di Bethzatha/Bethesda di Gerusalemme (Gv5,3b-4) e la ‘Guerra dei sei giorni’ (5-10 giugno 1967) . . . . . » 27
MICHELE LUZZATI z.l., Elia da Genazzano: la sua parentela e i quat-tro cognomi della famiglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 47
DANIELE NISSIM, Nomi ebraici e corrispondenti nomi locali a Pado-va nella seconda meta del XV secolo . . . . . . . . . . . . . . . . . » 69
ETA MODERNA
MICHELA ANDREATTA, Raccontare per persuadere: conversione enarrazione in Via della Fede di Giulio Morosini . . . . . . . . . » 85
BENJAMIN ARBEL, Notes on the Delmedigo of Candia . . . . . . . . » 119
STEFANO ARIETI, Amato Lusitano nella medicina del Cinquecento » 131
ELVIRA AZEVEDO MEA, Fermento de novas mentalidades: memoriasdas que saltaram tabus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 137
— 727 —
CARLA BOCCATO, Vicende giudiziarie di un ebreo di Venezia nel Set-tecento in due processi degli Ufficiali al Cattaver . . . . . . . . . Pag. 151
MADDALENA DEL BIANCO COTROZZI, Ancora su Samuel e AbramMorpurgo di Gradisca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 167
RICCARDO DI SEGNI, L’immersione rituale (tevila) e la tonsura nelprocedimento di riammissione dei convertiti: fonti e problemi » 179
CRISTIANA FACCHINI, Predicare nel ghetto. Riflessioni sulla predica-zione come performance rituale nel mondo ebraico di eta barocca » 187
LUCIA FRATTARELLI FISCHER, «Vivere nella sua Legge»: Phelipealias Philotheo Montalto da Firenze a Venezia, da Parigi ad Am-sterdam. Nuovi documenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 201
ANDREA GARDI, Vicini e lontani. Luigi Ferdinando Marsigli e gliEbrei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 227
LAURA GRAZIANI SECCHIERI, Gli Ebrei di Ferrara di fronte al terre-moto del 1570 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 245
PIETRO IOLY ZORATTINI, Carlo Antonio Maria Saverio Giuli aliasMariam, convertito presso la Pia Casa di Venezia nel secondoSettecento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 279
GERARD NAHON – MICHELE ESCAMILLA, Matines juives a Bayonneau XVIIe siecle au filtre du Saint Office . . . . . . . . . . . . . . . » 295
MARIA PIA PEDANI, Kira e sultane nel Cinquecento ottomano . . . » 345
MAURO PERANI, L’atto di morte del rabbino Sabbetay Mika’el Gine-si (1759) e il Registro dei verbali delle sedute consiliari. Un in-teressante esempio di incrocio delle fonti interne per la storia de-gli Ebrei di Lugo a meta Settecento . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 363
ADRIANO PROSPERI, Un ebreo gesuita: Gian Battista Romano aliasEliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 387
BENJAMIN RAVID, A Moneylender (1592) and a Ghetto (1777-78):New Light on Venetian Spalato and its Jews . . . . . . . . . . . . » 395
MYRIAM SILVERA, Un midrash, due interpretazioni: la pluralita deimondi per Mose Maimonide e per Isaac Abravanel . . . . . . . . » 417
GIULIANO TAMANI, Il commento di Semu’el ha-Kohen da Pisa al ca-pitolo terzo di Qohelet (Venezia 1640) . . . . . . . . . . . . . . . . » 431
ANDREA ZANNINI, Nazionalita, religione e commercio a Venezia agliinizi del Seicento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 443
INDICE
— 728 —
TOMO II
ETA CONTEMPORANEA
ELIA BOCCARA, Elitarismo, Israelitismo, e Neo-Marranesimo tra gliEbrei portoghesi di Tunisi: l’esempio della famiglia Valensi . . Pag. 459
ANTONIO DANIELE, La poesia di Primo Levi . . . . . . . . . . . . . . » 489
EMANUELE D’ANTONIO, Graziadio Isaia Ascoli e l’antisemitismo diCesare Lombroso. Una critica epistolare . . . . . . . . . . . . . . . » 503
BRUNO DI PORTO, Per un profilo culturale di Raffaele Ottolenghi.Contributo su aspetti di fondo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 519
GIOVANNI LUIGI FONTANA, La Scuola ‘Ottorino Tombolan Fava’ ele origini del distretto calzaturiero della Riviera del Brenta(1923-1943) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 535
FELICE ISRAEL, Studi su Filosseno Luzzatto II: i rapporti familiaridalla fanciullezza alla maturita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 547
GADI LUZZATTO VOGHERA, Ripensare Jules Isaac: a cinquant’annidalla morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 559
JOHN TEDESCHI, A harbinger of Mussolini’s Racist Laws: the case ofMario Castelnuovo-Tedesco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 569
IDA ZATELLI, Graziadio Isaia Ascoli e il IV Congresso Internaziona-le degli Orientalisti a Firenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 587
TEORIA E STORIOGRAFIA
LUCA ARCARI, La comparazione come metodo di selezione ‘cristiano-centrica’ in Wilhelm Bousset. La ‘sostanziale differenza’ del giu-daismo nel comparativismo storico-religioso tra Ottocento e No-vecento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 597
PIER ANGELO CAROZZI, «Quanto e difficile dire mito...». Una lette-ra storico-esegetica di Salvatore Minocchi a Uberto Pestalozza » 623
MARCELLO MASSENZIO, Etnologia e teoria della religione. I contri-buti di Emile Durkheim, Sigmund Freud, Rudolf Otto . . . . . » 641
RENATO ONIGA, Le Pagine ebraiche di Arnaldo Momigliano . . . » 655
FULVIO SALIMBENI, Tra storia e letteratura. A proposito di un’anto-logia di scrittori ebrei italiani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 671
INDICE
— 729 —
INDICI
Indice degli autori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 683
Indice dei nomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 701
Indice dei luoghi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 721
INDICE
— 730 —
MARCELLO DEL VERME
VOCI DAL PASSATO PER L’OGGI
L’ANGELO [DEL SIGNORE] ALLA PISCINA DI BETHZATHA/BETHESDADI GERUSALEMME (GV 5,3B-4) E LA ‘GUERRA DEI SEI GIORNI’
(5-10 GIUGNO 1967)
1. ‘DUE ANGELI’
A ‘due angeli’, uno della vita e l’altro della morte, pensavo e, in immagine,quasi li vedevo tanti anni fa,1 rifacendomi direttamente ma non esclusivamen-te alla Bibbia (ebraica e cristiana).2 E a quell’immagine ritorno facendone l’og-
1 Ero a Gerusalemme per motivi di studio con altri colleghi e amici, tutti stranieri occidentali:due italiani, un polacco, un maltese e altri dalle Americhe. In tutto quindici studenti. Risiedevamoinsieme ai professori – un’equipe internazionale di qualificati docenti (esegeti, storici e archeologi)– nello stesso College, nella zona araba della Citta vecchia di Gerusalemme, ‘citta santa’ per le trereligioni monoteistiche e abramitiche (Ebraismo, Cristianesimo e Islam). La zona araba di Gerusa-lemme, la Cisgiordania e buona parte del deserto del Negev a Sud fino ad Aqaba era sotto il pro-tettorato dell’Hashemite Kingdom of Jordan. Tutto quel territorio oggi fa parte dello Stato di Israelea seguito della distruttiva ‘Guerra [di conquista secondo alcuni e/o di liberazione secondo altri] deisei giorni’. Il mio/nostro periodo gerosolimitano, della durata per la maggior parte di noi poco menodi un anno (dal luglio 1966 al giugno 1967), fu bello e arricchente, ma sul finire divenne drammatico,a dir poco. Prima della ‘Guerra dei sei giorni’, ci si spostava indisturbati in tutta l’area della citta e neiterritori confinanti, Giordania e Israele. Bastava, infatti, esibire semplicemente un permit al check-point della ‘Porta di Mandelbaum’. Con relativa liberta facevamo le nostre escursioni geografichee archeologiche con le visite guidate ai villaggi e alle cittadine arabe e israeliane. Cio contribuivaad arricchire le nostre conoscenze sperimentando on the spot e ravvicinate due culture (quella arabae quella ebraico-israeliana), anzi tre perche – come cultori di scienze bibliche e archeologiche – era-vamo particolarmente interessati al mondo-ambiente (cultura) ‘beduino’, del deserto e delle zone li-mitrofe, non privo di valori e portatore di tradizioni e usanze importanti e utili per interpretare al-cune antiche tradizioni bibliche e coraniche. Dopo la guerra si passo, invece, da un clima politico-territoriale di quasi ‘pacifica convivenza’ a una situazione di aperta ostilita, ‘divisioni e reciproci so-spetti’ tra Arabi/Palestinesi e Israeliani. Consequenzialmente, controlli negli spostamenti in citta edifficolta/impossibilita di muoversi sul territorio anche per noi studenti stranieri.
2 In particolare, dall’Apocalisse di Giovanni e dai Manoscritti di Qumran. L’Apocalisse, un te-sto protocristiano che va letto con discernimento, perche e la ‘rivelazione di cose nuove’ in un lin-guaggio che si rifa al ‘Primo Testamento’ (AT) e lo rilegge alla luce del Secondo (NT). Non c’e dascambiare l’aggettivo ‘apocalittico’ come sinonimo di ‘terribile, atroce, catastrofico’, come avvienenel G. DEVOTO – G.C. OLI, Vocabolario della lingua italiana, Milano, CDE s.d. La cosa fu giusta-
— 27 —
getto di questo contributo in omaggio allo stimato collega Pier Cesare che var-ca la soglia dei settanta anni.
Sullo sfondo di una contrapposizione tra ‘due angeli’, rivivo due realta: laprima, di salvezza; la seconda, di morte. Un esame, cioe, di due fatti distan-tissimi tra loro, quasi duemila anni (ca. 28-30 e.v., l’episodio di Gv 5, 1-9a;e la ‘Guerra dei sei giorni’ del giugno 1967), che mi fanno riflettere anchesul valore/senso della storia intesa come una reale (intendo, vera) magistra vi-tae.3 Ovviamente, nella prospettiva di una ricerca che non sia disattenta aglieventi/accadimenti passati (positivi o negativi che siano stati), ma prova a ri-leggerli e a ripensarli.
Conseguentemente, gli eventi del passato e quelli piu recenti possono con-durre a due opposte considerazioni: i fatti, quelli ‘salvifici’, potrebbero (do-vrebbero?) orientare lo studioso in generale e lo storico in particolare a desi-derare che essi non si ripetano; quelli ‘mortiferi’, da tutti (o quasi tutti)condannati, inviterebbero lo storico e ogni ricercatore piu in generale a dare
mente notata alcuni anni fa da un fine e colto esegeta del NT, poco prima di lasciarci (r.i.p.): M.ADINOLFI, Apocalisse. Testo, simboli e visioni, Casale Monferrato (Al), Piemme 2001, p. 9. Nei ma-noscritti di Qumran, il termine $al~ e molto frequente: ricorre ca. 50 volte senza contare la quantitaconsiderevole di sinonimi alternativi a $al~. Inoltre, nei manoscritti alcuni angeli sono chiamati pernome; e soprattutto va sottolineato che per gli Esseni-qumranici gli angeli sono creature che vivonodisposti in due distinte regioni, conformemente al dualismo che connotava la Weltanschauung delgruppo. Ossia la ‘sfera di Belial’ (mal’ak mast
˙ema, ‘l’angelo dell’inimicizia’ e il suo seguito, ‘angeli
della perdizione’ o ‘angeli della tenebra’) viene contrapposta alla ‘sfera di Dio’ (gli ‘angeli della san-tita’ o ‘angeli della sua [di Dio] verita’ o ‘angeli della luce della sua gloria’). Dell’angelo e/o degliangeli come messaggero/i umano/i o divino/i e portatori di salvezza o di catastrofi, e ricolma la Bib-bia, letta nel piu ampio contesto/ambiente del Vicino Oriente antico (semitico e/o ebraico-giudaico,greco classico ed ellenistico-romano), e non solo. Rinviamo per questo al lemma a> cceko|, in GrandeLessico del Nuovo Testamento, ed. it. a cura di F. Montagnini e G. Scarpat, I, Brescia, Paideia 1965(ed. orig. Stuttgart, W. Kohlhammer Verlag 1933), coll. 193-230, con richiami sia alla grecita classicae all’Ellenismo (W. GRUNDMANN, ivi, coll. 195-202), sia all’AT (G. VON RAD, ivi, coll. 202-213), alGiudaismo (G. KITTEL, ivi, coll. 213-219), sia al NT, alla Cristianita primitiva e qualche accennoal rabbinismo (ivi, coll. 219-230). Piu aggiornata e completa nei riferimenti testuali, correttamenteinseriti nel piu ampio contesto del Vicino Oriente antico (Ugarit, gli Aramei, la Mesopotamia, la Fe-nicia) e con richiami puntuali ai messaggeri umani (messi personali o legati politici [al sing. o alplur.]), ai messaggeri di Dio (in senso generale, i profeti, i sacerdoti e il mal’ak yahwh/mal’ak ’elo-hı7m) e ai manoscritti di Qumran, rinviamo alla voce $al~ (mal’ak) di D.N. FREEDMAN – B.E. WIL-
LOUGHBY – H.-J. FABRY, in Grande Lessico dell’Antico Testamento, ed. it. a cura di P.G. Borbone, V,Brescia, Paideia 2005 (ed. orig. Stuttgart, W. Kohlhammer 1984.1986), coll. 51-71.
3 Pace Corrado dr. Augias che nella conduzione di una popolare trasmissione (Le Storie - diarioitaliano) a TV3 il 28 maggio 2013, presentando il volume di G.M. BARBUTO, Machiavelli, all’insegnadel motto «tra le volpi e i leoni», definiva, ritengo con frettolosita e, forse, anche un pizzico di sup-ponenza (pardon!), la storia ‘maestra della vita’ come una ‘balla’ (del passato e del presente). Questasua posizione (e di altri), se non ulteriormente spiegata, rivela – a mio avviso – un agnosticismo e/ostoricismo alquanto diffusi, ma che dovrebbero essere meglio giustificati. In tal senso, ci piace rin-viare il/i lettore/i a una recentissima lezione (lunedı 1 luglio 2013, ore 16.00) tenuta dal prof. AntonioGargano all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ([email protected]) di Napoli su‘Emile Durkheim, l’ambigua sopravvivenza del positivismo’.
MARCELLO DEL VERME
— 28 —
una lettura dei fatti, certo non moralistica, che sia attenta anche ai valori vei-colati dai testi. E cio ‘disvela’, o dovrebbe almeno agevolare, l’intenzione degliautori e il/i significato/i che gli autori hanno inteso depositare nei testi (fatti eparole), pensando, forse, a parte i contemporanei anche ai futuri lettori. An-che a noi? La cosa non (mi) sembra del tutto ipotetica ne puramente imma-ginaria.
2. ‘ANGELO DELLA VITA’
Si narra nell’Evangelo di Giovanni,4 redatto verso la fine del I sec. d. C. senon prima: 5 «A Gerusalemme, presso la porta delle Pecore, vi e una piscina,chiamata in ebraico Bethzatha,6 con cinque portici (>Ersim de+ e$ m soi&| <Ieqoro-
4 Per la traduzione del NT e della Bibbia in generale, seguiamo La Bibbia di Gerusalemme, Bo-logna, EDB 2009. Si fa presente, pero, che nella pericope di Gv 5, 1-9a noi includiamo anche ivv. 3b-4, contra la traduzione appena citata, che segue altre edizioni critiche del NT. Espungonoquesti vv., ritenendoli come una glossa, la maggioranza degli studiosi, dai quali noi – insieme a (po-chi) altri – ci distanziamo. Torneremo su questo nel punto seguente.
5 Cosı J.H. CHARLESWORTH, The Priority of John? Reflections on the Essenes and the First Edi-tion of John, in Fur und wider die Prioritat des Johannesevangeliums. Symposium in Salzburg am 10.Marz 2000, mit Beitragen von Paul N. Anderson et alii, hrsg. von P. Leander Hofrichter, Hildes-heim-Zurich-New York, Georg Olms Verlag 2002, pp. 73-114. Tra le sue molteplici e condivisibili(a nostro avviso) argomentazioni, che studiano cinque aree: critica testuale, storia della composi-zione, relazioni ‘intracanoniche’ di Gv, storia delle religioni e archeologia, l’A. approfondisce anchel’episodio del paralitico, narrato da Gv 5, 1-9 ss., ponendo particolare attenzione ai realia e ritrova-menti in loco, cioe nella piscina di Bethesda (Bethzata) [sic]. Cfr. specialmente le pp. 80-82 e la Con-clusione (pp. 113-114). Questa posizione del collega e amico Jim non si riferisce alla ‘redazione fi-nale’ di Gv (anche lui pensa alla data ca. 95 e.v.) ma a una ‘prima edizione’ del quarto vangelo,molto probabilmente dello stesso autore. Su questa linea, l’indipendenza cioe di Giovanni dai Sinot-tici (Mc, Mt e Lc), si sono schierati, negli ultimi decenni, diversi studiosi ed esegeti del NT («Moreand more scholars now are reporting that their research indicates that John, at least the first edition,was composed independently of the Sinoptics» [ivi, p. 79]).
6 «Piscina probatica» e il nome che la Vulgata da al luogo dove Gesu guarı il paralitico infermoda trentotto anni. Molto probabilmente il nome ‘probatica’ – dovuto a uno svarione originato dalfatto che la piscina sorgeva nell’angolo nord-est di Gerusalemme vicino alla ‘Porta delle Pecore’(cfr. Ne 3,1.32; 12,39) – e da scartare. In realta, il/i nome/i e la scelta del nome della piscina sonopiu problematici. Ad es., per Armando Rolla (e la maggioranza degli studiosi) la piscina si chiamavain ebraico Bet hesda’ (= casa della misericordia), in greco bgherda* (cfr. A. ROLLA, Piscina probatica, inEnciclopedia della Bibbia, Torino, LDC 1971 [ed. or. Enciclopedia de la Biblia, Barcelona, EdicionesGarriga 1967], V, pp. 784-785); ID., Scavi archeologici a Gerusalemme nell’ultimo ventennio [1958-1978], in Gerusalemme. Atti della XXVI Settimana Biblica dell’A.B.I. in onore di C. M. Martini, acura di M. Borrmans et alii, Brescia, Paideia 1982, pp. 131-142 [spec. p. 142]). Alla stessa conclu-sione – ma con sfumature diverse e documentazione piu ampia – giunge anche M. KUCHLER (Die‘‘Probatische’’ und Betesda mit den funf STOAI [Joh 5,2], in Peregrina Curiositas. Eine Reise durchden orbis antiquus. Zu Ehren von Dirk Van Damme, a cura di A. Kessler et alii, Freiburg(Schweiz)-Gottingen, Vandenhoeck & Ruprecht 1994, p. 127, nota 1). Come abbiamo cercato di di-mostrare in un precedente lungo contributo (cfr. M. DEL VERME, La citta di Gerusalemme come polosoteriologico. Religioni di salvezza a Bethzatha/Bethesda [Gv 5,1-9], «Studi e Materiali di Storia delle
VOCI DAL PASSATO PER L’OGGI
— 29 —
kt* loi| e$pi+ sz& pqobasijz& joktlbg* hqa, g< e$pikecole*mg <Ebai] rsi+ bgherda* , pe*mse rsoa+ |
e>votra) (5,2), sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppie paralitici (v. 3), che aspettavano il moto dell’acqua» (oppure «che l’angelodel Signore si lavava» nella piscina) (vv. 3b). «Un angelo infatti in certi mo-menti scendeva nella piscina e agitava l’acqua; il primo a entrarvi dopo l’agi-tazione dell’acqua guariva da qualsiasi malattia fosse affetto» (v. 4). E qui, allapiscina di Bethzatha/Bethesda, Giovanni ambienta il caso di «un uomo (para-litico) – accompagnato forse la da parenti o amici, ma l’evangelista non lo pre-cisa – che da trentotto anni era malato» (v. 5). Stranamente, e per sua disav-ventura, il paralitico e abbandonato a se stesso sotto i portici in compagniadegli altri infermi. Tutti erano a conoscenza e sapevano da lunga data che l’an-gelo [del Signore], agitando l’acqua della piscina, poteva apportare loro laguarigione e l’attendevano speranzosi. Ma la guarigione scattava soltantoper chi si fosse immerso per primo nella vasca. ‘Quella volta’,7 il paralitico
Religioni», LXXV, 2009, pp. 145-198, qui nota 1, pp. 145-147) i probabili nomi per la piscina – allaluce delle testimonianze papiracee e dei piu antichi codici (e versioni) del NT – si riducono a tre: 1.bghrsai]da* (= luogo della pesca), attestato sia dai papiri P66 (ca. 200 d.C.) e P75 (inizio III sec. d.C.) siadal codice Vaticano (in sigla B [03] del IV sec. d.C.); 2. bgherda* (e termini simili), testimoniato dalcodice maiuscolo alessandrino (in sigla A [02] del V sec. d.C.) e dalla maggioranza dei codici. Questonome, a motivo delle attestazioni siriache, dipende probabilmente dall’aramaico Bet hesda’ (= casadella [divina] misericordia/grazia); 3. bg(h)faha* del codice onciale Sinaitico del IV sec., in sigla S se-condo la nomenclatura di A. Merk). Il nome, che significa «luogo dell’olivo», deriva dall’aramaicoBet zaita’, e designa la zona/quartiere a nord della citta di Gerusalemme, chiamato bgfeha* , che furicostruito nel I sec. d.C. cambiando nome in jaimo* poki| (= citta nuova), come ricorda Flavio Giu-seppe (bell. V, 151). Noi preferiamo la denominazione bg(h)faha* (infra, nota 13; e ulteriori motiva-zioni in DEL VERME, La citta di Gerusalemme cit., pp. 145-147, nota 1).
7 «Dopo questi fatti ricorreva una (opp. la) festa dei Giudei e Gesu salı a Gerusalemme (Lesa+
sat& sa g’ m [g< ] e<oqsg+ sx& m <Iotdai*xm jai+ a$ me*bg <Igrot& | ei$| <Ieqoro$ ktla)» (v. 1). L’evangelista Giovanni non pre-cisa a quale delle cinque principali feste giudaiche egli faccia riferimento. Sia che si accetti la lectio g<
e<oqsg+ ‘la festa’, cioe con l’articolo – che «prima era considerata spesso e volentieri come lectio difficilior[perche] e attestata da S C L D P W k al. co Tat 33 Origpt Cyr.», sia che si preferisca «la lezione senzaarticolo, contenuta nelle copie principali del testo alessandrino e che adesso ha il sostegno di P66.75 eanche di D K H 0125 u al. Epiphan, Kr, la quale, secondo alcuni, si deve ritenere come la migliore dalpunto di vista della critica testuale e per antichita ed ampiezza di tradizione» (cfr. Il vangelo di Gio-vanni. Parte seconda... Commento di Rudolf Schnackenburg, Brescia, Paideia 1977 [ed. or., Freiburgim Breisgau, Verlag Herder 1971], «Commentario Teologico del Nuovo Testamento», IV/2, p. 165),non si deve pensare alla festa di Pasqua. E piu probabile (cosı anche Schnackenburg, ivi, p. 166)che Giovanni alluda alla festa della Pentecoste, che nella tradizione giudaica ricordava il dono dellaTorah a Mose per il popolo. Anche a Qumran, per la Pentecoste o ‘Festa delle settimane’, si celebravala rinnovazione annuale del patto di alleanza tra Jahweh e il suo popolo (qui, la ‘comunita della nuovaalleanza’ che si sostituisce e/o rappresenta il [resto o santa radice del] popolo). A proposito di questa‘significativa (nuova)’ terminologia per indicare i covenanters (i ‘comunitari’) che vivevano sullasponda nord-occidentale del Mar Morto, cfr. M. DEL VERME, Comunione e condivisione dei beni.Chiesa primitiva e giudaismo esseno-qumranico a confronto, Brescia, Morcelliana 1977. A nostro avviso– insieme a pochi altri studiosi [ma noi proponevamo questa denominazione gia negli anni ’70 delloscorso secolo] –, questa comunita giudaica va intesa non come ‘Esseni tout court’ ma in senso specificocome un ‘gruppo particolare’ di Esseni. Di qui la nostra scelta del sostantivo ‘Esseni-qumraniti’ e del-
MARCELLO DEL VERME
— 30 —
trentottenne giovanneo – a differenza di tante altre volte che era venuto allapiscina e non aveva avuto/trovato alcuno che lo aiutasse a calarsi nella vasca –e suo malgrado, sempre un altro lo aveva preceduto quando l’acqua si agitava– si affido a Gesu per aiuto. Quale aiuto? Che gli desse una mano per calarsiprima degli altri nella piscina appena l’acqua si agitava (v. 7) ed essere guarito.Gesu passa subito all’azione: «Gesu vedendolo giacere e sapendo che da mol-to tempo era cosı, gli disse: ‘‘Vuoi guarire?’’» (v. 6b). Il fatto nuovo e inattesoe che il paralitico non ottiene l’aiuto fisico per immergersi, ma «Gesu gli disse:‘‘Alzati, prendi la tua barella e cammina’’. All’istante quell’uomo guarı: presela sua barella e comincio a camminare» (vv. 8-9a). Per di piu «quel giorno eraun sabato» (v. 9b).8
Fu quello un evento particolare, un ‘segno’ (gr. rglei& om) che fa luce – co-me avviene altrove nel Vangelo di Giovanni 9 – sulla sua teologia redazionale,che presenta Gesu come ‘il salvatore’. In questa circostanza, Gesu e visto co-me l’agente umano-divino che subentra all’ ‘angelo che guariva’ scendendo e/oagitando l’acqua della piscina. Si noti, poi, che la cosa avviene in un luogo do-ve la tradizione popolare ebraica 10 – cosı sembra – assegnava gia all’acqua un
l’aggettivo ‘esseno-qumranico’. Gli Esseni, infatti, come ricorda Flavio Giuseppe, erano presenti intutta la Giudea. Tra gli innumerevoli studi riguardanti la composizione di questa comunita, a partiredal 1947/1948, ne citiamo soltanto uno: S. TALMON, The Community of the Renewed Covenant: Bet-ween Judaism and Christianity, in The Community of the Renewed Covenant: The Notre Dame Sympo-sium on the Dead Sea Scrolls (1993), a cura di E.C. Ulrich and J.C. Vanderkam, Notre Dame IN,University of Notre Dame Press 1994, pp. 3-24. Desidero ringraziare – ancora oggi – l’amico e mae-stro prof. Talmon (r.i.p.), che molti anni fa mi arricchı – in un primo incontro a Gerusalemme ma neseguirono altri – della sua dottrina e con studi ‘pionieristici’ su Qumran. Ne conservo vivo il ricordo,tra i ‘momenti piu belli’ delle mie ‘salite’ a Gerusalemme.
8 l richiamo al sabato, nota giustamente Schnackenburg, diventa «il punto di congiunzione coni successivi sviluppi, quali li espone l’evangelista» («Commentario Teologico cit., p. 169). Nella peri-cope che segue l’episodio della guarigione (vv. 10-18) c’e l’interludio della richiesta ‘sospettosa’ deifarisei al paralitico guarito su «Chi e l’uomo che ti ha detto: ‘‘Prendi la tua barella e cammina’’». Ilmiracolato al momento non lo sapeva, ma lo comprese «poco dopo [quando] Gesu lo trovo nel tem-pio e gli disse: ‘‘Ecco: sei guarito! Non peccare piu, perche non ti accada qualcosa di peggio’’» (v.14). Segue l’attestazione (si direbbe la ‘missione’) del paralitico ai Giudei, per dire loro che era statoGesu a guarirlo. E in un giorno di sabato! Sara stato questo anche il commento ‘scandalizzato’ dialcuni Giudei, che scatenarono l’azione persecutoria verso Gesu (v. 16). Lo scandalo/sdegno fari-saico contro Gesu costituisce per lui l’occasione – certo nella visione e redazione giovannea – perpronunciare uno dei discorsi piu densi della sua attivita pubblica: presentarsi come ‘il Figlio inviatodal Padre’ (vv. 19-44). A conclusione del suo discorso Gesu richiama la personalita di Mose e la forzadelle divine Scritture. Si dispongono in parallelo i «suoi [di Mose] scritti» e le «mie [di Gesu] pa-role». Cio viene a confermare la nostra (insieme a pochi altri esegeti, cfr. precedente nota 7) convin-zione che il lemma generico «una festa dei Giudei» (i.e. e<oqsg+ , non g< e<oqsg+ sx& m <Iotdai*xm del v. 1) e daprendere come un sabato nel quale ricorreva la festa ebraica di Pentecoste.
9 Cfr. l’esaustiva Appendix III: Signs and Works di R.E. BROWN, The Gospel according to John, I-XII, translated with an introduction and notes, Garden City NY, Doubleday & Company 1966(«The Anchor Bible» 29), pp. 525-532 con bibliografia.
10 La quale aiuta a inquadrare piu realisticamente e a interpretare meglio l’episodio di guari-
VOCI DAL PASSATO PER L’OGGI
— 31 —
potere terapeutico particolare. L’angelo e l’acqua della piscina di Bethzatha/Bethesda (Gv 5,1-9a) sono presentati in diade, fonte/i cioe di salute e di gua-rigione, cosı come avveniva per altri luoghi di Gerusalemme.11 E anche altro-
gione narrato da Giovanni. Facciamo appello a questa religiosita anche perche essa – ci sembra – nonsia stata finora adeguatamente presa in considerazione ne utilizzata dagli esegeti per determinare ilvalore contestuale di Gv 5, 1-9a. Si trattava, forse, di una religiosita che mediava tra il rigoroso mo-noteismo ufficiale ebraico e le divinita/religioni di salvezza pagane, molto diffuse nel mondo/am-biente ellenistico-romano senza escludere la Giudea (cfr. M. HENGEL, Giudaismo ed ellenismo. Studisul loro incontro, con particolare riguardo per la Palestina sino alla meta del II secolo a.C., a cura diS. Monaco, red. e indici di O. Ianovitz, Brescia, Paideia 2001[ed. or. Tubingen, Mohr, 19883]). Comesi vedra, a Gerusalemme – con certezza al tempo di Aelia Capitolina (132-135 e.v.) se non prima –negli scavi eseguiti a Bethzatha e attestata la presenza di un culto guaritore serapideo e/o asclepiadeo.Aelia Capitolina potrebbe o aver continuato riti guaritori (pagani?) gia attivi a Bethzatha o, piu ve-rosimilmente, avra trasformato il posto in un culto pagano esclusivo, un luogo che gia la precedentefede popolare israelitica riteneva terapeutico (cosı pp. 311-316 E. TESTA, La Piscina Probatica, «LaTerra Santa», XL, 1964). Il culto di Serapide al tempo di Aelia Capitolina e ben documentato ancheda monete. Secondo per importanza solo a quello della dea Fortuna, il culto serapideo era attivo aGerusalemme fin dal 115 e.v., come documenta una iscrizione trovata alla Porta di Sion: una legioneromana invoca il dio Serapide, cfr. H.M. COTTON et alii, Corpus Inscriptionum Iudeae/Palestinae, Vo-lume I: Jerusalem, Part 2: 715-1120, Berlin-Boston, De Gruyter 2012, pp. 1-2 (= n. 705). Oltre alculto principale di Giove Capitolino, le monete registrano altre divinita: Bacco, Serapide, Astartee i Dioscuri. Ulteriori notizie (riportate da Eusebio e da Girolamo) circa i culti pagani nell’area ge-rosolimitana ricordano rispettivamente le dee Afrodite (Astarte) e/o Venere, cfr. E. SCHURER, TheHistory of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B.C.-A.D. 135), A New English Versionrevised and edited by G. Vermes & F. Millar, Edinburgh, T. & T. Clark 1973, I, pp. 553-557, spec.554 sg. Per un elenco delle monete e altri manufatti attestanti il culto serapideo a Bethzatha/Bethesda,rinviamo alla Table des planches di A. DUPREZ, Jesus et les dieux guerisseurs. A propos de Jean, V, Pa-ris, Gabalda, 1970, p. 180, pl. XVII-XXII; e per una rassegna numismatica piu completa, che illustri lasituazione di Aelia Capitolina, si veda A. SPIJKERMAN, A Supplemental Study of the Coinage of AeliaCapitolina, «Liber Annuus», VII, 1956-1957, pp. 145-164.
11 La quantita di bagni e di vasche a Gerusalemme e dintorni, come la piscina di Bethzatha anord-est della citta vecchia e quella di Siloe, situata a Silwan nella periferia orientale, documentanol’uso dell’acqua da parte degli Ebrei non soltanto per scopi alimentari e igienico-sanitari, ma ancheper le purificazioni rituali (miqwa’ot) e per cercare la guarigione dalle infermita attraverso l’immer-sione nell’acqua, come in Gv 5,3b-4. Per la piscina di Siloe, va ricordato che nel dicembre 2004 gliarcheologi delle Antichita israeliane scoprirono, a una dozzina di metri dal bacino bizantino – chela tradizione riconosce come la piscina di Siloe, nel ricordo della guarigione del cieco nato (Gv9,7-11) – un bacino piu antico dell’epoca di Gesu. Come e noto, Siloe e menzionata nelle fontigiudaiche come luogo per le purificazioni dei pellegrini che salivano al Tempio di Gerusalemme,soprattutto per le principali festivita ebraiche. Nella zona dove alcuni operai erano a lavoro perinstallare una condotta d’acqua, gli archeologi individuarono un bacino quadrilatero largo ca.50 mt. Si era gia a conoscenza di un bacino che doveva alimentare l’acqua della fonte, ma sene erano perdute le tracce. Tutto intorno al quadrilatero, poi, sono stati portati alla luce alcuniscalini per (facilitare) la discesa dei pellegrini durante l’immersione. Gli Ebrei osservanti, dopola purificazione, si mettevano in cammino su verso il Tempio, percorrendo una strada pavimentatache portava dritto alla Citta santa, dove venivano formulate le preghiere rituali e offerti i sacrificiprescritti dalla Torah. I ritrovamenti in loco – tra l’altro alcune monete e cocci di ceramica – per-mettono di affermare che la frequentazione del luogo fosse attiva tra il 50 a.C. e il 70 d.C., tra lafine cioe del periodo erodiano e la caduta di Gerusalemme e la distruzione del Tempio, cfr.S. LAURANT, La piscina di Siloe, «Il mondo della Bibbia», LXXXVI, 2007, p. 25; e M. KUCKLER,Die Beiden Heilsamen Wasser Jerusalems: Betesda und Shiloach zur Zeit Jesu, «Welt und Umweltder Bibel», XLIV, 2007, pp. 24-27.
MARCELLO DEL VERME
— 32 —
ve, ad es. nei numerosi luoghi/santuari terapeutici del Vicino Oriente e del-
l’Occidente antichi.12
2.1. Critica testuale, filologia e archeologia di Gv 5,3b-4
Come si diceva, Gv 5,2 riferisce che la guarigione del paralitico trentotten-
ne fu operata da Gesu a Bethzatha (v. 2),13 in un giorno festivo (v. 1).14 La for-
12 Alcune testimonianze in DEL VERME, Gerusalemme come polo soteriologico cit., in partico-lare i paragrafi 5.1 e 5.2, pp. 162-166; 166-169, con molti riferimenti bibliografici. Tra gli studiosiche hanno approfondito l’argomento in questione un posto di rilievo va assegnato alla studiosa mes-sinese Giulia Sfameni Gasparro. Ricordiamo alcuni suoi contributi: G. SFAMENI GASPARRO, Le re-ligioni del mondo ellenistico, in Storia delle religioni. 1. Le religioni antiche, a cura di G. Filoramo,Roma-Bari, Laterza 1994, pp. 409-450, e bibliografia; EAD., Oracoli Profeti Sibille. Rivelazione e sal-vezza nel mondo antico («Biblioteca di Scienze Religiose», 171), Roma, LAS 2002; EAD., Asclepio eGlicone: simbologia ofidica e divinita guaritrici e oracolari, in Voci dall’area santuariale di Lanuvium.Un percorso storico-religioso con ricadute nel presente, a cura di M. Del Verme, Bornato in Francia-corta (Bs), Sardini 2013, pp. 59-80. La Sfameni Gasparro fa un’eccellente sintesi dei miti/culti/ritigreci tra Oriente e Occidente del periodo ellenistico-romano, rilevando la continuita e insieme latrasformazione della ‘realta greca’ con l’acquisizione di esperienze religiose locali. Noi diremmo,le interazioni tra la persistenza delle tradizioni e dei culti locali antichi e la loro trasmigrazione aldi fuori dei confini nazionali, in concomitanza con l’intensificarsi di traffici commerciali, movimentifrequenti di individui, gruppi e intere comunita, e lo spostamento di eserciti dall’una all’altra re-gione. Con la conseguente nascita/costruzione di vere e proprie colonie in tutta l’area/bacino delMediterraneo antico. Buona documentazione su questi culti, riti e dottrine dei cosiddetti ‘Grecid’Occidente’, con richiami sintetici ma puntuali anche alla funzione iatrico-medicale in particolaredi Asclepio (dio della medicina) e di Igea (figlia e moglie di Asclepio e personificazione della salute),si trova nei contributi di G. MADDOLI, Culti e dottrine religiose dei Greci d’Occidente e M.M. SASSI,La filosofia nel mondo greco d’Occidente, in I Greci in Occidente, a cura di G. Pugliese Carratelli,Milano, Bompiani, 1996, pp. 481-498; 515-522. Specificatamente, per le divinita di origine/impor-tazione egiziana, cfr. anche S. DONADONI, La religione egiziana, in Storia delle religioni. 1. Le reli-gioni antiche cit., pp. 61-113, spec. pp. 110-113. Per Gerusalemme e l’area semitica in generale, cfr.DEL VERME, Gerusalemme come polo soteriologico cit., passim; DUPREZ, Jesus et les dieux guerisseurscit., e J.H. CHARLESWORTH, The Good and Evil Serpent: How a Universal Symbol Became Christia-nized, New Haven-London, Yale University Press 2009, passim. La funzione universalistica e sote-riologica di Gerusalemme come ‘polo salvifico’ per alcune religioni mediterranee (ad es., i culti/ritidi Asclepio/Esculapio e Serapide) e non soltanto per la religione ‘palatina’ prevalente a Gerusa-lemme durante il periodo monarchico, e stata sottolineata anche da I. OGGIANO, Dal terreno al di-vino. Archeologia del culto nella Palestina del primo millennio, Roma, Carocci 2005, pp. 190 sgg. epassim.
13 Preferiamo questa denominazione, cioe Bethzatha, cosı come accettato nelle edizioni critichedi E. et E. NESTLE – K. ALAND, Novum Testamentum graece, Stuttgart-New York, Deutsche Bibel-gesellschaft 197926 e K. ALAND – M. BLACK – C.M. MARTINI – B.M METZGER – A. WIKGREN, TheGreek New Testament, Munster/Westafalia, Institute for New Testament Textual Research 19753.Per questa scelta ci appelliamo anche alla supposizione filologica – ma riformulandola – di H. RE-
LAND che gia nel 1714 (Palaestina ex Monumentis veteribus illustrata. Liber secundus in quo agitur deintervallis locorum Palaestinae, Trajecti Batavorum, G. Broedelet 1714, p. 856) proponeva di recu-perare dietro il termine greco bgherda* l’aramaico Bes e$ sda (= ‘luogo dell’acqua [che fuoriesce o chescorre a torrenti]’). Anche a Qumran, il Rotolo di rame (3Q15), un documento scritto in un ebraicopopolare pre-mishnico su due lamine di rame arrotolate, che si e rivelato il piu misterioso tra tutti iManoscritti del Deserto di Giuda, nella col. XI 12 troviamo il lemma Bes e$ sdasayim (= ‘luogo delladoppia corrente’) cfr. Editio princeps curata da J.T. Milik [«Discoveries in the Judean Desert» III],
VOCI DAL PASSATO PER L’OGGI
— 33 —
za argomentativa ma ‘problematica’ per intendere correttamente la pericopedi Gv 5,1-9a, sta nella scelta/accettazione critica dei vv. 3b-4 della recensioneK, del codice maiuscolo Q, delle versioni antiche lat e syp e dello scrittore gre-co Kr. La maggior parte dei critici testuali e degli esegeti li espungono comeuna ‘glossa’ tarda, quindi da non prendere in considerazione.15 Noi accettia-mo, invece, questi due vv., anzi ce ne serviamo come un punto di forza per‘scoprire’ il contesto reale e allo stesso tempo simbolico del racconto giovan-neo. L’argomentazione e centrale nel presente contributo.
pl. LVIII, pp. 296-297. L’editore scrive: «Tout pres la, a Bet-Esdatain, dans la piscine [la] ou l’onentre dans son bassin [plus] petit»). Per questo lemma e stata proposta anche un’altra lettura, i.e.bet ha-asuhin (!yhwXah tyb): «In Beth ha Ashuhin, in the cistern at the entrance to the ymwmyt[smallest water basin?]», cfr. The Dead Sea Scrolls. Study Edition, ed. by F.G. Martınez – E.J.C.Tigchelaar, Vol. One: 1Q1-4Q273, Grand Rapids MI, Eerdmans 2000, pp. 238-239. Sia che si ac-cetti la prima lezione sia la seconda siamo sempre in presenza di un luogo con riferimento all’acqua(acque/correnti o piscina/vasca, etc.). Cio autorizzerebbe, secondo alcuni, a stabilire una connes-sione con il termine greco Bg(h)fada* , per altri con Bgherda* di Gv 5,2. A nostro avviso, riprendendoanche la succitata supposizione di Reland, si potrebbe (dovrebbe?) concludere per questa solu-zione: il sostantivo Bg(h)fada* e da interpretarere come un derivato dal plurale aramaico enfaticoBes esdasa, sostituendo cioe sd con una f (come avviene, ad es., per Asdod, in greco >Afxso|). Con-seguentemente, la localita che Flavio Giuseppe (bell. V, 151) chiama Bgfeda* equivarrebbe aBg(h)fada* di Gv 5,2 (come si legge nel codice Sinaitico). Il termine Bg(h)fada* alluderebbe esatta-mente al sito di Gerusalemme connesso all’acqua (o alle acque) o a una vasca/piscina, ossia al to-ponimo qumranico bet ’esdatayin (o bet ha-asuhin) di 3Q15 XI 12-13. Per la scelta del termineBg(h)fada* – con qualche cautela – opta anche Duprez, che scrive: «sur la localisation il faut recon-naıtre qu’aucun des arguments n’est absolument peremptoire et qu’il existe meme une divergenceentre Josephe d’une part, le rouleau de Qumran et l’Evangile de l’autre». E prosegue: «Mais cettedivergence n’est pas irreductible, car, dans les toponymes, le glissement d’un nom designant al’origine un endroit tres precis a tout un quartier est frequent». E conclude affermando che la pi-scina di Bethzatha puo essere localizzata «avec une tres grande probabilite» proprio nel luogo at-tuale, di proprieta dei Padri Bianchi, presso la chiesa di sant’Anna, cfr. DUPREZ, Jesus et les dieuxguerisseurs cit., pp. 155.158-159. Contra KUCKLER, Die Beide Heilsamen Wasser Jerusalems cit., spec.p. 127, nota 1; p. 132, nota 12 e p. 138, nota 30. Questa posizione e condivisa anche da altri stu-diosi che – (quasi) con le (nostre) medesime argomentazioni – propendono pero per la lezioneBgherda* .
14 Era un sabato, come ricorda Giovanni rilevando la meraviglia scandalizzata e la ‘persecu-zione’ dei Giudei (5,16). Un plurale collettivo da intendere pero – qui come altrove nell’Evangelodi Giovanni – come riferimento soltanto ad ‘alcuni’ gruppi e non a tutti i Giudei. Cfr. ancheS.M. BRYAN, Power in the Pool: the Healing of the Man at Bethesda and Jesus’ Violation of the Sabbath(Jn. 5,1-18), «Tyndale Bulletin», LIV/2, 2003, pp. 7-22.
15 Tra i tanti, cfr. G.D. FEE, On the Inauthenticity of John 5:3b-4, in ID., To What End Exegesis?Essays Textual, Exegetical, and Theological, Grand Rapids MI, Eerdmans 2001, pp. 17-28, un con-tributo di carattere specificamente – ma univocamente (purtroppo!) – testuale attraverso l’analisi deivari codici (che riportano i vv. 5,3b-4) e le loro ricadute esegetiche e teologiche. Assoluto silenzio,invece, sugli apporti archeologici dagli scavi di Bethzatha. Su questi torneremo in seguito, perche essisuffragano (ci sembra) l’accettazione critica di Gv 5,3b-4.
MARCELLO DEL VERME
— 34 —
2.1.1. Testo 16 e traduzione 17 di Gv 5, 3b-4
v. 3b e$ jdevole* mxm sg+ m sot& t% daso| ji* mgrim.
v. 4 a> cceko| ca+ q jasa+ jaiqo+ m jase* baimem e$ m sg# joktlbg* hqy
jai+ e$ sa* qarre so+ t% dxq"
o< ot# m pqx& so| e$ lba+ | lesa+ sg+ m saqavg+ m sot& t% dato|
t< cig+ | e$ ci* meso, x’ dg* pote jasei* veso morg* lasi.v. 3b aspettando [= gli ammalati di 3a] il moto dell’acqua,v. 4 perche un angelo in certi momenti discendeva nella piscinae metteva in movimento l’acqua;il primo, dunque, che vi entrava, dopo che l’acqua era stata agitata,guariva, qualunque fosse la malattia di cui soffriva.
2.1.2. Critica testuale e analisi filologica a favore di Gv 5,3b-4
Uno sguardo anche cursorio all’apparato critico in calce alla pericope di
Gv 5,1-9a fa concludere che soprattutto i vv. 3b-4 hanno avuto una storia/tra-
dizione testuale molto complessa e variegata.18
Il v. 3b, che le edizioni critiche di Merk, Vogels 19 e Bover 20 accettano
mentre Nestle-Aland et alii 21 lo espungono, manca nei papiri P66 e P75, nei
16 Seguiamo l’edizione di A. MERK, Novum Testamentum Graece et Latine, a cura di C.M. Mar-tini, Romae, Sumptibus Pontificii Instituti Biblici 19649 («Scripta Pontificii Instituti Biblici» 65), adlocum.
17 Nostra traduzione.18 Oltre ai commentari del Vangelo di Giovanni, rinviamo ai seguenti studi: T. ANTOLIN, La au-
tenticidad de Joa. 5,3b-4 y la exegesis de vers. 7, XVIII Semana Biblica Espanola, Sept. 1957, Madrid,Consejo Superior de Investigaciones Cientıficas 1959, pp. 374-391; S. BARTINA, Papiros y hermeneuticapara el pasaje evangelico de la Piscina probatica (5,1-47), in Atti dell’XI Congresso internazionale di Pa-pirologia, Milano, Istituto lombardo di scienze e lettere 1966, pp. 499-507; J.M. BOVER, Autenticidadde Joa. 5,3b-4, «Estudios Bıblicos», XI, 1952, pp. 69-72; J.C. CRAVIOTTI, Autenticidad de San Juan, V,3b-4, «Revista Bıblica», XIV, 1952, pp. 14 sgg.; KUCKLER, Die Beide Heilsamen Wasser Jerusalems cit.;M.L. RIGATO, L’infermo trentottenne presso «la Riserva» Bet-saida (Gv 5,1-6.14) nell’immaginario cul-tuale giovanneo, in La Parola di Dio cresceva (At 12,24). Scritti in onore di Carlo Maria Martini nel suo70º compleanno, a cura di R. Fabris, Bologna, EDB 1998, pp. 171-194; T. NICKLAS – T.J. KRAUS, Joh5,3b-4. Ein langst erledigtes textkritisches Problem?, in Rappresentazioni del Giudaismo e una polemicasull’interpretazione del Corano, «Annali di storia dell’esegesi» XVII, 2/2000, pp. 537-556. Quest’ul-timo e uno studio puntuale e analitico, che riporta (sintetizzandole) le diverse opinioni/scelte critichedegli studiosi che hanno analizzato le molteplici testimonianze (papiri, codici e citazioni patristiche) diGv 5,3b-4. Per le citazioni patristiche, in particolare Mt 9,1-8 e Gv 5,1-14, vedi anche il contributo diM. DULAEY, Les paralytiques des evangiles dans l’interpretation patristique: du texte a l’image, «Revued’etudes augustiniennes et patristiques», LII, 2006, pp. 287-328.
19 H.J. VOGELS, Novum Testamentum Graece et Latine, Freiburg-Barcelona, L. Schwann 19554.20 J.M. BOVER, Novi Testamenti Biblia graeca et latina, Madrid, Consejo superior de investiga-
ciones cientificas 19685.21 E. ET E. NESTLE – K. ALAND, Novum Testamentum Graece, Stuttgart-New York, Wurttem-
bergische Bibelanstalt e American Bible Society 196325 (idem nella 28. reviderte Auflage, hrgb. von
VOCI DAL PASSATO PER L’OGGI
— 35 —
codici maiuscoli B S C* L A* 0125 0141, nelle versioni antiche q syc ar co+ enello scrittore siriaco Ta1. E presente, invece, nella recensione K, nel codicemaiuscolo Q, nelle versioni lat e syp e nello scrittore greco Kr.
Il v. 4, che Merk, Vogels e Bover includono nel testo critico mentre Nes-tle-Aland 22 et alii lo espungono, e assente nei codici maiuscoli B S C* D W,nelle versioni antiche f l q vg’ syc ar sa+ e nei papiri P66 e P75. E presente,invece, nella recensione K, nei codici maiuscoli A T L, nelle versioni anticheit syp vgc1 e negli scrittori Ta4 Tert Did Cy Kr.23 Quanto alla Vulgata, il v. 3b eriportato da tutti i codici, non cosı il v. 4 che e assente in S Z* U D.
Esponiamo alcuni motivi 24 che giustificano la nostra scelta di includere ivv. 3b-4 nel testo critico di Gv 5,1-9a.25 Gia sessanta anni fa, K. H. Rengstorf 26
faceva notare che nel racconto della guarigione del paralitico per ben quattrovolte (Gv 5,4.6.9.14) viene ripetuta l’espressione «essere guarito» (gr. t< cig& ci*-merhai), che non ricorre altrove nel Vangelo di Giovanni, ne si legge nei Sinot-tici quando narrano episodi di guarigioni operate da Gesu. Non si puo trat-tare, quindi, di un caso fortuito, ma la scelta di vocabolario sembraintenzionale. L’espressione t< cig& ci*merhai ricorre identica – o poco diversa –in molte iscrizioni provenienti da Epidauro, che ricordano casi di guarigione
B. und Kurt Aland, Joannis D. Karovidopoulos, Carlo Maria Martini, Bruce M. Metzger, Stuttgart,Deutsche Bibelgesellscahft 2012), e ALAND – BLACK – MARTINI – METZGER – WIKGREN, The GreekNew Testament cit.
22 Nella edizione del 2012, cit., il v. 4 (con attestazioni) e riportato nell’apparato critico tra pa-rentesi quadre [4], che nel pensiero degli editori significa: «Square brackets always reflect a greatdegree of difficulty in determining the text» (cfr. Introduction, p. 54*).
23 Il v. 4 presenta alcune varianti nella tradizione testuale: invece di jase*baimem (discendeva) icodici onciali A Y riportano e$kot* eso, e al posto di e$sa* qarrem (metteva in movimento), i codici maiu-scoli Cc M U P V H L, quelli minuscoli 713 251 482 373 e due codici della vetus latina c r leggonoe* sa* qarreso (si agitava o veniva agitata).
24 Altre motivazioni sono riportate in DEL VERME, Gerusalemme come polo soteriologico cit.,pp. 150-152; e ID., La piscina probatica: Gv 5,1-9. Un problema di critica testuale e di esegesi di fronteai risultati degli ultimi scavi, «Bibbia e Oriente», XVIII, 1976, pp. 109-119.
25 Sono relativamente pochi gli esegeti che difendono l’autenticita di Gv 5,3b-4. Ne citiamo al-cuni: Vaccari, Mollat, Leal, Duprez, Simoens, Nicklas-Kraus e chi scrive (ma lo proponevamo piu di25 anni fa: DEL VERME, La piscina probatica: Gv 5,1-9 cit., pp. 109-110). La maggior parte degli stu-diosi, invece, li rigetta come una glossa: Alfred Wikenhauser, Francois Marie Braun, Rudolf Bult-mann, Andre Feuillet, Raymond Edward Brown, Leonhard Goppelt, Rudolf Schnackenburg, Ste-phen K. Ray, Andreas J. Kostenberger e Giancarlo Gaeta. Per questi il v. 3b sarebbe una ‘glossaesplicativa’ suggerita e che anticipa quanto viene narrato nel v. 7 (A. WIKENHAUSER, L’evangelo se-condo Giovanni, Brescia, Morcelliana 1962, p. 196); e il v. 4, anch’esso ritenuto una glossa, sarebbeun’eco della fede popolare nell’angelo che scendendo nella piscina dava all’acqua una temporaneavirtu terapeutica (cosı WIKENHAUSER, ibid.; R. BULTMANN, Das Evangelium des Johannes, Gottingen,Vandenhoeck & Ruprecht 1957, p. 180, et alii).
26 K.H. RENGSTORF, Die Anfange der Auseinandersetzung zwischen Christusglauben und Askle-piosfrommigkeit, Munster, Aschendorf 1953, pp. 16-17.
MARCELLO DEL VERME
— 36 —
attribuiti ad Asclepio. Secondo l’A., quel lemma [questo termine e nostro],una modalita stilistica tipica e ricorrente specie nelle narrazioni miracoloseasclepiadee, era noto a Giovanni che l’avrebbe inserito/riportato nel raccontodel paralitico guarito a Bethzatha/Bethesda per sottolineare e ribadire ai suoilettori che il vero e unico guaritore-e-salvatore fosse Gesu ma non Asclepio.Inoltre tutto il racconto giovanneo (redazionale) farebbe pensare che il riferi-mento al mondo di Asclepio (una divinita che guarisce) rinvii al periodo du-rante il quale la Chiesa primitiva era impegnata a difendersi dalle divinita gua-ritrici pagane, osteggiandole in nome e nel ricordo dell’attivita pubblica eguaritrice di Gesu di Nazareth.
Sugli asclepieia e i riti di guarigione che si svolgevano in quei luoghi/san-tuari, ci soffermeremo nel punto seguente. Ci preme, pero, anticipare che letestimonianze riguardanti questi luoghi sacri, iatrici e salutiferi, e legati quasisempre all’acqua, supportano la nostra (insieme a pochi altri) scelta testuale.Le stesse argomentazioni filologiche (e di vocabolario) avanzate da Rengstorfsono su questa linea. Soprattutto se si tiene conto della presenza a Gerusalem-me – e proprio nell’area dove Giovanni ambienta la piscina di Bethzatha/Be-thesda – di un santuario dedicato al dio Serapide/Asclepio, databile con cer-tezza al tempo di Aelia Capitolina (132-135 d.C.), se non prima.27
Si e gia detto, citando Rengstorf,28 che il vocabolario della pericope inquestione non e specificamente giovanneo, ma l’evangelista ha potuto integra-re l’episodio del paralitico, di cui era a conoscenza personalmente (o percheproveniva da una fonte precedente o da una tradizione popolare che localiz-zava il miracolo del paralitico in un santuario guaritore). La tradizione potreb-be essere antica, perche essa e connessa (o connettibile) alla realta di un luogoguaritore a Bethzatha al tempo di Gesu, come si puo rilevare dai livelli piubassi degli scavi, che risalgono con certezza al periodo giudaico. In seguito– ma soltanto per ragioni teologiche 29 – i manoscritti alessandrini avrebbero
27 Recentemente il valente studioso americano J.H. Charlesworth (Teologia biblica e simbolismodel serpente, in Voci dall’area santuariale di Lanuvium cit., pp. 81-114), con riferimento a Gv 5,1-9a,in particolare ai vv. 2-3, ha scritto: «Soltanto il quarto evangelista, tra le testimonianze del I secolo,ricorda i cinque portici, scavati a nord della montagna del Tempio. La ci sono grotte dove sono staterinvenute ceramiche ellenistiche. L’autore, probabilmente, era a conoscenza che la piscina di Beth-zatha fosse un luogo nel quale Asclepio veniva onorato e venerato, quasi certamente da soldati ro-mani che erano accampati nella vicina fortezza Antonia. Nei primi secoli della Cristianita, molti ro-mani (specialmente il pkg& ho| sx& m a$ rhemot* sxm, siukx& m, vxkx& m, ngqx& m) pensavano che due divinitagareggiassero tra di loro per la devozione e la promessa di salute: Asclepio e Gesu» (ibid., 107). Un’i-potesi non peregrina.
28 Cfr. supra nota 26.29 Evitare, cioe, l’eccessiva umanizzazione di Gesu. Gli amanuensi di scuola alessandrina erano
molto attenti a sottolineare la divinita di Gesu: per essi egli e il Cristo, soprattutto il ‘Cristo’. La sua
VOCI DAL PASSATO PER L’OGGI
— 37 —
espunto i vv. 3b-4, cosı come fecero – e per le medesime cautele teologiche – per
gli episodi dell’adultera (Gv 7,53-8,11) e del sudore di sangue di Gesu (Lc 22,
43-44).
2.2. L’archeologia a sostegno di Gv 5,3b-4
Le relazioni delle diverse campagne di scavi a Bethzatha e gli studi di ap-
profondimento che ne sono seguiti sono numerosissimi.30 Per non ripeterci ed
evitare di riproporre qui argomentazioni sviluppate in extenso altrove,31 ci li-
mitiamo a qualche conclusione (archeologica in particolare) che supporti la
nostra posizione (minoritaria tra gli studiosi) favorevole all’autenticita di Gv
5,3b-4.Partiamo di qui. Lo studioso Eugenio Alliata, docente presso lo Studium
Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, pur valutando positivamente i vari
ritrovamenti in loco a sostegno del racconto di Gv, 5,1-9a, resta pero alquanto
perplesso per la non-presenza a Bethzatha di una realta importante, cioe rivoli
d’acqua termali.32 A nostro avviso, lo stimato collega dimentica – e/o trascura –
frequentazione di luoghi, che la tradizione popolare ebraica (non di stretta ortodossia) riteneva tera-peutici per la presenza dell’angelo [del Signore], o di un santuario (pagano?) faceva problema.
30 Alcuni studi vengono elencati da DEL VERME, Gerusalemme come polo soteriologico cit.,p. 155, nota 39.
31 DEL VERME, Gerusalemme come polo soteriologico cit., pp. 153-160, con riferimenti agli studipiu rappresentativi fino al 2009. Particolare attenzione e stata riservata ai contributi di DUPREZ, Jesuset le dieux guerisseurs cit., spec. cap. I: Les donnees archeologiques, pp. 28-56; ID., Probatique (Pi-scine), DBS VIII, 1972, pp. 606-621, con ampia bibliografia finale; e P. BENOIT, Decouvertes archeo-logiques autour de la Piscine de Bethesda, in Jerusalem through the Ages. The Twenty-Fifth Archaeo-logical Convention, October 1967, a cura di J. Aviram, Jerusalem, The Israel Exploration Society1968, pp. 48-57. Merita attenzione, in fine, un recente studio di U.C. VON WAHLDE, The Pool(s)of Bethesda and the Healing in John 5: A Reappraisal of Reserach and of the Johannine Text, «RevueBiblique», CXVI, 1/2009, pp. 111-136, che fa il punto su tutti (o quasi) i risultati notevoli circa la/episcina/e menzionate in Gv 5.
32 L’archeologo francescano, in una nota concisa ma puntuale, descrive l’odierna situazione de-gli studi circa la piscina di Bethzatha/Bethesda e il testo di Gv 5, richiamando anche alcuni precedentie importanti risultati. Gli scavi ad est della piscina, fatti negli anni Sessanta dello scorso secolo, hannodocumentato che il sito fu occupato in epoca evangelica: le monete ritrovate nei livelli inferiori vannoda Alessandro Janneo (103-76 a.C.) alla prima rivolta ebraica contro Roma (66-70 d.C.); la modestadecorazione architettonica delle costruzioni trovate in situ non si addice al tipo di case private, ma fapensare a qualcosa come uno stabilimento pubblico destinato a bagni; l’edificio venne trasformatodopo il 135, quando la Gerusalemme ebraica divenne una citta, colonia romana, chiamata Aelia Ca-pitolina. Fu allora – tra il II e il IV sec. dell’era volgare – che un santuario o stabilimento paganosorse sul bordo orientale della piscina: numerosi frammenti di intonaco dipinto a bande con coloricontrastanti testimoniano la bellezza dell’edificio, e i numerosi ex-voto ritrovati in loco sono segnocerto della frequentazione del posto per finalita religiose e curative, perche nel mondo pagano unluogo di cura e un santuario religioso concretamente non si distinguevano (ivi, p. 24). Seguono al-cune sue perplessita, ad es., se la rinomanza del posto fosse dovuta alle guarigioni, hanno un fonda-
MARCELLO DEL VERME
— 38 —
una importante regola di critica testuale che potrebbe/dovrebbe valere anche
per l’archeologia, i.e.: testes non numerandi, sed ponderandi sunt. E le testimo-
nianze, certe e sicure, di altri realia (ma non l’acqua) rinvenuti in loco, una si-
mul le antiche attestazioni letterarie circa la piscina di Bethzatha confermano
la bonta della tradizione giovannea del cap. 5, compresi i discussi vv. 3b-4.
Senza escludere, poi, che prossime nuove campagne di scavi potrebbero con-
fermare i dati gia acquisiti e riservare (positive) sorprese.33
mento data la non-presenza in loco di acque termali con finalita curative. Come spiegare cio? «Unosconvolgimento tellurico – si chiede Alliata – puo aver provocato la scomparsa di una sorgente dotatadi tali qualita? Antiche tradizioni religiose ebraiche possono essere passate nell’ambiente pagano del-l’Aelia Capitolina? O ancora, il ricordo della guarigione operata da Cristo puo aver procurato a que-sto luogo la sua fama? La piena comprensione e la messa a fuoco di questo contesto ci sfuggono»(cfr. E. ALLIATA, Sui passi di Gesu: Due piscine miracolose, «Il mondo della Bibbia», LXXXVI,2007, pp. 24-25). La realta di Bethzatha/Bethesda si ripresenta, in qualche modo analoga, oggidı,in una cittadina del Lazio, Lanuvio (Rm) ai Colli Albani. Le fonti antiche, greche e latine, riportanoconcordemente la presenza di abbondanti acque in loco e nell’ager Lanuvinus, specie nell’area san-tuariale del Tempio di Giunone Sospita (salvatrice), la dea principale della citta, protettrice insiemead Ercole di Lanuvium (nel Latium vetus). Nell’Introduzione al volume Voci dall’area santuariale diLanuvium cit. (vedi supra, nota 12), scrivevo: «Anche Lanuvium, come gli altri centri del Latium Ve-tus, era ricca d’acqua [...]. Non mancano nel territorio numerosi elementi che sottolineano l’atten-zione della citta alla gestione e all’approvvigionamento dell’acqua. E noto che nel III sec. a.C. unmagistrato cittadino si occupo di realizzare una condotta per l’adduzione di acqua probabilmentedestinata al santuario di Ercole. Egli, in ricordo di tale intervento, appose una iscrizione (Eph. Epigr.IX 620) su un labrum in travertino, oggi conservato al Museo Nazionale Romano. In eta tardo-re-pubblicana la citta provvide anche a dotarsi di un acquedotto che, con percorso sotterraneo, portavaacqua in citta dalle sorgenti ubicate nella parte settentrionale dell’ager Lanuvinus [...]. Esso alimen-tava certamente i numerosi balnea pubblici della citta, di cui abbiamo notizia soprattutto dalle iscri-zioni (cfr. G.G. FAGAN, Bathing in Public in Roman World, Ann Arbor 1999, pp. 15, 22, 167-169,180, 203, 246, nn. 46, 59, 91, 102, 216). [...] L’abbondanza di acque, unita alla fertilita dei terrenivulcanici dell’ager, e da annoverare tra i principali fattori che nell’antichita resero rinomata e deside-rata la residenza per la qualita della vita a Lanuvium» (cfr. DEL VERME, Voci dall’area santuariale diLanuvium cit., nota 3, pp. 26-27). Eppure chi visita e si aggira oggidı tra le aree santuariali di Lanu-vium (e dell’ager Lanuvinus), alla ricerca di abbondanti fonti/rivoli di acqua, come quelli descrittinelle fonti antiche (cfr, in particolare, i contributi di L. GALIETI, Acque salutifere nel mondo anticoe a Lanuvium [Latium Vetus] e di M. SCHROTT, Acqua e vita, in DEL VERME, Voci dall’area santua-riale di Lanuvium cit., pp. 115-118; 133-148), prova qualche delusione. In bella vista – o sepolti neglistrati piu bassi degli scavi – restano soltanto ruderi: rovine (pietre e altri realia), che parlano di unpassato storico ricco e illustre, ma delle abbondanti acque sul territorio – a parte il vasellame e i votivi(specie anatomici) e le polle e piccole cascate d’acqua nell’area Pantanacci – restano poche tracce. Sipotrebbe dire: e la natura che cambia, come affermava Eraclito di Efeso (VI-V sec. a.C.) o, meglio,come tramanda una/la storia dell’eraclitismo con la concezione del mondo come un perpetuo dive-nire (pa+ msa q$ ei*). Qualcosa di simile – in forma pero piu vistosa rispetto alla situazione attuale a La-nuvio – e potuto/dovuto accadere anche per Bethzatha/Bethesda, cosı come per tanti altri santuarisalutiferi del Vicino Oriente antico.
33 La studiosa Claudine Dauphin, attuale direttrice del Bethesda Project at St Anne’s, Jerusalem-Paris, ha parzialmente anticipato nuovi risultati, promettendo la pubblicazione di un Preliminary Re-port nella stessa rivista e la relazione finale da parte della BAR (British Archaeological Reports), In-ternational Series, in due volumi, presso la Archaeopress di Oxford (cfr. C. DAUPHIN, The BetesdaProject at St Anne’s in the Old City of Jerusalem, «Proche-Orient Chretien», LV, 2005, pp. 263-269, qui 268). Non ci risulta, pero, che gli studi annunciati siano stati finora pubblicati; comunque,
VOCI DAL PASSATO PER L’OGGI
— 39 —
Ribadiamo che alcuni risultati degli scavi archeologici a Bethzatha, in par-
ticolare la scoperta delle ‘piscine curative’ nell’area intorno alla chiesa di san-
t’Anna,34 dove le fonti letterarie e Gv. 5 localizzavano la piscina, rendono giu-
stizia e accreditano la tradizione ebraica 35 e cristiana 36 circa la collocazione
noi non facciamo parte di quel gruppo di studiosi inclini a un certo ‘dogmatismo archeologico’: iritrovamenti sono certamente importanti, ma non esauriscono tutta la ricerca. Peraltro siamo inun ambito di studi molto complessi: i dati archeologici possono aiutare a provare/confermare la con-sistenza e veridicita dei testi e delle antiche tradizioni, ma i vacat (vuoti, lacune) nelle fonti non pre-cludono ulteriori e future scoperte. Frattanto la ricerca scientifica puo/deve provare altre strade perrisolvere i problemi sia di critica testuale sia di esegesi.
34 A sinistra dell’attuale via ‘Dolorosa Street’, muovendosi dall’Arco del cosiddetto ‘Ecce homo’e proseguendo verso la Porta di Santo Stefano (o Lions Gate), una delle sette Porte della Citta vec-chia. Come si e visto, gli scavi hanno confermato la localizzazione tradizionale di Bethzatha/Bethesda:gia Eusebio, verso il 330 e Girolamo nel 372, ne avevano parlato puntualmente. Birket Israıl – doveveniva collocata Bethesda dal XIV secolo in poi – non e quindi il sito dell’antica piscina. Le guarigioninarrate nell’Evangelo di Giovanni non avvenivano cioe nei due grandi bacini (Birket Israıl), ma neipiccoli bagni, situati a lato e di dimensione piu ridotta, quindi piu adatti per l’immersione dei malati.Molto probabilmente, il paralitico fu guarito la, perche dei cinque grandi portici menzionati da Gv5,2b non e rimasta traccia negli strati degli scavi di epoca gesuana. La localizzazione dei portici vaposta altrove, cioe nel luogo dove furono rinvenuti due grandi bacini di forma irregolare. In alterna-tiva, se quei portici esistevano al tempo di Gesu dovevano essere di dimensione piu modesta, e an-drebbero percio localizzati nella zona dove si trovano i piccoli bagni. Cfr. sull’argomento ancheKuckler (infra). Questo spinoso ‘problema archeologico’ viene aggirato da quegli studiosi (in mag-gioranza esegeti) che si accontentano di interpretare i «cinque portici» come un’indicazione giovan-nea di carattere simbolico e/o allegorico, un richiamo cioe ai cinque libri della Torah. Va in questadirezione, tra gli altri, C.H. DODD, L’interpretazione del quarto vangelo, Brescia, Paideia 1974 (ed. or.London 1965), pp. 393 sgg. M. Hengel, insieme ad altri, interpreta, invece, i cinque portici e i tren-totto anni dell’infermo (v. 5) rispettivamente come un richiamo simbolico ai «cinque libri di Mose» ealla «dura permanenza degli ebrei» nel deserto (Dt 2,14-15; e 1,1-46, spec. vv. 45 e 46). Kuckler epiu perentorio: egli nega addirittura l’esistenza materiale dei cinque portici. In Giovanni essi avreb-bero un valore unicamente allegorico, cfr. KUCKLER, Zum ‘‘Probatischen Becken’’ und zu Betesda mitden funf Stoen, cit., pp. 381-382. Questa opzione (non del tutto giustificata) dell’A. elimina tutte ledifficolta e i problemi di carattere archeologico connessi alla dislocazione/posizione dei cinque por-tici nel sito di Bethzatha. Certo i portici dovettero scomparire molto presto, perche gia Eusebio diCesarea, il piu antico storico cristiano che li ricorda dopo Giovanni, scriveva: «Bezatha cioe la pro-batica ‘come avente un tempo [cioe ‘nel passato’, gr. so+ pakaio+ m] cinque portici’» (bgfaha* g= si| e+rsi+m g<pqobasijg* , so+ pakaio+ m e\ rsoa+ | e>votra jsk (da Enchiridion Locorum Sanctorum, a cura di Donato Baldi,Jerusalem, Typis PP. Franciscanorum 1935, p. 573, par. 682).
35 Vedi supra, nota 11. Inoltre, nonostante che le tradizioni giudaiche ortodosse appaiano reti-centi verso i culti e/o bagni guaritori – che mai o quasi mai vengono esplicitamente menzionati negliscritti ufficiali – essi pero sono alquanto diffusi all’interno di gruppi che vivevano al margine dell’or-todossia, ad es. le cosiddette sette battiste. Le pratiche ‘lustrali’ e ‘terapeutiche’ si radicano, infatti, suantichissime tradizioni semitiche per le quali l’acqua svolgeva un ruolo mantico, favorevole ai sogni eall’azione terapeutica della divinita. Gli antichi dei guaritori semitici, come ad es. Eshmun e Sha-drafa, godettero di grande popolarita nel Vicino Oriente antico, cfr. DUPREZ, Probatique (Piscine)cit., col. 618, con bibliografia. La cosa era gia stata puntualmente studiata da J. THOMAS, Le mouve-ment baptiste en Palestine et en Syrie, 150 av. J.-C. 300 ap. J.-C. («Universitas Catholica Lovaniensis»,Ser. 3, XXVIII), Gembloux, Duculot 1935, e anche L. CIRILLO, Fenomeni battisti, «Rivista di Storiae Letteratura Religiosa», XXIX (1993), pp. 269-303. Su questo argomento riportiamo inoltre il pen-siero di A. Rolla, che piu di quarant’anni fa scriveva: «Non e improbabile che nonostante l’opposi-zione della religione ufficiale il popolo di Gerusalemme guardasse con simpatia a queste pratiche di
MARCELLO DEL VERME
— 40 —
della guarigione del paralitico. Come si e visto, le due tradizioni letterarie in-
dipendentemente – e oggi anche l’archeologia – documentano che in quell’a-
rea era attivo un luogo/santuario di guarigione collegato all’acqua salutifera (la
piscina) al tempo di Gesu e molto probabilmente gia prima.Gv. 5 narra che a Bethzatha «l’angelo [del Signore] scendeva nella piscina
e in certi momenti agitava l’acqua» (a> cceko| ca+ q jase*baimem e$m sg& joktlbg* hqy jai+
e$ sa* qarre so+ t% dxq) (v. 4a). Alle due realta, l’angelo e l’acqua, veniva abitual-
mente accreditata la guarigione degli ammalati. Nel racconto giovanneo – ve-
ro/reale (piu probabilmente) o simbolico che sia – e l’ ‘angelo della vita’ 37 che
trionfa con la sua azione positiva sulla negativita della malattia.38 ‘Quella vol-
bagni guaritori piu o meno collegate con l’intervento di Jahve», ROLLA, Piscina probatica cit., p. 785.Anche Shimon Gibson, in un puntuale contributo che studia le connessioni tra i riti giudaici di pu-rificazione e la situazione di Betesda, rileva che Bethzatha/Bethesda, come pure la piscina di Siloe asud del Monte del Tempio, furono concepite durante il regno di Erode il Grande (37-4 a.C.) comeuna risposta all’obbligo delle purificazioni rituali per tutti i pellegrini giudei che numerosi accorre-vano a Gerusalemme durante le principali festivita. E dal momento che le malattie e le malformazionifisiche interdicevano l’accesso al Tempio si cercava presso queste piscine la guarigione (miracolosaper la [supposta e/o presunta] presenza dell’angelo di Jahweh (con citazione di Gv 5,1-18 e9,7.11). Cfr. S. GIBSON, The Pool of Betesda in Jerusalem and Jewish Purification Practises of the Se-cond Temple Period, «Proche-Orient Chretien», LV, 2005, pp. 270-293.
36 In primis, l’Evangelo di Giovanni, sia che la pericope 5,1-9a venga letta in chiave realistica(piu probabilmente) come un evento degli anni 28-30 dell’era volgare sia come un rglei&om che fa-rebbe luce soltanto sulla teologia redazionale di Giovanni (ca. fine I secolo e.v.). Giovanni intendepresentare la persona di Gesu come ‘il salvatore’ (o< Rxsg* q) in contrapposizione ai ‘molti’ rxsg& qe|
(salvatori, protettori, liberatori), epiteto di divinita pagane (come ad es. Zeus, Apollo, i Dioscuri,Hermes, Serapide/Asclepio/Esculapio e divinita tutelari), di re o governanti e di altre personalitaonorate/divinizzate a seguito di particolari prestazioni o imprese. Cfr. la voce rxsg* q nei dizionari:F. MONTANARI, Vocabolario della lingua greca, con la collaborazione di Ivan Garofalo e DanielaManetti, Milano, Loescher Editore 2000 [ottava ristampa] e, con maggiori attestazioni, H.G. LID-
DELL – R. SCOTT, A Greek-English Lexicon, rev. and aug. throughout by Sir Henry Stuart Joneswith the assistance of Roderick McKenzie. With a Supplement 1968, Oxford, Clarendon Press1968).
37 Non e da escludere che la menzione dell’angelo [del Signore], in Giovanni come nella tra-dizione testuale (e nelle intenzioni dei copisti), potrebbe avere lo scopo di ‘giudaizzare’ un santuarionon ebraico in situ.
38 Come e noto, nella tradizione ebraico-giudaica l’infermita e altri malanni fisici, economici emorali sono visti molto spesso come conseguenza del/i peccati dell’individuo o del popolo. Di quianche lo ‘scandalo’ dei farisei all’annuncio di una guarigione da parte del paralitico, e ancor piu per-che ‘operata’ in un giorno di obbligatorio ‘riposo’ festivo (Gv 5,14-16). Vedi anche S.M. BRYAN, Po-wer in the Pool: the Healing of the Man at Bethesda and Jesus’ Violation of the Sabbath (Jn. 5:1-18),«Tyndale Bulletin», LIV, 2003/2, pp. 7-22. Un percorso tra le interpretazioni patristiche di Gv 5,1-14 (e Mt 9,1-8) e tracciato da M. DULAEY, Les paralytiques des evangiles dans l’interpretation patri-stique: du texte a l’image, «Revue d’etudes augustiniennes et patristiques», LII, 2006, pp. 287-328.Th. Vallianippuram, in una dissertazione discussa in India al St Peter’s Pontifical Institute, si spingefino a rilevare nelle due pericopi giovannee (5,1-4 e 9,1-47) la possibilita di capire l’atteggiamento/stile di Gesu verso il suo mondo ambiente, con riflessi anche sull’oggi, cfr. T. VALLIANIPPURAM, NewSociety in John’s Gospel: Work of Jesus and His Attitude towards the World in Jn. 5:1-4 and 9:1-47,Ph. Dissertation, St Peter’s Pontifical Institute, Bangalore, Aloor 2008.
VOCI DAL PASSATO PER L’OGGI
— 41 —
ta’, pero, il paralitico trentottenne non fu guarito tramite l’immersione nell’ac-qua agitata dall’angelo, ma fu guarito direttamente da Gesu.
3. ‘ANGELO DELLA MORTE’
Proseguendo nell’immagine dei ‘due angeli’, ‘l’angelo della morte’ l’ho vi-sto., invece, sempre a Gerusalemme, decenni fa, cioe nel giugno 1967. Ne av-vertii la presenza nella guerra tra Israeliani e Palestinesi. Evento catastrofico edistruttivo di uomini e cose. L’ho visto aleggiare sulla ‘Citta santa’ e sui terri-tori circostanti nello scontro fulmineo della ‘Guerra dei sei giorni’.39 Le con-seguenze di quel disastroso conflitto furono immani: morti, sofferenze umanee danni economici per i due popoli in lotta tra loro. Nell’area di Gerusalem-me-e-dintorni e in altre regioni quella guerra lampo apporto ‘nuovi’ problemie creo ‘nuovi’ scenari politici con l’acuirsi di antiche inimicizie.
I riflessi negativi 40 si riverberarono anche su noi studenti, sia quelli delloStudium Biblicum Franciscanum 41 sia di altre istituzioni scientifiche internazio-nali come l’Ecole Biblique et Archeologique Francaise de Jerusalem.42 Tutti oquasi tutti i problemi insorti dopo la guerra restano ancora irrisolti. A circacinquant’anni di distanza dagli eventi.
Nella ‘Guerra dei sei giorni’ apparve minaccioso l’ ‘angelo della morte’ – unsimbolo biblico, che nella tradizione ebraica e cristiana (pre)annuncia semprecatastrofi, sventure e distruzioni – in particolare a noi studenti di Scienze bibli-che, residenti nei suddetti centri internazionali, persone pacifiche, non schieratitra i due fronti in guerra. Spettatori muti e impotenti, ma sgomenti e dolenti.
39 La ‘Guerra dei sei giorni’ (ebraico: ~ymyh tXX tmxlm, Milhemet Sheshet Ha Yamim; arabo:, an-Naksah, ‘la sconfitta’), che all’interno dei precedenti conflitti arabo-israeliani fu una
guerra lampo ma atroce tra Israele, da una parte, ed Egitto, Siria e Giordania, dall’altra. Ancora oggi,l’esito di quella guerra pesa sulla condizione giuridica e politica dei ‘territori occupati’ (liberati?) e sulproblema ad essi connesso dei rifugiati palestinesi.
40 Una sintomatica esperienza: all’indomani della vittoria israeliana, se non prima (mi sembragia nel secondo giorno di belligeranza), sul nostro College, lo Studium Biblicum Franciscanum dellaFlagellazione sulla Via Dolorosa Street (a pochi centinaia di metri con entrata alla sinistra l’area dellapiscina di Bethzatha), fu issata la bandiera israeliana. Segno di vittoria o di conquista? La (non) ri-sposta dipende ovviamente dai differenti punti di vista, politici e, per alcuni, anche religiosi. L’eternoritorno, cioe, in qualche modo il ‘miope’ (pardon!) appello alla Bibbia per affrontare e risolvere iproblemi di confine.
41 Uno Studium internazionale, diretto dai Frati Minori, che dal 2001 si e trasformato in Facoltadi Scienze bibliche e Archeologia della Pontificia Universitas Antonianum di Roma.
42 E stata la prima istituzione accademica di Terra Santa (fondata nel 1890) sotto la direzionedei Padri Domenicani, che ha formato – e continua in questa attivita scientifica e meritoria – docentie ricercatori di scienze bibliche e archeologiche.
MARCELLO DEL VERME
— 42 —
Nei giorni immediatamente dopo la fine del conflitto arabo-israeliano anoi studenti dello Studium Biblicum Franciscanum, ritornati finalmente all’a-perto – dopo alcuni giorni di coprifuoco passati al riparo dalle bombe negliscantinati nel Museo archeologico dislocato al piano terra dello Studium –per osservare i danni del conflitto, si offrı una scena orribile: centinaia e cen-tinaia (non e un’iperbole!) di cadaveri di soldati caduti durante lo scontro ar-mato, ma ancora insepolti. Nella stragrande maggioranza erano giordani e pa-lestinesi abbattuti durante il combattimento: essi giacevano in tutta la zonache va dalla ‘Porta dei leoni’ (a Est della citta vecchia) verso il torrente Kedrone risale al Monte degli Ulivi. Anche a Sud della citta, nell’area che degradaverso la valle del torrente Hinnon (detta Geenna), la stessa scena di morte:cadaveri sparsi e insepolti.
Questa scena di morte e il territorio devastato a causa della guerra, ripre-sentandosi (a me) nel ricordo, fanno ancora male.43 Chi l’ha poi in qualchemodo ‘vissuta’ – come me e altri colleghi allora studenti a Gerusalemme – spe-ra che non si ripeta mai piu. Soprattutto ci si augura che le conseguenze tra-giche di quel conflitto (di conquista o di liberazione del territorio?) del 5-10giugno 1967 e soprattutto le gravi ricadute sul piano politico per le due particontendenti vengano finalmente affrontate e risolte con realismo, giustizia edequita.
4. CONCLUSIONE
I due eventi presi in esame, lontanissimo il primo meno distante il secon-do, tutti e due, ricordandoli, continuano a farmi(ci) pensare e a riflettere an-che sulla funzione degli accadimenti passati per noi contemporanei. Di piu,deo vel bona fortuna atque hominibus volentibus, fanno sperare a tutti (o qua-si) 44 che si possa arrivare a un mutamento dello status quo nella regione e in
43 «L’interrogativo sul dolore [mia nota: specie quello che nasce dalle guerre tra gli umani] escandalo per chi crede e per chi non crede. La misura e la stessa, e cosı l’impotenza rispetto a tuttoil male della natura, che non dipende da noi, e spesso anche rispetto al male della storia, che moltodipende da noi. I tentativi di chiudere il cerchio del male dentro un confine concettuale hanno por-tato a risultati impronunciabili» (M. VELADIANO, La propria storia con Dio. Credenti e non credentialla ricerca della verita, da «La Repubblica delle idee» del 17.09.2013).
44 Ultimamente, infatti, dall’Iran e da Israele sono arrivati segni di disgelo. Diremmo, in imma-gine, e iniziato – e vogliamo sperarlo – il volo dell’ ‘angelo della vita’, perche il Ministro degli EsteriZarif faceva gli auguri alle autorita israeliane su twitter per il Capodanno ebraico, prendendo le di-stanze da Ahmadinejad a proposito del massacro nazista: «Colui che lo negava – ha affermato – none piu in carica». Ma su un’altra sponda, nella Siria del regime di ’Al Assad, sono ancora attivi focolaidi guerra. Riapparira ‘l’angelo della morte’ anche sulle alture del Golan e/o altrove: ahime, il fanta-
VOCI DAL PASSATO PER L’OGGI
— 43 —
tutto il Vicino Medio Oriente.45 La storia nelle sue luci e nelle sue ombre sipropone, in questo senso, come una reale (vera) magistra vitae. Si potrebbeaddirittura parlare/evocare una teologia della storia? 46
Di piu, se poi i ‘due angeli’, che nell’immagine sono in contrapposizionetra loro ieri e ancora oggi (purtroppo!),47 decidessero di unirsi in volo, simbo-licamente e realmente rappacificati, anzi volassero in coppia per annunciarenell’area contesa: Salam (arabo ), salvezza, salute, pace; e Shalom (ebraico~Alv"), pace, salute e benessere (anche come armonia e crescita sociale),48 aidue popoli a tutt’oggi divisi, noi potremmo commentare gioiosi e augurare lo-ro (in immagine, alla ‘coppia di angeli’) – con una stessa espressione, diversasolo nella lingua ma non nel significato: As-salam ’aleikum (arabo
); e Shalom aleichem (ebraico ~kyl[ ~wlX). La pace [sia] su di voi.49
Lanuvio, ‘Casa Shalom’, 30 giugno 2014.
sma e l’incubo di una guerra totale nell’area mediorientale, come avvenne 47 anni fa durante la‘Guerra dei sei giorni’? Speriamo di no.
45 In occasione di un viaggio per certi versi emblematico, in apertura del grande giubileo cri-stiano dell’anno 2002, il compianto arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini (r.i.p.) in un discorsotenuto a Gerusalemme affermava: «[...] chiediamo a tutti di unirsi nella condanna di ogni fanatismo eintolleranza religiosa, di ogni ‘‘guerra santa’’ che genera solo violenza, terrore e morte. Nessunaguerra e santa [...]. Non bisogna escludere nessuna persona, nessun popolo, dall’abbraccio dellapace, dalla dignita e dalla giustizia» (Cfr. G. RAVASI, Martini. Le mie tre citta. Un colloquio nell’ami-cizia, Cinisello Balsamo [Mi], ed. San Paolo 2002, p. 56).
46 «Nessuna algebra del bene e del male – continua la Veladiano – puo essere evocata davanti aldolore. Anche chi crede conosce tutta la tentazione del disperare. E a volte dispera. Ma non per sem-pre e certo non grazie a una malintesa devozione che blocca il pensiero davanti al dubbio, ma perchenon e proprio capace di farlo. La sua storia con Dio lo fa rialzare. Nel corpo che si rimette in piedianche suo malgrado quando cade e nello spirito che non sa pensarsi finito. E allora grazie alla suastoria con Dio, non lascia Dio da solo davanti all’ingiustizia del mondo [il corsivo e nostro]» (VELA-
DIANO, La propria storia con Dio cit.).47 Con amarezza, segnalo un recente episodio editoriale: in una email [a marcello.delverme@u-
nina.it] del 1.10.2013, venivo informato dall’editore (evito il nome per non propagandare il suo pro-dotto. Pardon!) della pubblicazione di un New Book (credo un ebook), dal titolo: Jews, Antisemitism,and the Middle East. L’A., Michael Curtis, e correttamente presentato dall’editore come «a distin-guished professor emeritus of political science at Rutgers University, USA». Mio commento: il sot-totitolo del volume – posto dall’editore (?) – Will animosity toward Jews and the State of Israel everend? – insieme ai commenti elogiativi di alcuni studiosi, per lo piu Ebrei – non incoraggiano la mia‘immagine pacificatrice’ dei ‘due angeli’ in volo. Contra, vivaddio, c’e una bella iniziativa editoriale:Sacro e pop, in esclusiva il prezioso libro degli angeli, da Tiepolo a Vasco Rossi (cfr. «la Repubblica» del14.12.2013), che puo rincuorarci sul ruolo positivo degli angeli.
48 Cfr. il lemma ~Alv" di F.J. STENDENBACH, in Grande Lessico dell’Antico Testamento cit., IX, inparticolare le coll. 321-327, con amplissima bibliografia (coll. 318-321).
49 Un aforisma rabbinico cosı parla di Gerusalemme: «Il mondo e come un occhio: il bianco e ilmare, l’iride e la terra, la pupilla e Gerusalemme e l’immagine in essa riflessa e il tempo». Che l’im-magine riflessa nella pupilla, il tempo, diventi il ‘tempo della pupilla’, quando Gerusalemme brilleraper l’arrivo della pace. Purtroppo, pero, gli ultimissimi segnali non sono proprio lusinghieri. Il 25
MARCELLO DEL VERME
— 44 —
aprile 2014, mentre in Italia si festeggiava la liberazione dal nazifascismo, dalla Palestina e Terra diIsraele giungevano notizie di stampa non del tutto incoraggianti e contrastanti con la citata visionerabbinica di Gerusalemme. Dal versante palestinese: per un professore arabo, Mohammed S. DajaniDaoudi, che nello scorso marzo aveva portato per la prima volta una trentina di studenti palestinesiin visita a Auschwitz per raccontare loro dell’Olocausto, al ritorno in patria e iniziato un incubo. «Miaccusano – egli afferma – di lavaggio del cervello e di aver avallato le menzogne degli ebrei». E daIsraele, dopo l’intesa tra Olp e Hamas, si apprende, pero, che il Gabinetto sulla sicurezza avrebbedeciso di interrompere i colloqui di pace con i Palestinesi. Che sara? Si continui a sperare, perchele smentite-del-giorno-dopo non mancano da entrambi i fronti contrapposti. Il primo ministro israe-liano, Benjamin Netanyahu, affermava: «C’e tempo per tornare indietro... Abu Mazen (Olp) torniindietro», mentre da Ramallah giungeva notizia che Mahmoud Abbas (Abu Mazen) avrebbe definitol’Olocausto il «crimine piu atroce che l’umanita abbia conosciuto nella storia moderna» (ingl. themost heinous crime of modern era, cfr. «The Times of Israel Daily Edition» del 27 aprile 2014). Se-nonche gia il giorno dopo dello stesso mese, mentre tutto il paese (Israele) si fermava per ricordare levittime dell’Olocausto, il presidente Shimon Peres concludeva che Israele e il mondo devono rima-nere vigili contro la minaccia di antisemitismo. Ahinoi, il ‘ping-pong’ di timori e diffidenze recipro-che continua. Fino a quando? Ma si puo sperare, perche nella giornata dell’8 giugno in Vaticanoabbiamo visto Papa Francesco protagonista del dialogo inter-religioso e di nuove speranze di pacein Medio Oriente. Nei Giardini Vaticani, come e noto, si e svolto lo storico incontro del pontefice,vescovo di Roma, con il presidente israeliano Shimon Peres, quello palestinese Abu Mazen e il pa-triarca di Costantinopoli Bartolomeo. Una comune invocazione per la fine delle ostilita in MedioOriente, in un momento in cui i negoziati israelo-palestinesi ristagnavano. L’iniziativa di Bergoglioha puntato sulla forza della preghiera come «capacita di affratellare le fedi e rilanciare il processodi pace tra israeliani e palestinesi».
VOCI DAL PASSATO PER L’OGGI
— 45 —
FINITO DI STAMPARE
PER CONTO DI LEO S. OLSCHKI EDITORE
PRESSO ABC TIPOGRAFIA • SESTO FIORENTINO (FI)
NEL MESE DI NOVEMBRE 2014
STORIA DELL’EBRAISMO IN ITALIASTUDI E TESTI XXX
Diretta da
PIER CESARE IOLY ZORATTINI
NON SOLO VERSO ORIENTESTUDI SULL’EBRAISMO
IN ONORE DIPIER CESARE IOLY ZORATTINI
I
a cura di
MADDALENA DEL BIANCO COTROZZI
RICCARDO DI SEGNI e MARCELLO MASSENZIO
con la collaborazione di
MARIA AMALIA D’ARONCO
FIRENZE
LEO S. OLSCHKI EDITOREMMXIV
ISSN 1122-0716
ISBN 978 88 222 6356 8
S.E.I.XXX
L.S.O.
L’opera, in due tomi, e dedicata a Pier CesareIoly Zorattini per festeggiare gli oltre quaran-t’anni delle sue ricerche sulla storia dell’unicaminoranza non cristiana presente ininterrotta-mente da oltre duemila anni in Italia: gli Ebrei.Studiosi di fama internazionale e giovani ri-cercatori hanno profuso la ricchezza e lacomplessita delle loro competenze ripercor-rendo la storia delle principali componentidel Giudaismo – ashkenazita, sefardita e ita-liana – dai rapporti con le societa di acco-glienza della Diaspora alle dinamiche inter-ne del Giudaismo: la cultura, il pensiero el’ortoprassi.La miscellanea, per la ricchezza, l’originalitadei contributi e la vivacita espositiva degliautori travalica la cerchia degli specialisti esi apre al piu vasto pubblico di quei lettoricolti, desiderosi di approfondire la conoscen-za di aspetti complessi del mondo ebraico edella sua eredita culturale, non solo di quelloitaliano ma di tutta l’area mediterranea.Completano e arricchiscono l’opera ampi earticolati indici.
NO
NS
OL
OV
ER
SO
OR
IEN
TE
–I