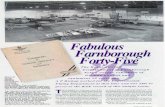La libertà dal dispotismo
Transcript of La libertà dal dispotismo
a cura di
FABRIZIO MASTROMARTINO
Con testi di
Milton, Spinoza, Collins, Hume, Montesquieu, Voltaire, Blackstone, d’Holbach, Condorcet, Filangieri, Verri, Kant, Fichte, Bentham,
von Humboldt, Constant, Marx, Mill
G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO
PER LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONEUN’ANTOLOGIA FILOSOFICA: DA MILTON A MILL
G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO
PER LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONEUN’ANTOLOGIA FILOSOFICA: DA MILTON A MILL
a cura di
FABRIZIO MASTROMARTINO
Con testi di
Milton, Spinoza, Collins, Hume, Montesquieu, Voltaire, Blackstone, d’Holbach, Condorcet, Filangieri, Verri, Kant, Fichte, Bentham,
von Humboldt, Constant, Marx, Mill
© Copyright 2012 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINOVIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100
http://www.giappichelli.it
ISBN/EAN 978-88-348-3943-0
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso di-verso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail [email protected] e sito web www.clearedi.org.
Sono state effettuate scrupolose ricerche ma non sono stati individuati tutti i titolari dei diritti di sfrutta-mento economico dell’opera. Il curatore resta a disposizione per ogni adempimento nei confronti degli eventuali aventi diritto.
Indice
– 1 –
INDICE
pag.
Presentazione 3
SEZIONE PRIMA
LA LIBERA RICERCA DELLA VERITÀ
Introduzione 6
I John Milton. Areopagitica 21
II Anthony Collins. Discorso sul libero pensiero 34
III John Stuart Mill. Saggio sulla libertà 42
SEZIONE SECONDA
LA LIBERTÀ DAL DISPOTISMO
Introduzione 53
IV Baruch Spinoza. Trattato teologico-politico 69
V Montesquieu. Lo spirito delle leggi 78
VI Voltaire. L’A.B.C. 84
VII D’Holbach. Etocrazia o il governo fondato sulla morale 90
VIII Pietro Verri. Delle nozioni tendenti alla pubblica felicità 97
IX Immanuel Kant. Sopra il detto comune 100
X Johann Gottlieb Fichte. Rivendicazione della libertà di pen-
siero 107
Indice
– 2 –
SEZIONE TERZA
CONTRO LA CENSURA PREVENTIVA
Introduzione 121
XI William Blackstone. Commentari sulle leggi d’Inghilterra 135
XII Condorcet. Frammenti sulla libertà della stampa 138
XIII Wilhelm Von Humboldt. Sulla libertà di stampa 147
XIV Benjamin Constant. Sul progetto di legge relativo alla censura 152
XV Karl Marx. Osservazioni sulla censura in Prussia 158
SEZIONE QUARTA
IL TRIBUNALE DELLA PUBBLICA OPINIONE
Introduzione 172
XVI David Hume. Sulla libertà di stampa 178
XVII Gaetano Filangeri. La scienza della legislazione 182
XVIII Jeremy Bentham. Libertà di stampa e discussione pubblica 188
Bibliografia (selezione) 195
Per la libertà di espressione
– 53 –
Introduzione
1. Nell’Europa continentale il controllo autoritario della stampa viene edifi-
cato a partire dalla seconda metà del ‘600, con il chiaro intento di cristalliz-
zare la vita sociale e la forma politica dello Stato in formule che dovevano
apparire definitive e intaccabili, poiché presentate come vere, la cui conser-
vazione legittimava il dispiegamento di un apparato censorio, amministrato
dalla corona, volto a reprimere qualsiasi opinione fosse giudicata eterodossa
in rapporto ai principi informatori dello Stato 68. Alle opportunità culturali
offerte dallo sviluppo della tecnica tipografica, che porta sul mercato forme
nuove di stampa di rapido consumo, come le gazzette, gli opuscoli e in se-
guito i giornali, si oppone un sistema repressivo, nel quale lo strumento pe-
nale assume progressivamente un ruolo di secondo piano e che piuttosto
tende ad organizzarsi attorno a una strategia mirata al controllo della produ-
zione intellettuale e del mercato editoriale 69.
Ai censori, alle dirette dipendenze del sovrano, è affidata la previa valu-
tazione della conformità dei contenuti dei manoscritti in relazione alla pre-
valente communis opinio sostenuta dalla monarchia. L’attività degli scrittori
e degli stampatori favorevoli alla corona viene sistematicamente favorita:
all’imprimatur è associata la protezione, di solito decennale, dalle ristampe
non autorizzate e dalle contraffazioni in tutto il territorio dello Stato, nonché
una garanzia di difesa dalla concorrenza, anche estera.
In Francia la definizione del sistema dei privilegi coincide con la secola-
rizzazione della censura, con l’estromissione cioè delle autorità ecclesiasti-
che dal controllo dei manoscritti, affidato a funzionari laici, inquadrati in un
68 Cfr. L. COMPAGNA, Alle origini della libertà di stampa in Francia, Laterza, Ro-
ma-Bari, 1979, pp. 189-190. 69
Cfr. E. TORTAROLO, L’invenzione della libertà di stampa. Censura e scrittori nel
Settecento, Carocci, Roma, 2011, p. 40. Non mancano tuttavia provvedimenti monar-
chici di segno esclusivamente repressivo, come quello contenuto in un’ordinanza emes-
sa dalla corona francese il 16 aprile 1757, ricordata da P. BERNARD, Traité théorique et
pratique de l’extradition, Rousseau, Parigi, 1883, p. 360: «Tous ceux qui seront con-
vaincus d’avoir composé, fait composer et imprimer des écrits tendant à attaquer la reli-
gion, à donner atteinte à notre autorité, et a troubler l’ordre et la tranquillité de nos
États, seront punis de mort. Tous ceux qui auront imprimé lesdits ouvrages, les libraires,
colporteurs et autres personnes qui les auront répandus dans le public, seron pareille-
ment punis de mort».
Fabrizio Mastromartino
– 54 –
organo centrale, la Direction de la librarie, cui è assegnato il compito di ri-
lasciare permessi e privilegi di stampa. Alla valutazione favorevole del cen-
sore segue il rilascio di un privilegio, che sancisce formalmente
l’approvazione reale dell’opera, o, in alternativa, di un permesso tacito. Dal-
la seconda metà del XVIII secolo, questa seconda tipologia di autorizzazione
prevarrà sulla prima, arrivando a comprendere circa il 57% della produzione
libraria 70.
Questo regime di controllo sulla stampa, i cui elementi repressivi sono af-
fiancati da un insieme di concessioni e privilegi per gli scrittori, gli editori e
i tipografi inquadrati nell’economia statale del libro, genera una tale compe-
netrazione tra l’autorità monarchica, i suoi funzionari e i letterati, da rendere
assai difficile l’elaborazione di espliciti argomenti intesi a rivendicare una
stampa libera dall’approvazione preventiva della censura sovrana 71. Nel
continente sono infatti pochi, scarsamente articolati – ma retoricamente inci-
sivi – gli interventi in difesa della libertà di espressione esplicitamente con-
trari a un sistema che, pur sapientemente edificato dalle istituzioni dello Sta-
to di antico regime, presta il fianco a una sostanziale inefficacia nei risultati
effettivamente raggiunti 72.
2. Dove vi è un maggiore spazio di libertà, come nelle Province Unite olan-
desi, in cui vige un regime repubblicano che fa della tolleranza religiosa e
della convivenza tra diverse confessioni la propria cifra identitaria, può capi-
tare che fiorisca il seme del libero pensiero. Esemplare, e unica nel suo tem-
po, è la rigorosa difesa della libertà di espressione svolta da Baruch Spinoza,
inimitabile precorritore della filosofia della libertà.
Collocata nell’ultimo capitolo del suo Tractatus theologico-politicus, a
chiusura della parte politica dell’opera, che occupa i quattro capitoli conclu-
sivi, l’argomentazione di Spinoza si sviluppa a partire dalla tesi che identifi-
ca la «facoltà di ragionare liberamente e di giudicare di qualsiasi cosa» con
un diritto indisponibile e inalienabile, «al quale – scrive – nessuno può ri-
nunciare, neppure volontariamente», poiché «ognuno è […] padrone dei
propri pensieri». «Violentissimo sarà dunque quello Stato – accusa – in cui
sia negata a ogni individuo la libertà di dire e di insegnare ciò che pensa».
D’altronde, spiega, in rapporto ai pensieri il pluralismo è inevitabile. Tale è
70 Cfr. S. LANDI, Stampa, censura e opinione pubblica in età moderna, Il Mulino,
Bologna, 2011, pp. 76-77 e 81. 71
Cfr. E. TORTAROLO, L’invenzione della libertà di stampa, cit., pp. 77-82. 72
Ivi, p. 78.
Per la libertà di espressione
– 55 –
la varietà delle opinioni che è facile «verificare con l’esperienza […] come
fra le teste vi siano altrettante differenze che fra i palati». L’uniformità del
pensiero non solo è improbabile; il pluralismo delle idee gli appare necessa-
rio: «non può accadere che tutti pensino le medesime cose nel medesimo
modo, e che parlino tutti a una sola voce» 73.
Certamente egli parlava una voce diversa, che aveva maturato probabil-
mente anche a causa delle drammatiche vicende che avevano contrassegnato
la sua vita. Discendente di una famiglia di ebrei che il fanatismo religioso
aveva scacciato dalla penisola iberica, nel 1656 viene scomunicato dalla
comunità ebraica di Amsterdam. Decide così di trasferirsi prima a Leida, poi
all’Aia, dove vive della sua professione di intagliatore di lenti. Geloso cu-
stode della sua indipendenza di libero pensatore rifiuta l’offerta di una catte-
dra accademica ad Heidelberg Scritto in latino e pubblicato anonimo, con falso luogo di edizione e falso
nome di editore, il Tractatus appare ad Amsterdam nel 1670. All’indomani
della pubblicazione è subito attribuito a Spinoza. Quando l’autore viene a
sapere del progetto di pubblicazione dell’opera in nederlandese, si reca per-
sonalmente ad Amsterdam per bloccarne la realizzazione, per timore che con
la traduzione l’opera avrebbe ottenuto maggiore diffusione. Infatti, già a po-
chi mesi di distanza dalla stampa, i sinodi delle Chiese d’Olanda sollecitano
l’intervento censorio e la condanna del libro da parte delle autorità politiche,
le quali accolgono con favore la censura ecclesiastica.
Dopo oltre quattro anni dalla pubblicazione la Corte d’Olanda condanna
l’opera (insieme al Leviatano di Hobbes), vietandone la circolazione. Sono
così interdette la stampa e la diffusione delle opere, in quanto sovversive
della religione riformata e calunniose nei confronti di Dio. Tuttavia, il Trac-
tatus sarà ripubblicato dallo stesso editore che, dopo le riedizioni del 1672 e
del 1673, ne darà alle stampe, con diversi stratagemmi, altre due, nel 1674 e
nel 1677. Tradotto in francese nel 1678, in inglese nel 1689 (nell’anno del
Toleration Act) e in nederlandese nel 1693 e nel 1694, è inserito nell’Index
librorum prohibitorum con i decreti del 1679 e del 1690, che ne vietano fi-
nanche la detenzione privata. Sarà pubblicato così in lingua italiana solo nel
1875.
L’opera, che sarà presto guardata come un fulgido esempio di una preco-
ce filosofia dei lumi maturata in seno alla cultura secentesca, non poteva non
destare preoccupazione nelle autorità politiche e religiose del suo tempo.
Spinoza vi espone una concezione repubblicana dell’organizzazione politica,
il cui «fine ultimo», dichiara, non consiste «nell’esercitare il dominio, né nel
73 Infra, pp. 70-71.
Fabrizio Mastromartino
– 56 –
controllare gli uomini per mezzo della paura, sottomettendoli al diritto altrui,
ma, al contrario, nel liberare ciascuno dalla paura, [...] affinché ciascuno
conservi nel modo migliore il proprio naturale diritto a esistere e a operare,
senza danni per sé e per altri». «Lo scopo della repubblica – precisa – non
consiste nel trasformare gli uomini da esseri razionali in bestie o in automi,
ma invece nel far sì che […] essi stessi facciano uso della libera ragione […]
senza fronteggiarsi con animo iniquo. Scopo della repubblica – conclude – è
dunque, in realtà, la libertà» 74.
Nel dominio della libertà, vero obiettivo del contratto sociale posto a
fondamento dello Stato, primeggia il libero pensiero, «la libertà di filosofare
e di dire quello che sentiamo»: libertà che Spinoza, in una lettera scritta a
Henry Oldenburg nel 1665, mentre si accingeva a iniziare la stesura del
Tractatus, affermava di voler «difendere in tutti i modi» 75. A suo avviso, è
una libertà che rientra in «quel che non può essere proibito» e che perciò
«deve necessariamente essere concesso». Anche quando l’autorità riesca a
sopprimerla, l’asservimento delle coscienze, afferma Spinoza, non è che ap-
parente: gli uomini «penserebbero una cosa, ma ne direbbero sempre
un’altra». Con il risultato che, poiché «ben difficilmente potrà mai accadere
che tutti parlino entro limiti prestabiliti» da altri, piuttosto che ottenere
l’uniformità del pensiero la coartazione delle idee corrompe la buona fede,
favorendo la dissimulazione 76.
Così non si muovono i cittadini all’obbedienza, scrive, ma li si incita ad
«opporre resistenza», poiché «nulla essi tollerano con maggior fastidio
quanto il fatto che si considerino dei crimini le opinioni che credono vere» 77.
Poiché consta che la natura umana è costituita in questo modo, ne consegue che le
leggi in materia di opinioni, non riguardano i disonesti, ma le persone dabbene, e
che non siano emanate per controllare i malvagi, ma piuttosto per irritare gli onesti,
e che non possano essere sostenute senza grave pericolo per lo Stato.
3. In Francia, Montesquieu è uno dei primi scrittori a schierarsi contro la pe-
nalizzazione del libero pensiero. Gli argomenti avanzati dal più autorevole
dei philosophes sono rintracciabili con fatica nella sua opera maggiore,
74 Ivi, p. 71.
75 Citato nella Introduzione, al Tractatus theologico-politicus. Trattato teologico-
politico, Bibliopolis, Napoli, 2007, a cura di P. TOTARO, p. XXI. 76
Infra, p. 74. 77
Ibidem.
Per la libertà di espressione
– 57 –
L’Esprit des lois, dove sono disseminati, disordinatamente, nei tanti capitoli
di cui essa si compone. In quella che rappresenta la summa della sua scienza
politica, e più in generale della società, alla cui elaborazione Montesquieu
attenderà per oltre vent’anni, la difesa della libertà di espressione, pur limpi-
da, non solo è espressa con cautela, ma manca di qualsiasi riferimento criti-
co verso il sistema della censura preventiva. È il segno di un’accortezza, che
incontra il senso della misura e della moderazione, probabilmente dovuta
all’esperienza personale del philosophe con il sistema regio di controllo del-
la stampa.
Nel 1721, le Lettres persanes appaiono ad Amsterdam, anonime, senza
autorizzazione e con luogo di edizione e indicazione dell’editore falsi.
L’opera viene immediatamente condannata e messa all’Indice, soprattutto
per le opinioni ivi esposte sulle questioni religiose 78. Ciò non ne impedisce
il grande successo, decretato dalla stampa di una decina di edizioni nello
stesso anno della sua apparizione. Consapevole dei rischi in cui avrebbe po-
tuto incorrere con la pubblicazione di un trattato politico, anche per L’Esprit
des lois Montesquieu evita di intraprendere una difficile negoziazione con la
censura regia. Il libro appare a Ginevra nel settembre del 1748, grazie a un
piccolo stampatore lionese trasferitosi nella Confederazione elvetica. L’anno
successivo ottiene in Francia il permesso tacito, che ne consente la pubblica-
zione a Parigi e a Lione. A distanza di due anni dalla sua circolazione nei
territori francesi, la Sorbona emette un giudizio negativo sull’opera, che nel
dicembre del 1751 è condannata dalla Congregazione dell’Indice.
È il dispotismo il vero bersaglio di Montesquieu: «Nulla – scrive – rende
[...] il delitto di lesa maestà più arbitrario che quando lo si fa consistere in
parole indiscrete»; «ovunque questa legge è stabilita – conclude perentoria-
78 A quasi quarant’anni dalla revoca dell’Editto di Nantes, che aveva nuovamente in-
fiammato la persecuzione della minoranza ugonotta presente in Francia, Montesquieu
esortava a ristabilire un regime di tolleranza religiosa, in modo da favorire l’importante
contributo sociale offerto dalle confessioni minoritarie, frenando le ambizioni di quella
dominante. Cfr. MONTESQUIEU, Lettres Persanes & Considérations, (1721), Larousse,
Parigi, 1952, p. 37: «On remarque que ceux qui vivent dans des religions tolérées se
rendent ordinairement plus utiles à leur patrie que ceux qui vivent dans la religion do-
minante, parce que, éloignés des honneurs, ne pouvant se distinguer que par leur opu-
lence et leurs richesses, ils ont portés à en acquérir par leur travail, et à embrasser les
emplois de la société les plus pénibles»; «Ce n’est point la multiplicité des religions qui
a produit ces guerres [de religion], c’est l’esprit d’intolérance qui animait celle qui se
croyait la dominante».
Fabrizio Mastromartino
– 58 –
mente – non solo non esiste più libertà, ma neppure la sua ombra»79. «Le pa-
role non formano un corpo di reato», afferma, poiché «non restano che nel
campo delle idee». Sono di fatto innocue, argomenta il philosophe, e rara-
mente rassomigliano a delle azioni esteriori, unici atti penalmente condan-
nabili. La loro intrinseca equivocità le rende tali e indifferenti per chi le ri-
ceve: «Nella maggior parte dei casi – scrive – non significano nulla in se
stesse, ma per il tono con cui vengono dette. Spesso, ripetendo le stesse pa-
role, non si rende più il senso originario: questo senso dipende dai legami
che le parole hanno con altri elementi. Talvolta il silenzio esprime più che
qualsiasi discorso. Non vi è nulla di più equivoco di tutto questo» 80.
È così stabilita una differenza tra parole e azioni, tra atti che di per sé non
meritano alcuna qualificazione penale e atti suscettibili di punizione, poiché
lesivi di diritti e interessi altrui: «Le parole che sono unite a una determinata
azione ne assumono la natura. Così, un individuo che si rechi sulla pubblica
piazza per esortare i sudditi alla rivolta è colpevole di lesa maestà, perché le
parole sono unite al fatto, e vi partecipano». «Non sono le parole che vengo-
no punite – argomenta – ma un’azione nella quale si impiegano delle paro-
le. Esse non diventano un delitto – conclude – che quando preparano, ac-
compagnano o seguono una azione delittuosa» 81.
Altrove, nel capitolo XXVII del Libro XIX, dove Montesquieu elogia la
costituzione mista inglese, che considera il modello storico meglio articolato
allo scopo di respingere il dispotismo, allude poi, solo evasivamente, ai be-
nefici che alla società deriverebbero da una stampa libera, la quale avrebbe il
pregio «di stimolare tutti i congegni del governo, rendendo attenti tutti i cit-
tadini» 82.
3. Nella dirompente e provocatoria opera di Voltaire, in rapporto alle tante
pagine dedicate al problema della tolleranza religiosa scarni e quasi episodi-
ci appaiono i riferimenti alla libertà di espressione. Forse il più significativo
è quello contenuto in un saggio minore, L’A.B.C., in cui il philosophe, im-
79 «La sola tirannia e l’ignoranza, che confondono i vocaboli e le idee più chiare –
ripeterà C. BECCARIA – possono dar questo nome [quello di lesa maestà], e per conse-
guenza la massima pena, a’ delitti di differente natura, e rendere così gli uomini, come
in mille altre occasioni, vittime di una parola». In ID., Dei delitti e delle pene, (1764),
Mursia, Milano, 1973, p. 41. 80
Infra, p. 80. 81
Ibidem. 82
Ivi, p. 82.
Per la libertà di espressione
– 59 –
personando un cittadino inglese, celebra l’importanza della libertà ottenuta
Oltremanica e in alcuni Paesi del continente:
Perché gli uomini possono abusare della scrittura, è necessario vietarne l’uso? Tanto
varrebbe che vi rendessero muto per impedirvi di fare cattive argomentazioni. Si ruba
per le strade, bisogna per questo proibire di camminarci? Si dicono sciocchezze e ingiu-
rie, bisogna proibire di parlare? Da noi ognuno può scrivere quello che pensa a suo ri-
schio e pericolo; è il solo modo di parlare alla nazione. Se essa trova che avete parlato
in modo ridicolo, vi fischia; se in modo sedizioso, vi punisce; se saggiamente e nobil-
mente, vi ama e vi ricompensa. La libertà di parlare agli uomini con la penna è stabilita
in Inghilterra come in Polonia; lo è nelle Province Unite; lo è infine nella Svezia, che ci
imita; deve esserlo nella Svizzera, senza di che la Svizzera non sarebbe degna di essere
libera. Nessuna libertà tra gli uomini, senza quella di esprimere il proprio pensiero 83.
Scritto in una fase matura del lunghissimo itinerario intellettuale del phi-
losophe, in cui Voltaire si sentiva più vicino alle idee repubblicane, L’A.B.C.
appare cinque anni dopo quel manifesto della libertà di coscienza che è il
Trattato sulla tolleranza, dove la libertà del pensiero, in particolare nelle co-
se religiose, è guardata come indomabile e ogni tentativo di costringerla a
piegarsi all’ordine dogmatico delle opinioni dominanti è giudicato destinato
al fallimento 84. Lontana dalla sistematicità del trattato di Montesquieu, la
produzione di Voltaire risponde alle sollecitazioni della storia e all’esigenza
di un’azione politica immediata: dalla rappresentazione della realtà, che il
philosophe coglie sempre acutamente, egli ricava una critica dell’esistente e
delinea proposte per la sua trasformazione, elevando il ragionamento al di là
delle particolari circostanze da cui muove.
La difesa della libertà di espressione è però appena schizzata. Più che
un’argomentazione, si può rintracciare l’affermazione di un principio, quello
della libertà di espressione come prima libertà, condizione di tutte le altre
libertà, e quello della libertà della penna, «prima arma contro la tirannide»,
ben più efficace della spada 85.
4. Sollecitata da queste voci autorevoli, nelle ultime decadi del secolo, si
impone progressivamente una richiesta sempre più insistente di sovverti-
83 VOLTAIRE, L’A.B.C., 1768, in Scritti politici, R. Fubini (a cura di), UTET, Torino,
1964, p. 884. Infra, p. 85. 84
Cfr. VOLTAIRE, Trattato sulla tolleranza, (1763), UTET, Torino, 2006: «Sarebbe
molto più facile sottomettere il mondo intero con le armi che sottomettere tutti gli spiriti
di una sola città». 85
Infra, p. 87.
Fabrizio Mastromartino
– 60 –
mento del sistema di controllo autoritario sulla stampa. Si sviluppa una linea
argomentativa che reclama un mutamento radicale nei rapporti di forza tra
gli scrittori e le istituzioni dello Stato e che corre parallela alla linea ufficia-
le, cui si sostituisce definitivamente all’indomani della Rivoluzione. È una
svolta determinata da almeno due fattori: da un lato, la grande espansione
dell’economia del libro, scaturita dall’incremento degli stampatori e so-
prattutto dei lettori; dall’altro, la notevole impressione suscitata dalle notizie
provenienti dall’altro capo dell’Atlantico, le quali fomentano la discussione
pubblica e la riflessione degli scrittori 86.
Nell’anno in cui la Virginia annuncia la propria indipendenza dalla ma-
drepatria inglese, dotandosi di una dichiarazione dei diritti in cui solenne-
mente si proclama la libertà della stampa, senza limiti né restrizioni, in Eu-
ropa iniziano a circolare idee nuove volte a mettere direttamente in discus-
sione il modello fino ad allora dominante 87.
86 Cfr. E. TORTAROLO, L’invenzione della libertà di stampa, cit., pp. 160-161.
87 All’art. XII della Dichiarazione di indipendenza della Virginia, (1776), è proclam-
ato: «The freedom of the press is one of the greatest bulwarks of liberty and can never
be restrained but by despotic governments». Ancora più esplicita è la Dichiarazione del-
la Pennsylvania, in cui è affermato che «Il popolo ha diritto alla libertà di parlare e scri-
vere e pubblicare ciò che pensa; pertanto la libertà di stampa non deve essere ristretta».
Entrambe riecheggiano nel primo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti
d’America, che vieta al Congresso federale di legiferare restrittivamente sulla materia.
Su questo vincolo costituzionale, si ricordi l’opinione scettica espressa da Alexander
Hamilton, secondo cui l’unica reale salvaguardia della libertà di stampa, così come di
tutte le altre libertà fondamentali, risiede nell’opinione pubblica, nello spirito del popolo
e nel senso di responsabilità del governo: «What signifies a declaration, that ‘the liberty
of the press shall be inviolably preserved’? What is the liberty of the press? Who can
give it any definition which would not leave the utmost latitude for evasion? I hold it to
be impracticable; and from this I infer, that its security, whatever fine declarations may
be inserted in any constitution respecting it, must altogether depend on public opinion,
and on the general spirit of the people and of the government». In HAMILTON A., MADI-
SON J., JAy J., The federalist or the new Costitution, (1788), Dutton, New York, 1961, n.
84. Notissimo è poi il sincero elogio che Alexis de Tocqueville dedicherà oltre mezzo
secolo più tardi al potere esercitato dalla stampa in America: «La stampa esercita […]
un immenso potere in America. Essa fa circolare la vita politica in tutte le zone di que-
sto vasto territorio. Con il suo occhio sempre aperto mette incessantemente a nudo i se-
greti moventi della politica e costringe gli uomini politici a comparire, di volta in volta,
davanti al tribunale dell’opinione. Essa riunisce gli interessi attorno a certe dottrine e
formula il simbolo dei partiti; attraverso di essa i partiti si parlano senza vedersi, si in-
tendono senza venire a contatto. Quando un grande numero di organi della stampa giun-
ge a procedere nella medesima direzione, la loro influenza diviene alla lunga quasi irre-
Per la libertà di espressione
– 61 –
Un intervento significativo è quello di d’Holbach – attivissimo enciclo-
pedista 88 – che pubblica tutte le sue opere fuori dai territori della corona,
sottraendosi così al controllo dei censori. Nell’Ethocratie, apparsa ad Am-
sterdam nel 1776, egli fa del libero esame e della libera discussione i privi-
legi, come tali relativi e particolari, dei sapienti e dei letterati, ai quali la
massima libertà di espressione deve essere concessa per il bene del governo
e dell’intera comunità: «Ostacolare e perseguitare la libertà di pensare, di
scrivere e di stampare – dichiara – è un’impresa tirannica e insensata, inutile
e contraria al bene della società» 89. Solo con il fondamentale contributo de-
gli scrittori – prosegue – il progresso delle istituzioni pubbliche e lo sviluppo
della vita civile sarebbero assicurati. Alla società deriverebbero innumerevo-
li vantaggi: «La legislazione potrebbe facilmente correggersi, semplificarsi,
diventare più chiara e accessibile; l’educazione, quasi impossibile a rettifi-
carsi presso un popolo schiavo e vizioso, diventerebbe fra le mani di una
saggia amministrazione – conclude – il vivaio di cittadini illuminati, virtuo-
si, capaci» 90.
Più che la rivendicazione di una libertà assoluta e universale, è un elogio
del platonico buon governo dei filosofi quello progettato da d’Holbach, la
cui opera riflette una moderazione che poco più di un decennio più tardi sa-
rebbe apparsa ben poco lungimirante. L’obiettivo del philosophe è quello di
influenzare il programma di riforme che ministri illuminati della Corona
avrebbero dovuto realizzare. D’Holbach scarta l’idea della rivoluzione come
mezzo di trasformazione sociale, contando piuttosto sulla capacità della so-
cietà di progredire sotto la guida di uomini illuminati. Nell’Ethocratie egli
propone un piano di riforme per la società cui si rivolge: «una legislazione
conforme alla virtù, che possa essere in pari tempo vantaggiosa per i Sovra-
ni, per i sudditi, per le nazioni, per le famiglie e per ogni cittadino» 91.
Alla fiducia nel governo illuminato fa da contraltare la denigrazione del
popolo soggiogato dal dispotismo:
sistibile e l’opinione pubblica, colpita sempre dallo stesso lato, finisce per cedere sotto i
loro colpi»; in TOCQUEVILLE A. de, De la démocratie en Amérique, (1835-1840), trad.
it., La democrazia in America, UTET, Torino, 2007, Libro I, p. 223. 88
Scrive quasi 400 articoli tra il 1751 e il 1765. 89
P.H.T. D’HOLBACH, Ethocratie ou le gouvernement fondé sur la morale, 1776,
trad. It Etocrazia o il governo fondato sulla morale, Milella, Lecce, 1980, pp. 172-173.
Infra, p. 94. 90
Ivi, p. 95. 91
P.H.T. D’HOLBACH, Ethocratie, cit., prefazione dell’autore, p. 37.
Fabrizio Mastromartino
– 62 –
Si trova in queste nazioni – scrive – una moltitudine di cittadini ignoranti, presun-
tuosi o perversi, che si sono abituati a guardare i loro usi più nocivi come delle cose
sacre, i loro pregiudizi come princìpi sicuri, le loro opinioni false come massime
infallibili, i loro interessi personali come quelli dell’intera nazione, le loro ingiusti-
zie come diritti inviolabili: questi sono i malati ostinati di cui un sovrano coraggio-
so e preoccupato della sua gloria deve intraprendere la cura se vuole aspirare
all’immortalità. Sono evidentemente i vizi degli uomini che provocano il dispoti-
smo e la tirannia. Occorre uno scettro di ferro per soggiogare e contenere degli
schiavi senza ragione e senza moralità, i cui eccessi soltanto la paura può arresta-
re92.
Il riconoscimento della libertà di espressione, difesa nella parte dell’opera
dove d’Holbach tratta dei princìpi generali di riforma delle leggi dello Stato
che un governo illuminato dovrebbe garantire allo scopo di salvaguardare i
diritti naturali dei cittadini, può senz’altro rimediare a questo stato di cose.
La libertà di stampa è infatti guardata come un mezzo concreto per mettere
in moto un processo che doveva portare alla diffusione dell’educazione so-
ciale, finalizzata alla costituzione di un’opinione pubblica finalmente in gra-
do di confrontarsi criticamente con il potere ecclesiastico e governativo.
5. A distanza di circa un decennio, interviene, in area germanica, la logica
sistematica del magistero di Kant, maestro, tra gli illuministi, nel fare della
battaglia della filosofia dei lumi la causa dell’umanità. «L’illuminismo –
scrive in un celeberrimo saggio – è l’uscita dell’uomo da uno stato di mino-
rità il quale è da imputare a lui stesso»; il motto oraziano, sapere aude, con
cui si esorta l’uomo ad avere il «coraggio di servirsi del proprio intelletto
senza essere guidati da un altro», è adottato da Kant come formula esplicati-
va dell’inclinazione della filosofia del rischiaramento 93. Per il suo trionfo –
prosegue – «non occorre altro che la libertà; e precisamente la più inoffensi-
va di tutte le libertà, quella cioè di fare pubblico uso della propria ragione in
tutti i campi». Il pubblico uso della ragione, «l’uso che uno ne fa, come stu-
dioso – davanti all’intero pubblico dei lettori», deve essere interamente libe-
ro; diversamente dal suo uso privato, «quello che ad un uomo è lecito farne
92 Ivi, pp. 38-39.
93 I. KANT, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, 1784, trad. it., Risposta
alla domanda che cos’è l’illuminismo?, in N. MERKER (a cura di), Editori Riuniti, Ro-
ma, 2006, p. 48.
Per la libertà di espressione
– 63 –
in un certo ufficio o funzione civile di cui egli è investito», che – conclude
Kant – può essere invece ristretto e condizionato94.
Altrove, in uno scritto minore, polemizza poi apertamente contro la fuor-
viante distinzione tra la «libertà di pensare», che presuppone banalmente un
atto interno come tale necessariamente libero da interferenze altrui, e la «li-
bertà di parlare e di scrivere», solo per mezzo della quale il pensiero può es-
sere manifestato e comunicato ad altri: «Ma in quale misura e con quale
esattezza – scrive – sapremmo noi pensare se non pensassimo per così dire
in comunione con altri cui noi comunichiamo i nostri pensieri e che a noi
comunicano i loro!» 95.
Il sentiero che conduce al terremoto politico e sociale rappresentato dalla
Rivoluzione è finalmente segnato. Due anni prima, uno dei suoi protagonisti,
Mirabeau, scrive a Federico Guglielmo II – insediatosi sul trono di Prussia
all’indomani della morte di Federico II – esortando il nuovo principe ad abo-
lire ogni forma di censura: «La sola obiezione speciosa contro la libertà illi-
mitata della stampa» – afferma – «è la licenza dei libelli. Non ci si accorge
che la libertà della stampa cancella il loro pericolo, perché in regime di li-
bertà di stampa resta solo la libertà. I libelli più calunniosi hanno potere solo
nei paesi dove non si è liberi di stampare» 96. L’anno successivo, in un acco-
rato appello a quanti avrebbero partecipato agli Stati generali di Francia,
chiede ai futuri legislatori che la prima legge licenziata consacri per sempre
la libertà della stampa, «la liberté la plus inviolable, la plus illimitée», quella
senza la quale tutte le altre libertà non potrebbero essere conquistate, poiché
è soltanto attraverso di essa che i popoli possono comprendere il proprio di-
ritto ad ottenerla e che i governanti possono riconoscere il proprio interesse
ad accordarla 97.
6. Con il colpo mortale inferto allo Stato di antico regime dalla Rivoluzione
e con la proclamazione della libertà di espressione negli articoli 10 e 11 del-
la Dichiarazione dell’89, si infrange irreversibilmente quel mondo statico e
94 Ivi, p. 50.
95 Cfr. I. KANT, Was heisst sich im Denken orientiren?, (1787), trad. it., Cosa signi-
fica orientarsi nel pensare?, in I. KANT, W. VON HUMBOLDT, Antologia, Roma, 1965,
p. 68. 96
MIRABEAU, Lettre remise à Frédéric Guillaume II, roi régnant de Prusse le jour
de son avènement au trône, 1787. L’estratto della lettera è citato da E. TORTAROLO,
L’invenzione della libertà di stampa, cit., p. 163. 97
MIRABEAU, Sur la liberté de la presse, imité de l’anglais, de Milton, cit., p. 59.
Fabrizio Mastromartino
– 64 –
monolitico, fatto di verità ufficiali e, come tali, non revocabili né modifica-
bili, creato dal potere soverchiante del dispotismo sovrano tipico dello Stato
assoluto 98. D’ora in avanti, l’ambito naturale in cui la vita del popolo si di-
spiega è quello della libertà. Alla Repubblica, ai suoi rappresentanti legisla-
tori, è fatto divieto di restringerla. Tuttavia, nei casi in cui il suo esercizio
procuri un danno ai diritti e agli interessi altrui o della società in generale, la
legge può provvedere a stabilirne dei limiti 99.
Ne deriva un paradosso, che è la cifra della distanza che separa lo spirito
della Rivoluzione dalla filosofia dei lumi, gli ideali di un secolo illuminato
dalla loro concretazione storica: alla proclamazione della libertà di manife-
stare le proprie opinioni, di «parlare, scrivere, stampare liberamente», si
contrappongono le esigenze – evidentemente superiori – della legge, che co-
sì viene costituzionalmente legittimata a reprimerne l’esercizio abusivo,
quando «turbi l’ordine pubblico» e «nei casi determinati dalla legge» stessa,
espressione di un potere che – parafrasando Montesquieu – non pone freni al
suo stesso potere, potendo essa in ogni momento svuotare la regola che at-
tribuisce una libertà, predeterminando arbitrariamente le sue eccezioni 100.
È un paradosso, questo, che favorirà un rapido arretramento della libertà
di espressione e l’affermazione in tutta Europa, negli anni della Restaurazio-
ne, di nuovi regimi e istituzioni di controllo della stampa 101. Persino Kant,
assai impressionato dagli eccessi della Rivoluzione e dall’uso disinvolto del-
la ghigliottina, attenua il proprio convincimento, relativizzandone la portata
con cauta moderazione. La famosa «libertà della penna», invocata dal più
influente illuminista tedesco in un suo scritto giustamente celebre, contropo-
tere e forma di resistenza contro l’eventuale ingiustizia recata alla comunità
dai decreti del sovrano, è «l’unico palladio dei diritti del popolo»; d’altra
parte, essa non è assoluta, ma va «tenuta nei limiti del rispetto e dell’amore
per la costituzione sotto la quale si vive dai sentimenti liberali che ispirano i
sudditi (le cui penne si limitano reciprocamente da sé per non perdere tale
98 Cfr. L. COMPAGNA, Alle origini della libertà di stampa in Francia, cit., p. 190.
99 Si ricordi l’art. 5 della Declaration: «La Loi n’a le droit de défendre que les ac-
tions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empê-
ché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas». 100
Cfr. artt. 10 e 11 della Declaration: «Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par
la Loi»; «La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à
répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi». 101
Cfr. E. TORTAROLO, L’invenzione della libertà di stampa, cit., p. 166.
Per la libertà di espressione
– 65 –
libertà)» 102. «Contestare al popolo questa libertà – aggiunge – non solo è
privarlo di ogni pretesa giuridica nei riguardi del sovrano, poiché se essa è
negata tutte le altre libertà vengono meno, ma è togliere al sovrano […] ogni
conoscenza di ciò che, se gli fosse noto, modificherebbe lui stesso, ed è por-
lo in contraddizione con se stesso» 103. Si consuma così il ripiegamento delle
aspirazioni liberali, germinali nel pensiero illuministico, sul fianco degli in-
teressi dello Stato, considerati ora sotto uno sguardo che eleva il punto di vi-
sta del principe a principio informatore dell’ordine politico e giuridico delle
libertà
Dove le maglie del sistema censorio sono ben più fitte e serrate, sono gli
scrittori stessi a contenere i propri pensieri in binari predeterminati dalle au-
torità secolari ed ecclesiastiche o a rinunciare a renderli pubblici per il timo-
re di aver in essi mal celato l’afflato della libertà che li agita. È questo il ca-
so di Pietro Verri, la cui difesa della libertà di espressione è tratteggiata in
un’operetta dimenticata e recentemente riportata alla luce, Delle nozioni
tendenti alla pubblica felicità, scritta verosimilmente tra il 1791 e il 1792.
Organizzata secondo il genere dialogico-didascalico, altrove già frequentato
dall’autore, è articolata in quattro dialoghi, in cui sono illustrati: idee genera-
li sul governo, nozioni relative all’idea di libertà e ai mezzi per condurvi il
popolo e, infine, i princìpi fondamentali necessari per mantenere una società
libera.
Della filosofia della libertà, ampiamente circolante anche nei territori ita-
liani soggetti all’Impero, come Milano, l’operetta rappresenta un tentativo di
divulgazione, allo scopo di compendiare in uno scritto breve, di semplice
comprensione, i cardini essenziali del pensiero dei lumi. È Verri stesso a de-
cidere di non dare alle stampe il manoscritto, probabilmente a causa delle
medesime ragioni opportunistiche che avevano motivato la rinuncia alla
pubblicazione di altri suoi scritti politici, le Osservazioni sulla tortura e le
Idee politiche. Motivazioni che egli così esemplifica, nel 1790, con franca
rassegnazione 104:
102 Cfr. I. KANT, Über den Gemeinspruch «Das mag in der Theorie richtig sein,
taugt aber nicht für die Praxis», (1793), trad. it., Sopra il detto comune: «Questo può
essere giusto in teoria, ma non vale nella pratica, in Scritti politici e di filosofia della
storia e del diritto, UTET, Torino, 1965, pp. 270-271. Infra, p. 105. 103
Ibidem. 104
Citato da G. Barbarisi, nella sua Introduzione a P. VERRI, Delle nozioni tendenti
alla pubblica felicità, (1791-1792), Salerno editrice, Roma, 1994, p. 9.
Fabrizio Mastromartino
– 66 –
Se fossi nato nell’Inghilterra, o nella Francia, io sarei un uomo come gli altri; nato
nell’Italia e singolarmente nel Milanese, io non posso sfogare i miei pensieri se non
collo scrivere, e per non turbare la placidezza della mia vita rinunziare all’idea di
pubblicare un libro che non conciterebbe che paura ed odio contro il suo autore.
Eppure gli argomenti rintracciabili nell’operetta riproducono quasi fe-
delmente ragionamenti svolti dai philosophes oltre vent’anni prima, come
chiaramente testimonia un passo in cui la penna di Verri sembra davvero so-
vrapporsi a quella di Voltaire, ad essa unendosi nella comune battaglia con-
tro il dispotismo 105:
Impedirete voi che si accenda fuoco perchè non seguano incendj? Se volete preve-
nire tutt’i mali, impedite che gli uomini non operino: questo sarebbe lo stato di mor-
te. Impedite che gli uomini non parlino per prevenire la bugia, la contumelia, la ca-
lunnia? Prevenite i delitti coll’impedire l’ozio, col castigare prontamente, col pre-
miare le buone azioni, col dilatare per mezzo della educazione il senso morale. Ma
è la politica degli ignoranti e de’ Tiranni quella di ammortire le azioni degli uomini,
e interdire loro le facoltà; la vita sociale si misura colla somma delle azioni, convien
diriggerle con buone leggi, ma non vincolare giammai la molla della attività.
7. I drammatici sviluppi della Rivoluzione, che culminano nell’instaurazione
del Terrore, inducono molti illuministi a indietreggiare, moderando il tono
della critica della ragione contro i rappresentanti del potere assoluto nel
Continente. Non tutti – come è invece per Kant – mostrano però di accettare
con remissione l’ostinata espressione del dispotismo nella nuova stagione
della Restaurazione. Vibrante e a tratti violenta è, per esempio, la Rivendica-
zione della libertà di pensiero scagliata dal giovane Fichte contro i principi
dell’Europa che l’hanno finora calpestata.
Scritta nel 1792, è la manifestazione della reazione virulenta che suscita-
no due editti liberticidi, emanati dalle autorità prussiane con il consenso di
Federico Guglielmo II: il primo in materia di cose religiose, in cui si con-
dannano le libere interpretazioni del testo biblico e si deplora la filosofia dei
lumi; il secondo in tema di censura, che inasprisce il controllo autoritario
sulla stampa. Nel 1791, il ministro Wöllner designa un censore unico, cui
affida la vigilanza di ogni testo manoscritto destinato alla stampa: indipen-
dentemente dalla materia trattata nel testo, in applicazione dell’editto è da
105 Cfr. infra, pp. 98-99.
Per la libertà di espressione
– 67 –
questo solo funzionario dello Stato che è fatta dipendere la sorte della pro-
duzione culturale in Prussia 106.
La Rivendicazione è una severa ammonizione rivolta a tutti i prìncipi
d’Europa, in particolare a quelli dell’area germanica, primo tra tutti il sovra-
no di Prussia, Federico Guglielmo II. È uno scritto bellicoso che, celebrando
il trionfo della Rivoluzione borghese, assume subito toni minacciosi:
Non sembra che si sia ancora compresa la lezione – tuona Fichte – di un tremendo
spettacolo di questa sorta, che ci hanno offerto i giorni nostri. Io temo non sia più
tempo, o sia l’ultimo tempo consentito, perché si aprano le dighe, se non si vuole
che esso le travolga violentemente e porti una terribile devastazione nei campi in-
torno 107.
Il discorso è una dichiarazione di guerra all’ordine politico del dispoti-
smo, una condanna inappellabile dell’asservimento ossequioso della pubbli-
ca opinione all’autorità, un’istigazione alla ribellione contro «quel detto che
la missione del principe sia di vegliare la nostra felicità». «Noi non sappia-
mo – ironizza Fichte – […] che cosa serva ad accrescere la nostra felicità;
se invece lo sa il principe ed è là apposta per guidarci verso di essa, noi dob-
biamo seguire la nostra guida ad occhi chiusi; egli fa di noi ciò ch’egli vuole
e, quando noi lo interroghiamo, ci assicura, sulla sua parola, che ciò è ne-
cessario per la nostra felicità». «No, o principe, – conclude – tu non sei il
nostro Dio. Da lui noi attendiamo la felicità; da te, la difesa dei nostri dirit-
ti»108.
Tra questi diritti, la manifestazione esteriore del pensiero – «intimo ele-
mento costitutivo della [...] personalità» dell’uomo – è forse il più fonda-
mentale: «Una delle sorgenti più ricche per la nostra istruzione e cultura –
afferma – è la comunicazione degli animi con gli animi. Al diritto di attinge-
re a questa sorgente noi non potremmo rinunziare senza rinunziare alla no-
stra spiritualità, alla nostra libertà e personalità» 109. Ribaltando
l’argomentazione svolta da Filangieri, che deduce il diritto alla libera mani-
106 V.E. ALFIERI, Prefazione a J.G. Fichte, Sulla rivoluzione francese. Sulla libertà
di pensiero, Laterza, Bari, 1966, pp. VI-IX. 107
J.G. FICHTE, Zurückforderung der Denkfreiheit von den Fürsten Europens, die
sie bisher unterdrückten, 1793, trad. it., Rivendicazione della libertà di pensiero dai
principi dell’Europa che l’hanno finora calpestata, in ID., Sulla rivoluzione francese,
cit, p. 7. Infra, p. 109. 108
Ibidem. 109
Ivi, p. 112.
Fabrizio Mastromartino
– 68 –
festazione delle idee dal dovere di ciascuno di contribuire al bene della so-
cietà 110, Fichte fonda la libertà di espressione sul diritto, passivo, di ciascu-
no di entrare in contatto con il pensiero degli altri: «Posta l’inalienabilità del
nostro diritto di ricevere – argomenta – anche l’altrui diritto di dare diviene
inalienabile» 111.
È un ragionamento, quello che si dipana nel pamphlet fichtiano, tutto in-
terno al discorso dei diritti del soggetto. La sua «spontaneità», «il suo pen-
siero» sono inviolabili: come tali, devono ricevere una protezione giuridica
dalla tirannia invincibile del potere sovrano 112. L’autorità dello Stato non è
legittimata dunque a limitare la libertà di pensiero, di espressione e di stam-
pa. Coloro che travalicano i limiti imposti dal diritto naturale alle loro fun-
zioni amministrative, imbrigliando la libera ricerca e la comunicazione dei
suoi risultati, errati o corretti che siano, sono i veri nemici dello Stato, «i soli
– accusa – colpevoli di lesa maestà», quelli che consigliano ai principi di la-
sciare i propri popoli «nella cecità e nell’ignoranza, di diffondere tra di essi
nuovi errori e mantenere vivi gli errori antichi, di impedire e proibire la libe-
ra ricerca in qualsiasi forma» 113.
Contro questi nemici dello Stato e i prìncipi che li ascoltano e ne mettono
in pratica i consigli, la sollevazione rivoluzionaria del popolo appare a Fich-
te non solo legittima ma necessaria 114:
Se veramente la cultura in vista della libertà è l’unico fine supremo
dell’associazione statale, tutte le costituzioni politiche che come fine ultimo hanno
lo scopo direttamente opposto e cioè la schiavitù di tutti e la libertà di uno solo, la
cultura di tutti per gli scopi di quest’uno e l’impedimento di tutte le specie di cultura
che conducono alla libertà del maggior numero, non soltanto sono passibili di mu-
tamento, ma debbono anche di fatto mutare.
110 Su cui vd. infra, Introduzione alla Sezione quarta, § 2.
111 Infra, p. 111.
112 Ivi, p. 114.
113 Ivi, p. 118.
114 J.G. FICHTE, Beitrag zur Berichtigung über die französische Revolution, 1793,
trad. it., Contributi per rettificare i giudizi del pubblico sulla rivoluzione francese, in
ID., Sulla rivoluzione francese, cit, pp. 111-112.