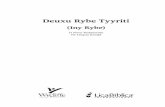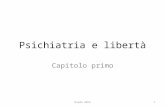Sulle tracce della verità. Percorsi religiosi tra antico e contemporaneo
Verità e libertà nel Nuovo Testamento
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Verità e libertà nel Nuovo Testamento
Verità e libertà nel Nuovo TestamentoLinee orientative per l’educazione
ernesto borGhi
«Cristo non disse di essere la tradizione, ma la verità»(Tertulliano, De virginibus velandis I,1)
1. Premessa generale
Nel rapporto tra azione evangelizzatrice (= diffusione in ogni direzione possibile della consapevolezza esistenziale che il Dio di Gesù Cristo ama ve-ramente e liberamente gli esseri umani e propone loro questo genere di amore come valore essenziale della vita) ed educazione (= attività volta a far emerge-re, in verità e libertà, il meglio dell’identità spirituale, culturale e sociale di ogni individuo), due questioni ineludibili e fondamentali sono, propriamente, che cosa siano verità e libertà. Nella frammentazione etica e culturale contempora-nea questi interrogativi sembrano peregrini, in particolare a chi vive superfi-cialità culturale e qualunquismo valoriale. Cionondimeno sono domande che compaiono sempre più, sia pure in misura variamente articolata e riflessa, non soltanto nelle speculazioni filosofiche o teologiche degli intellettuali di pro-fessione, ma anche nei discorsi della gente comune. Nel corso delle prossime pagine cercherò di offrire alcuni elementi di risposta a queste due domande, considerando quale punto di vista fondamentale il rapporto tra evangelizza-zione ed educazione attraverso un’attenzione specifica alla rivelazione neo-testamentaria, nei suoi contesti di espressione originaria e nelle sue ricadute formative per la vita del nostro tempo.
2. Verso la verità nel Nuovo Testamento
Due sono i vocaboli che l’ebraico e il greco, non soltanto nei testi biblici, ma certamente in essi, utilizzano per esprimere il concetto di verità: ’emet e alètheia. Si tratta di termini che non rendono soltanto il valore semantico che i dizionari della lingua italiana indicano per verità, ma dicono molto di più. Alè-theia ha un significato non riconducibile, come ’emet, al polo semantico fedeltà/stabilità/consistenza, ma ad un dato di ordine “visivo”. Infatti alètheia presenta
190 Ernesto Borghi
con l’a- privativo iniziale la radice dei verbi lanthànô/lethô (= nascondo qual-cosa a qualcuno, sono nascosto) indicando, quindi, un valore che è verità in quanto disvelatezza, chiara rivelazione.
Nel NT alètheia ricorre 104 volte secondo una gamma di valori semantici in cui la dimensione esistenziale ha certamente la prevalenza (80 sono le atte-stazioni in proposito).
2.1. Verità in senso esistenziale
Nell’unica ricorrenza delle versioni sinottiche (cfr. Mc 5,33), la donna che ha perso sangue per dodici anni esce dall’anonimato per raccontare a Gesù tutto quello che ha fatto e quanto le è successo, quindi tutta quanta la verità.
Questo valore esistenziale appare 18 volte nella versione giovannea.– Il prologo è molto eloquente: amore gratuito e verità sono caratteristiche
proprie del Verbo fatto carne.
14 E la Parola di vita si fece essere umano e venne ad attendarsi in mezzo a noi; e noi contemplammo la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di amore gratuito e di verità. 15 Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è passato davanti a me, perché era prima di me». 16 Dalla sua pienezza noi tutti ricevemmo e amore gratuito su amore gratuito. 17 Perché la Torà fu data attraverso Mosè, ma l’amore gratuito e la verità si realizzarono attraverso Gesù Cristo.
Un duplice dato interessantissimo in questi versetti è la rivelazione dell’a-more di Dio e della sua autenticità vera nel divenire essere umano di Dio stesso in Gesù Cristo.1 Altrettanto rilevante è l’attuazione dell’amore e della verità attraverso la figura complessiva di Gesù Cristo, ossia tramite quanto il Nazareno crocifisso e risorto è stato e ha vissuto nella sua esistenza, dalla relazione d’amore col Padre all’offerta d’amore a ogni essere umano.
– Alla donna di Samaria incontrata presso il pozzo di Sicar il Nazareno (cap. 4) fa notare come non conti il luogo in cui si presta culto a Dio:
1 «L’amore di Dio è vero, leale in quanto mantiene le promesse. Per cui in Cristo noi contempliamo l’amore vero, ossia fede, ostinato. La verità che dà sicurezza e a cui aderiamo non è altro che questo amore. La Parola è “piena di verità” non nel senso che contiene una serie di verità, ma perché costituisce l’espressione, la manifestazione dell’amore “vero” e irriducibile di Dio nei confronti degli uomini» (a. pronzato, Un vangelo per cercare: Giovanni, Gribaudi, Torino 1986, 184).
Verità e libertà nel Nuovo Testamento 191
23 Viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. 24 Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità.
Questo spirito mette gli esseri umani in condizione di elevarsi dalla ma-terialità egoisticamente chiusa in se stessa e di adorare effettivamente Dio attraverso scelte di vita ad immagine e somiglianza di quelle proprie del Dio di Gesù Cristo per l’umanità.2 I temi giovannei sono strettamente intrecciati: Gesù è la verità nel senso che egli rivela la verità di Dio agli uomini. Lo Spi-rito è lo Spirito di Gesù ed è lo Spirito di verità che deve guidare gli uomini nella verità. Questa ispirazione divina è caratteristica fondante l’adorazione nei confronti di Dio, adorazione che è effettiva se si realizza nell’adesione esistenziale alla «“verità-valore”, specchio fedele di ciò che Gesù guardando il Padre comunica a noi … Essa è totalmente orientata verso un’applicazione pratica dei valori nella vita: non è quindi solo speculativa o contemplativa, ma racchiude in sé i caratteri per una provocazione di vita reale, che si manifeste-rà nella persona di Gesù e nei suoi comandamenti. Gesù esprime tutto questo con il suo insegnamento, la sua condotta e con tutto se stesso».3
– Giovanni il battezzatore ha reso testimonianza alla verità (cfr. Gv 5,33). Gesù è via, verità e vita (cfr. Gv 14,6): in quanto Figlio amato che ama il Padre e i fratelli, è la via della salvezza perché manifesta la verità divina e umana ed è la vita perché dona l’amore, che è la vita divina stessa.4 Il Paraclito è Spirito di verità (cfr. Gv 14,17; 15,26; 16,13).
Gesù, mentre sta per arrivare al culmine della sua esperienza terrena, affer-ma: «Ma io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà a voi il Paràclito; se invece me ne vado, lo manderò a voi» (Gv 16,7). Se Gesù non giunge ad esprimere il senso culminante della sua esistenza (= mostrare il senso della vita nell’amore concreto vissuto nella morte di croce e nella risurrezione), l’amore stesso (= lo Spirito) non può entrare nell’esistenza degli esseri umani: questa è la verità che il Nazareno
2 «Se il dio della religione necessita di un tempio e di un culto, il Padre, per essere tale, ha bisogno di figli che gli assomiglino. L’assomiglianza al suo amore è l’unico culto che il Padre richiede» (a. maGGi, Come leggere il Vangelo [e non perdere la fede], Cittadella, Assisi 20094, 44).
3 u. Vanni, Il tesoro di Giovanni. Un percorso biblico-spirituale nel Quarto Vangelo, Cittadella, Assisi 2010, 109-110.
4 «La via non è una strada, ma una persona da seguire; la verità non è un concetto, ma un uomo da frequentare; la vita non è un dato biologico, ma un amore da amare» (S. Fausti, Una comunità legge il vangelo di Giovanni, EDB-Ancora, Bologna-Milano 2008, 347).
192 Ernesto Borghi
vuole manifestare.5 «Gesù rivive nei suoi e compie tra loro e con loro le sue opere più grandi per la manifestazione della giustizia divina nel mondo. La verità si manifesterà così nella sua efficacia, nella sua universalità e lì si rivelerà nel mondo il segreto del Padre. La sua vita inesauribile nascosta dagli infiniti artifici umani, è stata manifestata dal Figlio nella sua vicenda individuale. Ora dovrà compiersi come presenza ed effusione del divino nei cuori, liberati da ogni dubbio, tristezza e paura».6 E nel capitolo conclusivo dei “discorsi dell’addio”, rivolgendosi al Padre, invoca pressantemente la santità da parte sua per quanti hanno fiducia nel Dio che egli ha manifestato e manifesta e deve trattarsi di una consacrazione nella verità (cfr. Gv 17,17b.19).
– Nel dialogo tra Pilato e Gesù già processato dal Sinedrio (altro testo che leggeremo più a fondo nelle prossime pagine), all’affermazione terminale di Gesù («chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce» - 18,37b) fa riscontro il noto interrogativo del procuratore romano: «Che cosa è la verità?» (18,38).
Complessivamente si può affermare che la verità nella versione giovannea consiste nella santità della vita abitata dal rapporto costitutivo con il Vivente per eccellenza la cui Pasqua apre l’avvenire. La verità rimane un’esperienza di rinascita che pone in posizione dialettica la conoscenza e la vita nel nome del Logos venuto nello spazio e nel tempo umani. Tutto ciò lega inscindibilmente tra loro verità divina e verità umana.7
Al di fuori dei testi sinora menzionati le attestazioni ulteriori di questa parola appaiono molto pregnanti in una prospettiva che vede sempre inter-dipendenti ed interattive mente e cuore, individualità e socialità, attenzione a Dio e agli altri esseri umani. Alla ricorrenza sostanzialmente referenziale di At 26,25 (= Paolo afferma di dire parole di verità, simile, in certo modo, a quella di Rm 9,1)8 fanno seguito le altre 30 attestazioni nell’epistolario paolino.
– Nella Lettera ai Romani il discorso è tra l’esistenziale e il dottrinal-pa-storale. Infatti sin dal cap. 1 Paolo afferma che la verità di Dio è alternativa all’idolatria:
5 Cfr. u. neri, L’addio di Gesù ai discepoli: il discorso della grande consolazione (Gv 13-16), Edi-zioni San Lorenzo, Reggio Emilia 2001, 155-157.
6 r. osculati, L’evangelo di Giovanni, IPL, Milano 2000, 159.7 Cfr. p. Gire, La question de la vérité dans l’Évangile selon saint Jean, in «Recherches de Science
Religieuse» 88 (2000) 95-113.8 In ordine all’equazione verità = corrispondenza alla realtà si vedano anche, oltre a At 12,9 e
1Tm 2,7, le 12 attestazioni seguenti tratte dal Vangelo secondo Giovanni, cioè 3,33; 4,18; 5,31.32; 7,18; 8,13.14.17.26; 10,41; 19,35; 21,24 e 1Gv 2,8.
Verità e libertà nel Nuovo Testamento 193
18 In realtà l’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ogni ingiustizia di individui che soffocano la verità trattenendola nell’ingiustizia, 19 poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto; Dio stesso lo ha loro manifestato […] 25 essi cambiarono la verità di Dio nella menzogna e venerarono e adorarono la creatura al posto del creatore, che è benedetto nei secoli.
Se gli esseri umani si sottraggono alle strutture che conferiscono loro stabili-tà, direzione e senso, prestando indebita attenzione a beni penultimi e elementi del creato, vengono meno, come qualsiasi altra costruzione intelligente: è la ve-rità incontrovertibile delle cose. Se un edificio non è posto in grado di rispettare le leggi della statica e altre condizioni naturali, crolla. «Così l’uomo: rifiutando Dio o, peggio, mettendosi al suo posto, smarrisce se stesso e le sue relazioni. Questo smarrimento è l’ira di Dio».9 Il quadro qui definito non è quello relativo a chi è colpevolmente ignorante di Dio o è stato mal creato, ma quello delineato da quanti rifiutano volutamente di adorare Dio e rendergli grazie.
La verità del giudizio di Dio si contrappone al resistere alla verità e all’ob-bedire all’ingiustizia propri degli idolatri e immorali. E comunque è illusorio credere che nella Torà in sé risiedano conoscenza e verità (cfr. Rm 2,2.8.20).
La verità di Dio (= la sua fedeltà), a confronto con la possibile menzo-gna umana, non dovrebbe far scomparire completamente tale peccaminosità umana («Ma se per la mia menzogna la verità di Dio risplende per sua gloria, perché dunque sono ancora giudicato come peccatore?» - Rm 3,7)?10 Cristo è servitore di quanti sono circoncisi in favore della verità di Dio, ossia della fedeltà a se stesso e alla sua offerta di alleanza, tutto culminante in Cristo stesso (cfr. Rm 15,8).
– In 1Cor 5, con un linguaggio di chiara impostazione giudaica, Paolo dice:7 Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova, poiché siete azzimi. E
infatti la nostra Pasqua, Cristo, è stato immolato! 8 Perciò celebriamo la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con azzimi di sincerità e di verità.Il tarsiota considera condizioni indispensabili per festeggiare adeguata-
9 b. maGGioni, La lettera ai Romani, in Lettere di Paolo, a cura di B. Maggioni - F. Manzi, Cittadella, Assisi 2005, 36.
10 «Se la menzogna dell’uomo è il mezzo che permette alla verità di Dio di splendere maggiormente, rivelando tutta la sua potenza e la sua gloria, mostrando che Dio è Dio, non è il caso di pensare che si possa fare il male perché ne venga il bene? Di fronte a questa do-manda Paolo sembra particolarmente indignarsi, ritenendola quasi un’offesa personale. Chi attribuisce al suo modo di intendere il vangelo un simile fraintendimento è un diffamatore e una calunniatore e merita condanna» (ibi, 53-54).
194 Ernesto Borghi
mente la Pasqua, ossia per essere partecipi dell’esistere di chi ha donato se stesso per gli esseri umani, due valori fondamentali: una sincerità11 e una ve-rità essenziali come il pane della celebrazione pasquale. E tale invito a far fe-sta, dal riferimento alla Pasqua all’esistenza quotidiana degli individui, diventa «un’esortazione a vivere nuovi rapporti nella comunità cristiana».12
Chi vive secondo il valore decisivo di Cristo, l’amore, non può che gioire intensamente e visibilmente nella verità che è il contrario dell’ingiustizia (si potrebbe tradurre, quindi, anche onestà vera) perché è questo amore che suscita una gioia chiaramente visibile nella verità (cfr. 1Cor 13,6).
– Nelle varie attestazioni di 2Cor il discorso assume una notevole intensità e compendiarietà. Infatti Paolo ha annunziato apertamente la verità del Van-gelo, ossia il Vangelo in quanto tale (cfr. 2Cor 4,2), così come caratteristica del ministero apostolico paolino è dire parole di verità (cfr. 2Cor 6,7.8). Paolo ha detto cose vere ai Corinzi13 in senso assoluto e in riferimento a Tito (cfr. 2Cor 7,14b) e la verità di Cristo è in Paolo (cfr. 2Cor 11,10). Anche per questo il vanto di Paolo verso Dio sarebbe legittimo, dunque vero (cfr. 2Cor 12,6).
E comunque il tarsiota, al cap. 13, afferma qualcosa di teologicamente ed antropologicamente conclusivo:
5 Mettete alla prova voi stessi se siete nella fede, esaminate voi stessi. Non rico-noscete forse che Gesù Cristo abita in voi? A meno che la prova non sia contro di voi! 6 Spero tuttavia che riconoscerete che essa non è contro di noi. 7 Noi preghia-mo Dio che non facciate alcun male, e non per apparire noi superiori nella prova, ma perché voi facciate il bene e noi restiamo come senza prova. 8 Non abbiamo infatti alcun potere contro la verità, ma (possiamo fare qualcosa) per la verità.
Se per Paolo verità e parola di Dio sostanzialmente sono congruenti (cfr. il già citato 4,2), è evidente che essa abbia lo stesso potere divino (cfr. 13,4), dunque non possa essere annichilita dagli esseri umani. Cionondimeno essi e, in primo luogo, gli apostoli potranno contribuire alla diffusione della parola di Dio e, quindi, della verità.
– D’altronde la verità del Vangelo di Gesù Cristo è la sostanza del suo contenuto (cfr. Gal 2,5.14; 4,16; 5,7). L’obiettivo del tarsiota era uno solo:
11 Per la corrispondenza verità = sincerità cfr. Fil 1,18.12 r. Fabris, Prima lettera ai Corinzi, Paoline, Milano 1999, 80.13 Circa la corrispondenza verità = autenticità cfr. Tt 1,13 e anche Lc 16,11; Gv 1,9; 4,23.37;
6,32.55(2); 7,28; 8,16; 15,1; 17,3; 19,35; 1Ts 1,9; Eb 8,2; 9,24; 10,22; 1Pt 5,12; 2Pt 2,22; 1Gv 2,27; 5,20; 3Gv 12; Ap 3,7.14; 6,10; 15,3; 16,7; 19,2.9.11; 21,5; 22,6.
Verità e libertà nel Nuovo Testamento 195
difendere la verità del Vangelo. E costringere qualcuno alla circoncisione per entrare a far parte dei discepoli di Gesù Cristo e del suo annuncio di bellez-za e di bontà sarebbe stata proprio una violazione di tale verità. Essa non è un dato speculativo o intellettuale, ma è l’affermazione dell’amore di Dio a favore degli esseri umani, i destinatari Galati in primis, attraverso il Nazareno crocifisso e risorto. Il cambiamento nell’esercizio della loro libertà che ha portato i Galati a non seguire più la verità dell’evangelo non dipende certo da Paolo. Egli non ha fatto altro che promuovere il rapporto tra loro e il Signore e confida che essi ne siano consapevoli.
– Parola della verità è il Vangelo della salvezza (cfr. Ef 1,13) e obiettivo di ogni individuo deve essere quello di vivere secondo la verità nell’amore per crescere verso Cristo. Ciò significa conoscere Cristo, ossia dare ascolto all’insegnamento della verità in lui. Ne consegue l’esigenza di rinnovare pro-fondamente la propria mentalità, diventando individui veramente nuovi nella giustizia e nella santità, dunque dicendo la verità al proprio prossimo:
15 Al contrario, vivendo secondo la verità nell’amore fraterno, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo […] 17 Vi dico dunque e vi scongiuro nel Signore: non comportatevi più come i pagani nella vanità della loro mente, 18 accecati nei loro pensieri, estranei alla vita di Dio a causa dell’ignoranza che è in loro, e per la durezza del loro cuore. 19 Diventati così insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni sorta di impurità con avidità insaziabile. 20 Ma voi non così avete imparato a conoscere Cristo, 21 se proprio gli avete dato ascolto e in lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, 22 per la quale dovete deporre l’identità umana vecchia con la condotta di prima, l’iden-tità che si corrompe dietro le passioni ingannatrici 23 e dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente 24 e rivestire l’identità umana nuova, creata secondo Dio nella giustizia e nella santità vera. 25 Perciò, bando alla menzogna: dite ciascuno la verità al proprio prossimo; perché siamo membra gli uni degli altri.14
In questo quadro il riferimento ai cristiani di Efeso a comportarsi, in quan-to figli di Dio consapevoli, come figli della luce (cfr. 5,8) fa comprendere il contenuto di detto comportamento: «frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità». Vivere così è possibile se si combatte il male, anzitutto
14 «In questa comunicazione così quotidiana consiste la vita del corpo di Cristo che è la Chiesa: una moltitudine di legami e giunture, che non soltanto s’incastrano alla perfezione, ma si alimentano e si danno vita gli uni gli altri» (J. sánchez bosch, Lettera agli Efesini, in Nuovo Commentario Biblico. Atti degli Apostoli - Lettere - Apocalisse, a cura di a.J. Levoratti, tr. it., Borla-Città Nuova, Roma 2006, 410).
196 Ernesto Borghi
avendo una stretta relazione funzionale con la verità (lett. cintisi i fianchi con la verità – cfr. Ef 6,14).
Paolo invita continuativamente i cristiani di Filippi a porre mente e cuore in quello che anzitutto è vero, attribuendo questa caratteristica a quanto essi hanno appreso, ricevuto, ascoltato e visto in lui (cfr. Fil 4,8-9). E il Vangelo è parola di verità nell’annunciare la speranza e nel manifestare la grazia di Dio (cfr. Col 1,5.6).
– In 1Pt 1,22 santificare le anime obbedendo alla verità significa amarsi come fratelli. E nella Prima lettera di Giovanni le valenze dei termini sono diffe-renziate e complementari. Infatti in 1,6.8 verità significa essere in comunione con Dio, dunque non essere nelle tenebre, dicendo, nel contempo, di essere senza peccato. In 2,4 essere nella verità, vuol dire conoscere Dio e implica mettere in pratica i comandamenti, primo fra tutti amare dell’amore divino.
Diversamente la verità non sussiste in chi non agisce così. E secondo 2,21 nessuna menzogna può venire dalla verità così come (cfr. 3,18.19) amare con i fatti e nella verità è segno che si è nati dalla verità. Chi conosce Dio, ascolta chi proclama il vangelo secondo gli apostoli (4,6) e da questo ascolto si evince la verità. Comunque lo Spirito è la verità (5,6). E, in continuità con 1Gv in 2Gv 1.2.3.4, si sostiene che camminare nella verità15 significhi amarsi gli uni gli altri.
2.2. Verità in senso dottrinale
Venti volte il lessico della verità esprime questo valore in senso dottrinale e le attestazioni nelle lettere pastorali vi fanno la parte del leone (il 65% del totale).
– In 2Ts 2,10 si legge che l’amore della verità è condizione indispensa-bile per essere salvi; diversamente l’annientamento esistenziale è garantito. Qualche versetto dopo (cfr. v. 12) l’autore del testo sottolinea che chi non ha fiducia nella verità16 è destinato alla condanna divina, mentre la fede nella verità presente nei destinatari tessalonicesi appare come strumento salvifico per loro (cfr. v. 13).
– Obiettivo divino è la salvezza e la conoscenza della verità da parte di tutti gli esseri umani e Paolo è presentato come maestro dei pagani nella fede e nella verità (1Tm 2,7b). In questo quadro, si deve essere consapevoli di un fatto
15 Questa espressione ricorre anche in 3Gv 1.3.4.16 Si veda, in merito, anche 1Tm 6,5.
Verità e libertà nel Nuovo Testamento 197
fondamentale, come si arguisce sin da 1Tm 2,1: il Dio di cui si sta parlando ha quale termine essenziale della propria identità di realizzare la pienezza di vita a livello universale, pienezza che è strettamente connessa alla conoscenza della verità (= epìghnosis alêtheias).
Ma in che cosa consiste tale conoscenza? «La epìghnosis non si identifica con la ghnosis. Quest’ultima può essere la meta della mente umana, mentre la epìghnosis è la conoscenza dall’alto, che giunge come dono di Dio e interpella direttamente la fede e il discernimento nello Spirito. Il termine alètheia appar-tiene al linguaggio missionario di Paolo, dove indica il vangelo annunziato, al quale l’uomo è invitato a dare l’assenso della fede, e che, in Giovanni, si iden-tifica con lo stesso Cristo Gesù, grazie al quale si può entrare in comunione con Dio».17
Timoteo deve preoccuparsi di essere «dispensatore ortodosso della parola della verità» (2Tm 2,15) e di stare alla larga da ogni pervertitore di essa come quanti sostengono che la risurrezione si sia già verificata (cfr. v. 18). Timoteo stesso deve svolgere con mitezza il suo ministero di contrasto verso gli op-positori religiosi, confidando che essi possano essere condotti a riconoscere la verità (cfr. v. 25).
Varie donne stentano a giungere alla conoscenza della verità (cfr. 2Tm 3,7) e oppositori di essa sono anche individui che si comportano come i maghi egiziani ostili a Mosè18 (cfr. v. 8) e altri che paleseranno il loro rifiuto nei con-fronti della verità (cfr. 4,4; cfr. anche Tt 1,14).
Tito viene presentato come colui che ha il compito di apostolo di Gesù Cristo «secondo la conoscenza della verità conforme a un’autentica religiosi-tà» (cfr. 1,1) .19
La Chiesa del Dio vivente» viene prospettata come «colonna e sostegno della verità» (1Tm 3,15) e chi si allontanerà dalla fede in Gesù Cristo alla fine della storia imporrà, tra l’altro, limitazioni alimentari ai fedeli e a quanti «co-noscono la verità» (1Tm 4,3).
– Essere peccatori deliberati dopo «aver ricevuto la piena conoscenza della verità» (Eb 10,26) è condizione cristianamente indifendibile.
– E i destinatari della 2Pt sono certamente sicuri nella verità presente (cfr.
17 p. ioVino, Lettere a Timoteo, lettera a Tito, Paoline, Milano 2005, 83.18 Cfr. Es 7,11.22.ecc.19 Nel linguaggio delle lettere pastorali “la conoscenza della verità conforme alla vera re-
ligiosità” «diventa sinonimo di “conoscenza di Cristo” o del vangelo, in conformità alla fede accolta nel kerygma e divenuta coerente orientamento della vita credente» (p. ioVino, Lettere a Timoteo, lettera a Tito, 142).
198 Ernesto Borghi
1,12), ma vi sono stati dei falsi profeti che hanno condotto lontano dalla via della verità (cfr. 2,2) non poche persone.
– E il destinatario della 3Gv è chiamato a mettere quanti si sono recati da lui per ragioni apostoliche e missionarie nelle migliori condizioni possibili al fine di favorire la diffusione della verità (v. 8).
3. Verso la libertà nel Nuovo Testamento
Parlare di libertà in ambito biblico significa considerare l’essere umano nella sua globalità, quindi tenere presente che le dimensioni interiore e socia-le, spirituale e materiale, religiosa e politica sono strettamente interconnesse. Ogni momento di separazione tra questi campi della vita umana è visto come una fase patologica dell’esistenza, come un momento in cui il male prevale sul bene.
La dinamica biblica della libertà umana conosce certamente la dimensione della liberazione da una condizione variamente negativa e frustrante. D’altra parte la libertà umana autentica non è concepita al di fuori della dedizione esistenziale verso il Creatore e le creature, in particolare gli altri esseri umani. Nel Nuovo Testamento questa prospettiva è ribadita con accenti e sottoline-ature molto interessanti e gli scritti paolini presentano la stragrande maggio-ranza delle attestazioni in proposito.
– Dalle 41 attestazioni neo-testamentarie20 della radice eleuth- emerge un’i-dea di libertà che è anzitutto liberazione da ogni vincolo esterno all’essere umano che ne limiti le possibilità di sviluppo relazionale.
Questo vale per la Torà quando è vista come via di salvezza in quanto tale. Il cap. 6 della Lettera ai Romani lo mostra chiaramente. Infatti chi si è lasciato immergere nella logica di vita di Gesù e l’ha realmente accettata, non deve farsi complice di un orientamento di vita che si oppone alla vocazione data da Dio (cfr. 6,13a). Essere al servizio del peccato o essere al servizio della giustizia nell’alleanza con il Signore Dio: questa è l’alternativa secca di fronte alla quale si trova la libertà di ogni esistenza umana. Paolo la ripropone ripe-tutamente, mutando la costruzione delle argomentazioni ed osservazioni (cfr. 6,16.18-19), avvalendosi anche di ironia sarcastica (cfr. 6,20-21).
20 Cfr. Mt 17,26; Gv 8,32.33.36; Rm 6,18.20.22; 7,3; 8,2.21; 1Cor 7,21.22.39; 1Cor 9,1.19; 10,29; 12,13; 2Cor 3,17; Gal 2,4; 3,28; 4,22.23.26.30.31; 5,1.13; Ef 6,8; Col 3,11; Gc 1,25; 2,12; 1Pt 2,16; 2Pt 2,19; Ap 6,15; 13,16; 19,18.
Verità e libertà nel Nuovo Testamento 199
Egli, comunque, tiene ferma la tesi di fondo. A suo avviso l’autentica co-scienza, quella di essere stati accolti gratuitamente da Gesù Cristo nel suo Re-gno solo per amore, deve orientare gli esseri umani a respingere ogni tentativo delle vecchie abitudini, figlie e prigioniere del peccato, di essere ancora attive anzitutto nel cuore degli individui. Il tutto nella consapevolezza che liberazione, libertà e animazione da parte dello Spirito coincidono. Quanto più lo Spirito di Dio, cioè la logica d’amore divina è accettata dagli individui come motore della loro vita, tanto più essi sono liberi (cfr. 2Cor 3,17; Rm 8,21; 1Cor 10,29).
– Questo discorso risulta ulteriormente valido, quando si prendono in con-siderazione le ricorrenze dei termini del campo semantico redenzione.21 Si trat-ta del sostantivo lytron (= riscatto),22 del verbo lytrûn (= riscattare, redimere),23 dei sostantivo lytrosis (= redenzione)24 e lytrotes (= redentore).25 Essi hanno ascendenti primo-testamentari che rinviano costantemente alla grande espe-rienza della liberazione dalla schiavitù egiziana e alla conclusione dell’alleanza tra Dio e il popolo (cfr. Dt 7,6-8). Queste parole dispiegano prospettive stra-ordinarie all’umanità. Si tratta della partecipazione sia alla liberazione conse-guente al mistero pasquale (cfr. 1Cor 1,30; Rm 3,24; Mt 20,28; Mc 10,45) sia a quella alla fine della storia, che vedrà la pienezza dei frutti dell’opera divina in Gesù Cristo (cfr. Ef 1,7; 4,30; Col 1,14). È una libertà che nasce dalla libera-zione in Cristo Gesù. Egli ha deciso di mettersi a servizio degli altri donando totalmente se stesso e assumendosene le conseguenze estreme, e ciò per la loro liberazione: questa appare come la più alta delle manifestazioni della liber-tà divina nei confronti dell’uomo.
4. Verità nella libertà, libertà nella verità: letture neo-testamentarie parti-colari
4.1. Da Galati 5
1 In vista della libertà Cristo ci liberò; resistete dunque con continuità e non lasciatevi assoggettare di nuovo al giogo della schiavitù. 2 Ecco, io Paolo vi dico: se vi farete circoncidere, Cristo non vi gioverà assolutamente. 3 E testimonio an-
21 Cfr. Mt 20,28; Mc 10,45; Lc 1,68; 2,38; 21,28; 24,21; At 7,35; Rm 3,24; 8,23; 1Cor 1,30; Ef 1,7.14; 4,30; Col 1,14; 1Tm 2,6; Tt 2,14; Eb 9,12.15; 11,35; 1Pt 1,18.
22 Cfr. Mt 20,28; Mc 10,45.23 Cfr. Lc 24,21; Tt 2,14, 1Pt 1,18.24 Cfr. Lc 1,68; 2,38; Eb 9,12.25 Cfr. At 7,35.
200 Ernesto Borghi
cora una volta a chiunque si fa circoncidere che egli deve osservare tutta quanta la Torà. 4 Non aveste più nulla a che fare con Cristo voi che vi fate giustificare nella Torà; siete caduti fuori del raggio d’azione della grazia. 5 Noi infatti per virtù dello Spirito, attendiamo a partire dalla fede la giustificazione e vi speriamo. 6 Infatti in Cristo Gesù non ha alcuna importanza la circoncisione o la non circoncisione, ma la fede che si costruisce per mezzo dell’amore.
La condizione di cui si parla è quella della libertà in quanto tale (v. 1a): la prima affermazione del discorso inizia dall’esplicitazione del fine essenziale della presenza del Messia nella storia (la libertà) e termina con la realizzazione oggettiva di questa situazione (liberò).26 Tra questi due limiti Paolo colloca pri-ma l’oggetto di questo agire (noi, ossia la totalità degli esseri umani senza divi-sioni di ordine sociale o culturale) e, subito dopo, il soggetto agente (Cristo).
La libertà dal male e dalla morte è un dato acquisito per quanto attiene alla responsabilità divina: in questo versetto Paolo sintetizza in una frase quanto già ripetutamente aveva detto, in varie forme, nel corso della lettera, ma es-senzialmente in negativo (cfr. 1,4; 3,1; 4,4-5): «“liberare” ha un senso positivo, esprime il raggiungimento di una situazione ottima, il conferimento di un bene quanto mai desiderabile, la libertà, che corrisponde alla piena dignità umana».27 E, se Dio ha fatto una scelta evidente a favore degli esseri umani, la “palla” passa ora a questi ultimi: una decisione di libertà, che sia all’altezza della situazione, implica (v. 1b) una tenace e costante determinazione contro la possibilità di restare soggetti alla logica del male.28
L’egocentrismo soffocante, che è esattamente il contrario dell’opzione d’amore manifestata da Gesù sulla croce, è il male da vincere. Paolo utilizza nel v. 1b due imperativi, l’uno aoristo e l’altro presente (stêkete […] kài mê […] enéchesthe) per sottolineare quanto la resistenza in questione debba radicarsi in
26 L’aoristo indicativo che êleuthérosen evidenzia appare importante proprio nell’indicare la definitività puntuativa dell’azione espressa: l’intervento di Cristo è il discrimine decisivo della storia. E la collocazione del verbo in questione come ultima parola del v. 1a ne sottoli-nea retoricamente il valore contenutistico culminante.
27 a. Vanhoye, Lettera ai Galati, Paoline, Milano 2000, 123. 28 Commento al v. 1b: «La libertà ricevuta per grazia non è possesso inalienabile né condi-
zione di esistenza irreversibile, bensì un bene minacciato, esposto alla tentazione del ritorno al passato servile … Di qui l’esortazione a persistere nella libertà, facendo tacere il richiamo della foresta e resistendo al canto delle sirene. Si noti che non esorta a liberarsi – e in questo è antimoderno – bensì a rimanere nella libertà avuta in dono, una permanenza creativa e matu-rante: la sua attuazione nelle scelte e nell’agire di ogni giorno l’approfondisce e l’arricchisce» (G. barbaGlio, Gesù di Nazaret e Paolo di Tarso. Confronto storico, EDB, Bologna 2006, 255).
Verità e libertà nel Nuovo Testamento 201
una scelta fatta decisamente molto tempo prima, ma richieda una conferma quotidiana. Infatti il rischio di ritornare alla soggezione precedente alla croce e risurrezione di Cristo è sempre presente. Infatti i Galati, qui come in 4,8-9, con le loro scelte di allontanamento dal Vangelo di Gesù di marca paolina, stanno letteralmente ritornando allo stato di schiavitù: il linguaggio di Paolo riecheggia ancora quello esodico primo-testamentario, ma l’intensità del det-tato è ancora maggiore, come è evidente in un vero e proprio klymax nei vv. 2-3-4.
In un rapporto con Gesù Cristo, che sia carico della familiarità partecipe e del senso di responsabilità altruistico che Dio propone all’essere umano, con-ta soltanto fidarsi di Lui amandolo nella pratica della vita. La fede è la strut-tura portante e l’amore è l’energia che la anima. Si potrebbe dire che la fede è lo scheletro e l’amore è il sistema nervoso e l’insieme degli organi vitali fondamentali a cominciare dal cuore, dai polmoni e dalla circolazione sanguigna.
Si tratta di una fede, che, a partire dal radicamento nel Dio di Gesù Cristo, agisce e che esiste solo in ragione dell’amore. Ciò vuol dire delineare opere, progettare azioni, stabilire priorità di vita, focalizzare rapporti capendo l’im-portanza di passione, intelligenza e creatività. Insomma, essa è il soggetto ma il suo esistere è effettivo solo e soltanto in ragione dell’amore che traduce nella realtà, senza limiti anzitutto temporali,29 idee, prospettive e scelte.
La vita umana è davvero libera da tutto ciò che ne mortifica i giorni, se si esprime in un amore fatto secondo la figura e ad immagine dell’amore di Dio per l’umanità. La connessione pratica ed inscindibile tra fede e amore costituisce il punto d’arrivo del discorso paolino. Infatti il cuore strutturale della fede, ossia della fiducia che dà speranza e senso all’esistenza, è l’amore, il quale, però, necessita di costante discernimento circa le sue possibilità d’a-zione ritornando continuamente alla sua fonte originaria: l’agire di Dio per il mondo e per l’umanità culminato nella scelta sacrificale di Gesù Cristo, pro-clamatore dell’evangelo del Regno, morto e risorto.
4.2. Da Giovanni 3
16 Infatti Dio ha tanto amato il mondo da donare il suo Figlio unigenito, affin-ché chiunque crede in lui non sia annientato, ma abbia la vita eterna. 17 Dio non
29 La locuzione conclusiva del v. 6 è imperniata su un verbo al presente participio (energûmène) di valore mediale in cui sono del tutto chiare sia la duratività dell’azione manife-stata che la concretezza semantica della stessa: la fede attraverso l’amore opera, lavora, agisce a tutti gli effetti.
202 Ernesto Borghi
ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato attraverso di lui. 18 Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. 19 E il giudizio critico è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini amarono le tenebre piuttosto che la luce, perché le loro opere erano malvagie. 20 Chiunque infatti compie azioni vili e cattive, odia la luce e non viene alla luce affinché non siano messe sotto accusa le sue opere. 21 Ma chi opera la verità viene alla luce, affinché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in relazio-ne con Dio.
Riprendendo quanto detto nel Prologo, il testo giovanneo (vv. 19ss.) sin-tetizza la presa di posizione umana nella storica preferenza30 per la direttrice tenebre-male-insensatezza/superficialità, insomma, in definitiva irresponsabilità etica, nonostante una vita radicalmente innovativa sia a portata di mano, perché ha, in Gesù Cristo, un volto, una parola umana, dei sentimenti e dei pensieri incomparabilmente umani (v. 20).
Ogni confronto con la luce della verità, dunque l’amore di Dio in Gesù Cristo, è accuratamente evitato da chi opera “nell’oscurità”. E il fine è presto detto: sottrarsi al confronto con l’oggettiva negatività, dunque con la distrut-tività relazionale del proprio agire. Al contrario, e con una formula assai più breve, chi opta per la vita, è un facitore di verità, perché si apre con fede alla parola di Dio nell’esegesi ed ermeneutica senza eguali garantita da Gesù e agisce coerentemente. “Fare la verità” equivale a “fare il bene”. La fedeltà agli esiti di questa “analisi” ed “interpretazione” che dal Nazareno arriva all’atten-zione di ciascun essere umano costituisce la costruzione della verità possibile ad ogni individuo: l’onestà nei confronti di Dio e l’accoglimento della sua volontà quale direttrice-guida della propria vita.
Tentare di essere esegeti ed ermeneuti esistenziali sempre più autentici del-la rivelazione di Gesù conduce a non aver paura di rivelare quello che si com-pie. Anzi ci si espone alla valutazione esterna, non certo per esibizionismo o per ricercare anzitutto la conferma divina della bontà del proprio esistere ed operare, ma per rispondere concretamente e coerentemente ad un dato di fatto fondamentale. Gesù porta alla luce ciò che un uomo è e la vera natura della sua vita. Gesù è una luce penetrante, che provoca il giudizio rendendo
30 La coppia di espressioni amare/odiare dei vv. 19-20 deve essere intesa correttamente: poiché la lingua ebraica non ha termini per indicare la nozione di preferire, essa viene espressa sovente proprio con la contrapposizione ossimorica amare/odiare (cfr., in proposito, anche dei passi delle altre versioni evangeliche, come, per esempio, Mt 10,37-38; Lc 14,25-27) che propone in lingua italiana connotati più aspri e duri di quanto l’originale voglia intendere.
Verità e libertà nel Nuovo Testamento 203
evidente ciò che l’uomo realmente è. Lo scopo espresso conchiude circolar-mente quanto detto nel v. 16: far comprendere che l’agire umano si compie, anche qui dal passato al presente, nell’ambito del rapporto con Dio (v. 21).31
4.3. Da Giovanni 8
In Gv 8,31-59 si nota come la condizione di libertà sia il punto di arrivo di un processo che parte dall’ascolto della parola di Dio e passa attraverso la scelta di seguire Gesù, parola divina incarnata, nella quotidianità di ogni giorno.
Vediamo il testo, commentandolo brevemente nelle sue scansioni fonda-mentali: «31 Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto a lui: “Qua-lora rimaniate nella mia parola, siete davvero miei discepoli; 32 conoscerete la verità e la verità renderà liberi voi”». La formulazione appare simile ai proto-colli d’alleanza di Es 6,2-8 e 19,3-6. La premessa è eventuale32 (la fedeltà dei credenti era soprattutto passata33 e al Maestro, comunque, non in lui e nella sua parola), ma la condizione principale è reale (il verbo este, un indicativo pre-sente, lo dimostra). Insomma non è sicuro che vi sia tale fedeltà esistenziale, dal passato al presente, ma, in sua presenza, è certa la condizione di discepoli effettivi, quindi un ascolto pratico e quotidiano della sua parola (cfr. anche Mt 7,21-27; Lc 6,46-49).
Tale sicurezza, dall’attualità all’avvenire, vale da punto di partenza per le due affermazioni successive. Infatti la conoscenza della verità e la conseguen-te azione liberatrice posta in atto da essa sono inscindibilmente connesse a tale discepolato. Il futuro di entrambi i verbi colloca il discorso verso un av-venire senza vincoli temporali di sorta.
La relazione esistenziale con verità e libertà dipende da un effettivo rap-porto con il Dio di Gesù Cristo, rapporto che si realizza a partire da una
31 «“Fare la verità” è il contrario del “fare il male” o “le opere cattive”. Ma per fare la ve-rità bisogna prima conoscerla. Per questo bisogna che il Figlio dell’Uomo sia innalzato: in lui vediamo l’amore con cui siamo amati» (s. Fausti, Una comunità legge il vangelo di Giovanni, 71).
32 La frase condizionale, infatti, è, per la congiunzione introduttiva e il modo del verbo utilizzato, parte di un periodo ipotetico dell’eventualità. Il significato rimanere indica un rap-porto vitale, come tra il tralcio e la vite nel successivo cap. 15.
33 Il verbo che ho tradotto con che avevano creduto è un perfetto participio che esprime un’a-zione compiuta nel passato, i cui effetti si ripercuotono sul presente. D’altra parte, a giudicare dal prosieguo della disputa con Gesù, verrebbe da pensare che tali effetti contemporanei non si manifestino…
204 Ernesto Borghi
scelta di obbedienza esistenziale, di discernimento vitale rispetto a quanto il Nazareno propone con la sua parola. Si tratta di un’opzione che non può avere limitazioni neppure nelle capacità di comprensione del suo obiettivo fondante. Infatti la parola in cui si può liberamente rimanere, per essere realmente colta, deve diventare l’atmosfera, l’orizzonte, il sistema di riferimento di chi dice di assentirvi.
Gesù è l’opera di Dio, non solo uno dei tanti contenuti della vita umana, la fede non è una delle tante opere dell’esistere umano. Ogni azione, pensiero, domanda deve far riferimento a questa parola e rimanere l’orizzonte della vita. «Se rimarrete in questo orizzonte la verità vi farà liberi».34 La colloca-zione del pronome che indica i destinatari del processo di verità/libertà, cioè voi, all’ultimo posto nella triplice sequenza dei vv. 31b-32 mostra in modo cul-minante quanto sia del tutto personale l’esito benefico finale del dinamismo avviato dall’eventualità di restare fedeli alla parola del Nazareno.35
La libertà di cui egli parla suscita non nei suoi nemici, ma in coloro che hanno affermato di affidarsi a lui una reazione piccata e via via più aggressiva:
33 Gli risposero: «Noi siamo discendenza di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire: Diventerete liberi?». 34 Gesù rispose: «In verità, in verità vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. 35 Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, ma il figlio vi resta sempre; 36 qualora dunque il Figlio vi renda liberi, sarete liberi davvero. 37 So che siete di-scendenza di Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova posto in voi. 38 Io dico quello che ho visto presso il Padre; anche voi dunque fate quello che avete ascoltato da parte del padre vostro!». 39 Gli risposero: «Il no-stro padre è Abramo». Rispose Gesù: «Se siete figli di Abramo, fareste le opere di Abramo! 40 Ora invece cercate di uccidere me, che vi ho detto la verità che udii da parte di Dio; questo, Abramo non lo fece. 41 Voi fate le opere del padre vostro». Gli risposero: «Noi non siamo nati da impurità colpevole, noi abbiamo un solo Padre, Dio!». 42 Disse loro Gesù: «Se Dio fosse vostro Padre, certo mi amereste, perché da Dio uscii e sono giunto; non sono venuto da me stesso, ma egli mi ha
34 G. dossetti Jr, Per avere la vita. Lettura del Vangelo di Giovanni, Edizioni San Lorenzo, Reggio Emilia 2008, 111.
35 «Perché … Gesù era libero? Perché aveva un progetto. Libertà, infatti, non vuol dire soltanto essere liberi da condizionamenti che ci bloccano e ci impediscono di essere auten-ticamente noi stessi: vuol dire piuttosto esprimere un progetto, avere un progetto, un riferi-mento. Gesù sa e sente che la sua vita è intimamente unita al Padre, sa che non è solo, sa che c’è qualcuno in vista del quale egli agisce. Vive la sua esistenza in piena libertà che si traduce in capacità di amare, di dedicarsi, di donarsi. E ci invita ad entrare nella sua libertà, nel suo progetto» (c.m. martini, Qualcosa in cui credere, Piemme, Casale Monferrato 2010, 119).
Verità e libertà nel Nuovo Testamento 205
mandato. 43 Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non siete capaci di ascoltare la mia parola. 44 Voi siete di paternità diabolica, e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin da principio e non ha perse-verato nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando dica il falso, parla da se stesso, perché è menzognero e padre della menzogna. 45 A me, invece, voi non credete, perché dico la verità. 46 Chi di voi può accusarmi di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? 47 Chi è da Dio ascolta le parole di Dio: per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio».
I giudei pensano ad una libertà veramente tale per rendita di posizione culturale e religiosa: Abramo è il loro padre nella fede, dunque tale condizio-ne dovrebbe essere sufficiente per sottrarli a qualsiasi dipendenza culturale e sociale. Gesù parla di una libertà in atto, di un agire riconducibile ad una scelta d’amore a favore suo in quanto inviato diretto di Dio. «Il peccato per Giovanni è non credere nel Figlio, non vivere da figli e da fratelli. Per credere bisogna essere sufficientemente liberi dai pregiudizi e dai vizi che ci tengono schiavi dell’ignoranza e dell’egoismo».36 La divisione dal Divino, non l’unione costituzionale con lui realizzata nella figliolanza è il connotato qualificante di questi esseri umani. Vi è in proposito una prova oggettiva? Sì: essi, al di là delle asserzioni di fede, perseguono l’eliminazione di Gesù. La verità che egli propone è tutto ciò che ha detto e fatto sinora, parole ed azioni che essi non accettano.
A questo punto gli interlocutori del Maestro prendono le fattezze dei suoi consueti avversari nella versione giovannea e il discorso si acuisce nella parte conclusiva del capitolo:
54 Rispose Gesù: «Qualora io dica il mio valore obiettivo da me stesso, il mio valore non è nulla; chi manifesta il mio valore è il Padre mio, del quale voi dite: “È nostro Dio!”, 55 e non lo avete riconosciuto né lo conoscete. Io invece lo conosco. E qualora dica che non lo conosco, sarò come voi, un mentitore; ma lo conosco e osservo la sua parola. 56 Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e se ne rallegrò fieramente». 57 Gli dissero allora i Giudei: «Non hai ancora cinquant’anni e hai visto Abramo?». 58 Rispose loro Gesù: «In verità, in verità vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono». 59 Allora raccolsero pietre per scagliarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.
Lo scontro si acuisce perché i giudei continuano a ragionare, come succe-de spesso agli interlocutori di Gesù nel Vangelo secondo Giovanni, su un piano
36 s. Fausti, Una comunità legge il vangelo di Giovanni, 218.
206 Ernesto Borghi
storico-materiale, mentre il Nazareno è ad un livello teologico e antropologi-co sostanziale. Egli li accusa di non essere in relazione effettiva con Dio e di non essere neppure reali figli di Abramo, mentre egli è davvero in rapporto con il Padre. La massima tragedia per il cristiano sarebbe di proclamare que-sto Dio quale Dio di qualcuno senza conoscerlo lui stesso (vv. 54-55) e questo è proprio l’obiettivo del Gesù giovanneo: rivendicare di non correre assoluta-mente tale rischio esiziale.
L’affermazione teologica culminante del v. 58 esalta, nel legame con il testo di Es 3,14, l’identità essenziale del Dio del Sinai e di Gesù Cristo: una presenza di amore liberatore nella vita degli esseri umani a cominciare dal po-polo che attraverso Mosè sarà condotto a libertà storica e nel Cristo crocifisso e risorto a libertà sostanziale e definitiva.37 Essere liberi significa, in questa linea, optare per una ricerca della luce dell’amore che duri tutta una vita. Que-sto percorso è possibile soltanto se l’affermazione egocentrica della propria identità non si frappone all’inizio e al progredire lungo questo cammino. «La nostra tradizione […] si misura su di lui. Il suo amore che lo ha portato alla croce per me e per tutti è il criterio di validità di ogni tradizione».38
4.4. Da Giovanni 18
33 Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Tu sei il re dei Giudei?». 34 Gesù rispose: «Dici questo da te oppure altri te l’hanno detto sul mio conto?». 35 Pilato rispose: «Sono io forse Giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me; che cosa hai fatto?». 36 Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei
37 «Gesù è la verità che ci fa liberi. È infatti il Figlio che rivela l’identità nostra come figli e di Dio come Padre, liberandoci dalla menzogna che ci rende schiavi di una falsa immagine di lui e di noi. La Chiesa (ndr: nelle sue articolazioni confessionali, nelle sue istituzioni e nei suoi membri individuali), pur credendo in Gesù, scopre in sé una doppia paternità che si manifesta rispettivamente come fiducia/ascolto o sfiducia/non-ascolto del Figlio» (ibi, 217).
38 s. Fausti, Verità del Vangelo, libertà di figli. Commentario spirituale alla lettera ai Galati, Piem-me, Casale Monferrato 1999, 77. «Come è possibile uscire dai simboli sacri della tradizione, per affidarsi al paradossale uomo di Nazareth, privo di educazione teologica, violatore della legge, dalle origini incerte e provinciali, egocentrico e bestemmiatore? Non è meglio elimina-re un simile provocatore prima che il danno diventi irrimediabile? Oppure il volto di Dio è proprio quello e in lui si compie l’attesa più profonda della legge e dei profeti, la speranza di ogni animo buono sia in Israele che tra le genti?» (r. osculati, L’evangelo di Giovanni, 89-90). L’interrogativo resta aperto al discernimento di lettrici e lettori.
Verità e libertà nel Nuovo Testamento 207
servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». 37 Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici; io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 38 Gli dice Pilato: «Che cos’è la verità?».
Il contesto dell’intero giudizio a cui Gesù viene sottoposto è ancora una volta il confronto tra piani di discorso alternativi: da una parte vi è quella che è reputata una finzione burlesca per moltissimi e che è invece la realtà auten-tica (= Gesù re e Signore), dall’altra vi è la finzione irrealistica che, invece, si impone come realtà autentica (= la sovranità del potere religioso giudaico e del potere politico romano, che si presentano come istanze ultimative e con-dannano il detentore del vero potere assoluto, Gesù).
Pilato chiede conto a Gesù del suo agire come ragione fondamentale per la quale egli gli è stato consegnato e lettrici e lettori della versione giovannea hanno visto per tutti i capitoli precedenti che cosa il Nazareno abbia fatto e quanto “sostanzialmente” meritasse la condanna che i capi dei Giudei stanno invocando per lui. Il procuratore romano parla ad un livello effettuale imme-diato, Gesù risponde secondo un livello sostanziale complessivo.
La regalità gesuana non ha alcun connotato di prevaricazione, non può riconoscersi nelle caratteristiche distintive del potere umano, così come anche Pilato lo interpreta. «Gesù non prende il potere con la violenza, perché vuole liberarci da essa. È pastore in quanto agnello immolato, è re in quanto servo innalzato. Il suo modo di regnare restituisce all’uomo la sua verità di figlio, la sua libertà di fratello, che sa amare come è amato […]. La sua regalità è “in” questo mondo non solo in modo spiritualistico, come meta ideale della storia. È un modo concreto di vivere la quotidianità, che testimonia a tutti la bellezza di un’esistenza autentica».39
Rendere testimonianza alla verità significa condurre alla fedeltà culminante le relazioni fondamentali dell’esistenza: l’amore verso Dio nell’amore a favore degli esseri umani. E l’espressione successiva essere dalla verità significa essersi aperti alla parola divina e all’amore divino, venire alla luce (cfr. 3,19-21; 1Gv 3,19).40 Questa nozione di verità, non concettuale o intellettuale, ma com-plessivamente esistenziale, dal cuore alla mente, dall’interiorità alla socialità, è del tutto alternativa rispetto a quella, intrinsecamente mondana, a cui i capi
39 s. Fausti, Una comunità legge il vangelo di Giovanni, 452.40 Cfr. d. muñoz león, Vangelo secondo san Giovanni, in Nuovo Commentario Biblico. I Vangeli,
a cura di A.J. Levoratti, Borla - Città Nuova, Roma 2005, 1012.
208 Ernesto Borghi
giudaici e, a suo modo, Pilato stesso fanno riferimento.L’interrogativo radicale del v. 38 «Che cos’è la verità?» è quello che da
sempre l’essere umano si pone e il fatto che Pilato, invece di rispondere alla domanda di Gesù, ne ponga un’altra, sottolinea quanto egli sia lontano dal comprendere un fatto decisivo: la verità, in quel momento, sta dinanzi a lui, è la persona di Gesù con tutto quello che ciò ha significato e significa in termini di umanità generosa e libertà dal male. «La domanda rimane rivolta al lettore, a tutti. O si risponde ad essa o si uccide la verità, come Pilato. Egli ha capito qualcosa; per esempio che Gesù è innocente. Se si fosse esposto per difende-re questa verità, avrebbe capito il resto. Chi prende le difese del debole, presto o tardi esce dalla cecità e conosce la verità».41 Pilato si ritrae dalla verità, non la riconosce e la domanda posta, in un certo senso, si risponde da sola, perché verità è tutto quello che Pilato e il “mondo” che egli abita non sono.
5. Per un modello di evangelizzazione veramente e liberamente educativo
Come abbiamo visto dai percorsi biblici tratteggiati e dai testi biblici esa-minati, verità e libertà sono valori “interiorizzati” e “sociali”: il dono e la sco-perta della verità rendono veramente liberi, e l’esercizio della libertà è richie-sto anche solo per aver accesso alla verità. Dalla Bibbia emergono una verità liberante e una libertà vera e l’interazione tra queste dimensioni vi appare decisiva per fare educazione nel senso più umanizzante del termine.
Le letture bibliche condotte, pur limitate in termini di numero e di pro-fondità esegetico-ermeneutica, consentono di arrivare ad una conclusione: la nozione di amore espressa dal Primo al Nuovo Testamento e culminante nella donazione di sé fatta da Gesù di Nazaret sulla croce e nelle apparizioni da Risorto è e resta la verità fondamentale del cristianesimo e il modo cristiano paradig-matico di vivere la libertà. A fronte di questo decisivo dato di fatto, nell’attuale quadro sociale complessivo appaiono due esigenze formative fondamentali:
– come educare molti giovani che non patiscono tanto per mancanza di libertà, di possibilità ed espressività, ma per via di una libertà poco illuminata dalla verità o di interpretazioni poco veritiere della libertà;
– come far capire ad educatori ed educandi che l’adesione esistenziale alla fede cristiana è tanto più efficace ed autorevole se dalle Chiese cristiane di-scende attenzione alla verità come tradizione viva e non come tradizionali-smo autoritario, come relazione d’amore a Gesù Cristo crocifisso e risorto e
41 s. Fausti, Una comunità legge il vangelo di Giovanni, 452.
Verità e libertà nel Nuovo Testamento 209
non anzitutto come richiesta di adesione ad una serie di mere formulazioni dogmatiche.42
5.1. Le istanze fondamentali del discorso per oggi e per domani
La verità del cristianesimo fondato nella sua radice fondamentale, che non è certo la cultura greca o l’ellenizzazione, ma anzitutto il giudaismo, è, come si è visto e detto, il libero amore del Dio di Gesù Cristo verso gli esseri umani come proposta di vita globale e totalizzante alla loro libertà.
Allora la verità da ricercare sono anzitutto le realizzazioni e le possibilità di realizzazione di un amore siffatto in tutti i contesti esistenziali raggiungi-bili. In questa prospettiva credenti, atei e agnostici possono dialogare tra loro senza inimicizie, attraverso un confronto di spiritualità, che vada alla ricerca di un umanesimo davvero radicale per il bene di tutti.
Se Dio creò il mondo per amore, e quindi l’amore rende accessibile il senso ultimo della realtà, la vera identità può essere ritrovata soltanto nel prossimo; Dio non lo si può esperire nell’essere, né nell’avere, bensì nel dividere e non con-dividere, e nella tensione reciproca insita in ogni potenza amorosa. Una vita com-piuta, quindi, non è il contrap-porsi del confronto, né l’op-porsi di amore-odio, tanto meno lo è lo scom-porsi nell’antagonismo, ma il vero in-contrarsi nell’es-sere effettivamente in due. Poiché l’essere umano è un’entità dialogica, bisognosa di un Tu che lo faccia maturare, crescere e diventare il suo sé, come si fa a fargli capire con l’affetto che è nato per amare e che il modo migliore per amare il suo sé è soltanto attraverso l’apertura e l’orientamento all’altro?43
42 «Siamo così condotti alle radici dell’“emergenza educativa”, il cui punto cruciale sta nel superamento di quella falsa idea di autonomia che induce l’uomo a concepirsi come un “io” completo in se stesso, laddove, invece, egli diventa “io” nella relazione con il “tu” e con il “noi”. Tale distorsione è stata magistralmente illustrata dal Santo Padre: “Una radice essen-ziale consiste – mi sembra – in un falso concetto di autonomia dell’uomo: l’uomo dovrebbe svilupparsi solo da se stesso, senza imposizioni da parte di altri, i quali potrebbero assistere il suo autosviluppo, ma non entrare in questo sviluppo. In realtà, è essenziale per la persona umana il fatto che diventa se stessa solo dall’altro, l’‘io’ diventa se stesso solo dal ‘tu’ e dal ‘noi’, è creato per il dialogo, per la comunione sincronica e diacronica. E solo l’incontro con il ‘tu’ e con il ‘noi’ apre l’‘io’ a se stesso. Perciò la cosiddetta educazione antiautoritaria non è educazione, ma rinuncia all’educazione: così non viene dato quanto noi siamo debitori di dare agli altri, cioè questo ‘tu’ e ‘noi’ nel quale si apre l’‘io’ a se stesso”» (conFerenza episco-pale italiana, Educare alla vita buona del Vangelo, n. 9).
43 V. FranKl - p. lapide, Ricerca di Dio e domanda di senso, Claudiana, Torino 2006, 65.
210 Ernesto Borghi
5.2. Per una verità libera e una libertà vera nell’interiorità individuale e nella convivenza sociale
Che cosa è la verità? Quando Pilato rivolge questa domanda a Gesù di Na-zaret, come abbiamo letto in Gv 18,38, essa appare un terreno di confronto esistenziale assai importante ed è collocata al di fuori di dottrinalismi e teo-rizzazioni astratte, secondo una concretezza relazionale propria, in generale, dei testi delle origini cristiane. Questo interrogativo ha oggi ancora un signi-ficato al di fuori dei dibattiti della cosiddetta cultura colta? Certamente sì. A questo proposito la nostra epoca, anzitutto in Occidente, è contraddistinta da due fenomeni di grande rilevanza: da una parte, l’affermazione della verità in termini fondamentalistici; dall’altra, il desiderio di ricercare la verità in valori etici davvero umanizzanti.
L’integralismo culturale, che è alla base del primo fenomeno e si manifesta in forme “apologetiche” uguali e contrarie in campo “religioso” e “laico”, parte da un tragico presupposto: chi pensa e agisce così, crede di detenere il monopolio della verità sul senso della vita e circa le questioni fondamentali dell’esistenza dell’uomo e del mondo. Verità sa, allora, di dogmatismo avvi-lente, al di fuori di ogni libertà interpretativa.44
La maggioranza della popolazione, credo, anche in Italia, è costituita da donne e uomini che vogliono essere sempre più capaci di vivere le proprie giornate, facendo esperienza di valori veri nel senso più esistenziale possibile. Bambini, ragazzi e giovani, a seconda del loro stadio di maturazione interiore e sociale, hanno certamente bisogno di sapere come spendere al meglio la loro libertà, secondo prospettive che alcune componenti della società occi-dentale contemporanea non aiutano certo ad individuare: esempi massmedia-li come “Il grande fratello” e scelte politiche nazionali come i tagli finanziari indiscriminati degli ultimi anni in Italia in campo scolastico e universitario sono manifestazioni evidenti di una cultura che non ha a cuore la formazione
44 È legittimo domandarsi, per esempio, quanti, nei “quadri dirigenti” delle diverse arti-colazioni confessionali della Chiesa di Gesù Cristo si sentirebbero di sottoscrivere quanto segue: «La tentazione che le Chiese vivono al loro interno è quella di percepirsi totalmente in possesso della Verità di Dio e quindi di sentirsi forti e potenti nei confronti degli altri uomini. Anche tra le diverse confessioni cristiane vi è ancora la pretesa di rappresentare tutta la Ve-rità e di possederla per imporla agli altri che ne sono privi. Questo arrogante atteggiamento deriva da una concezione statica e fissa della Verità, secondo cui principi e valori sono fissati in un universo ideale intoccabile che la chiesa ha fatto suo definitivamente» (l. raniero, Ri-conciliati per riconciliare: traguardo e compito per ogni chiesa cristiana, in «Studi Ecumenici» 27 [2010] 426-427).
Verità e libertà nel Nuovo Testamento 211
interiore e sociale dell’essere umano e favorisce il depauperamento della liber-tà individuale a fini francamente assai disumanizzanti.
Sedicenti credenti e cosiddetti non credenti, d’altra parte, spesso sono in-dividui che, da varie prospettive, tentano di prendere sul serio il Vangelo di Gesù e si pongono questioni sempre più approfondite in ordine alle ragioni per cui cercare di credere o poter credere nell’amore di Gesù Cristo crocifisso e risorto nella realtà quotidiana della vita.45
Questo è l’amore che, nel I secolo d.C., ha reso Gesù di Nazaret attento, secondo le versioni evangeliche, alle esigenze di liberazione dal male di tante persone incontrate nella sua vita. Questo è l’amore che fa intimare, dal Gesù crocifisso a Dio Padre (cfr. Lc 23,34), di perdonare subito e senza remissione coloro che lo vogliono morto. Questo è l’amore che nel XX e XXI secolo ha spinto e spinge, per esempio, don Carlo Gnocchi, Marcello Candia, madre Teresa di Calcutta e Gino Strada a mettere al servizio degli altri il cuore e la mente, le risorse spirituali e materiali, nella difesa e nella promozione della di-gnità umana al di là di barriere, confini e separazioni dettate da opportunismi ed egoismi di ogni genere.
Questo amore, ossia questa autenticità esistenziale, è la verità delle verità. Essa trova cercatori ed oppositori, interpreti effettivi o solo sedicenti, trasver-salmente, tra chi si dice credente come tra chi afferma di non esserlo. Giorno dopo giorno può essere bello e utile che chiunque si chieda quanto questo amore conti nella propria vita, sempre per dare risposte sempre più mature a questo interrogativo: che cosa è la verità?
La maturità di tali risposte dipende, anzitutto nella Chiesa, ma anche in qualsiasi istituzione formativa e in ogni individuo, da una percezione decisiva: la persuasione di non detenere la Verità, ma di esserne alla ricerca costante per il bene comune, in dialogo intelligente e costruttivo con chi ha diversa ispirazione culturale e spirituale.46
45 «Un vero uomo è l’uomo libero da ogni servilismo esteriore, che non si inchina a bacia-re la mano di nessuno, né desidera che qualcuno si inchini a baciare la sua, atteggiamenti che contrassegnano l’esistenza all’insegna del potere e non della libertà. Ed è libero da ogni servi-lismo interiore, ripulisce la mente da parole e concetti uditi da altri, se non ne è intimamente convinto. Egli non obbedisce, pensa. Ma pensa per cercare di obbedire alla verità, perché sa che la più dura prigionia è quella verso se stessi e che essa può venire sconfitta solo da un amore più grande di quello verso se stessi, l’amore, appunto, per la verità che si dice come bene e come giustizia» (V. mancuso, La vita autentica, Cortina, Milano 2009, 170).
46 «Solo una comunità accogliente e dialogante può trovare le vie per instaurare rapporti di amicizia e offrire risposte alla sete di Dio che è presente nel cuore di ogni uomo. Oggi si impone la ricerca di nuovi linguaggi, non autoreferenziali e arricchiti dalle acquisizioni di
212 Ernesto Borghi
Davvero la conoscenza rende più ricco, vero e puro l’amore, e l’amore rende più profonda, paziente e tenera la conoscenza. E pur intuendo dove Lei vuol condurmi, e cioè che un amore per essere autentico chiede di essere libero e, quindi, anche la scienza che scaturisce dall’amore per la natura chiede una libertà incondizionata, bisogna fare delle precisazioni. La libertà, nell’amore come nella scienza, chiede di essere sempre accompagnata dalla responsabilità. Il gesuita Bernard Lonergan […] coniuga oggettività della conoscenza e soggettività uma-na proprio attraverso la responsabilità nella quale deve necessariamente confluire il processo conoscitivo. Il vincolo per la scienza è quindi che essa sia rispettosa della dignità umana e della libertà della persona […]. Penso che in generale ogni vita umana sia unica e irripetibile, da qualsiasi “grembo” provenga, pur ricono-scendo che non tutti i “grembi” sono uguali. Così come ogni regime di conviven-za familiare è un dono, se vissuto nell’amore; ma non tutte le convivenze garan-tiscono ai contraenti e ai loro congiunti garanzie di stabilità e di unità. Anche in questo caso inviterei chiunque a non dissociare mai la statua della libertà da quella della responsabilità. Alla Chiesa si può rimproverare una scarsa sensibilità verso la fiaccola della libertà, ma certo non verso la responsabilità e la verità, le cui sta-tue ancora nessuno ha costruito. Dice Gesù durante l’Ultima Cena: «Consacrali nella verità, la tua parola è verità» (Gv 17,17).47
In questa prospettiva è evidente quanto la verità appaia unica e quanto sia-no del tutto varie e molteplici le vie per arrivarvi. Ed è altrettanto importante sottolineare quanto le situazioni ove tale verità eminentemente relazionale non si realizza siano tragiche e devastanti per gli individui e per i gruppi sociali che vivono tale carenza. La base di riferimento può essere certamente quella che, per esempio, Benedetto XVI propone nell’enciclica Caritas in veritate (n. 19):
Paolo VI nell’Enciclica Populorum progressio osservava che le cause del sottosvi-luppo non sono primariamente di ordine materiale. Egli ci invitava a ricercarle in altre dimensioni dell’uomo. Nella volontà, prima di tutto, che spesso disattende i doveri della solidarietà. Nel pensiero, in secondo luogo, che non sempre sa orientare convenientemente il volere. Per questo, nel perseguimento dello svi-luppo, servono «uomini di pensiero capaci di riflessione profonda, votati alla ricerca d’un umanesimo nuovo, che permetta all’uomo moderno di ritrovare se stesso». Ma non è tutto. Il sottosviluppo ha una causa ancora più importante del-la carenza di pensiero: è «la mancanza di fraternità tra gli uomini e tra i popoli».
quanti operano nell’ambito della comunicazione, della cultura e dell’arte. Per questo è neces-sario educare a una fede più motivata, capace di dialogare anche con chi si avvicina alla Chie-sa solo occasionalmente, con i credenti di altre religioni e con i non credenti» (conFerenza episcopale italiana, Educare alla vita buona del Vangelo, n. 41).
47 c.m. martini, Ricerca e Carità, Editrice San Raffaele, Milano 2010, 83-84.
Verità e libertà nel Nuovo Testamento 213
Questa fraternità, gli uomini potranno mai ottenerla da soli? La società sempre più globalizzata ci rende vicini, ma non ci rende fratelli. La ragione, da sola, è in grado di cogliere l’uguaglianza tra gli uomini e di stabilire una convivenza civica tra loro, ma non riesce a fondare la fraternità. Questa ha origine da una vocazione trascendente di Dio Padre, che ci ha amati per primo, insegnandoci per mezzo del Figlio che cosa sia la carità fraterna. Paolo VI, presentando i vari livelli del processo di sviluppo dell’uomo, poneva al vertice, dopo aver menzionato la fede, «l’unità nella carità del Cristo che ci chiama tutti a partecipare in qualità di figli alla vita del Dio vivente, Padre di tutti gli uomini».
Occorre tornare a pensare e ad agire umanisticamente. A orientare la ri-cerca della verità verso quanto aiuta l’essere umano ad essere sempre meglio e sempre più intelligentemente ragionevole e radicalmente sociale, ossia dav-vero evangelico. Lo spirito dell’essere umano è troppo importante perché si lascino le sue interpretazioni dominanti nelle mani di fanatici senz’altro “religiosi” ma evidentemente non credenti e di intolleranti variamente laicisti oppure di spiritualisti alla moda o ancora di intellettuali o politici, pronti a difendere i propri interessi economici o di potere gabellandoli come difesa dei “valori cristiani”. Quanti tra loro sembrano non chiedersi mai quali siano le ragioni del perdurare dell’ingiustizia e dell’illegalità sia nel mondo cosiddetto sviluppato come nelle società più povere a livello socio-economico?
Tutti costoro, probabilmente, non hanno compreso che l’unico modo se-rio di esistere è porsi continuamente due semplici, brevi domande, partico-larmente significative: se non conosco e amo me stesso, chi lo farà al mio posto? Se non conosco e amo gli altri, chi sono? Per rispondervi, vi è una direttrice etica fonda-mentale, certo non unica, ma molto significativa: tenere stabilmente in rela-zione dinamica la conoscenza dell’idea di Dio e di essere umano che la Bibbia propone e l’ascolto quotidiano degli altri.
Oggi la disaffezione di tantissimi verso la fede cristiana proposta dalle Chiese sarà avviata a superamento e la fede cristiana autentica, cioè quella biblicamente radicata, avrà un futuro per il bene di tutti, secondo me, ad una condizione: se il Vangelo e l’essere umano, la fede e l’antropologia, l’evange-lizzazione e l’educazione procederanno da alleate interagenti. Quanti giovani, se si trovassero realmente di fronte proposte educative fondate sull’effettiva inscindibilità di questo binomio, imparerebbero a vivere la loro libertà secon-do la verità delle verità che ho prima menzionato?
Per dare a questa “alleanza” una buona prospettiva di sviluppo, è indi-spensabile credere nell’educazione dell’essere umano ad ampio, amplissimo spettro, per ogni generazione vivente nel nostro Paese e, in generale, mutatis mutandis, sul nostro Pianeta.
214 Ernesto Borghi
Nutrire questa convinzione potrebbe non bastare se non le si desse con-cretezza attraverso l’instaurazione e la cura di relazioni umane vitali e significative e spazi fisici strutturati, capaci di far crescere al loro interno forme di vita in cui bellezza e bontà siano sperimentabili. La formazione della persona, infatti, «passa attraverso la frequentazione concreta di spazi di condivisione dell’u-mano, capaci di rispondere sia ai bisogni di accoglienza, amicizia, sicurezza, operatività, sperimentazione, confronto, sia di sviluppare relazioni, conoscen-ze, capacità».48
La famiglia, la scuola, le comunità religiose, le società sportive, i centri e le associazioni culturali sono luoghi in cui l’individuo, in forme diverse, dagli aspetti fondamentali a quelli complementari, può e deve poter costruire le proprie “competenze” alla relazionalità e fare esperienza di “bellezza” e di “bontà” in base a quanto viene considerato come persona e valorizzato nelle sue capacità, doti e possibilità. E quanto più la coscienza spirituale, sociale e civile di ciascuno è favorita nella sua costruzione effettivamente umana,49 tanto più egli sarà in grado di instaurare rapporti arricchenti per sé e per altri.
5.3. Per educare alla verità nella libertà, alla libertà nella verità
In un’epoca in cui, per molte ragioni, vari aspetti della vita sono messi in discussione – le nozioni del rapporto con l’altro sesso, con il proprio corpo, con il dolore, con il tempo, con la natura, con l’inizio e la fine della vita – e non si accettano (io dico giustamente) soluzioni “facilmente prefabbricate” o “soltanto tradizionali” da chi è più o meno lontano dalla vita comune, sono sempre più indispensabili delle risposte effettivamente sapienziali alla luce del Vangelo, che siano per nulla astratte dalle questioni e dai problemi quotidiani dell’esistenza.
Per costruire itinerari formativi sempre più capaci di mettere in relazio-ne le parole evangeliche e, in generale, bibliche e la vita quotidiana degli individui, servono certamente pazienza, creatività e determinazione educa-tive, ma sono anche indispensabili risorse umane ed economiche adeguate. Queste condizioni spirituali e materiali sono e saranno presenti solo se è e sarà effettiva la fiducia nella libertà di pensiero e di azione che un confronto intelligente ed appassionato con la verità del Vangelo sviluppa per il bene
48 p. triani, Verso una rinnovata responsabilità educativa, in id. (ed.), Educare, impegno di tutti, Ave, Roma 2010, 36.
49 Cfr. e. borGhi - F. buzzi, La coscienza di essere umani, Ancora, Milano 2001, passim.
Verità e libertà nel Nuovo Testamento 215
proprio e altrui, al di fuori di steccati ideologici e settarismi religiosi di qual-siasi genere.
Il nostro tempo può offrire condizioni particolarmente favorevoli alla col-laborazione tra persone di varia ispirazione culturale, tra istituzioni religiose, sociali e politiche, senza prevaricazioni da parte di alcuno. Infatti la maggior parte della popolazione, lo ribadisco, appare non integralisticamente religiosa né laicista e neppure la società, anzitutto quella italiana, nel suo insieme lo è. Molti cristiani vorrebbero poter vivere in una Chiesa così connotata, che sa-rebbe una formidabile attraente testimonianza anche verso tante persone che la guardano, invece, con sospetto e diffidenza.50
Una Chiesa realmente ispirata a questo quadro ideale sarebbe veramente capace di guardare bene all’avvenire? Sì, perché saprebbe leggere liberamente i “segni dei tempi”, cioè riuscirebbe – e molti cristiani riescono ancora a farlo nonostante tutto e tutti – ad «individuare e ammirare nell’altro, spesso in chi non si penserebbe, il segno messianico per eccellenza che è la “fede” come coraggio di progettare il futuro. Ogni volta che ciò avviene, è un “avveni-mento” che si osserva a partire dal suo irraggiamento e dal “contagio” che provoca. Ma siccome questa fecondità messianica è mescolata ad avvenimenti di ogni specie e di altro ordine, prodotti e amplificati dall’opinione pubblica ed ecclesiale, non è facile discernerla».51
Nessuno ha il monopolio della verità e meno che mai la ricetta decisiva ed esaustiva per dire come si ama. Ogni confronto culturale serio deve essere favorito, anche in ambienti che talora ne parlano come un valore, salvo avere grandi difficoltà a praticarlo e a farlo praticare in modo davvero adulto, cioè libero e responsabile. Ma dimostrare che si può amare effettivamente l’altro è possibile. E rendere chiaro che questo fatto è quanto di più costruttivamente vero esista nella vita degli esseri umani anche oggi dipende da ciascun essere umano, quale che sia la sua ispirazione culturale, la sua condizione esistenzia-le, il suo livello di responsabilità nelle Chiese e nelle società. Senza facilonerie, senza integralismi e senza inutili paure. Sapendo che nessuno può essere libe-ro per un altro, perché la scelta se e come essere liberi e se e come essere veri spetta a ciascuno, se egli vuole essere realmente umano.
50 «Quando gli uomini – disperati, sfiduciati, tristi – vedranno cristiani sorridenti, amabili, pronti al perdono e alla condivisione, uniti nell’essenziale tra loro, saranno affascinati dalla vita evangelica e ciascuno si chiederà: “Che cosa mi impedisce di essere battezzato?” (At 8,36)» (s. Vitalini - G. zois, Ma com’è Dio? Fontana, Lugano 2010, 69-70; cfr. anche l. bet-tazzi, Vescovo e laico? Una spiegazione per gli amici, EDB, Bologna 2010, passim).
51 c. theobald, Trasmettere un vangelo di libertà, EDB, Bologna 2010, 120.




























![Panorama do Antigo Testamento [introdução da literatura do AT]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631cabbed5372c006e048d2f/panorama-do-antigo-testamento-introducao-da-literatura-do-at.jpg)