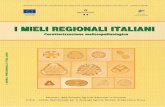La libera ricerca della verità
Transcript of La libera ricerca della verità
a cura di
FABRIZIO MASTROMARTINO
Con testi di
Milton, Spinoza, Collins, Hume, Montesquieu, Voltaire, Blackstone, d’Holbach, Condorcet, Filangieri, Verri, Kant, Fichte, Bentham,
von Humboldt, Constant, Marx, Mill
G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO
PER LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONEUN’ANTOLOGIA FILOSOFICA: DA MILTON A MILL
G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO
PER LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONEUN’ANTOLOGIA FILOSOFICA: DA MILTON A MILL
a cura di
FABRIZIO MASTROMARTINO
Con testi di
Milton, Spinoza, Collins, Hume, Montesquieu, Voltaire, Blackstone, d’Holbach, Condorcet, Filangieri, Verri, Kant, Fichte, Bentham,
von Humboldt, Constant, Marx, Mill
© Copyright 2012 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINOVIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100
http://www.giappichelli.it
ISBN/EAN 978-88-348-3943-0
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso di-verso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail [email protected] e sito web www.clearedi.org.
Sono state effettuate scrupolose ricerche ma non sono stati individuati tutti i titolari dei diritti di sfrutta-mento economico dell’opera. Il curatore resta a disposizione per ogni adempimento nei confronti degli eventuali aventi diritto.
Indice
– 1 –
INDICE
pag.
Presentazione 3
SEZIONE PRIMA
LA LIBERA RICERCA DELLA VERITÀ
Introduzione 6
I John Milton. Areopagitica 21
II Anthony Collins. Discorso sul libero pensiero 34
III John Stuart Mill. Saggio sulla libertà 42
SEZIONE SECONDA
LA LIBERTÀ DAL DISPOTISMO
Introduzione 53
IV Baruch Spinoza. Trattato teologico-politico 69
V Montesquieu. Lo spirito delle leggi 78
VI Voltaire. L’A.B.C. 84
VII D’Holbach. Etocrazia o il governo fondato sulla morale 90
VIII Pietro Verri. Delle nozioni tendenti alla pubblica felicità 97
IX Immanuel Kant. Sopra il detto comune 100
X Johann Gottlieb Fichte. Rivendicazione della libertà di pen-
siero 107
Indice
– 2 –
SEZIONE TERZA
CONTRO LA CENSURA PREVENTIVA
Introduzione 121
XI William Blackstone. Commentari sulle leggi d’Inghilterra 135
XII Condorcet. Frammenti sulla libertà della stampa 138
XIII Wilhelm Von Humboldt. Sulla libertà di stampa 147
XIV Benjamin Constant. Sul progetto di legge relativo alla censura 152
XV Karl Marx. Osservazioni sulla censura in Prussia 158
SEZIONE QUARTA
IL TRIBUNALE DELLA PUBBLICA OPINIONE
Introduzione 172
XVI David Hume. Sulla libertà di stampa 178
XVII Gaetano Filangeri. La scienza della legislazione 182
XVIII Jeremy Bentham. Libertà di stampa e discussione pubblica 188
Bibliografia (selezione) 195
Presentazione
– 3 –
Presentazione
Scopo di questa antologia è di presentare, secondo un ordine ragionato e
sistematico, i principali argomenti retorici a sostegno della battaglia per
l’affermazione della libertà di pensiero, di espressione e di stampa, condotta
da filosofi e da scrittori politici tra la metà del XVII secolo e la metà del
XIX secolo. È una battaglia intellettuale di straordinaria rilevanza per la for-
tuna della cultura politica liberale, per il successo della filosofia dei lumi e
per le sorti della Rivoluzione, che prende avvio nel laboratorio costituziona-
le dell’Inghilterra del ‘600, culmina nel fulgore dell’illuminismo che prepara
la fiammata rivoluzionaria americana e francese e si estende infine alla più
ampia discussione pubblica circa le regole che devono disciplinare la libertà
di stampa e i limiti della libertà di espressione nel nascente stato di diritto.
Oggi il libero pensiero, la libertà di espressione e la sua classica garanzia
– la libertà di stampa – sono parte del patrimonio fondamentale delle società
democratiche. Per quanto indiscutibili sotto il profilo politico e inalienabili
sotto il profilo giuridico, pongono innumerevoli nuove questioni che forma-
no oggetto di un incessante dibattito pubblico: dalla libertà della rete, al di-
ritto di critica, di satira e di cronaca e gli inevitabili conflitti con il diritto al-
la reputazione e alla privacy; dalla libertà delle arti, alla libertà
d’insegnamento, etc. La presentazione antologica dei brani selezionati forni-
sce uno strumentario concettuale, un prontuario argomentativo e un com-
pendio dei principali profili problematici attinenti a questo classico tema,
nella convinzione che i vocabolari e gli argomenti elaborati nel passato ser-
vano da guida e da orientamento nella lettura del presente.
L’antologia è organizzata in quattro sezioni tematiche – La libera ricerca
della Verità, La libertà dal dispotismo, Contro la censura preventiva, Il tri-
bunale della pubblica opinione – all’interno delle quali i brani sono ordinati
cronologicamente.
La prima sezione raccoglie testi in cui la rivendicazione della libertà di
espressione è ancorata alle esigenze dell’impresa della conoscenza; il lessico
e le modalità argomentative testimoniano ancora la preminenza del proble-
ma della tolleranza religiosa sulla questione della libertà politica: si rivendi-
ca la libertà di comunicazione delle proprie convinzioni religiose e il libero
Presentazione
– 4 –
esame delle cose alla ricerca della Verità, tanto negli studi religiosi quanto in
quelli politici.
La seconda sezione fa entrare il lettore nel vivo della battaglia illumini-
stica per la libertà di espressione, rivendicata come diritto naturale e inalie-
nabile dell’uomo contro il dispotismo dei monarchi assoluti: una rivendica-
zione che all’indomani della Rivoluzione assume i tratti di una dichiarazione
di guerra rivolta allo Stato di Antico regime.
La terza sezione presenta brani in cui la difesa della libertà di espressione
e di stampa è affiancata: a una critica radicale della censura preventiva, alla
progettazione di regole certe per il dispiegamento entro limiti definiti della
libertà di espressione, alla critica feroce della figura del censore e del ruolo
politico e sociale della censura, alla sua delegittimazione e finalmente alla
richiesta della sua definitiva abolizione.
La quarta sezione infine raccoglie testi in cui si affaccia l’idea tipicamen-
te moderna dell’opinione pubblica (formata, nel senso habermasiano, dalla
«attività razionale di un pubblico capace di giudizio»), come freno
all’arbitrio del governo, come strumento essenziale per la conservazione dei
diritti dell’uomo e come strumento di resistenza al malgoverno.
Ogni sezione tematica è corredata da un testo introduttivo che ha
l’obiettivo di guidare il lettore alla consultazione del volume, illustrando
come, nei diversi momenti storici, la questione della libertà di espressione si
sia concretamente posta e su che basi, e in che modo, sia stata affrontata e
risolta.
– Nota redazionale –
Nella trascrizione degli estratti selezionati sono state mantenute le note presenti
nella fonte utilizzata. Là dove non vi è alcuna indicazione, le note si intendono
dell’autore del brano. Quando il testo corrispondente alle note è tra parentesi qua-
dre, sono del traduttore o del curatore della fonte utilizzata. Infine, con l’espressione
N.d.C. si è inteso indicare le note scritte dal curatore della presente antologia.
Fabrizio Mastromartino
– 6 –
Introduzione
1. «[…] Dal momento che la Verità è in campo noi le faremmo torto a dubi-
tare della sua forza con censure e divieti. Lasciate che lei e la menzogna
vengano alle prese: chi ha mai visto la Verità avere la peggio in uno scontro
libero e aperto? La migliore e più ferma soppressione del falso ne è la confu-
tazione. […] Chi non sa infatti che la Verità è seconda in forza solo
all’Onnipotente? Essa non ha bisogno né di schemi politici, né di strata-
gemmi, né di censure per vincere: quelli sono i sotterfugi e le difese che
l’errore usa contro il suo potere» 1.
Quando John Milton, nel 1644, scrive queste parole nella sua celeberrima
Areopagitica, intende difendere un principio nuovo, la libertà di espressione,
con un linguaggio e uno strumentario argomentativo tradizionale, saldamen-
te ancorato alla questione più dibattuta del suo tempo: il problema della tol-
leranza religiosa. La Verità – con la maiuscola – è quella della vera fede cri-
stiana; l’errore è la via tracciata dalle opinioni che da essa si discostano; la
libertà, rivendicata dal grande poeta e letterato inglese contro la censura e
altre proibizioni, è quella di comunicare pubblicamente le proprie convin-
zioni religiose, affinché «un po’ di generosa prudenza, un po’ di tolleranza
reciproca e qualche grano di carità» spingano gli uomini «a collegarsi e
unirsi in una comune e fraterna ricerca della Verità» 2.
2. Com’è noto, la censura preventiva ha origini ecclesiastiche anteriori
all’esplosione della Riforma. Già al volgere del XV secolo e nei primi de-
cenni del ‘600, si susseguono costituzioni papali intese ad erigere un sistema
accentrato di controllo della stampa, che si realizza compiutamente con la
rifondazione dell’Inquisizione per opera del pontefice Paolo III. La Bolla Li-
cet ab initio, del 1542, recupera la vecchia legislazione medievale, avvalen-
dosi dei medesimi mezzi repressivi e aggiungendone di nuovi, come la cen-
sura preventiva sui libri, la stesura di un catalogo di libri considerati proibiti
e la predisposizione di sanzioni pecuniarie e penali per i tipografi e i librai
che non si conformino alle direttive delle gerarchie ecclesiastiche 3.
1Infra, p. 32.
2Infra, p. 31
3 Cfr. I. MEREU, Storia dell’intolleranza in Europa, Bompiani, Milano, 1975, p. 48.
Per la libertà di espressione
– 7 –
In Inghilterra, all’introduzione nel Paese delle prime presse per la stampa
fanno immediatamente seguito, già con Enrico VIII, provvedimenti mirati a
sottoporre la nuova arte tipografica al controllo regio. Nel 1557, le ordinanze
emesse dalla Regina Maria decretano che uno scritto può essere stampato
solo dopo aver ricevuto la formale autorizzazione della Corona e dopo esse-
re stato iscritto nel registro della Corporazione dei Librai (Company of Sta-
tioners), alla quale sono delegati il sequestro e la distruzione degli scritti non
autorizzati. Ma un vero e proprio sistema censorio è stabilito negli anni suc-
cessivi da Elisabetta I, con l’Atto di uniformità (1559) e con l’Atto di su-
premazia (1563), con cui viene sancito lo scisma della Chiesa d’Inghilterra
dall’autorità di Roma ed è rafforzato il controllo sulle opinioni religiose. Nel
1586 la Camera Stellata, organo giurisdizionale della Corona cui è affidato
l’ufficio della censura, introduce l’obbligo dell’imprimatur, l’apposizione,
all’inizio o alla fine del volume stampato, di una formula con cui si rende
visibile al pubblico l’ottenuta approvazione dell’arcivescovo di Canterbury e
del vescovo di Londra.
Questa disciplina legale della censura preventiva è periodicamente rinno-
vata fino al decreto emesso dalla Camera Stellata nel 1637 (Decree of Star-
re-Chamber concerning printing), che conferma il divieto di pubblicazione
di «libri o pamphlets sediziosi, scismatici o offensivi, costituenti uno scan-
dalo per la Religione, o la Chiesa o il Governo, o i Governanti della Chiesa o
dello Stato», consentendo solo la stampa del libro «legalmente licenziato e
autorizzato» da speciali autorità e «inscritto nei registri della Corporazione
dei Librai» 4.
3. Pochi anni dopo, quando si innesca quel conflitto tra re e Parlamento che
segnerà irreversibilmente la storia costituzionale inglese, la Camera Stellata
viene destituita: il Parlamento, nel 1641, ne decreta l’abolizione, avviando
l’abbattimento della struttura legislativo-giudiziaria di controllo della stam-
pa. Si realizza così un brevissimo periodo di sostanziale libertà, in assenza di
una regolamentazione giuridica vigente, che suscita un tale fervore culturale
– di cui è protagonista lo stesso Milton, che tra il 1641 e il 1642 pubblica
ben cinque scritti antiepiscopali – da indurre lo stesso Parlamento ad indie-
treggiare. Accingendosi a riformare l’ordinamento della Chiesa
d’Inghilterra, la cui discussione si realizza in un clima di forte conflitto tra
fazioni concorrenti (episcopalisti, presbiteriani, indipendenti), il Parlamento,
dopo aver reso nullo il decreto, lo ripristina, con lievi modifiche, il 14 giu-
4 Cit. in BREGLIA, Prefazione a J. MILTON, Areopagitica: discorso per la libertà del-
la stampa, Laterza, Bari, 1933, pp. XVIII-XIX.
Fabrizio Mastromartino
– 8 –
gno 1643, per volontà soprattutto dei presbiteriani, spalleggiati dalla corpo-
razione degli Stationers, che pretendeva il ripristino dei propri privilegi eco-
nomici. Contemporaneamente è istituita l’Assemblea di Westminster, com-
posta da 150 membri, cui è affidato il compito di stabilire il governo e la li-
turgia della Chiesa d’Inghilterra.
Meno di due mesi dopo, Milton pubblica il suo trattato sul divorzio, Doc-
trine and discipline of divorce, che gli procura immediatamente l’accusa
mossa dagli Stationers di aver contravvenuto al nuovo Licensing Act, aven-
do fatto stampare il libro senza previa autorizzazione e senza averlo iscritto
nei registri della Corporazione. Un anno dopo, il 13 agosto 1644, uno dei
teologi dell’Assemblea di Westminster – Palmer – pronuncia un sermone
davanti alle due camere in cui condanna il trattato di Milton, stigmatizzan-
dolo come «un perfido libro che era in circolazione senza la debita licenza
dei censori, sebbene meritasse d’esser bruciato – il cui autore era stato così
impudente da apporvi il suo nome e da dedicarlo al Parlamento stesso» 5.
L’Areopagitica è la risposta che Milton oppone a queste accuse.
4. Composta in soli tre mesi, tra settembre e novembre del 1644, è univer-
salmente riconosciuta come un monumento letterario alla libertà intellettua-
le. Organizzata secondo lo schema canonico dell’orazione classica, richia-
mato esplicitamente nel titolo dell’opera – che è quello della settima orazio-
ne del retore ateniese Isocrate –, è giustamente considerata una delle più ra-
dicali difese della cultura laica e della libertà di espressione di ogni tempo,
nonostante tra i suoi contemporanei abbia trovato scarsa fortuna e non abbia
avuto alcun impatto politico apprezzabile. Solo nel 1695 il Parlamento deci-
derà infatti di non rinnovare il Licensing Act, smantellando così implicita-
mente il regime della censura preventiva. Nel suo secolo il pamphlet di Mil-
ton susciterà inoltre poco interesse. Verrà ripubblicato solo nel 1738, se si
esclude una versione in compendio stampata nel 1693. E soprattutto sarà so-
lo sporadicamente menzionato dalla gran parte degli scrittori e degli uomini
politici del suo tempo, forse anche a causa della mancanza nel testo di rife-
rimenti a princìpi generali circa la libertà di stampa e al contemperamento di
questa libertà con gli interessi dello Stato 6. Sarà però riscoperto durante il
‘700, specialmente in Francia, dove alla vigilia della Rivoluzione Mirabeau
5 Cit. ivi, p. XX.
6 Cfr. F.S. SIEBERT, Freedom of the press in England : 1476-1776 : the rise and de-
cline of government controls, University of Illinois Press, Urbana, 1952, p. 197.
Per la libertà di espressione
– 9 –
ne ricaverà un appassionato appello agli Stati generali in vista della redazio-
ne della Dichiarazione dell’89 7.
Il valore, non solo letterario ma filosofico, dell’Areopagitica è peraltro
indiscusso. Contro il tentativo di rinnovare l’alleanza tra potere religioso e
potere politico, rinsaldata con il nuovo decreto sulla censura, Milton esorta il
Parlamento a cancellare un provvedimento che giudica destinato a risultare
inefficace, rispetto ai suoi legittimi obiettivi, e soprattutto inevitabilmente
nocivo per la società inglese. Lungi dal sopprimere i libri scandalosi o sedi-
ziosi, il decreto – denuncia Milton – avrà l’effetto perverso di dissuadere gli
uomini dallo studio e dalla ricerca della verità, lo scopo più nobile dello spi-
rito umano. La severa compressione della libertà di stampa realizzata
dall’ordine del Parlamento frustrerà ogni attività intellettuale, ponendo una
grave ipoteca sulla causa della conoscenza.
Notissima è la rappresentazione celebrativa del libro, della sua importan-
za quasi sacrale, tratteggiata da Milton al principio del pamphlet: «I libri –
scrive – [...] non sono per nulla cose morte, bensì contengono in sé una po-
tenza di vita che li rende tanto attivi quanto quello spirito di cui sono la pro-
genie; di più, essi preservano come in una fiala la più pura forza ed essenza
di quel vivente intelletto che li generò», «quell’essenza eterea e sublime»
che è «il respiro della ragione stessa». «È quasi uguale uccidere un uomo
che uccidere un buon libro. Chi uccide un uomo – spiega – uccide una crea-
tura ragionevole, immagine di Dio, ma chi distrugge un buon libro uccide la
ragione stessa», «un’immortalità più ancora che una vita». Ciò che viene
perduto, afferma Milton, è così importante che «il volgere degli evi spesso
non recupera la perdita di una verità respinta, per la cui mancanza popoli in-
teri vengono a soffrire» 8.
La censura, costringendo un autore a sottostare all’arbitrio di un supervi-
sore, «che può cancellare o alterare ciò che non si accordi strettamente con
la mentalità bigotta che chiama suo giudizio», è la massima espressione di
un paternalismo di Stato che, fingendo di assistere gli scrittori nella ricerca
della verità, li espropria della loro stessa identità, svilendone l’originalità e
l’eccentricità in rapporto alle opinioni consolidate. Il risultato, conclude Mil-
ton, è la mortificazione della cultura e dell’attività intellettuale: alla censura
dei libri che potrebbero far avanzare l’uomo lungo la via della verità fa da
contraltare la pubblicazione dei soli libri autorizzati, che, essendo espressio-
ne di ciò che è «già comunemente accettato», appaiono a Milton – che cita
7 Cfr. MIRABEAU, Sur la liberté de la presse, imité de l’anglais, de Milton, (1788),
Parigi, 1792, (edizione elettronica). 8 Infra, p. 22.
Fabrizio Mastromartino
– 10 –
l’autorevole opinione di Bacone – niente più che «il linguaggio dei tempi»,
specchio fedele di conoscenze acquisite, valide, come tali, solo per la pro-
pria epoca 9.
5. «La comune e fraterna ricerca della verità», afferma Milton, è un’impresa
collettiva che rifugge l’uniformità delle opinioni. L’avanzamento nella co-
noscenza avviene per gradi. È un’attività progressiva nella quale l’errore,
l’opinione difforme dalle idee già comunemente accettate, possiede
un’importanza fondamentale: «molte – scrive – devono essere le spaccature
e molti i tagli nella cava e nel legno prima che la casa del Signore possa ve-
nir costruita. E quando poi ogni pietra è ben sistemata con le altre, non può
essere unita in un tutto continuo, non può altro, in questo mondo, che essere
contigua, né ogni parte della costruzione può essere di una sola forma – no –
, la perfezione consiste piuttosto in questo: che da molte moderate varietà e
fraterne dissomiglianze, che non siano troppo sproporzionate, nasce la bella
e leggiadra simmetria che rende grata l’intera massa e struttura» 10.
Torna qui esplicitamente il registro religioso, di cui il Discorso di Milton
è pregno, svelando plasticamente quanto, ancora alla metà del ‘600, la ri-
vendicazione della libertà di espressione sia tributaria della richiesta di un
regime di tolleranza religiosa, nel quale diverse confessioni, non più declas-
sate a sètte eterodosse, possano convivere pacificamente, con le chiese alli-
neate ai dogmi ufficiali, sotto un’unica casa, che è quella di Cristo. La meta-
fora usata da Milton è quella, classica, della parabola della zizzania, in cui è
detto che «i servitori gli dissero: Vuoi dunque che andiamo e le cogliamo?
Ma egli disse: No, che talora, cogliendo le zizzanie, non diradichiate insieme
con esse il grano»; dove «il campo è il mondo, e la buona semenza sono i
figliuoli del regno, e le zizzanie sono i figliuoli del maligno; e il nemico che
l’ha seminate è il diavolo, e la mietitura è la fin del mondo, e i mietitori sono
gli angeli» 11.
Nella visione di Milton, critico severo della persecuzione per motivi reli-
giosi, la parabola illustra l’insegnamento del Nuovo Testamento secondo cui
la Chiesa non possiede armi “materiali”, ma solo spirituali per condurre gli
uomini alla verità cristiana: «Non è possibile per l’uomo – scrive – separare
il grano dalle erbacce [...]; ciò sarà compito degli Angeli alla fine delle cose
mortali. Se tutti quindi non possono essere dello stesso parere – e chi
s’aspetta che lo siano? – è senza dubbio più salutare, giudizioso e cristiano
9 Infra, p. 28.
10 Infra, p. 31.
11 Matteo, XIII, 28-29 e 38-39.
Per la libertà di espressione
– 11 –
che molti siano tollerati piuttosto che tutti quanti forzati» 12. «Se […] noi –
prosegue –, nella fretta di un precipitoso zelo, non facessimo distinzione, ma
decidessimo di chiuder loro le bocche perché temiamo essi vengano con
nuove e pericolose opinioni, come noi comunemente le giudichiamo a priori,
prima ancora di averle capite – maledetti noi, che pensando così di difendere
il Vangelo ne siamo i persecutori» 13.
Dalla tolleranza, argomenta Milton, tutti invece trarrerrebbero beneficio.
Non solo coloro che propugnano opinioni errate, ma anche chi percorre la
via della verità, poiché – spiega – «molte sono le vie per trarre vantaggio da
coloro che, non soddisfatti da formule trite, sono capaci di concepire ed
esporre al mondo nuovi punti di vista. E fossero essi anche solo come la
polvere e la cenere dei nostri piedi, fin tanto che in quella forma possano an-
cora servire a lustrare e a far splendere l’arsenale della Verità, persino così
12 Analoga lettura è sostenuta da Roger WILLIAMS in quella che doveva apparire la
più radicale condanna della persecuzione per motivi religiosi pubblicata in Inghilterra,
stampata nello stesso anno dell’Areopagitica e immediatamente condannata dal Parla-
mento al rogo: «Cristo comanda che le zizzanie e il grano, che alcuni intendono essere
coloro che camminano nella verità e coloro che camminano nella menzogna, debbano
essere lasciate stare nel mondo e non estirpate prima del raccolto, che è la fine del mon-
do». In Id., La sanguinaria dottrina della persecuzione per causa di coscienza, Giappi-
chelli, Torino, 1994, p. 11. «E la ragione sembra essere – spiega Williams – che coloro
che ora sono zizzania possono in seguito diventare grano; coloro che adesso sono cie-
chi, possono in seguito vedere; coloro che adesso Gli resistono, possono in seguito rice-
verLo». Ivi, p. 12. Evidente in entrambi i passi è il richiamo alla lezione erasmiana: «Gli
schiavi che vogliono falciare la zizzania prima del tempo sono coloro che pensano che i
falsi apostoli e gli eresiarchi debbano essere soppressi con la spada e i supplizi. Il pa-
drone del campo, invece, non vuole che vengano sterminati, ma che siano tollerati per il
caso che si emendassero e da zizzania diventassero frumento. Se poi non si ravvedono,
si lasci al loro giudici di punirli un giorno». ERASMO DA ROTTERDAM, Parafrasi su San
Matteo, in Opera omnia, 1703, vol. VII, citato da J. LECLER, Histoire de la tolérance au
siècle de la Réforme, (1955), trad. it., Storia della tolleranza nel secolo della Riforma, vol.
II, Morcelliana, Brescia, 1967, p. 146. 13
Infra, p. 33. Riecheggia in questo passo l’ammonimento di Sebastiano CASTEL-
LIONE, campione della tolleranza al tempo del rogo di Michele Serveto, secondo cui
poiché le sacre scritture «sono oscure, e spesso tramandate per enigmi, e di questi si di-
sputa già da più di mille anni e non si è potuto trovare un accordo […] e per tale ragione
la terra è stata riempita di sangue innocente: dobbiamo assolutamente […] temere di
crocifiggere in mezzo ai ladroni (che meritatamente crocifiggiamo) anche Cristo, imme-
ritatamente». In Id., Prefazione alla Bibbia, (1551), in Id., Fede, dubbio e tolleranza, La
nuova Italia, Firenze, 1960, p. 58.
Fabrizio Mastromartino
– 12 –
non sarebbero da ripudiare totalmente» 14. «L’analisi dell’errore» – conclude
Milton – è infatti necessario «alla conferma della verità», poiché essa si rive-
la tale solo quando è raffrontata con opinioni difformi, con essa inconciliabi-
li e perciò giudicate erronee 15.
6. È l’affermazione di un nuovo metodo, quello del libero esame, che prelu-
de lo spirito dell’illuminismo, incarnato nell’Inghilterra dell’inizio del XVIII
secolo dal movimento dei liberi pensatori. Riunitosi attorno alla figura cari-
smatica del conte di Shaftesbury, si forma un gruppo di intellettuali che fa
uso della libertà conquistata con la “gloriosa rivoluzione”, rivendicando
l’affrancamento del pensiero libero da una società fondata sui dogmi imposti
dalle autorità politiche e religiose.
Il celeberrimo Act of toleration, promulgato da Guglielmo d’Orange nel
1689, segna «un confine tra due epoche» 16, chiudendo definitivamente, in
Inghilterra, la lunga stagione delle persecuzioni per motivi religiosi, durata
oltre 150 anni e contrassegnata da fasi di diversa intensità. Tuttavia, l’editto
non è privo di ambiguità, che derivano dal tentativo di conciliare la libertà
religiosa con l’unione della Chiesa e dello Stato, rappresentata da un monar-
ca che è anche capo della Chiesa anglicana: dalla tolleranza sono infatti
esclusi i cattolici, i Sociniani, gli ebrei e gli atei. Pochi anni dopo, è final-
mente stabilita la libertà della stampa, in conseguenza del rifiuto opposto dal
Parlamento inglese nel 1694 al prolungamento della validità della disciplina
legislativa sulla censura reintrodotta nel 1643, confluita in uno Statuto del
1662, rinnovato fino all’inizio dell’ultima decade del secolo 17. Da allora,
l’assenza di un regime di previa approvazione dei manoscritti per la stampa
diviene irreversibile: i numerosi tentativi dei governi conservatori, sollecitati
dalla Corona, di fissare restrizioni per scongiurare la pubblicazione di scritti
contro il potere regio e il governo saranno, tra il 1703 e il 1707 e tra il 1710
e il 1714, tutti destinati a fallire.
Si realizzano così le condizioni per la diffusione di scritti eterodossi e
provocatori, nemici del conformismo dogmatico, che trovano inedita visibi-
lità grazie a un sistema editoriale ormai sciolto da qualsiasi forma di control-
lo centralizzato. Rapidamente emerge un movimento di scrittori e pamphlet-
14 Infra, p. 33.
15 Ibidem.
16 R.H. BAINTON, The Travail of Religious Liberty. Nine Biographical Studies,
(1951), trad. it., La lotta per la libertà religiosa, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 238. 17
Cfr. la sintetica ricostruzione illustrata da W. BLACKSTONE, infra, p. 136, in nota.
Per la libertà di espressione
– 13 –
tisti che inneggia al libero pensiero, le cui opere creano fermento e scalpore
nella società.
Personalità di spicco di questo gruppo di intellettuali, di cui fa parte John
Toland, è Anthony Collins; la sua opera più nota, A discourse of free-
thinking, occasion’d by the rise and growth of a sect call’d free-thinkers, ne
è il manifesto. Qui, il libero pensiero, precisamente definito al principio del
Discorso come «l’uso dell’intelligenza nel tentare di scoprire il significato
di qualsivoglia asserzione, nell’esaminare la natura delle prove a suo favore
o ad essa contrarie, e nel giudicarla in base alla forza o alla debolezza delle
prove» 18, è contrapposto all’accettazione aprioristica delle conoscenze ac-
quisite, che si affida passivamente alle opinioni altrui cui riconosce autorità:
un abito mentale rivoluzionario, secondo il quale il pensiero «rifiuta di esse-
re controllato da qualsiasi autorità che non sia la sua propria» 19.
7. Pubblicato anonimo nel 1713, inizialmente attribuito erroneamente a To-
land e presto attribuito a Collins, indicato dal tipografo come autore del ma-
noscritto, il Discorso viene più volte ristampato già nello stesso anno della
sua apparizione e tradotto immediatamente in francese. Destinato a gran for-
tuna, si diffonde rapidamente in Inghilterra e nel Continente, suscitando una
tempesta di critiche, tra cui quella che riscuote più successo è quella del filo-
logo Richard Bentley 20. Lo scandalo è tale che Collins decide di trasferirsi
per qualche mese in Olanda, mentre divampano le critiche sul suo libro, per
scongiurare il rischio di essere bersaglio di iniziative persecutorie.
La conoscenza, scrive Collins, si raggiunge solo mediante l’esercizio del
libero pensiero: «nessuna asserzione, infatti, può essere riconosciuta come
vera, o scartata perché falsa, se non dopo un tale uso dell’intelligenza». Non
può esservi progresso però – aggiunge – attraverso l’azione di pochi, ma so-
lo quando venga a tutti riconosciuto di pensare liberamente. Perfettamente
18 Infra, p. 34.
19 J.B. BURY, A history of freedom of thought, (1913), trad. it. Storia della libertà di
pensiero, Feltrinelli, Milano, 1959, p. 16. 20
Esemplare è il severo giudizio formulato dall’abate E-F. Mallet nell’Encyclopédie:
«Le traité de la liberté de penser, de Collins, passe parmi les inconvaincus, pour le chef-
d’œuvre de la raison humaine; & les jeunes inconvaincus se cachent derriere ce redou-
table volume, comme si c’étoit l’égide de Minerve. On y abuse de ce que présente de
bon ce mot, liberté de penser, pour la réduire à l’irreligion; comme si toute recherche
libre de la verité devoit nécessairement y aboutir». Cfr. ID., Liberté de penser, in Ency-
clopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1765, Verlag,
Stoccarda, 1966, tomo IX, p. 473.
Fabrizio Mastromartino
– 14 –
consapevole delle implicazioni sociali delle sue tesi, Collins insiste sulla na-
tura collettiva della conoscenza umana, cui ciascuno contribuisce. I risultati
cui questa impresa perviene, afferma, «non saranno mai tanto perfetti, come
sarebbero se tutti gli uomini fossero stati autorizzati ed incoraggiati a pensa-
re», poiché il suo avanzamento è «proporzionale al grado di libertà di pen-
siero che prevale» nella società 21.
La potenza retorica dell’opera si dispiega in particolare nella critica mos-
sa da Collins contro coloro che vorrebbero imporre dei limiti al libero pen-
siero, dove la posizione liberticida, enunciata in nome del rispetto del sapere
tradizionale e della conservazione dello status quo, è sottoposta a
un’efficace reductio ad absurdum:
Io non ho modo di distinguere il vero dal falso, né di sapere se mi trovo in pericolo
o no, se non facendo uso dell’intelligenza e della ragione che Dio mi ha dato, e do-
vrei, invece, senza alcuna ragione, supporre di essere sulla retta via e in salvo. In-
somma, mi si impedisce di usare il metodo migliore per prevenire errori pericolosi,
per il timore di cadere in errori pericolosi, come se mi si impedisse di usare gli oc-
chi, per timore di un uso scorretto di essi, ed io camminassi ad occhi chiusi per
l’eventualità di sbagliare strada se camminassi ad occhi aperti 22.
È infatti «la riflessione autonoma» il «migliore dei mezzi per scegliere la
giusta soluzione del problema» 23. L’uomo, afferma Collins, è in grado di
riconoscere come vere le altrui convinzioni solo se assume un’indipendenza
di giudizio nella formazione del proprio convincimento, solo quando ha il
coraggio di pensare autonomamente emancipandosi dai dogmi che gli sono
stati inculcati. Sapere aude, il motto che meglio rappresenterà la filosofia dei
lumi, è l’esortazione proclamata dai liberi pensatori.
8. La critica avanzata da Collins, che qui ha valore generale, non nasconde
poi il principale obiettivo che si prefigge: quello di condannare i limiti im-
posti all’applicazione del libero pensiero alle questioni religiose. Anche in
questo caso, nota, vi è una contraddizione: se, da un lato, «una retta opinione
su temi del genere è ritenuta assolutamente necessaria per la salvezza
dell’umanità dai nemici del libero pensiero, mentre errori e fraintendimenti,
si pensa, rendono gli uomini passibili di condanna», dall’altro, negando la
possibilità di una riflessione completamente autonoma, si fa in modo che gli
21 Infra, p. 35.
22 Ivi, p. 36.
23 Ibidem.
Per la libertà di espressione
– 15 –
uomini «potranno trovarsi solo per caso dalla parte giusta»; «se infatti non
rifletteranno autonomamente – scrive – non avranno altra scelta che seguire
opinioni inculcate da nonne, madri, preti, oppure acquisite per circostanze
del tutto accidentali» 24.
Collins riprende una tesi già affermata da Locke, di cui egli è amico e di-
scepolo, spingendo l’argomentazione ben più in là delle intenzioni che gui-
davano il maestro. Locke aveva fermamente condannato come assurdo il
principio territorialista che aveva informato la Pace di Augusta, nel 1555, e
la Pace di Westfalia, nel 1648, affermando che «se i mortali si trovassero
nella condizione che ciascuno dovesse metter da parte i dettami della sua ra-
gione e della sua coscienza ed abbracciare ciecamente i dogmi del suo so-
vrano», «la felicità o la sofferenza eterna sarebbero dovute unicamente a
quel caso che è la nascita» 25. Ma mentre Locke mantiene ferma l’idea che è
«una sola la via» che conduce alla salvezza in Cristo, Collins sostituisce alla
fede, generata dalla casualità di un’educazione acritica e dogmatica,
«l’evidenza delle cose come guida alla verità» 26.
È il trionfo della ragione, del suo esercizio senza limite alcuno, quello
professato dai liberi pensatori: un uso davvero “spregiudicato”, senza freni
né pregiudizi, che a Collins appare tanto più necessario nelle questioni teo-
logiche, che – scrive – «non possono essere trattate per delega», poiché
ognuno «ha l’obbligo di credere in prima persona» 27. Seguendo, in questo
caso senza deviazioni, la lezione di Locke, secondo cui «[...] qui ciascuno è
giudice per se stesso di ciò che è giusto», dato che «in materia di fede e di
culto religioso, un altro non può giudicare per lui» 28, Collins indica nelle
convinzioni religiose l’ambito in cui più è necessario che ognuno svolga una
propria autonoma riflessione personale: «non posso delegare nessun altro a
credere per me, né potrebbe salvarmi la fede di qualcun altro, tranne la mia.
Dunque in fatto di religione – conclude – ho il dovere di pensare da me» 29.
24 Ibidem.
25 J. LOCKE, A letter concerning toleration, (1689), trad.it. Lettera sulla tolleranza,
in ID. Scritti sulla tolleranza, a cura di D. Marconi, Utet, Torino, 2005, pp. 137-138. 26
Infra, p. 36. 27
Ivi, p. 40. 28
J. LOCKE, A second letter concerning toleration, (1690), trad.it. Seconda lettera
sulla tolleranza, in ID., Scritti sulla tolleranza, cit., p. 268. 29
Infra, p. 40.
Fabrizio Mastromartino
– 16 –
9. Ancora ben oltre un secolo più tardi, quando la connotazione liberale del-
la costituzione mista inglese aveva da tempo celebrato i suoi trionfi, ponen-
dosi come stabile guida nel percorso intrapreso dal Continente verso lo stato
di diritto, «l’argomentazione contro la libertà di opinione», circa «la fede in
un Dio e in una vita futura», – riconoscerà John Stuart Mill – «è considerata
più valida, sia in termini di verità sia di utilità» 30. Tuttavia, le premesse da
cui muove il discorso in difesa della libertà di espressione alla metà del se-
colo XIX appaiono nel frattempo radicalmente mutate. La travolgente sta-
gione dei lumi ha innervato le istituzioni politiche penetrando negli ordina-
menti giuridici, nei canoni legislativi e nei costumi sociali, archiviando il si-
stema di potere di antico regime e condannando il dispotismo nel nome della
libertà, nuovo cardine dell’organizzazione politica, principio informatore
della società liberata dal dominio sovrano dello Stato assoluto.
Nel 1858, quando appare forse l’opera più matura di Mill, On liberty, il
filosofo inglese può affermare a ragion veduta che «è da sperare che sia tra-
scorsa l’epoca in cui era necessario difendere la “libertà di stampa” come
una delle garanzie contro un governo corrotto o tirannico». Incontrovertibile
appare ormai che «la libertà di coscienza nel suo senso più ampio» la «liber-
tà di pensiero e sentimento», la «assoluta libertà di opinione in tutti i campi,
pratico o speculativo, scientifico, morale, o teologico» sono comprese nella
«regione propria della libertà umana», ove l’individualità di ciascuno può
svilupparsi pienamente 31. Facendo proprio l’adagio humboldtiano – posto
da Mill ad epigrafe del suo saggio – che nobilita l’importanza «dello svilup-
po umano nella sua più ricca diversità» 32, egli individua nel dispiegamento
della natura umana «in direzioni innumerevoli e contrastanti» «l’unico fatto-
re infallibile e permanente di progresso» sociale, scientifico e culturale 33.
Accanto a queste considerazioni di ordine etico, inneggianti alla ricchez-
za individuale dell’uomo che si sprigiona nella affermazione autonoma di
ciascuno, Mill, di nota formazione benthamiana, affianca un motivo utilitari-
stico in difesa della libertà di espressione. Rievocando un brillante passo
dell’argomentazione retorica di Milton, dove il letterato aveva stigmatizzato
la «soppressione» di un libro come un «omicidio», «un martirio», «una spe-
30 Ivi, p. 48.
31 Ivi, p. 43.
32 Cfr. von HUMBOLDT, Idee per un saggio sui limiti dell’attività dello Stato, (1792),
Editori Riuniti, Roma, 1974, cit. in J. STUART MILL, On liberty, (1859), trad.it. Saggio
sulla libertà, Il Saggiatore (NET), Milano, 2002, p. 1. 33
Ivi, pp. 33 e 101.
Per la libertà di espressione
– 17 –
cie di massacro» 34, altrettanto efficacemente Mill condanna la censura della
libera espressione del pensiero come «un crimine particolare»: «impedire
l’espressione di un’opinione – scrive – significa derubare la razza umana, i
posteri altrettanto che i vivi, coloro che dall’opinione dissentono ancor più
di chi la condivide». Tutti traggono vantaggio dal confronto con un’opinione
diversa dalla propria: «se l’opinione è giusta» – argomenta – «sono privati
dell’opportunità di passare dall’errore alla verità; se è sbagliata, perdono un
beneficio quasi altrettanto grande, la percezione più chiara e viva della veri-
tà, fatta risaltare dal contrasto con l’errore» 35.
Al di là della forma retorica in cui è espressa, l’argomentazione svolta da
Mill è per altri versi incommensurabile con quella sviluppata dal suo più au-
torevole predecessore. Vi è qui infatti l’abbozzo di una visione epistemolo-
gica assai avanzata, che, enormemente distante dall’epoca di Milton, nella
quale il razionalismo empirista è un fenomeno ancora marginale, precorre le
più accreditate teorie della conoscenza della metà del Novecento 36. Di fron-
te alla grande impresa della conoscenza, afferma Mill, l’uomo si dimostra
fallibile, «un essere soggetto all’errore» 37; la verità che egli pensa di posse-
dere non può che essere effimera, incerta, sempre tendenzialmente caduca,
poiché in ogni momento revocabile da una “verità” rivale che ne sfida la
fondatezza. È dunque solo attraverso un confronto costante ed eventualmen-
te mediante uno scontro tra punti di vista diversi e incompatibili che si co-
struisce e si fortifica l’edificio del sapere umano.
La battaglia contro la difesa dogmatica del “pregiudizio” è radicale: «la
fonte di tutto ciò che vi è di rispettabile nell’uomo inteso come essere sia in-
34 Infra, p. 22.
35 Ivi, p. 46.
36 Un’originale teoria di chiara ispirazione empirista è elaborata, sul piano del di-
scorso teoretico, da MILL in particolare nell’opera A system of logic, del 1843. È lo
stesso Mill a metterne in luce il carattere programmatico e “militante”, nella sua Auto-
biografia, Laterza, Bari, 1976, p. 176, dove il modello epistemologico dell’empirismo è
contrapposto all’idealismo (tedesco) a quell’epoca assai diffuso anche nel Regno Unito:
«Sono persuaso che la tesi secondo la quale le verità esterne alla mente possono essere
conosciute mediante l’intuizione o la coscienza, indipendentemente dall’osservazione o
dall’esperienza, costituisce nei nostri tempi il grande sostegno intellettuale delle false
dottrine e delle cattive istituzioni. Con l’aiuto di questa teoria, qualsiasi credenza invete-
rata e qualsiasi sentimento intenso di cui non si ricordi l’origine vengono dispensati
dall’obbligo di trovare una loro giustificazione razionale, ed eretti a loro propria e auto-
sufficiente garanzia e giustificazione. Mai ci fu nel passato uno strumento del genere,
escogitato per consacrare i pregiudizi profondamente radicati». 37
Infra, p. 48.
Fabrizio Mastromartino
– 18 –
tellettuale sia morale», scrive, si trova in «una qualità della mente umana»,
«la possibilità di correggere i propri errori, di rimediarvi con la discussione e
l’esperienza». «Non con la sola esperienza», precisa: «la discussione è ne-
cessaria per indicarne l’interpretazione» 38. La contrapposizione tra verità ed
errore, viziata da un contrassegno teologico che identifica la prima nella fe-
de e il secondo nell’eresia, è finalmente demistificata e letteralmente travolta
da una dialettica nuova, nella quale la riabilitazione dell’errore incrocia il
riconoscimento del carattere sempre provvisorio della verità: finché i due
elementi, contrapposti dal regime dell’intolleranza dello Stato assoluto nella
stagione delle persecuzioni per motivi religiosi, non tendono a confondersi,
scolorando in un’indistinta mistura, nella quale l’unico tono che risalta chia-
ramente è quello della discussione e dei suoi risultati 39.
38 Ivi, p. 47. Aveva già insistito con chiarezza sull’importanza della discussione per
la ricerca della verità d’Holbach, secondo il quale «è solo dalla discussione che può
uscire la verità sempre utile al pubblico e che deve servire da base a ogni conoscenza
umana». Cfr. infra, p. 93. 39
Una severa requisitoria contro una presunta «verità oggettiva» distintamente di-
stinguibile dall’errore aveva svolto Fichte contro le pretese della censura prussiana di
impedire l’espressione di opinioni difformi da quelle comunemente accettate: «È asso-
lutamente impossibile comunicare la verità, quando non è insieme permesso diffondere
gli errori»; intanto perché «la verità obbiettiva nel più rigoroso senso della parola con-
traddice direttamente all’intelletto dell’uomo e di ogni essere finito»; poi perché pari-
menti mistificatorio è il modo in cui il potere e le sue strutture di controllo presentano
ciò che chiamano «errori confutati», che, proprio perché già confutati, nessuno dovreb-
be poter continuare a diffondere: «Per chi sono essi confutati? Se queste confutazioni
fossero evidenti per noi, riuscissero a soddisfare noi, credete forse che continueremmo a
sostenere quegli errori? credete voi che preferiremmo errare anziché pensare rettamente,
preferiremmo essere folli anziché accorti? e che potremmo riconoscere un errore come
soltanto errore, per poi subito accettarlo? pensate forse che noi unicamente per gusto di
spiritosaggine e per stuzzicare ed irritare i nostri buoni tutori vorremmo introdurre nel
mondo cose di cui sappiamo benissimo noi stessi che sono false? Quegli errori dunque
sono da lungo tempo confutati, ce lo dite voi sulla vostra parola. Dovrebbero quindi es-
sere confutati almeno per voi, dato che voi volete trattare onorevolmente con noi. E al-
lora non vorreste dirci, o illustri figli della terra, quante notti avete vegliato nelle più se-
rie meditazioni per scoprire ciò che tanti uomini, liberi da tutte le altre vostre cure di
governo, dedicando tutto il loro tempo a tali ricerche, non hanno ancora fino adesso po-
tuto scoprire? oppure voi lo avete trovato senza tanta riflessione e senza tanta istruzione,
unicamente con l’ausilio del vostro genio divino?». La conclusione è lo smascheramen-
to dell’arbitrio esercitato dallo Stato nel tentativo di controllo delle opinioni: «Vero è
pertanto ciò che voi volete sia vero; e falso ciò che volete sia falso». Cfr. infra, pp. 113-
114.
Per la libertà di espressione
– 19 –
La forza e il valore dei giudizio umano – scrive Mill – dipendono interamente dalla
sua proprietà di poter venire corretto quando è errato; esso è attendibile soltanto
quando i mezzi per correggerlo sono tenuti costantemente a disposizione. Conside-
riamo una persona il cui giudizio sia veramente degno di fiducia: come lo è diventa-
to? Perché si è mantenuto aperto alle critiche riguardanti le sue opinioni e la sua
condotta. Perché si è imposto come prassi costante di ascoltare tutto ciò che potesse
venir detto contro di lui; di metterne a profitto quanto fosse giusto, e di chiarire, a se
stesso e se necessario ad altri, l’erroneità di quanto fosse erroneo 40.
Questo abito mentale – massima espressione del libero pensiero poiché
non solo esercita la propria libertà ma riconosce e valorizza l’esercizio della
libertà degli altri –, «costante abitudine a correggere e completare la propria
opinione confrontandola con le altrui [...] è l’unico fondamento stabile di
una corretta fiducia in essa». La verità, le opinioni che riteniamo più impor-
tanti e utili, non si proteggono confinandole in un recinto dalle mura invali-
cabili, né ibernandole sotto uno strato di ghiaccio ispessitosi nei secoli; la
libertà è il loro terreno di coltura, una discussione permanente ne garantisce
la vitalità: «non riposano su altra salvaguardia – conclude Mill – che un invi-
to permanente a tutto il mondo a dimostrarle infondate» 41.
Ne deriva una relativizzazione della verità e della certezza che
l’accompagna: vi sono così verità migliori di altre, essendo più certe e più
ben fondate di quelle che vi si oppongono. «Se la sfida non viene raccolta, o
viene tentata e perduta, siamo ancora molto lontani dalla certezza, ma ab-
biamo fatto quanto di meglio ci consente la presente condizione della ragio-
ne umana»; «possiamo avere la sicurezza di esserci avvicinati alla verità nel-
la misura a noi possibile. Questo è il grado di certezza raggiungibile» 42.
D’altra parte, nella concezione filosofica di Mill, la verità rimane comun-
que un traguardo reale, non solo un ideale mai perfettamente realizzabile.
Per quanto «pensare che la verità semplicemente in quanto tale – scrive –
abbia un qualche potere intrinseco, negato all’errore, di prevalere contro le
segrete e il rogo» sia espressione di un «sentimentalismo inutile», essa, così
concepita, è pur sempre invincibile 43. Il suo «reale vantaggio», argomenta,
40 Infra, p. 47.
41 Ibidem.
42 Ivi, p. 48.
43 L’invincibilità della verità è un topos classico dell’illuminismo. Cfr. D’HOLBACH,
infra, p. 93: «Le verità reali possono essere combattute senza che siano in pericolo, esse
galleggiano sempre nel torrente che, presto o tardi, trascina le menzogne dell’impostura
e di tutti i vani pregiudizi tanto contrari alla felicità delle nazioni».
Fabrizio Mastromartino
– 20 –
risiede nel fatto che «quando un’opinione è vera la si può soffocare una, due,
molte volte, ma nel corso del tempo vi saranno in generale persone che la
riscopriranno, finché non riapparirà in circostanze che le permetteranno di
sfuggire alla persecuzione fino a quando si sarà sufficientemente consolidata
da resistere a tutti i successivi sforzi di sopprimerla» 44.
44 Infra, pp. 49-50.