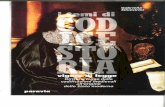Dalla verità alla legge. Epistemologia e teoria politica in Hobbes
Transcript of Dalla verità alla legge. Epistemologia e teoria politica in Hobbes
© Copyright L’Ircocervo 2012 – Fondazione Gentile Onlus | Autore: Gonzalo Letelier Widow Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it
DALLA VERITÀ ALLA LEGGE. EPISTEMOLOGIA E TEORIA POLITICA IN HOBBES
di Gonzalo Letelier Widow
Direttore del Centro de Estudios Tomistas Universidad Santo Tomás – Chile
Abstract Hobbes’ concept of science is a useful key to understand the main thesis of his political doctrine. Although Hobbes himself was not always coherent with his own notion of science, many of its most important concepts, such as social contract, sovereignity and law, can be explained as conclusions of his view of science as creative reasoning and rigourous deduction with a practical purpose. According to this view, civil science is the higher form of human knowledge. “Auctoritas, non veritas facit legem”1. Questa notissima citazione di Hobbes costituisce uno dei principi fondanti della moderna teoria politica. Di solito, la tesi va letta come un
1 OL, III, Leviathan, c.26, p.202. Le citazioni dell’opera di Thomas Hobbes corrispondono all’ormai classica edizione Molesworth. L’opera inglese (The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury; Now First Collected and Edited by Sir William Molesworth, John Bohn, London, 1839-45 in 11 volumi1), verrà citata con la sigla EW e il numero del volume, di capitolo e di pagina. Nel caso dell’opera latina (Thomae Hobbes Malmesburiensis Opera Philosophica quae Latine scripsit Omnia, in unum corpus nunc primum collecta studio et labore Gulielimi Molesworth, Joannes Bohn – Longman, Brown, Green et Longman, Londinum, 1839-1845, in 5 volumi), verrà citata con la sigla OL. Per il Leviathan (EW, III), tengo presente anche l’edizione di M. Oakeshott (T. HOBBES, Leviathan, Blackwell, Oxford, 1946), e la recente edizione trilingue della Bompiani, a cura di Raffaella Santi (T. HOBBES, Leviatano, testo inglese del 1651 a fronte, testo latino del 1668 in nota, Bompiani, Milano, 2001). Per il De Cive (e in generale per le altre opere scritte in latino e inglese), si rimanda indistintamente all’edizione originale latina (di OL, II, De Cive) oppure alla versione inglese (leggermente diversa, corrispondente a EW, II, Philosophical Rudiments concerning Government and society). Tengo presente anche la traduzione (dal latino) a cura di Tito Magri (T. HOBBES, De Cive. Elementi filosofici sul cittadino, Editori Riuniti, Roma, 1979). Per queste due opere maggiori (il Leviathan e il De Cive) ci limiteremo a indicare, rispettivamente, EW, III e EW, II oppure OL, II, senza precisare ulteriormente il titolo. Per tutte le altre, al numero del volume si aggiungerà anche il titolo dell’opera. Corsivi e maiuscoli, molto frequenti in Hobbes, sono sempre tratti dall’originale.
© Copyright L’Ircocervo 2012 – Fondazione Gentile Onlus | Autore: Gonzalo Letelier Widow Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it
2
radicale rifiuto della verità. La verità, si dice, se c’è qualcosa che possa ricevere quel nome, non ha niente da fare in ambito político. La questione, tuttavia, è più complessa. Hobbes è certamente stato ciò che oggi chiameremmo un “relativista”. Si potrebbe anche argomentare che fosse uno scettico. Ma certamente non si può affermare che non abbia elaborato un concetto di scienza o che questo concetto sia indifferente alla sua opera politica. Lo stesso “Leviathan” inizia con una considerazione sulla natura, non dell’uomo, ma sulla conoscenza umana. La tesi di questo scritto è che la teoria hobbesiana della scienza è una delle chiavi di lettura fondamentali per la sua dottrina politica. Infatti, forse potremmo dire che certi aspetti di questa dottrina non sono altro che una deduzione lineare da questo concetto di scienza. Ciò che è sicuro è il fatto che, se si prescinde di una attenta considerazione di questa dottrina della scienza, la sua teoria dell’azione umana, e quindi della legge e della sovranità, diventa semplicemente ininteligibile. Ci limiteremo qui a descrivere gli aspetti più essenziali di questa nozione di scienza per esplicitare poi le sue conseguenze sulla teoria dell’azione e, in particolare, sul rapporto fra conoscenza e volizioni. 1. Premessa metodologica: i mille volti di Hobbes L’idea secondo la quale il diritto è qualcosa imposto dal di fuori e dal di sopra dell’individuo comune è ormai parte integrale del modo in cui concepiamo il mondo. E tuttavia questa è una idea piuttosto nuova, dell’“altro ieri”2, comunque estranea alla mentalità premoderna. Se dovessimo attribuirle un’origine chiaramente definita, questa si troverebbe senza dubbio in Thomas Hobbes, autore che anticipa e contiene in modo assai chiaro, e diremmo “profetico”, gli elementi fondamentali delle nostre concezioni del diritto e della legge. Pochi autori sono così datati nelle loro conclusioni concrete, e così attuali nei loro principi generali e nei problemi che propongono. Thomas Hobbes è un autore sul quale ormai risulta difficile affermare qualsiasi cosa. Pensatore complesso e paradossale, che in modo costante tradisce i suoi stessi principi di chiarezza, coerenza e deduzione imparziale; osservatore acuto, ma arbitrario e
2 Cfr. P. GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, Giuffrè, Milano, 2001..
© Copyright L’Ircocervo 2012 – Fondazione Gentile Onlus | Autore: Gonzalo Letelier Widow Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it
3
tendenzioso; razionalista estremo di argomenti profondamente passionali; temibile polemista, il cui modo di difendere le sue posizioni con gli argomenti dell’opponente risultava estremamente efficace3, ma spesso finiva per oscurare le sue tesi di fondo. I suoi scritti sono il riflesso di questa personalità complessa4, e sono profondamente determinati dalle circostanze della sua vita, non solo per il suo linguaggio o mentalità, ma anche, e forse soprattutto, per l’intenzione con cui li scrisse5. La domanda su ciò
3 Cfr. N. BOBBIO, “Introduzione al De Cive”, in Thomas Hobbes, Einaudi, Torino, 1989, p.92-93 (già in T. HOBBES, Elementi filosofici sul cittadino, Utet, Torino, 1948, pp.9-40): “Hobbes sa bene che il modo più sicuro per abbattere gli avversari e convincere gli esitanti è di ritorcere gli argomenti. Ora, la sua dottrina contrattualistica é un geniale e malizioso gioco di ritorsione, a cui oggi guardiamo con stupefazione (...) come ad un capolavoro di arte dimostrativa e dialettica”. 4 In un libro dedicato alla sua figura da una prospettiva psicologica (Hobbes, Penguin, Harmondsworth, 1956), R. PETERS lo presenta come “an insecure, angry and intellectually arrogant theoretician” (p.37); “a self-made man whose feeling of insecurity and desire of esteem expressed itself in the flattering delusion that men were taking note of him and planning his decease” (p.27); “a dogmatist who believed that most of his countrymen were either stupid or riddled with various brands of anarchic individualism or both” (p.37). Secondo OAKESHOTT, Hobbes era “arrogant (…), dogmatic, and when he speaks it is in a tone of confident finality: he knows everything except how his doctrines will be received. (…) [H]e often changed his views, but he rarely retracted an opinion. (…) Like Epicurus, he had an affectation for originality. He rarely mentions a writer to acknowledge a debt, and often seems oversensitive about his independence of the past in philosophy. Aristotle’s philosophy is ‘vain’, and scholasticism is no more than a ‘collection of absurdities’.” (M. OAKESHOTT, “Introduction” a T. HOBBES, Leviathan, Blackwell, Oxford, 1946, pp.xiv-xv). La questione non è trascurabile, perché, come afferma lo stesso Oakeshott, “[t]he coherence of his philosophy, the system of it, lies not in an architectonic structure, but in a single ‘passionate thought’ that pervades its parts” (ibidem, p.xix). 5 Anche se metodologicamente sterile per questa ricerca, non è affatto assurdo supporre che a volte Hobbes volesse ingannare i suoi lettori casuali attraverso un doppio discorso (così, per esempio, M.A. KAPLAN, “How Sovereign Is Hobbes’ Sovereign?” Political Research Quarterly, (June 1956), Vol. 9 No.2, pp. 389-405, appunto rispetto al concetto di rappresentanza, centrale per il nostro problema). Anche OAKESHOTT (“The moral life in the writings of Thomas Hobbes”, in M. OAKESHOTT, Hobbes on Civil Association, Oxford University Press, Oxford, 1975) propone la tesi di un doppio discorso, esoterico ed essoterico. Più vicina all’idea dell’insincerità, invece, è la posizione di L. STRAUSS (“On the spirit of Hobbes’s political philosophy”, in M.C. BROWN (a cura di), Hobbes Studies, Blackwell, Oxford, 1965, pp.1-29, p.27; ristampa del primo capitolo di Natural right and history, Chicago University Press, Chicago, 1953), rispetto al suo ateismo. Essendo parte implicata, i numerosi testi in cui Hobbes sostiene di essere un fedele credente perdono ogni valore. L’ultima critica ha ribadito come, per comprendere l’opera di Hobbes, la sua inconfessata intenzione persuasiva è almeno così rilevante quanto potrebbero esserlo le sue pretese di
© Copyright L’Ircocervo 2012 – Fondazione Gentile Onlus | Autore: Gonzalo Letelier Widow Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it
4
che veramente pensasse e volesse dire Hobbes nei propri scritti non ha una risposta unica, perché lo stesso Hobbes non la permette6. L’analisi, quindi, deve essere cauta. D’altra parte, quello che interessa non è raffigurare la sua posizione personale, ma piuttosto determinare la sua influenza ed eredità nella filosofia giuridica e politica. Bisogna occuparsi del fondatore del giusnaturalismo moderno e del positivismo giuridico7, più che del polemista assolutista sui generis del seicento inglese. Nonostante questa cautela, ogni interpretazione globale di Hobbes deve far conto del problema delle antinomie, ambiguità e contraddizioni dell’opera hobbesiana,
scientificità. Cfr. T. SORELL, “Hobbes persuasive civil science”, in The Philosophical Quarterly, Vol. 40, No. 160 (Jul., 1990), pp.342-351. 6 L’opera di Hobbes ammette e ha ricevuto un’enorme varietà d’interpretazioni. Per fare soltanto un esempio, in materia politica lo si è considerato: liberale (L. STRAUSS, op. cit. e M.A. CATTANEO, “Hobbes’s theory of Punishment”, in Hobbes Studies, op. cit., pp.275-298, già “La teoria della pena in Hobbes”, in Jus, Vol. 11 (1960), pp.478-498 e Il positivismo giuridico inglese. Hobbes, Bentham, Austin, Giuffrè, Milano, 1962); borghese (C.B. MACPHERSON, The political theory of possessive individualism, Clarendon, Oxford, 1962 (trad. it. di Silvana Borutti, Libertà e proprietà alle origini del pensiero borghese. La teoria dell'individualismo possessivo da Hobbes a Locke, Mondadori, Milano, 1982, con introduzione di Antonio Negri) e “Hobbes’s burgeois man”, in Hobbes Studies, op. cit., pp.169-184, già “Hobbes Today”, in Canadian Journal of Economics and Political Sciences, Vol. 11 (Nov. 1945), pp.524-534); assolutista (A. PASSERIN D’ENTRÈVES, La dottrina del diritto naturale, Edizioni di Comunità, Milano, 1980 e N. BOBBIO, Thomas Hobbes, Einaudi, Torino, 1989) e totalitario (J. VIALATOUX. La Cité totalitaire de Hobbes, Gabalda - Lecoffre, Paris, 1935). La stessa cosa accade rispetto ad ogni materia particolare: ateo, agnostico o credente in materia religiosa; giusnaturalista, giuspositivista (e padre di entrambi) o teonomista rispetto alla fondazione del diritto. Tutte opzioni plausibili e con importante supporto testuale. Tra i numerosi studi di storia della critica, nei quali si può riscontrare una sintesi di queste posizioni e il loro rapporto, sono importanti, anche se un po’ datate, A. PACCHI, Introduzione a Hobbes, Laterza, Roma, 1971 (attualizzata nell’edizione di 1995) e “Cinquant’anni di studi hobbesiani” in Rivista di Filosofia, Vol. 57 (1966), pp.306-335, e di N. BOBBIO, “Breve storia della storiografia hobbesiana”, in N. BOBBIO, op. cit, pp.203-210, già in V. Mathieu (a cura di), Questioni di storiografia filosofica. Dalle origini all’Ottocento, La Scuola, Brescia, 1974, pp.324-328. Molto più recente e aggiornato è D.D. RAPHAEL, Hobbes. Morals and Politics, Routledge, London, 2004. Utile anche il saggio di F. VIOLA, “Hobbes tra moderno e posmoderno. Cinquant’anni di studi hobbesiani”, in Ragioni Critiche, No.5-6 (1998), pp.6-21. 7 Cfr. N. BOBBIO, “Legge naturale e legge civile nella filosofia politica di Hobbes”, in N. BOBBIO, op. cit., pp.111-145, già in Studi in memoria di Gioele Solari, Ramella, Torino, 1954, pp.61-101, e “Hobbes e il giusnaturalismo”, in N. BOBBIO, op. cit., pp.147-168, già in Rivista critica di storia della filosofia, XVII (1962), pp.470-485. Della stessa opinione è, per esempio, E. OPOCHER, Lezioni di Filosofia del Diritto, Cedam, Padova, 1983, p.111.
© Copyright L’Ircocervo 2012 – Fondazione Gentile Onlus | Autore: Gonzalo Letelier Widow Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it
5
condizione indispensabile per poter disegnare una lettura non già “vera” o “autentica”, ma semplicemente consistente8. È proprio la sua avversione per le sfumature, la sua inclinazione per le definizioni assolute e, paradossalmente, quella esigenza autoimposta di assoluta sistematicità geometrica a rendere particolarmente stridenti le ambiguità e i passaggi logici più deboli o inconsistenti. Così, Pennock ha potuto parlare della “confusing clarity”9 di Hobbes, e Giuseppe Sorgi addirittura ha dedicato un libro allo studio del problema10. 2. La filosofia politica come scienza ipotetica L’idea moderna di una “scienza politica” è dovuta a Hobbes, primo autore che ebbe il coraggio di estendere il metodo scientifico fondato da Galileo all’ambito della filosofia pratica così come Descartes lo aveva esteso alla filosofia teoretica11. Il punto di partenza della dottrina politica di Hobbes è appunto la scientificità della philosophia civilis, e quindi la sua concezione di scienza12.
8 H. WARRENDER, per esempio, dopo aver constatato che il pensiero di Hobbes è molto meno rigoroso e sistematico di quanto si credereva (fatto che, ormai, è diventato opinio communis tra gli studiosi), procede a “piece together Hobbes’s argument in so far as it may legitimately be done” (H. WARRENDER, The political philosophy of Hobbes. His theory of obligation, Clarendon, Oxford, 1957, p.2; trad. it. di Anna Minerbi Belgrado, Il pensiero politico di Hobbes. La teoria dell’obbligazione, Laterza, Bari, 1974). Infatti, secondo la Pitkin (H. PITKIN, “Hobbes’s concept of representation, II”, in The American Political Science Review, Vol. 58, No. 4 (Dec., 1964), pp.902-918, p.907) Warrender si costruisce un Hobbes troppo coerente per essere credibile. La stessa accusa di ricostruire l’opera di Hobbes a partire dei loro propri concetti e intenzioni è stata rivolta a F. S. MCNEILLY, The anatomy of Leviathan, Macmillan, London, 1968, a E.C. HOOD, The Divine Politics of Thomas Hobbes, Clarendon, Oxford, 1964 e, in misura minore, a A.E. TAYLOR, “The Ethical Doctrine of Hobbes”, in Hobbes Studies, op. cit, pp.35-56 (già in Philosophy, Vol. 13, No. 52 (Oct., 1938), pp.406-424), autori che sarebbero stati forzati a “correggerlo” negli aspetti non calzanti con la loro interpretazione. 9 Cfr. J. R. PENNOCK, “Hobbes’s confusing ‘clarity’ – The case of ‘liberty’”, en Hobbes Studies, op. cit, p.101-116, già in The American Political Science Review, Vol. 54, No. 2 (1960), pp.428-436. 10 G. SORGI, Quale Hobbes? Dalla paura alla rappresentanza, FrancoAngeli, Milano, 1989. 11 Passo questo che, molto probabilmente, sarebbe considerato invalido da questi autori. Il problema costituisce un interessante argomento di ricerca. 12 Questa impostazione si può trovare in alcune esposizioni globali del pensiero hobbesiano, come T. SORELL, Hobbes, Routledge, London – New York, 1986, in AA.VV. (a cura di T. Sorell), The
© Copyright L’Ircocervo 2012 – Fondazione Gentile Onlus | Autore: Gonzalo Letelier Widow Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it
6
In effetti, Hobbes considera la scienza politica come la maggiore fra le scienze, l’unica che si può designare propriamente con quel nome. Così, per esempio, il Praefatio dell’edizione latina del De Cive: “Sive igitur scientiarum dignitas ex dignitate eorum ad quos pertinent, sive ex numero eorum qui de ipsis scripserunt, sive ex judicio sapientissimorum hominum sestimanda est, dignissima certe scientiarum haec ipsa est, quse ad principes pertinet, hominesque in regendo genere humano occupatos”13. Scienza della quale, d’altra parte, lo stesso Hobbes si considera fondatore: infatti, “antiquior non sit (dico lacessitus, utque sciant se parum profecisse obtrectatores mei) libro quem De Cive ipse spcripse”14. Come si vede dalla citazione del De Cive, la ragione di questa superiorità è lo scopo e l’utilità, non l’oggetto come sarebbe in una prospettiva classica15. Questa sua scienza è conoscenza vera delle cause, ma non conoscenza della realtà in quanto tale. In modo tipicamente moderno, il primo problema filosofico non sono le cose conosciute, ma la stessa conoscenza16.
Cambridge Companion to Hobbes, Cambridge University Press, Cambridge, 1996 o in D.D. RAPHAEL, op. cit., ma è meno diffusa negli studi sulla sua dottrina politica. 13 OL, II, p.142. 14 OL, I, De Corpore, “Epistola Dedicatoria”, p.iii. 15 Cfr., per esempio, ARISTOTELE, Metafisica I, 1. 16 Per GALILEI, come per DESCARTES, il primo problema della scienza è il metodo (non le cose) che garantisce certezza (più che verità). Cfr. le loro due opere fondamentali, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo e il Discours de la Méthode, rispettivamente. Il punto, spesso ignorato, è in realtà centrale. Se ci atteniamo alle sue premesse, è chiaro che Hobbes non avrebbe mai preteso di spiegare la realtà effettiva delle cose (infatti, come afferma in OL, I, De Corpore, I, c.6, p.59: “Principia itaque scientiae omnium prima, sunt phantasmata sensus et imaginationis, quae quidem cognoscimus naturaliter quod sunt”; vid. anche il primo capitolo del Leviathan, EW, III, c.1, pp.1-3). I suoi riferimenti all’esperienza comune dovrebbero avere una funzione eminentemente persuasiva, non dimostrativa, e sarebbe metodologicamente incorretto e scientificamente fuorviante attribuire valore reale alle sue conclusione relative a le cose che trascendono l’esperienza sensibile. Ma lo stesso Hobbes non sembra di essere stato sempre fedele a queste premesse (come dimostrano gli esempi concreti dello stato di natura riportati in EW, III, c.13, 114-115, sui quali si tornerà più avanti). Questo semplice fatto permette di ridimensionare buona parte della discussione sull’eventuale fondazione dell’obbligatorietà della legge in Dio (cfr. l’ampio dibattito iniziato con TAYLOR, op. cit. e WARRENDER op. cit, e continuato poi, tra tanti altri, da W.B. GLOVER, “God and Thomas Hobbes”, in Hobbes Studies, pp.141-168 (già in Church History, Vol. 29, No.3 (1960), pp.275-297), F.C. HOOD, op. cit. e J.W.N. WATKINS, Hobbes’s System of Ideas, Gower, London, 1989), perché questo significherebbe dimostrare qualcosa che lo stesso Hobbes considerava indimostrabile. Tutto ciò che si dice su Dio è sempre detto da un’autorità umana (cfr. EW, III, c.32, p.361; c.43). Tentare di legittimare il potere politico in Dio si rivela un’operazione circolare.
© Copyright L’Ircocervo 2012 – Fondazione Gentile Onlus | Autore: Gonzalo Letelier Widow Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it
7
Secondo Hobbes, la scienza è conoscenza vera. E la verità si definisce come “the right ordering of names in our affirmations”17. Quindi la stessa scienza è conoscenza di nomi; infatti, la definisce come “the knowledge of all the consequences of names appertaining to the subject in hand”18. Ma in che modo può essere considerata scienza una conoscenza di nomi? Con una curiosa manovra dialettica, spesso utilizzata nei suoi scritti19, Hobbes fonda la propria tesi sugli argomenti della tesi contraria. In questo caso, si tratta di costruire una scienza a partire dal suo opposto: lo scetticismo radicale. L’inconoscibilità del reale, determinata dall’origine esclusivamente empirica della nostra conoscenza, non solo non impedisce la scienza ma addirittura la rende possibile. Questa operazione implica modificare la definizione di termini come “scienza”, “verità” e “causa” a partire da ciò che Hobbes considera il significato comune delle parole20, modificazione legittimata dal fatto che non esiste significazione reale al di là dei nomi, i quali non sono altro che artifici convenzionali. In altri termini, la verità scientifica è un artificio costruito dagli uomini; non un datum, ma un factum, un prodotto della ragione. Chiuso ogni acceso alla realtà delle cose, possiamo conoscere soltanto quello che noi stessi abbiamo fatto. Secondo l’efficace immagine di Strauss, la scienza hobbesiana (e dopo di essa, tutta la scienza giuridica moderna, nella misura in cui il suo oggetto non sono le condotte umane e le loro relazioni, ma il sistema delle norme convenzionali), crea un’“artificial island” senza altri limiti che quelli dell’immaginazione e del calcolo,
17 EW, III, c.4, p.23. 18 EW, III, c.5, p.35. 19 Bobbio cita un significativo esempio: Hobbes prende le tesi più radicali delle dottrine allora confrontate (dagli assolutisti, la sovranità assoluta, e dai contrattualisti, la convenzionalità dello stato), e procede poi a cancellare i loro limiti (l’origine divino e il diritto di ribellione, rispettivamente) introducendo in ciascuna di esse l’elemento più radicale della dottrina opposta. Così, risulta che il sovrano è assoluto appunto perché non esiste diritto divino, e il diritto di ribellione è contraddittorio appunto perché lo stato è convenzionale. Cfr. N. BOBBIO, “Introduzione al De Cive”, in op. cit., p.92-93. 20 Cfr. H. PITKIN, “Hobbes’s concept of representation, I”, in The American Political Science Review, Vol. 58, No. 2 (Jun., 1964), pp.328-340. Bernard GERT fa notare che le definizioni hobbesiane spesso mancano del necessario rigore (cfr. “Hobbes’s Psychology”, in The Cambridge Companion to Hobbes, op. cit., pp.157-174, p.162), probabilmente perché condizionate dagli obiettivi particolari dello scritto in cui si trovano.
© Copyright L’Ircocervo 2012 – Fondazione Gentile Onlus | Autore: Gonzalo Letelier Widow Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it
8
“wholy unenigmatic because we are its sole cause and hence have perfect knowledge of its cause”21. In ultim’analisi, l’intelletto pone il suo oggetto, il quale sarà sempre immanente al medesimo e la conoscenza verrà ridotta a introspezione22. È superfluo richiamare le proiezioni e conseguenze di questo principio. Negata l’intelligibilità degli enti naturali (ciò che noi non facciamo23, che Kant chiamerà “noumeno”), risulta di converso che gli oggetti “posti” da noi sono pienamente conoscibili dalla ragione, che diventa così assolutamente illimitata. Nella scienza non ci sono misteri; anzi, la scienza stessa consiste nella totale assenza di misteri. Secondo Oakeshott24, “Hobbes’s philosophy is, in all its parts, preeminently a philosophy of power precisely because philosophy is reasoning, reasoning the elucidation of mechanism, and mechanism essentially the combination, transfer, and resolution of forces. The end of philosophy itself is power — scientia propter potentiam. Man is a complex of powers; desire is the desire for power, pride is illusion about power, honour opinion about power, life the unremitting exercise of power, and death the absolute loss of power. And the civil order is conceived as a coherence of powers”. Prova di questo fatto è l’intero cap. X del Leviathan, secondo il quale sono potere la ricchezza, la liberalità, la reputazione, la popolarità ed ogni buona qualità umana; il successo, l’affabilità, la reputazione di prudenza, la nobiltà, l’eloquenza e così via per i 54 paragrafi dell’edizione Molesworth. Hobbes distingue due tipi di scienza, e pone come criterio della distinzione precisamente la relazione tra l’oggetto e il potere dell’uomo: le scienze dimostrabili, che 21 L. STRAUSS, op. cit. p.6, il quale rimanda, tra altri testi, a OL, II, De Homine c.10, § 4-5, pp.92-94. 22 “He that is to govern a whole nation, must read in himself, not this or that particular man; but mankind: which though it be hard to do, harder than to learn any language or science ; yet when I shall have set down my own reading orderly, and perspicuously, the pains left another, will be only to consider, if he also find not the same in himself. For this kind of doctrine admitteth no other demonstration” (EW, III, Introduction, p.xii). “Hobbes is quite clear that introspection and experience, not a materialistic philosophy, provide the key to understanding human behaviour” (B. GERT. op. cit., p.161). 23 Spiega OAKESHOTT nella sua fondamentale introduzione al Leviathan: “Reasoning is concerned solely with causes and effects. It follows, therefore, that its activity must lie within a world composed of things that are causes or the effects of causes. If there is another way of conceiving this world, it is not within the power of reasoning to follow it; if there are things by definition causeless or ingenerable, they belong to a world other than that of philosophy. (…) He denies, not the existence of these things, but their rationality” (“Introduction” al Leviathan, op. cit., p.xx). 24 “Introduction” al Leviathan, op. cit., p.xxi
© Copyright L’Ircocervo 2012 – Fondazione Gentile Onlus | Autore: Gonzalo Letelier Widow Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it
9
studiano gli oggetti creati dall’uomo, e quelle indimostrabili, che studiano le cose naturali, non create dal’uomo25. Il modello delle prime è la geometria, non perché essa sia la scientia prima, ma perché è stata quella che ha avuto più successo26. L’artificialità del suo oggetto implica, in primo luogo, che la scienza è sempre ipotetica27. Il suo punto di partenza è un principio fittizio (non falso né arbitrario), la cui validità deve essere confermata mediante il ragionamento, cioè il calcolo28 (e non mediante l’esperienza): “Out of all which we may define, that is to say determine, what that is, which is meant by this word reason, when we reckon it amongst the faculties of the mind. For REASON, in this sense, is nothing but reckoning, that is adding and subtracting, of the consequences of general names agreed upon for the marking and signfying of our thoughts”. Le conclusioni, quindi, più che “vere” o “false” in senso tradizionale, sono valide, coerenti e utili29. Una seconda conseguenza è che la intelligibilità delle cose scaturisce esclusivamente dai bisogni umani, i quali diventano così principio della conoscenza30. La rinuncia alla conoscenza della natura costituisce il prezzo da pagare per dominarla: “Finis autem seu scopus philosophiae est, ut praevisis effectibus uti possimus ad commoda nostra, vel ut effectibus animo conceptis per corporum ad corpora applicationem, effectus similes, quatenus humana vis et rerum 25 Per esempio EW, VII, Six Lessons to he Savilian Professors of the Mahematics, pp.183-184 e OL, II, De Homine c.10, § 4, p.92 26 La geometria “is the only science that it hath pleased God hitherto to bestow on mankind” (EW, III, c.4, p.24), “whose conclusions have thereby been made indisputable” (EW, III, c.5, p.33). “And truly the Geometricians have very admirably performed their part. For whatsoever assistance doth accrew to the life of man, whether from the observation of the heavens, or from the description of the earth, from the notation of times, or from the remotest experiments of navigation; finally, whatsoever things they are in which this present age doth differ from the rude simplenesse of antiquity, we must acknowledge to be a debt which we owe meerly to geometry” (EW, II, Epistle Dedicatory del De Cive, p.iv). 27 L. STRAUSS, op. cit., p.7. 28 EW, III, c.5, p.30. Cfr. i cap. 4-5 del Leviathan, e tutta la Pars Prima del De Corpore, il cui titolo nell’edizione Molesworth è, appunto, “Logica sive computatio”. 29 “[P]hilosophy is (…) conditional knowledge, knowledge of hypothetical generations and conclusions about the names of things, not about the nature of things. With these philosophy must be satisfied, though they are but fictions. Indeed, philosophy may be defined as the establishment by reasoning of true fictions” (OAKESHOTT, “Introduction” al Leviathan, op. cit, pp.xxvi-xxvii). L’identificazione del ragionamento pratico con il calcolo strategico è un principio ancora oggi fondamentale nelle scienze pratiche, soprattutto nell’ambito della filosofia analitica. 30 L. STRAUSS, op. cit., 9-10.
© Copyright L’Ircocervo 2012 – Fondazione Gentile Onlus | Autore: Gonzalo Letelier Widow Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it
10
materia patietur, ad vitae humanae usus industria hominum producantur (...) Scientia propter potentiam; Theorema (quod apud Geometras proprietatis investigatio est) propter problemata, id est propter artem construendi; omnis denique speculatio, actionis vel operis alicujus gratia instituta est utiiitas”31. Scientia propter potentiam. È questa la spiegazione ultima dello statuto epistemologico della scienza politica. Come vide Aristotele, se il bene umano è il maggiore tra i beni, esso diventa primo principio pratico e la politica, il primo tra i saperi32: “Dignissima certe scientiarum haec ipsa est, quae ad Principes pertinet, hominesque in regendo genere humano occupatos”33. L’uomo diventa così misura del reale. È sempre un intento operativo a determinare la scelta degli argomenti, il metodo della risposta, il tipo di argomento utilizzato e, infine, l’unità e coerenza di fondo della sua opera. La radicale dimensione operativa della scienza è una delle chiavi interpretative dell’opera di Hobbes. Egli, in effetti, non scrive per conoscere la verità delle cose, ma per risolvere problemi pratici, con una evidente subordinazione dell’argomentazione alle esigenze retoriche dei suoi scopi pratici, fatto che limita profondamente il suo rigore scientifico34. Lo stesso Hobbes ripete spesso che fu portato a scrivere le sue opere fondamentali “propter patriae praesentem calamitatem dolori justo”35. 31 OL, I, De Corpore, c.1, p.6. Anche se non sembra che l’abbia mai riconosciuto, Hobbes riceve una grande influenza dai suoi studi con Francis Bacon. 32 EN, VI, 1141a 20-22. Il punto è rilevato da L. STRAUSS, op. cit., 9-10. 33 OL, II, Praefatio al De Cive, p.142. 34 Un autore come OAKESHOTT, al quale non si può accusare di disprezzare Hobbes (“Leviathan is the greatest, perhaps the sole, masterpiece of political philosophy written in the English language. And the history of our civilization can provide only a few works of similar scope and achievement to set beside it”; “Introduction” al Leviathan, op. cit., p.viii) conclude che è scientificamente scorretto pretendere coerenza in Hobbes. Scusando Hobbes per accusare i suoi critici, riconosce che “there are inconsistencies in his doctrines, there is vagueness at critical points, there is misconception and even absurdity”, (ibidem, p.li), al punto che “we have been exasperated by the ambiguity with which Hobbes uses certain important words (such as obligation, power, duty, forbid, command), and have gone on, in an attempt to understand his theory better than he understood it himself, to interpret it by extracting from his writings at least some consistent doctrine”. (ibidem, p.lviii). Il punto è che Hobbes non è mai stato quel rigoroso “deduttore” di conclusioni necessarie a partire da premesse generali che egli stesso pensava di essere e voleva presentare; il vero Hobbes argomentava con tutti gli strumenti disponibili, in tono francamente polemico, per convincere di una tesi già adottata in precedenza, per esporre una scienza già finita. Questo fa della dimensione retorica dell’opera di Hobbes un aspetto molto più rilevante di quanto lui stesso non volesse riconoscere e la critica non si fosse accorta (cfr. D. JOHNSTON, The Rhetoric of Leviathan, Princeton
© Copyright L’Ircocervo 2012 – Fondazione Gentile Onlus | Autore: Gonzalo Letelier Widow Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it
11
In una efficace sintesi, Francesco Gentile riuniva questi due aspetti della scienza hobbesiana in ciò che denominava “caratteri fondamentali del sapere geometrico”: la convenzionalità (il sapere si fonda su un protocollo ipotetico dal quale si deducono le conclusioni) e la operatività (il sapere non è ricercato per se stesso ma è funzionale ad un obiettivo operativo prefissato)36. La teoria hobbesiana della sovranità, centro e compendio della sua teoria politica, è già implicita in questa particolare visione delle scienza. Basterà semplicemente circoscrivere questo discorso epistemologico generale all’ambito pratico, cioè alla civil science. In effetti, per il nominalismo hobbesiano, radicalmente scettico, “reason is omnipotent because it is impotent”37; può determinare convenzionalmente la realtà, appunto perché è incapace di conoscerla in se stessa. L’uomo è costretto a mettere ordine (ogni ordine) in cose che non ce l’hanno in assoluto, e deve farlo solo da se stesso38. Il problema di un ordine naturale da rispettare o di una verità fattuale da riconoscere non si presenta nemmeno, perché anche se esistessero, non li si potrebbe conoscere. Per la medesima ragione, questo dominio assoluto sulle cose (e sugli uomini) manca di ogni connotazione di valore. Radicalmente neutro, è semplicemente il modo (l’unico modo) in cui possiamo stabilire un rapporto con le cose. Conoscere le cose è costituirle, e University Press, Princeton, 1986; T. SORELL, “Hobbes’s persuasive civil science”, op. cit. e “Hobbes’s UnAristotelian political rhetoric” Philosophy & Rhetoric, Vol. 23, No. 2 (1990), pp.96-108 e V. SILVER, “Hobbes on rhetoric”, in The Cambridge Companion to Hobbes, op. cit., pp.329-345). Il punto si rivela molto illuminante rispetto ad uno dei problemi più controversi degli studi hobbesiani degli ultimi cinquant’anni: l’unità del sistema hobbesiano. La discussione ebbe inizio con L. STRAUSS (The Political Philosophy of Hobbes. Its Basis and Genesis, Oxford University Press, Oxford, 1936), il quale dissocia l’etica e la politica dalla metafisica, continuando con TAYLOR (op. cit.), che gli attribuisce un’etica autonoma dalle altre scienze al modo kantiano, e WARRENDER (op. cit.), il quale fonda etica e politica direttamente sul comando divino. La risposta di OAKESHOTT è molto suggestiva: l’unità del sistema hobbesiano non è da trovarsi nel materialismo o il meccanicismo delle sue premesse “metafisiche”, ma appunto nel suo concetto di filosofia e di scienza, nella sua epistemologia: “the system of Hobbes’s philosophy lies in his conception of the nature of philosophical knowledge, and not in any doctrine about the world”, “Introduction” al Leviathan, op. cit. p.xxvii. 35 Ibidem, p.154. 36 Cfr. F. GENTILE, Filosofia del Diritto, Cedam, Padova, 2006, p.13-21. Pur nella sua semplicità didattica, lo schema risulta particolarmente illustrativo rispetto a Hobbes. 37 L. STRAUSS, op. cit., p.29. 38 Cfr. L. STRAUSS, op. cit., p.8.
© Copyright L’Ircocervo 2012 – Fondazione Gentile Onlus | Autore: Gonzalo Letelier Widow Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it
12
costituirle è sottometterle. Non c’è relazione diversa dall’imposizione del proprio potere sull’altro, e non c’è limite diverso da quello che gli stessi uomini si (auto)impongano. Questa è anche la teoria hobbesiana della sovranità. È possibile trovare certe significative vicinanze tra queste tesi e la posizione di Kelsen, secondo il quale all’interno della scienza giuridica “ci sono soltanto degli interessi e quindi dei conflitti di interessi la cui soluzione è data da un ordinamento degli interessi che, o soddisfa un interesse contro l’altro e a spese dell’altro, oppure stabilisce un accordo, un compromesso fra gli interessi contrastanti”39. Le conseguenze di questa impostazione per il problema in discussione sono immediate. A rigore, la legge non può essere ricevuta in nessun modo dal cittadino, perché prima che gli fosse imposta, costui nemmeno esisteva. Riceve la legge solo chi è stato dichiarato soggetto alla legge dalla stessa legge40. Così come è la scienza teoretica a costituire il suo oggetto, così è la legge a costituire il cittadino e ad attribuirgli i suoi diritti. E così come ogni limite naturale è sempre estrinseco all’atto di posizione dell’oggetto, così la potestà legislativa del sovrano è assoluta, e non riconosce un ordine anteriore a se stesso Da una prospettiva esterna alla scienza, l’applicazione di una legge è pura forza. Ma qualificarla propriamente come forza supporrebbe un cittadino preesistente, un soggetto reale al quale questa legge viene imposta, una persona naturalmente giuridica. Tutto cambia dalla prospettiva propria della scienza giuridica, quella che Kelsen chiama “oggettiva”41. Così, per esempio, rispetto alla pietra, i colpi dello scalpello sono pura violenza, un’“aggressione” dello scultore; ma per la scultura, è quello che la costituisce come tale, quello che la fa possibile in assoluto. Il cittadino è un prodotto del contratto,
39 H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Einaudi, Torino, 2000, p.58. Il che non vuol dire che per il “cittadino” e l’“uomo” Kelsen (secondo la nota distinzione proposta da Treves per difenderlo dalle accuse di legittimare le peggiori aberrazioni giuridiche; cfr. la Prefazione del 1967, ibidem, p.14 e 19) non ci fossero rapporti intersoggettivi non conflittuali, ma che questi, se esistono in assoluto, sono irrilevanti per la scienza giuridica. Per lo stesso Hobbes, come per i giusnaturalisti moderni in generale, lo stato di natura non é altro che una finzione “vera”. 40 La risposta di buona parte dell’imperativismo, ma anche quella di Kelsen, è sostanzialmente identica: i veri destinatari della norma giuridica non sono i cittadini ma i funzionari che, ancora una volta, sono costituiti come tali dalla stessa legge. 41 Cfr. H. KELSEN, op. cit., pp.49-52.
© Copyright L’Ircocervo 2012 – Fondazione Gentile Onlus | Autore: Gonzalo Letelier Widow Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it
13
un artificio. L’atto legislativo del sovrano non è una vera limitazione della sua libertà, perché in realtà non è mai stato libero:
For in the act of our submission, consisteth both our obligation, and our liberty; which must therefore be inferred by arguments taken from thence; there being no obligation on any man, which ariseth not from some act of his own; for all men equally, are by nature free42.
Nella versione hobbesiana del contratto non c’è vera dicotomia tra uomo e cittadino perché il patto, essendo unilaterale, costituisce soltanto il sovrano, e i sudditi si definiscono esclusivamente per il suo rapporto ad esso. Un vero e proprio cittadino (nozione, questa, che a differenza di “suddito” possiede un suo significato indipendente43) non c’è affatto. La mutazione prodotta dal contratto nell’individuo è solo accidentale, e di conseguenza, la legge si presenta ancora come un limite alla sua libertà. A rigore, lo stato civile è una mera continuazione dello stato di natura; e infatti, come si avrà opportunità di vedere, la nozione hobbesiana di legge conserva molto di quella imposizione arbitraria della volontà del più forte propria dello stato di natura, anche in una prospettiva intrasistematica. A differenza di Rousseau, Hobbes non riesce a distinguere chiaramente tra i due stati, perché questo implicherebbe stabilire una frattura radicale tra l’homme e il citoyen, appunto quella proposta da Rousseau. Non a caso, il sovrano non è mai uscito dallo stato di natura. In sintesi, per Hobbes la scienza politica non ha come funzione propria la comprensione della società politica; la sua funzione è proprio stabilirla. Ma la si stabilisce utilizzando i materiali che c’erano prima di essa, senza alcun tipo di mutamento di sapore metafisico. Di conseguenza, è necessario supporre che questa materia con la quale si lavora sia la peggiore pensabile. Da Hobbes in poi, una scienza politica valida dovrà essere efficace anche per una società di diavoli44. Lo stesso principio regge la sua teoria dell’azione. 3. La scienza e i motivi dell’azione umana 42 Cfr. EW, III, c.21, p.203. 43 Non esiste suddito se non c’è un signore; il termine “cittadino”, invece, non designa una relazione di dipendenza. 44 I. KANT, Per la pace perpetua, primo supplementi degli articoli definitivi (PP, p.312).
© Copyright L’Ircocervo 2012 – Fondazione Gentile Onlus | Autore: Gonzalo Letelier Widow Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it
14
Il Leviathan comincia con una definizione dello Stato come un uomo artificiale, rispetto al quale l’uomo naturale costituisce la sua materia e il suo artefice45. L’opera di Hobbes è condizionata da questo punto di partenza: se l’individuo conosce solo se stesso, il problema politico consiste sostanzialmente nel riuscire a costituire attraverso la scienza dei rapporti intersoggettivi che siano diversi dalla violenza e la sopraffazione46. Siccome la vita in comune è impossibile per ipotesi, dovremo accontentarci della coesistenza delle individualità. Questa tesi non ha niente a che fare con la mitica “cattiveria” dell’uomo naturale hobbesiano. Le sue radici ultime stanno invece nella sua teoria della conoscenza, di stampo nominalistico, in virtù della quale solo l’individuo è reale. La società politica, invece, è un artificio creato per salvare l’uomo dai rischi di questa solitudine originale. Nasce con Hobbes la funzione soteriologica dello Stato moderno47. In effetti, la riflessione politica hobbesiana è segnata da una fortissima dimensione teologica, o meglio, escatologica. Come i classici, ma in un modo sovvertito, Hobbes attribuisce alla sapienza una capacità di redimere l’uomo dalla sua condizione naturale. Ma per lui, la sapienza, il primo dei saperi, non è altro che la “civil science”. Tuttavia, “natura non nisi parendo vincitur”48. È necessario capire i motivi naturali dell’azione umana per poter dirigerla. Ragione , vo lontà e rego le
45 Cfr. EW, III, pp.ix-x. 46 In realtà, come ha insegnato Francesco Gentile, il primo problema non è la possibilità di fondare una città partendo da premesse individualistiche, ma la possibilità stessa di un individualismo che non sia contraddittorio. In estrema sintesi, è la medesima autosufficienza dell’individuo ad esigere strutturalmente un suo riconoscimento dagli altri. Questo problema intrinseco a tutte le “geometrie legali” costituisce ciò che Gentile chiamava “l’aporia dell’individualismo”. Cfr. F. GENTILE, Filosofia del Diritto, op. cit., pp.135-142 e Intelligenza politica e ragion di Stato, Giuffrè, Milano, 1984, pp.223-229. 47 Su questo punto, cfr. OAKESHOTT, “Introduction” al Leviathan, op. cit., pp.liii-liv, il quale addirittura attribuisce a questa idea un’origine agostiniana, e F. GENTILE, “Esperienza giuridica e secolarizzazione”, in Esperienza giuridica e secolarizzazione, Atti dell’incontro di Pavia, 17, 18 e 19 settembre 1992, Giuffrè, Milano, 1994. 48 F. BACON, Novum Organum, libro I, aforisma 3.
© Copyright L’Ircocervo 2012 – Fondazione Gentile Onlus | Autore: Gonzalo Letelier Widow Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it
15
Come per l’empirismo in generale, per Hobbes la conoscenza è un processo eminentemente passivo e recettivo. La conoscenza non è tanto un atto del soggetto, quanto una modificazione meccanica dei suoi sensi. Di conseguenza, l’azione umana dipende semplicemente dal desiderio. In questo schema, “the thoughts are to the desires, as scouts; and spies, to range abroad, and find the way to the things desired”49. Il desiderio è la causa del “animal motion, otherwise called voluntary motion”50. La sinonimia tra questi due termini è molto significativa. Hobbes non distingue tra un appetito animale ed un altro razionale; anzi, la stessa idea di un appetito razionale gli sembra assurda, perché implicherebbe che non potrebbe esserci un atto volontario contrario alla ragione51. La volontà, che è atto e non facoltà52, è “the last appetite in deliberating”, e questa deliberazione, che consiste in una “alternate succession of appetites, aversions, hopes and fears”, esiste “no less in other living creatures than in man”53. In sintesi, “[l]’uomo è un essere della natura, determinato da leggi meccaniche, dominato da passioni connaturate e prepotenti”54. Questa riduzione della volontà a atto è determinante al momento di spiegare la coerenza e continuità della condotta dell’uomo. Questa non radica più in una inclinazione costante verso certi oggetti connaturata al soggetto, ma nella mutabile presenza di oggetti proporzionati alla contingente condizione del soggetto. In altri termini, essendo atto e non facoltà, la volontà non “si muove” ma “è mossa”. In questo contesto, il bene dipende da appetiti e avversioni che sono sempre in movimento. Secondo Hobbes,
whatsoever is the object of any man’s appetite or desire, that is it which he for his part calleth good: and the object of his hate and aversion, evil; and of his contempt, vile and inconsiderable. For these words of good, evil, and contemptible, are ever used with relation to the person that useth them: there being nothing simply and absolutely so; nor any common rule of good and
49 EW, III, c.8, p.61. 50 EW, III, c.6, pp.38-39. 51 Cfr. EW, III, c.6, p.48. 52 EW, IV, Of Liberty and Necessity, p.266: “as it is absurdly said, that to dance is an act allured, or drawn by fair means, out of the ability to dance; so is it absurdly said, that to will or choose, is an act drawn out of the power to will”. 53 EW, III, c.6, pp.48-49. 54 N. BOBBIO, “Introduzione al De Cive”, op. cit., p.95.
© Copyright L’Ircocervo 2012 – Fondazione Gentile Onlus | Autore: Gonzalo Letelier Widow Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it
16
evil, to be taken from the nature of the objects themselves; but from the person of the man, where there is no commonwealth; or, in a commonwealth, from the person that representeth it; or from ail arbitrator or judge, whom men disagreeing shall by consent set up, and make his sentence the rule thereof55.
Non esiste bene assoluto; bene e male non altro sono che nomi per designare quello che a ciascuno appare tale. Ma siccome la volontà non è libera (nel senso di capace di autodeterminarsi56), il fatto che qualcosa ci si presenti come buono non dipende da noi. E allora, da cosa dipende? Non dalla natura delle cose, è indubbio; ma neanche solamente dalla “persona dell’uomo”, dei suoi appetiti e desideri, perché questi costituiscono una regola puramente individuale. Solo la legge può essere “regola comune” del bene e del male. In altri termini, l’azione umana dipende, indistintamente e allo stesso modo, dalle passioni soggettive e dalla legge, che sono regole individuali e comuni rispettivamente. Infatti,
The language of desire, and aversion, is imperative; as do this, forbear that; which when the party is obliged to do, or forbear, is command; otherwise prayer; or else counsel.57
Secondo questa definizione di bene, le regole comuni (la legge) potranno influire sulla condotta solo attraverso le regole individuali (le passioni), cioè rendendo la cosa soggettivamente indesiderabile alla maggior parte degli uomini mediante l’introduzione di una passione più intensa di quella spontanea: la paura della sanzione. Così, Hobbes ci libera dalle regole morali oggettive per legarci, ipso facto, al determinismo degli appetiti e la coazione della legge. 55 EW, III, c.6, p.41. 56 Secondo Hobbes, atto “libero” è quello non prodotto da un impulso esterno, il che non significa che non sia necessitato. “Necessario” è il contrario di “contingente”, non di “libero”. Atti veramente “contingenti” non ce ne sono in assoluto. Il concetto è complesso perché prodotto da un tentativo di conciliare tesi profondamente opposte tra di loro. In realtà, queste opposizioni (e i luoghi in cui studia il tema) dimostrano che per Hobbes la libertà è un problema politico, non antropologico. Infatti, il suo unico vero contrario è la legge. Hobbes la studia come problema a se stante in due opere polemiche: On liberty and necessity (EW, IV, pp.229-278); trad. it. de Andrea Longega, Libertà e Necessità, Bompiani, Milano, 2000) e Questions concerning Liberty, Necessity and Chance (EW, V, trad. it. parziale nella stessa opera), ma lì il problema è metafisico e teologico. In rigore, la libertà è del tutto irrilevante per comprendere l’azione umana. 57 EW, III, c.6, p.50.
© Copyright L’Ircocervo 2012 – Fondazione Gentile Onlus | Autore: Gonzalo Letelier Widow Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it
17
Con Hobbes, l’atto di legiferare acquista un carattere amorale ed esclusivamente tecnico, il quale sarà profondamente modificato lungo la modernità, ma non sarà mai perso58. La questione non è già come dirigere le azioni libere ad un bene sociale, ma come condizionare la condotta (esterna) degli uomini mediante le loro passioni per raggiungere un determinato scopo scelto dal sovrano. La questione, quindi, è rendere l’azione umana oggetto di vera scienza. Fel i c i tà , potere , paura Seguendo il proprio concetto di scienza, Hobbes vuole spiegare i motivi dell’azione umana per poter modificarla. Ciò suppone identificare quell’oggetto che i diversi appetiti non possono non desiderare, in virtù del quale si desidera ogni cosa e il cui possesso costituisce la vera felicità. Non essendoci un bene assoluto che assuma questa funzione di finis ultimus e summum bonum, quell’oggetto non potrà che essere formale, astratto e generico. Così, per Hobbes la felicità è
[c]ontinual success in obtaining those things which a man from time to time desireth (…) For there is no such thing as perpetual tranquillity of mind, while we live here; because life itself is but motion, and can never be without desire, nor without fear, no more than without sense59.
La conseguenza di questo concetto di felicità è la decomposizione del bene umano in una successione indefinita di beni:
(…) the object of man’s desire, is not to enjoy once only, and for one instant of time; but to assure for ever, the way of his future desire, and
58 Come afferma T. NAGEL in un famoso articolo (“Hobbes’s Concept of Obligation”, Philosophical Review, Vol. 68, No. 1 (1959), pp. 68-83, p.74) la tesi secondo la quale “no man can ever act voluntarily without having as an object his own personal good”, ammessa anche da chi, come Warrender e Taylor vorrebbe postulare un genuino obbligo morale in Hobbes, costituisce in realtà “ the ruin of any attempt to put a truly moral construction on Hobbes's concept of obligation. It in a way excludes the meaningfulness of any talk about moral obligation. It deprives it of any room to work” In effetti, “[n]othing could be called a moral obligation which in principle never conflicted with self-interest”. HART addirittura considera “la permanente possibilità di conflitto tra l’obbligo o dovere e l’interesse” come uno dei tratti identificatori dell’obbligo. Cfr., HART, H. The concept of law, with a postscript edited by Penelope A. Bulloch and Joseph Raz, Clarendon, Oxford, 1994, tr. it. di M. Cattaneo, Il concetto di diritto, Torino, Einaudi, 2002, p.104. 59 EW, III, c.6, p.51.
© Copyright L’Ircocervo 2012 – Fondazione Gentile Onlus | Autore: Gonzalo Letelier Widow Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it
18
therefore the voluntary actions, and inclinations of all men, tend, not only to the procuring, but also to the assuring of a contented life60.
Vista la fragilità della vita felice, la possibilità di ottenerla dipende soltanto dal potere, il quale consiste nei “present means, to obtain some future apparent good”61. Con queste premesse, Hobbes può concludere: “I put for a general inclination of all mankind, a perpetual and restless desire of power after power, that ceaseth only in death”62. In altre parole, l’oggetto universale e necessario delle passioni dell’uomo è il potere63. E questo desiderio si realizza in due inclinazioni fondamentali. Da una parte, nell’amore per la vita, la comodità e il piacere, che si riducono al desiderio della propria conservazione, desiderio primario e fondamentale, causa di tutti gli altri e fondamento del primo diritto naturale64; “the sole root of all justice an morality”65. In secondo luogo, questo desiderio di potere si realizza nelle avversioni ai rispettivi contrari, le quali si riducono alla paura della morte, in particolare della morte violenta a mani di un altro. Questa passione non è certamente la prima, ma è quella più intensa66. In effetti, mentre la vita è solo un bene primario, ma non il sommo bene (che per Hobbes non esiste affatto), la morte invece, essendo contraria ad ogni bene, è il maggiore dei mali possibili. Così, paradossalmente, la morte si teme di più di quanto non si ami la vita. La distinzione è importante perché spiega il fatto che, seppur ci sono certi beni che si amano più della vita stessa67, solo la paura della morte costituisce il vero motore dell’azione umana. Con le parole di Strauss, “death takes the place of the telos”68. 60 EW, III, c.11, p.85. 61 EW, III, c.10, p.74. 62 EW, III, c.11, p.86. 63 Cfr. EW, III, c.10. 64 EW, III, c.14, 116-117. 65 L. STRAUSS, op. cit. p.13. 66 Secondo Bobbio, “[s]olo una passione nell’uomo è più forte dell’amor propio: ed è la paura di morire. Vanitoso ed egoista, l’uomo è anche vile” (N. BOBBIO, “Introduzione al De Cive”, op. cit., p.96). Pur condividendo l’interpretazione, non sembra lecito un giudizio morale su questa condizione dell’uomo che, secondo Hobbes, è un puro fatto anteriore ad ogni moralità. 67 Nonostante ciò, in OL, II, De Homine c.11, §6, p.98, Hobbes afferma che “Bonorum autem prima est sua cuique conservatio” (nella versione inglese, è “the greatest of goods”). Gli interpreti che seguono Warrender, utilizzano questa tesi dei beni superiori alla propria vita per confutare il cosiddetto “egoismo psicologico” hobbesiano. Secondo loro, nel Leviathan, Hobbes voleva soltanto dimostrare la validità delle sue tesi anche nei peggiori dei casi (cfr., per esempio, B. GERT, op. cit., pp.166-168, il quale rimanda a in primo luogo a De Cive, c.3, §12, e all’ottava legge naturale dello
© Copyright L’Ircocervo 2012 – Fondazione Gentile Onlus | Autore: Gonzalo Letelier Widow Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it
19
I mot iv i de l l ’azione e l ’osservanza de l la l egge Hobbes dichiara espressamente di voler fondare la scienza politica sulle effettive inclinazioni dell’uomo69. Di conseguenza, l’obbedienza soggettiva alla legge e l’osservanza di patti in generale si possono comprendere solo come il prodotto di un calcolo di convenienza individuale, secondo il quale il timore di una sanzione difficilmente evitabile risulta superiore alla speranza dei vantaggi che risulterebbero dalla trasgressione70. In una sola battuta, la teoria dell’azione di Hobbes e la politica fondata su essa si può sintetizzare dicendo che l’uomo “can never perform any action unless he believes it to be in his own best interest”71. La tesi di Hobbes è indubbiamente attuale. Così enunciato, il principio risulta piuttosto vicino all’ipotesi metodologica che sta alla base della “teoria dei giochi” e del ragionamento pratico inteso come “calcolo strategico”. Sono cambiati forse i termini e lo scopo del calcolo (il massimo vantaggio individuale in un contesto cooperativo), ma l’ipotesi rimane identica: l’uomo si muove soltanto per interessi personali, o almeno stesso Leviathan (EW, III, c.15, p.140); alle definizioni di Leviathan c.6, in particolare quella d’“indignazione”, e poi a De Homine, c.13, §9, a De Cive, Prefazione; c.2, §19; c.6, §5; c.3, §5; e infine Leviathan, cap.15). In realtà, anche questi passi possono leggersi come manifestazioni complesse dell’interesse proprio. Lo stesso Gert, d’altra parte, riconosce che Hobbes no prendeva le sue definizioni troppo sul serio, e si limitava a consegnare gli usi correnti utili alle sue teorie (B. GERT, op. cit., p.162). Come afferma Nagel, confutando precisamente Warrender, “an egoistic theory of motivation permeates the entire book [il Leviathan]” e “the arguments are in no way hidden”. Almeno due degli argomenti presentati sembrano definitivi: in primo luogo, il fatto che la giustificazione di ogni singola legge naturale è quella di evitare la guerra e salvare la propria vita; d’altra parte, la spiegazione di perché certi diritti, come ad esempio, il diritto di resistere sono inalienabili (NAGEL, op. cit. p.69). Infine, valgono come conferme, tra tanti altri passi, tutto il capitolo 10 del Leviathan sul potere, e il ragionamento sul odio che segue ai benefici ricevuti da uomini uguali (EW, III, c.11, p.87-88). 68 STRAUSS, op. cit., p.13. 69 EW, III, p.710: “For I ground the civil right of sovereigns, and both the duty and liberty of subjects, upon the known natural inclinations of mankind, and upon the articles of the law of nature”. In questo contesto, l’aggettivo “naturale” riferito alle inclinazioni designa la loro effettività, non la sua origine nella natura dell’uomo. 70 Cfr., por ejemplo, E. VITALE, Dal disordine al consenso, FrancoAngeli, Milano, 1994, p.147. 71 NAGEL, op. cit., p.74.
© Copyright L’Ircocervo 2012 – Fondazione Gentile Onlus | Autore: Gonzalo Letelier Widow Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it
20
bisogna pensare come se così fosse per convalidare i calcoli. Il che dimostra che, in ultim’analisi, si è accolta anche la sua psicologia egoistica. In questo contesto, il suddito obbedisce sempre contro se stesso, contro la propria volontà attuale. Anche se avesse un’intenzione perfettamente altruista di compiere la parola data o di obbedire alla legge, la sua volontà non è libera, e quindi non si può compromettere per il futuro. Come si è detto prima, la volontà è un atto, non una facoltà; le sue volizioni non dipendono da un’inclinazione fondamentale verso certi fini conosciuti come buoni, ma dalla presenza ai sensi di certi oggetti piacevoli, e quindi la stessa idea di legarla ad una promessa diventa improponibile. Nelle sue parole, le volizioni “proceed not from, but are the will; and the will is not voluntary: for a man can no more say he will will, than he will will will, and so make an infinite repetition of the word; which is absurd, and insignificant”72. D’altra parte, anche se ci fosse una piena coincidenza tra quello che la legge comanda e quello che il suddito vuole, questo fatto non sarebbe altro che, appunto, una mera coincidenza teoricamente indifferente, perché volontà e legge rimangono opposte e irriducibili per ipotesi. Ma allora, come è possibile il contratto che origina la società? L’uomo può fissare la propria volontà soltanto dal di fuori, mettendo se stesso in circostanze tali da necessitare le proprie azioni future. In concreto, lo fa stabilendo un potere così severo che sia psicologicamente impossibile volere una cosa diversa da quella che esso comanda73. In questo modo, in virtù di una scelta dello stesso suddito, “he that is to command, may by the use of all their means and strength, be able by the terror thereof to frame the will of them all to unity and concord, amongst themselves”74. In questo modo, Hobbes riconduce e riduce il diritto alla forza. Tuttavia, questo non significa necessariamente ammettere una vera identità75. In altri termini, è vero che “[f]ear of punishment is the cause of political obedience”76; ma questa affermazione lascia apperto il problema della vera causa dell’obbligo politico77. 72 EW, IV, Elements of Law, natural and civil, p. 69. 73 Cfr. H. PITKIN, “Hobbes’s concept of representation, II”, op. cit., p.903. 74 EW, IV, p.122. È significativo che in questo contesto politico Hobbes parli di “terror” e non soltanto di “fear”. 75 Ringrazio Gabriele De Anna per questa precisazione. 76 PETERS, op. cit, p.207. 77 Cfr. WARRENDER, op. cit., p.212: “The laws of nature, that command the individual to seek peace, keep covenants, &c., are from one point of view rational maxims for self-preservation; and
© Copyright L’Ircocervo 2012 – Fondazione Gentile Onlus | Autore: Gonzalo Letelier Widow Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it
21
La questione importante da notare è comunque il fatto che lo stato civile è prodotto da un esercizio intellettuale, è un artificio fondato su ciò che c’era prima e profondamente condizionato da esso. Lo stato di natura hobbesiano è un’ipotesi, anche se, a differenza di Locke, Rousseau o Kant, per lui non è non una pura astrazione. Con intenzione persuasiva, e in realtà contro il suo metodo, Hobbes propone esempi empirici come prova della sua argomentazione: la vita dei selvaggi americani, la guerra civile e, in generale, i rapporti tra gli stati78. E tuttavia, sia quando conserva una certa fedeltà al metodo ipotetico, sia quando si discosta da esso indicando casi concreti che dimostrano le sue tesi, ciò che muove l’argomentazione è sempre la pretesa di scientificità. 4. Il contratto come esigenza della ragione La prima caratteristica dello stato di natura è l’uguaglianza tra tutti gli uomini79: tutti siamo ugualmente miserabili. Hobbes riconosce le differenze naturali, tanto intellettuali quanto fisiche, ma le considera irrilevanti: il fatto è che qualsiasi uomo, anche il più debole, ha la forza sufficiente per uccidere un altro uomo, anche il più forte80. Questa uguaglianza naturale è causa dell’uguaglianza delle aspettative di potere, la quale, a sua volta, produce diffidenza e da questa, infine, nasce la guerra. Paradossalmente, ma sempre d’accordo con le premesse, questa guerra di tutti contro tutti non è una guerra per il potere, ma per la sopravvivenza. L’uomo dello stato di natura non si muove tanto per ambizione quanto per paura; domina, sì, ma per non essere dominato, ed uccide per non essere ucciso.
one answer to the question of why the citizen should obey the civil law, is that obedience constitutes the best means to his preservation (...) This answer, given in terms of self-preservation, however, is concerned with motive and not with obligation. (...) this consideration does not ensure their obligatory character”. Secondo questo autore, “it is only in their aspect of being commands of God that they are laws and hence oblige” (p.213). 78 Cfr. EW, III, c.13, 114-115. 79 EW, III, c.13, p.110. Non lo è l’assenza della legge, né il diritto a tutto né la guerra di tutti contro tutti, che sono effetti derivati da questa uguaglianza naturale. 80 Idem. Vid anche De Cive, c.1, §3.
© Copyright L’Ircocervo 2012 – Fondazione Gentile Onlus | Autore: Gonzalo Letelier Widow Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it
22
L’uomo naturale hobbesiano viene spesso rappresentato come uno che odia i suoi simili. L’atteggiamento naturale, invece, è piuttosto d’indifferenza, interesse egoistico e paura. Come afferma Nagel, “[h]e is susceptible only to selfish motivation, and is therefore incapable of any action which could be clearly labeled moral. He might, in fact, be best described as a man without a moral sense”81, il che è molto diverso da essere “immorale”. Il dramma del’uomo hobbesiano è che la sua natura individuale si oppone alla condizione sociale: “what the one urges with hope of achievement, the other makes impossible”82: il problema risiede, dunque, nella sua natura, non in una inesistente perversione morale. Homo homini lupus, certo, ma i lupi non sono moralmente cattivi. La guerra totale di Hobbes è una semplice deduzione dalla lotta per il potere, la quale, a sua volta, è il prodotto inevitabile della ricerca di felicità83. Infatti, la guerra non consiste in una situazione permanente di belligeranza, ma in una disposizione stabile ad una violenza puramente difensiva84. Solo se si coglie la profonda razionalità dello stato di natura hobbesiano si riesce anche a cogliere quanto indesiderabile esso sia, e quanto vicino risulti a quella inconfessata idea di uomo sottostante le scienze giuridiche contemporanee. Naturalmente, in queste condizioni
there is no place for industry; because the fruit thereof is uncertain: and consequently no culture of the earth; no navigation, nor use of the commodities that may be imported by sea; no commodious building; no instruments of moving, and removing, such things as require much force; no knowledge of the face of the earth; no account of time; no arts; no letters; no society; and which is worst of all, continual fear, and danger of violent death; and the life of man, solitary, poor, nasty, brutish, and short85.
È difficile immaginare una condizione più pietosa. Ma, come afferma Oakeshott, “[t]he remedy of the disease is homeopathic”86, perché “[t]he passions that incline men to peace” sono le stesse che cagionarono la guerra: “fear of death; desire of such things as are necessary to
81 T. NAGEL, op. cit., p.74. 82 M. OAKESHOTT, “Introduction” al Leviathan, op. cit., p xxxv; cfr. ibidem, p.lv. 83 M. OAKESHOTT, “Introduction” al Leviathan, op. cit., p.xxxiv. 84 EW, III, c.13, p.113. Hobbes definisce la pace mediante la guerra, e non viceversa. 85 EW, III, c.13, p.113. 86 M. OAKESHOTT, “Introduction” al Leviathan, op. cit., p.xxxvi.
© Copyright L’Ircocervo 2012 – Fondazione Gentile Onlus | Autore: Gonzalo Letelier Widow Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it
23
commodious living; and a hope by their industry to obtain them”87. La paura genera prudenza, la prudenza muove il ragionamento e, mediante questo, l’uomo riesce a trovare un modo di superare la propria condizione. Il costo, però, è molto elevato: la rinuncia totale ad ogni altra passione o desiderio, perché “[a]nything less than total obedience is total destruction”88. Il fatto che gli uomini siano disposti a sottoscrivere questo contratto ci dà la misura della paura hobbesiana. Infatti,
though of so unlimited a power, men may fancy many evil consequences, yet the consequences of the want of it, which is perpetual war of every man against his neighbour, are much worse. The condition of man in this life shall never be without inconveniences; but there happeneth in no commonwealth any great inconvenience, but what proceeds from the subject’s disobedience, and breach of those covenants, from which the commonwealth hath its being. And whosoever thinking sovereign power too great, will seek to make it less, must subject himself, to the power, that can limit it; that is to say, to a greater89.
5. Il sovrano, il patto e la legge come conclusioni scientifiche Le schiaccianti attribuzioni del sovrano costituiscono per Hobbes una tesi capitale, ma sistematicamente derivata. Non una premessa, ma una conclusione. Secondo Bobbio, addirittura, “tranne che nel nome, lo stato di Hobbes non aveva, come fu osservato da Carl Schmitt, nulla di mostruoso: era pura e semplicemente, in una età dominata dalla concezione meccanicistica dell’universo, una grande macchina, la macchina macchinarum”90. In altri termini, a causa
87 EW, III, c.13, p.116. 88 Q. SKINNER, “Hobbes’s Leviathan”, The Historical Journal, Vol.7, No.2, 1964, pp. 321-333, p.329. 89 EW, III, c.20. p.195. 90 BOBBIO, “Legge naturale e legge civile nella filosofia politica di Hobbes”, in N. BOBBIO, op. cit., p.68. Nonostante il pretesto storicistico di Bobbio, la mostruosità del Leviathan si trova precisamente nel aver trasfomato la società degli uomini in una macchina. Per le conseguenze giuridiche di questa visione (e per il profondo disagio di vederla seriamente considerata), vid. le riflessioni sulla Machina machinarum di N. IRTI, Nichilismo giuridico, Laterza, Roma – Bari, 2004.
© Copyright L’Ircocervo 2012 – Fondazione Gentile Onlus | Autore: Gonzalo Letelier Widow Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it
24
della natura dell’uomo, “sovereign power [is] not so hurtful as the want of it”91. Lo dimostra l’ostinata sopravvivenza di questa tesi in autori che non sarebbero mai disposti a riconoscere ad un monarca i poteri che gli attribuisce Hobbes. La società politica, da parte sua è un artificio, fondato non su una legge naturale relativa al bene umano92, ma sui diritti di un uomo che crea questa legge. Da Hobbes in poi, i diritti sono anteriori alla legge93, e questo ordine di precedenza implica che la società è soltanto ciò che gli uomini hanno voluto che essa sia. Fin qui, la questione è più o meno chiara. Un grosso problema, tuttavia, è determinare se gli uomini in stato presociale potevano volere altro. Il punto è molto controverso, perché Hobbes risulta qui particolarmente ambiguo. In effetti, non è chiaro se la legge naturale è vera legge (e non un mero consiglio prudenziale94), e perfino si potrebbe dubitare se il patto sociale è prodotto univoco di un ragionamento corretto. Ma se così fosse in entrambi i casi, dovremmo concludere che esiste un vero dovere morale di sottoscrivere il contratto, e questo
91 È il titolo dell’ultimo paragrafo del cap. 18 del Leviathano nell’edizione Molesworth. Cfr. EW, III, pp.169-170. 92 Secondo BOBBIO (“Legge naturale e legge civile nella filosofia politica di Hobbes”, op. cit.), la società e il patto si fondano sulla legge naturale che obbliga a ricercare la pace. L’interpretazione è sen’zaltro valida, ma resta il fatto che Hobbes enuncia questa legge in modo inseparabile dal primo diritto naturale (cfr. EW, III, c.13). Per il nostro problema, l’esistenza di un primo dovere che fonda doveri e diritti è relativamente indifferente, almeno fintantoché non si neghi la priorità dei diritti nella mentalità hobbesiana e moderna (vid. la citazione di STRAUSS nella prossima nota). Secondo Thomas NAGEL, op. cit., p.71, le definizioni di legge, libertà e diritto sono semplicemente contraddittorie: “Hobbes's position (...) appears in fact to be self-contradictory. For on the first page of Chapter 14 [EW, III, p.116], Hobbes makes the following sequence of assertions: first, that the right of nature is the liberty that each man has to preserve his own life; second, that a law of nature is a precept by which a man is forbidden to do what is destructive of his life, or to omit that by which he thinks it may be preserved; third, that since right is the liberty to do or forbear, whereas law binds you to do one particular thing, law and right differ as much as obligation and liberty, which are in one and the same matter inconsistent”. 93 L. STRAUSS, op. cit., p.13: “the fundamental moral fact is not a duty but a right (…) By nature, there exists only a perfect right and no perfect duty. The law of nature, which formulates man’s natural duties, is not a law, properly speaking”. In Hobbes, tuttavia, questa precedenza è puramente logica; solo con Locke la legge si subordinerà anche funzionalmente ai diritti. 94 Contro EW, III, c.15, p.147
© Copyright L’Ircocervo 2012 – Fondazione Gentile Onlus | Autore: Gonzalo Letelier Widow Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it
25
implicherebbe riconoscere un obbligo anteriore al patto95. Il problema rimane aperto. In ogni caso, anche se non ci fosse alcuna necessità logica, è indubbio che, per Hobbes, il contratto è almeno una esigenza della ragione96 e certamente vorrebbe presentarsi come una conclusione scientifica. Molto più chiara risulta, invece, la natura della legge civile. Secondo la filosofia politica classica, lo scopo primario della legge era quello di manifestare un bene comune a tutti perché fosse scelto liberamente dai cittadini; adesso, invece, la legge stabilisce e determina il bene, presentandolo ai sudditi sotto minaccia di coazione. Per Hobbes non esiste un bene comune, ma non solo perché non c’è un bene, ma soprattutto perché non c’è comunità, perché non esiste alcunché di veramente comune a molti. A partire da Hobbes, la causa dell’unità della società sono soltanto
the BONDS, by which men are bound, and obliged: bonds, that have their strength, not from their own nature, for nothing is more easily broken than a man’s word, but from fear of some evil consequence upon the rupture97.
Quello che spinge uomini che non condividono nulla a unirsi in società è il timore di tutti verso tutti; quello che li mantiene uniti, invece, è il terrore istituzionalizzato di tutti verso uno; con le parole di Bobbio, lo Stato “è la risposta della paura organizzata alla paura scatenata”98. Secondo Hobbes, nello stato di natura “[t]he notions of right and wrong, justice and injustice have there no place. Where there is no common power, there is no law: where no law, no injustice”. Al di là del suo radicale legalismo etico, questa affermazione esprime il vincolo teorico fra la legge e i rapporti sociali fra gli uomini. Se il giusto e l’ingiusto dipendono esclusivamente da una legge99, la quale, a sua volta, si definisce come comando di un
95 In modo salomonico, VITALE ritiene che il contratto non è conclusione necessaria della scienza, ma solo consiglio opportuno della prudenza (op. cit., p.133). 96 Cfr. la seconda legge di natura, EW, III, c.15, p.118. 97 EW, III, c.14, p.119. 98 N. BOBBIO, “Introduzione al De Cive”, op. cit., p.98-99. 99 EW, II, De Cive, c.6, §16, p.85: “Theft, murder, adultery, and all injuries are forbid by the laws of nature; but what is to be called theft, what murder, what adultery, what injury in a citizen, this is not to be determined by the natural, but by the civil law: for not every taking away of the thing which another possesseth, but onely another mans goods is theft; but what is ours, and what anothers, is a question belonging to the civil law. In like manner, not every killing of a man is
© Copyright L’Ircocervo 2012 – Fondazione Gentile Onlus | Autore: Gonzalo Letelier Widow Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it
26
potere comune, allora ci sarà giustizia ed ingiustizia soltanto rispetto al sovrano, perché solo con il sovrano esisteranno rapporti giuridicamente rilevanti. La funzione del diritto positivo, vera scienza giuridica derivata dalla scienza politica, non potrà più essere quella di superare il conflitto mediante la ricomposizione della relazione interrotta, perché è la stessa relazione a costituire il conflitto e a stabilire la rottura. La sua funzione sarà invece quella di neutralizzare il conflitto, cioè, di sancire definitivamente la rottura per sovrapporre all’assenza oggettiva di ordine, dal di fuori e dal di sopra, un ordine astratto, virtuale, disegnato dalla ragione sovrana e giustificato dalla sua volontà100. Il sovrano di Hobbes è il primo dei scienziati sociale.
murder, but onely that which the civil law forbids; neither is all encounter with women adultery, but onely that which the civil law prohibits”. È vero, e probabilmente anche Hobbes pensava così, che questi atti sono contrari alla legge naturale perché si oppongono al bene altrui, ma la stessa legge naturale è vera legge solo nella misura in cui il sovrano la riconosca tale (cfr. EW, III, p.145). 100 Per questa impostazione del problema, cfr. Francesco GENTILE, Filosofia del Diritto,op. cit. pp.179-228.