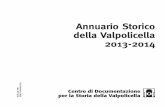Poveri e neppure belli: l’insignificanza dei luoghi come poesia senza nostalgia
Condotte di non-verità. Biografie irregolari e confessione senza verità nel governo dei rifugiati
Transcript of Condotte di non-verità. Biografie irregolari e confessione senza verità nel governo dei rifugiati
Condotte di non-verità.
Biografie irregolari e confessione senza verità nel governo dei rifugiati
Seconda metà del XVIII secolo, Francia: il sistema delle Lettres
de cachet da’ luogo a tutto un campo di saperi, un archivio
biografico, spiega Foucault, tale per cui “attraverso queste
lettere [...]una serie di banalità biografiche cominciano a
divenire oggetto di un sapere ancora infra-epistemologico a
quest’epoca”1. Biografie e condotte che restano infatti al di
sotto della soglia di psicologizzazione dei soggetti così come
del partage netto tra legale e illegale, e che vengono invece
inscritte in un “grigiore appena irregolare”: condotte non
colpevoli di infrazioni giuridicamente sanzionabili ma,
piuttosto, di tutta una serie di comportamenti “irregolari” in
quanto improduttivi, soggetti che si sottraggono o resistono
ai meccanismi di produzione capitalista e che vengono
catturati in un campo di sapere, registrate in un archivio
fino ad allora inesistente “attraverso l’irregolarità”2. Senza
mai nominare la nozione ‘verità’, nel Corso al College de
France del 1972-1973, La société punitive, Foucault indirizza lo
sguardo verso l’emergenza di un campo di sapere che si
costituisce sui soggetti creando soglie e partages infra-
epistemologici, che tracciano le soglie di accettabilità e
regolarità delle condotte. “Tratti”, li definisce Foucault, le
categorie di irregolarità (dissipazione, violenza, spreco,
dissoluzione) attraverso cui “il potere esercitandosi su un
1 M. Foucault, La société punitive. Cours au College de France 1973-1973, Gallimard, Paris, 2013, p. 134.2 Ivi, p.135.
individuo lo pone in una situazione di assoggettamento”.
Individui, corpi e condotte che diventano oggetto di un sapere
e che rientrano in ciò che a partire dal ’76 Foucault definirà
“regime di verità” – quello degli illegalismi – ma che non
sono tenuti a produrre un dire-vrai su se stessi. Condotte
registrate, archiviate e categorizzate per produrre una norma
di regolarità, margini di tolleranza degli illegalismi che
variano in funzione delle trasformazioni dei meccanismi di
produzione.
Discorsività e messa in discorso delle esistenze senza dire-vrai.
Per tracciare le genealogie del dire-vrai che Foucault
intraprende nelle conferenze tenute all’Università di Lovanio
nel 1981, Mal faire dire vrai, e nel Corso al College de France del
1980, Del governo dei viventi, vorrei partire in primo luogo dalla
discorsività senza dire-vrai attraverso cui certi soggetti, come
quelli descritti da Foucault ne La société punitive, vengono
prodotti al contempo come condotte governabili e oggetto di
sapere. In questo modo l’ingiunzione per il soggetto a dire la
verità su di sé che per Foucault caratterizza le società
occidentali può essere letto in relazione e a partire dal suo
limite, ovvero soffermandosi su meccanismi di potere e di
soggettivazione il cui regime di verità non prevede né rende
possibile una pratica di dire-vrai. Del resto, un’ analisi dei
regimi di verità nella loro molteplicità può andare oltre le
differenti modalità di articolare “manifestazione del vero e
soggetto che la opera”3 e reperire piuttosto dei meccanismi di
assoggettamento-soggettivazione in cui la produzione di verità3 M. Foucault, Del governo dei viventi. Corso al Collège de France, 1979-1980, Feltrinelli, Milano, 2014, p. 107.
non è necessariamente legata a un dire-vrai o si indirizza a
soggetti “incapaci” di verità. É per differenza e per scarto
rispetto ai meccanismi di assoggettamento-soggettivazione in
cui non vi è discorso di verità dei soggetti su di sé che le
genealogie del dire-vrai possono emergere nella loro specificità
tra la molteplicità di regimi di verità in gioco. In secondo
luogo, cercherò di mostrare come la centralità riservata da
Foucault nelle conferenze di Lovanio e nel Corso Del governo dei
viventi al dire-vrai, in quanto pratica costitutiva della produzione
di soggettività, sia il frutto di un déplacement dello sguardo
foucaultiano sia rispetto al piano delle relazioni di potere –
da un’analitica del potere ai rapporti tra governo di sé e
governo degli altri - sia in relazione al tipo
soggetto/individuo a cui questo si indirizza.
Per proseguire questo gioco di scarti tra differenti regimi di
verità torniamo al Corso La société punitive. Cambio di scena: non
più XVIII ma prima metà del XIX secolo, ancora Europa,
all’epoca in cui nascono e proliferano tutta una serie di
istituzioni di reclusione che vanno ben oltre le mura della
prigione. Sono istituzioni e forme sociali di controllo, dice
Foucault, “moltiplicatori di potere”4 che fissano gli individui
agli apparati di produttivi, per limitare le “condotte di
dispersione” e il rifiuto del lavoro, vere minacce di un
possibile inceppamento del sistema capitalista di produzione.
Reclusione che non mira come nel XVIII secolo (solo) ad
escludere, a marginalizzare, ma a re-inserire in un regime di
normalizzazione e di produzione. Piuttosto, si tratta di
4 La société punitive, p. 211
meccanismi di “sequestro” del tempo della forza lavoro dei
soggetti; una presa di potere sul loro tempo o meglio della
trasformazione della vita in forza lavoro: prendendo di mira
l’assioma marxista che vede nel lavoro l’esistenza concreta
dell’uomo, Foucault sottolinea che “il tempo e la vita de
l’uomo non sono lavoro per natura [...] è tutta questa energia
esplosiva che bisogna trasformare in una forza di lavoro
continua e continuamente offerta sul mercato. Bisogna
sintetizzare la vita in forza lavoro”5. Ora, queste
“istituzioni di sequestro” non funzionano tramite un discorso
di verità che il soggetto deve produrre su di sé e a cui deve
legarsi ma, piuttosto, attraverso il costituirsi di una sorta
di “costante antropologica”6 – l’apparizione del criminale come
nemico sociale – attorno a cui tutti i vari illegalismi di
condotta vanno a posizionarsi e a essere giudicati, esclusi,
tollerati o sanzionati. La produzione di norme che ne consegue
non corrisponde dunque al giuridicamente interdetto ma resta
in un campo più fluido e indeterminato che è quello degli
illegalismi popolari e dei comportamenti
tollerabili/intollerabili. Campo di norme che non definiscono
dei partages di verità attorno a cui corpi e condotte si
posizionano ma che inscrivono delle abitudini al livello del
corpo e del desiderio per neutralizzarne e gestirne
l’improduttività così come “l’irregolarità della mobilità
nello spazio”7. Insieme alle norme una nuova discorsività si
attiva, “il comportamento degli individui finisce per entrare
5 Ivi, p. 2366 Ivi, p. 2597 La société punitive, p.193
in un tipo di discorsività assolutamente nuovo”8. Questa messa
in discorso dei soggetti non è certo una novità del XIX
secolo, ci ricorda Foucault, ma una forma di presa sui corpi e
sulle condotte già pienamente all’opera nella pratica di
confessione. Tuttavia, e qui si situa il punto di maggiore
interesse per il nostro gioco di scarti, la discorsività che
si produce come effetto delle norme e dei meccanismi di
sequestro si differenzia in maniera sostanziale dalla tecnica
di confessione: quest’ultima, infatti “è caratterizzata dal
fatto che è il soggetto stesso a parlare; [essa] non lascia
mai alcun archivio [...] Al contrario ciò che appare nel IX
secolo è del tutto differente: si tratta di una discorsività
che riprende il quotidiano, l’individuale, l’intimo, il
corporeo, il sessuale all’interno di un certo spazio definito
dalle istanze di sequestro”9. In altre parole, la discorsività
che emerge dalle tecniche di sequestro serve a delineare “uno
spazio di contabilità morale quotidiana. La totalità del loro
tempo viene ripresa in tal modo all’interno di una
discorsività”. Una descrizione, peraltro, che sembra
approssimarsi non poco alla definizione di aveu fornita da
Foucault nella conferenza inaugurale di Lovanio: “la
confessione è un atto verbale attraverso cui il soggetto pone
un affermazione su ciò che è, si lega a questa verità, si pone
in un rapporto di dipendenza rispetto agli altri e modifica al
contempo il rapporto con se stesso”10. Ma proprio da questa
definizione emerge che l’istanza della produzione discorsiva è8 Ivi, p.2209 Ivi, p.221.10 M. Foucault, Mal faire dire vrai. Fonction de l’aveu en justice, Presses Universitaires de Louvain, Louvain, 2012, p.7
opposta nei due casi: da un lato il sapere di normalizzazione
sulle condotte prodotto che si produce insieme alle
istituzioni di sequestro, dall’altro il soggetto che è
obbligato a produrre un discorso di verità su di sé e a
stabilire se stesso all’interno di un rapporto determinato a
una certa verità11. Tuttavia, a un’analisi più attenta non è
difficile rintracciare ulteriori differenze che ancor più
qualificano i due discorsi di verità. La discorsività del
sequestro che si produce sui soggetti in quanto vita tradotta
in forza lavoro12 ha una duplice funzione: moralizzare corpi e
condotte e, insieme, avere presa sul loro tempo. Di fatti, non
è semplicemente questione di un’inversione della direzionalità
del discorso – l’individuo come soggetto o oggetto del
discorso di verità – ma della sua funzione: nel caso delle
istanze del sequestro a essere in gioco non é una
verbalizzazione esaustiva delle condotte ma un governo della
loro temporalità; ovvero, come ostacolare e squalificare,
irregolarizzando o rinchiudendo, le condotte resistenti, i
comportamenti improduttivi e la dissipazione della classe
operaia. Quello che si produce è allora un dire che in quanto
non è tale legato a una o a piú verità ma che fissa un campo
di irregolarità a partire da una norma che altro non è che “lo
strumento attraverso cui gli individui sono legati a questi
11 P. Chevallier, Vers l’éthique. La notion de « régime de vérité » dans le cours Du Gouvernement des vivants, in Lorenzini, Revel, Sforzini, Michel Foucault : éthique et vérité, 2013, Vrin, Paris.. 12 Il tempo gioca in questo contesto il ruolo di echangeur tra vita emeccanismi di produzione : « da un lato il tempo diventa la materia discambio, dall’altra è la misura del tempo che permette la quantificazionedello scambio […] un fenomeno essenziale che consiste nell’introduzionedella quantità di tempo come misura e non soltanto come misura economica »(La société punitive, p.86).
apparati di produzione”13. É importante sottolineare che in
questo contesto il punto di applicazione del potere a cui
Foucault si riferisce è quello della gestione e della
moralizzazione delle classi lavoratrici, della
capitalizzazione delle vite in forza lavoro e della loro
fissazione ai meccanismi di produzione. In questo senso si può
affermare che se da un lato a essere oggetto delle tecniche di
controllo e moralizzazione sono i comportamenti individuali,
dall’altro la discorsività sulle vite prodotta dalle
istituzioni di sequestro delinea i margini di tolleranza del
“grigiore degli illegalismi” da parte di ciò che potremmo
nominare una popolazione irregolare.
Le relazioni di potere e i discorsi di verità che Foucault
prende in esame nell’analisi sulla nascita della società
punitiva passano a lato rispetto ai centri di potere statali
andando a posare lo sguardo su tutto un réseau di istanze di
sequestro di cui la prigione è solo una forma sociale interna
a un sistema capillare di produzione e gestione degli
illegalismi. Questo “dislocamento” rispetto all’istituzione,
come Foucault lo ha definito in Sicurezza, territorio, popolazione, è
ciò che qualifica la postura analitica di Foucault lungo tutta
la sua ricerca. Tuttavia, con l’introduzione nel 1978 del
paradigma del governo Foucault opera un déplacement rilevante
rispetto allo spazio di relazioni di potere che sono oggetto
delle sue genealogie: non le economie di produzione o di
quadrillage delle condotte – scuole, prigioni, industrie – ma il
campo di azione delle relazioni tra governanti e governati e i
13 La société punitive, p.242
processi di soggettivazione relativi a quelle obbligazioni -
sapere su di sé e produzione di una verità su di sé – a cui il
soggetto si trova legato. Da un’analisi della regolazione e
del controllo di resistenze collettive – o meglio, di
comportamenti individuali che tuttavia danno luogo a fenomeni
di illegalismo – e da una lettura dell’economia delle
condotte il focus si sposta nell’80 e ’81 sui modi in cui un
certo soggetto si trova costituito e preso all’interno di un
campo di rapporti di forza, così come sulle pratiche di
trasformazione del soggetto stesso esercitate nella duplice
forma governo di sé-governo degli altri.
Le genealogie del dire-vrai foucaultiane vanno dunque a loro
volta situate all’interno di questo déplacement di piano verso
cui Foucault indirizza lo sguardo per analizzare il gioco di
saperi-poteri, nell’80 e ’81 ridefinito in termini di “regimi
di verità”. Déplacement che viene ben sottolineato dal
differente modo in cui Foucault si approccia al giuridico e
rispetto a cui il dire-vrai assume la sua centralità nelle
riflessioni dell’ ’80-’81. Infatti, le analisi sulla società
punitiva sono strutturate su una triangolazione tra pratica
giudiziaria, teoria penale e pratiche di reclusione,
sottolineando come il funzionamento e la razionalità di queste
terze non possono essere dedotte dalle prime due. Non solo un
discorso di verità non è richiesto al soggetto ma nemmeno deve
essere formulato dai meccanismi di potere-sapere, che
funzionano attraverso la messa in atto di tecnologie di
normalizzazione e moralizzazione. Invece, in Mal faire dire vrai la
genealogia della tecnica della confessione e dunque della
funzione del dire-vrai nella formazione della soggettività
occidentale è intrapresa da Foucault precisamente a partire
dalla sua interdipendenza con la pratica giudiziaria. In
effetti il dire-vrai acquista una centralità assoluta all’interno
delle tecniche di governo nella misura in cui l’angolo di
analisi diventa il modo in cui “i soggetti si sono
effettivamente legati nelle e attraverso le forme di
veridizione in cui si impegnano”14 e rispetto a cui, come
Foucault precisa, la pratica giudiziaria svolge un ruolo
chiave o in ogni caso una prospettiva privilegiata di analisi:
“mi sembra che possa essere interessante collocare queste
pratiche penali innanzitutto come centro di un primo cerchio
di intelligibilità all’interno delle tecniche di governo.
Governo inteso in senso ampio: [come] maniera di trasformare e
dirigere la condotta degli individui”15. Nel momento in cui
l’analisi foucaultiana si focalizza sull’asse
governanti/governati, il dire-vrai del soggetto e il legarlo
“alla sua propria verità, attraverso la sua verità e tramite
l’enunciazione da parte sua della sua propria verità” emerge
come cifra caratteristica del soggetto occidentale moderno16 e
come obbligazione socialmente e storicamente trasversale:
“questa obbligo di dire il vero su se stessi non è mai cessato
nella cultura cristiana, e verosimilmente nelle società
occidentali. Siamo obbligati a parlare di noi stessi per dire
il vero su di noi”17.
14 Mal faire, dire vrai, p.9.15 Ivi, p.12.16 Crf. Del governo dei viventi, Lezione del 19 marzo.17 Ivi, p. 313.
La centralità assegnata da Foucault a ciò che egli definisce
“la flessione del soggetto verso la propria verità” - e in cui
tale ‘propria’ verità è l’effetto di un certo regime di
sapere, quello psichiatrico-giuridico nelle società
contemporanee - è il frutto del déplacement dello sguardo
foucaultiano dall’economia delle condotte (im)produttive verso
lo spazio delle relazioni governanti-governati. A partire da
qui, ciò che vorrei provare a interrogare sono le forme di
soggettivazione che emergono, e il loro rapporto con pratiche
di dire-vrai, quando lo spazio delle relazioni governanti-
governati non è abitato da soggetti-cittadini ma da “biografie
irregolari” che di fatto sfuggono o non sono contemplate
nell’affermazione secondo cui vi sono “dispositivi [di verità,
N.d.A.] che informano ciò che costituisce la soggettività
cristiana, e di conseguenza la soggettività occidentale”.
Pratiche di mobilità, potremmo definirle, rispetto a cui
l’ingiunzione a dire il vero su di sé e a legarsi alla propria
verità si combina con tutta una serie di meccanismi di presa
sulla temporalità delle vite e sulla loro (im)produttività.
Del resto, l’equazione tra soggettività cristiana e
soggettività occidentale, o meglio la genealogia della seconda
a partire dalla prima, richiede oggi, anche all’interno dello
spazio europeo, una rivisitazione alla luce della dimensione
postcoloniale dell’Europa stessa. In tale contesto, le
migrazioni contribuiscono in maniera sostanziale a definire
tale condizione postcoloniale, in base a cui l’esistenza di
altri regimi di potere e governamentalità non è più (soltanto)
questione di ‘spazi altri’ ma implica direttamente quello
spazio europeo correlato di quella soggettività occidentale
oggetto delle analisi foucaultiane. Controllo sulla mobilità e
la temporalità delle vite dei migranti, frammentazione dei
progetti di migrazione, fissazione allo spazio e produzione di
forza lavoro irregolare si articolano con tecniche di governo
sulle condotte migranti che prevedono una messa in discorso
delle vite e delle storie di migrazione, insieme a una
classificazione, una ripartizione, di tali condotte in profili
di mobilità. In altre parole, i due sguardi dissocianti di
Foucault sulla produzione e sul governo di soggettività –
istanze di sequestro e regolazione temporale e ‘morale’ degli
illegalismi da un lato, obbligazione al dire-vrai e
coinvolgimento del soggetto nel produrre la verità su di sé
dall’altro – forniscono due coordinate da riassociare insieme
per analizzare la governamentalità delle pratiche (non
autorizzate) di mobilità. In tal modo si può cogliere inoltre
come gli stessi meccanismi disciplinari e il regime di
“governo attraverso la verità”18 risultano a loro volta
alterati, scomposti, riqualificati alla luce della presenza
delle “condotte irregolari” contemporanee. In particolare,
come cercherò di mostrare, nel caso specifico del governo dei
rifugiati la tecnologia della verbalizzazione si rivela una
paradossale confessione senza verità e il meccanismo di produzione
di soggettività e il discorso prodotto dal e sul soggetto
resta essenzialmente slegato ed esterno a esso.
In fondo, si potrebbe ripartire proprio dalle descrizioni di
Foucault dell’emergenza storica degli apparati di cattura e di
18 Mal faire, dire vrai, p.13.
moralizzazione per capire quanto l’esigenza di governare
pratiche di mobilità che diventano condotte irregolari e
dissidenti rispetto ai meccanismi di produzione sia alla base
di tutta una serie di tecniche e saperi di disciplinamento sui
corpi e sulle condotte. La “presa sul tempo” definisce uno dei
meccanismi principali di gestione e frammentazione dei
progetti di migrazione dei soggetti, ben prima di ogni
possibile messa in discorso richiesta ai migranti o effettuata
su di loro. E tuttavia, come accennato, lungi dall’essere
assenti, le tecniche di dire-vrai sono tra i tasselli che
compongono le geografie esistenziali dei migranti per come ri-
tracciate dalle politiche migratorie e narrate dalle politiche
di asilo che operano un triage tra soggetti vulnerabili e in
diritto di protezione e migranti economici. Quello su cui
invece vale la pena insistere é lo specifico regime di dire-vrai
in gioco nel governo dei rifugiati e i suoi effetti sulla
produzione di soggettività. Un regime di dire-vrai che si basa
essenzialmente su una presunzione di non-verità e che postula
dei soggetti incapaci di produrre un discorso di verità su di
sé. Se prendiamo in considerazione le storie che i richiedenti
asilo sono tenuti a raccontare di fronte alla commissione
territoriale che ha il potere di decidere se assegnare o meno
la protezione internazionale, queste non si presuppone che
siano storie 'vere’ ma ‘buone’. Ovvero, come sanno i migranti
in attesa del loro turno per l’ ‘esame di storie’, ciò che di
fatto viene chiesto a un richiedente asilo é di riuscire a
provare e a ricostruire una narrazione coerente della propria
esperienza di migrazione, che si inserisca a pieno titolo in
una dei ‘profili di mobilità’ fissati dalle politiche
migratorie – rifugiati, displaced persons, migranti economici,
soggetti vulnerabili... ‘Buone storie’ che devono rispondere e
conformarsi all’interno di una serie di categorie e condizioni
normative stabilite in anticipo dalla cartografia delle
mobilità irregolari tracciata dal regime delle migrazioni19. Al
limite si potrebbe dire che il governo delle condotte migranti
si esercita attraverso una produzione di ‘profili’: tutta una
serie infinita di complessità biografiche, percorsi di
migrazione, attraversamenti, numeri e esistenze in sospensione
vengono dissociate dalle singole condotte per essere
riassemblati in nuove categorie, in profili di mobilità
irregolare. Nonostante al richiedente asilo venga domandato di
dire la verità sulla propria storia di migrazione, in realtà
se il discorso di verità profferito non corrisponde né
risponde alle categorie di condotte migranti considerate
‘meritevoli’ e in diritto di protezione, il dire-vrai del
soggetto su di sé può addirittura risultare fonte di
esclusione dal sistema dell’asilo.
Il dire-vrai non é dunque in quanto tale condizione e tecnica di
‘guarigione’, integrazione o ‘salvezza’: piuttosto, a sua
volta il dire-vrai é subordinato a un regime di governo delle
condotte dove prioritario diventa domandarsi ‘la verità di chi
?’. Infatti, la verità e la messa in discorso richieste al
migrante non sono che la conferma di una adesione a una
‘verità già là’, quella attualizzata nei profili di mobilità
19 - Cfr. R. Beneduce Undocumented bodies, burned identities: refugees, sans papiers, harraga when things fall apart, in Social Sciences and Information, 2008, 47, pp. 505-527.
tracciati dalle agenzie di governo delle migrazioni e che
delinea un’economia e una geografia morali di pratiche
autorizzate e non autorizzate di migrazione. Al contrario, il
discorso del richiedente asilo viene postulato per principio
come non-vero, in quanto soggetto capace o sospetto di
mentire20. É solo attraverso un percorso narrativo che riesce a
evitare le incoerenze e le contraddizioni interne che il
discorso del migrante può eventualmente diventare una terapia di
verità. Su quest’ ultima nozione vale la pena soffermarsi per
individuare quel gioco di scarti presentato all’inizio di
questo intervento: “terapie di verità” le definisce Foucault
nella prima conferenza intitolata Soggettività e verità tenuta al
Darmouth College nel 1980 per indicare il “postulato,
generalmente accettato nelle società occidentali, secondo cui
per la propria salvezza ciascuno ha bisogno di conoscere il
più esattamente possibile chi é, e inoltre [...] deve dirlo il
più esplicitamente possibile”21. Ora, lo spostamento dello
sguardo sul governo dei rifugiati ci permette di interrogarci,
anche oltre il riferimento specifico alle migrazioni, se
effettivamente vi sia una ‘terapia’ prevista come esito del
discorso di verità richiesto ai soggetti oggi, o se invece sia
piuttosto l’impossibilita della norma a caratterizzare la
squalificazione di certi comportamenti e pratiche sociali. Nel
caso dei migranti questo interrogativo può essere presentato
20 Una “prova permanente”: così Foucault definisce la forma di sorveglianzaesercitata sulle classi lavoratrici e sulle condotte irregolari.“Un’inchiesta ma prima di ogni delitto, al di fuori di ogni crimine. Sitratta di un’inchiesta di sospetto generale e apriori dell’ individuo” (Lasociété punitive, p. 200).21 M. Foucault, Sull’origine dell’ermeneutica del sé, Cronopio, Napoli, 2012, pp. 32-33.
come una messa in discussione della logica di integrazione
presupposta in molte analisi politiche e teoriche
sull’immigrazione: l’eventuale protezione umanitaria o lo
status di rifugiato sono assegnati in cambio della
vulnerabilizzazione delle esistenze dei migranti, della loro
definitiva ‘migrantizzazione’. L’obbligazione a rendere il
proprio percorso di migrazione e di vita leggibile dalle
categorie governamentali non mira a ‘curare’ o ‘salvare’ il
soggetto incapace di dire il vero ma a descriverlo secondo un
certo schema diagnostico e ad assegnarlo a un determinato
spazio: la politica del reinsediamento che colloca i rifugiati
in paesi altri rispetto a quello dove hannoo ottenuto l’asilo
non è concepita sulla base in una logica di salvezza ma
piuttosto su una dislocazione e ricollocazione biopolitica
delle popolazioni migranti, dei corpi e delle esistenze.
Inoltre, i processi di soggettivazione legati alla produzione
di storie e di forme di confessione senza verità dipendono a
ben vedere come in rifrazione e in virtú dell’impatto con le
tecnologie e i saperi governamentali. In effetti, è sempre a
partire dalle geografie morali tracciate dal regime delle
migrazioni che un certo tipo di soggetto migrante viene detto
e raccontato, come migrante economico o rifugiato o rifugiato
diniegato: ad esempio, nella procedura di attribuzione
dell’asilo un ruolo fondamentale é giocato dalla lista UNHCR
in cui si distinguono Paesi di origine‘sicuri’ e ‘non sicuri’.
Tale criterio geopolitico va ad articolarsi con una
valutazione delle storie individuali rispetto a cui, come
sopra menzionato, i soggetti sono presupposti incapaci di
produrre un discorso di verità: a caratterizzare l’esame delle
domande di asilo è di fatti la non credibilità e la non
fondatezza della parola del rifugiato22. Quella del richiedente
asilo è per definizione una condotta non vera, che deve essere
passata al vaglio della geografia morale del sistema esclusivo
dell’asilo, provando una sorta di adesione asintotica ai
profili di mobilità stabiliti, al fine di poter ottenere il
riconoscimento nella geografia dell’umanitario. Ma confessione
senza verità non significa che non vi sia obbligo a mettere in
discorso la propria esistenza e il proprio percorso: al
contrario, al richiedente asilo é richiesta un’incessante
verbalizzazione fino al momento della decisione finale, una
messa in discorso che si rivela innanzitutto una messa alla
prova della consistenza e della coerenza della narrazione e
della corrispondenza tra eventi vissuti e racconto. Il
fondamentale discredito che accompagna l’esame delle storie
dei rifugiati si traduce in una sorta di ‘colpevolezza fino a
prova contraria’: il richiedente asilo deve convincere, più
che dimostrare, attraverso una serie di narrazioni coerenti,
che il suo caso costituisce un’eccezione rispetto alla
geografia morale in cui la sua esperienza di migrazione si
colloca. La confessione senza verità non comporta che il
soggetto si leghi al discorso su di sé e al modo in cui
verbalizza la propria esperienza di migrazione: a differenza
della corrispondenza tra discorso e soggettività che la
confessione psichiatrica richiede,23 nel governo dei rifugiati
22 Cfr. D.Fassin, The Precarious Truth of Asylum, in Public Culture, 2013, 25(1), pp. 39-63.23 Cfr. Mal faire dire vrai, conferenza del 2 aprile 1981
non importa che il soggetto autentichi se stesso attraverso un
coinvolgimento rispetto a quel discorso su di sé. In secondo
luogo, come Foucault spiega, la confessione, sia come tecnica
religiosa che nella sua variante secolare, mira a disciplinare
e governare il soggetto attraverso la sua individualizzazione24
o trasformazione25, e la sua adesione a un patto sociale: ad
esempio, la pratica della confessione nel contesto giuridico
comporta che il soggetto non solo riconosca il crimine ma
anche la validità della punizione e, di conseguenza, il patto
sociale in cui, attraverso l’atto di confessione, chiede di
essere reintegrato. Nel caso delle storie dei richiedenti
asilo, i minuziosi dettagli biografici a loro richiesti e le
prove psicologiche non mirano a estrarre una verità nascosta
del soggetto confessore ma a forzare quelle biografie in una
cartografia morale pre-esistente. La forza e l’obiettivo della
confessione senza verità sta nel suo effetto normalizzatore,
vale a dire nel riuscire a far aderire l’individuo a una certa
categoria di mobilità non ottenendo il suo consenso ma
inscrivendo il suo racconto di vita in essa. O, quando le24 Per una riflessione critica sul meccanismo di invididualizzazione percome tematizzato da Foucault si veda F. Sossi, Migrare. Spazi diconfinamento e strategie di esistenza, IlSaggiatore, Milano, 2007: “Quelloche non è del tutto tematizzato in Foucault è il fatto che l'archiviodell'individuale nasce con lo stato-nazione e con un raccontoindividualizzante della nazione che , mentre include in sé l'io prigionieroo l'io folle, propone anche un più inglobante noi cittadini, individuale egenerale al contempo, che ha come risvolto un voi stranieri a sua voltaarchiviato” (p.125).25 Infatti, l’obiettivo delle tecniche di confessione, anche nella loroversione contemporanea e secolare, comportano come spiegato da Foucault inMal faire, dire vrai, che il soggetto produca un sapere su di sé al fine di unasua trasformazione e per modificare la sua relazione con la propriamalattia o crimine. Al contrario, il l’ingiunzione discorsiva imposta airichiedenti asilo non ha per obiettivo la trasformazione del soggetto o unsuo engagement rispetto alle categorie di mobilità e di condotte entro cuisi cerca di inscrivere la sua biografia.
singolarità e i loro racconti eccedono e mal si collocano
rispetto allo spettro delle partizioni categoriali esistenti,
il diniego della protezione internazionale si combina a una
sostanziale invisibilizzazione di quei soggetti.
Ma al tempo stesso è precisamente questa discrasia che spesso
si verifica tra l’ epistemologia sottesa alla governamentalità
delle migrazioni e gli intricati percorsi di migrazione, non
inscrivibili in uno di quei profili o di quelle verità già là
che produce continue crisi nell’apparato discorsivo di cattura
delle pratiche di movimento, costringendolo a reinventarsi.
Dal lato delle istanze di potere, la proliferazione discorsiva
é altrettanto significativa: l’invenzione di nuove categorie e
profili di mobilità per stare al passo con la complessità e
l’eterogeneità delle pratiche di migrazione, nonché degli
intricati percorsi di vita fa sì che si assista a un costante
rinnovamento dei partages normativi tra condotte regolari e
irregolari, o comunque tra illegalismi (di mobilità) da
tollerare o sanzionare. In fondo, su cosa si applica e che
tipo di normalizzazione produce la norma di disciplinamento
delle condotte migranti ? Si potrebbe dire che é una norma che
regolarizza, e piú precisamente che regolarizza le irregolarità; non
regolarizzando giuridicamente gli illegalismi di mobilità ma
inscrivendoli in un regime gestionario di sapere che codifica
e ha presa su quelle condotte come ‘migrazioni da governare’.
Irregolarità prodotte e poi catturate all’interno di una
tassonomia di illegalismi articolati attorno a una norma che
non parte da una ‘soggettivita normale’ ma che in principio
definisce profili di condotte fuori posto. Di fronte alla
presenza di illegalismi che in un certo momento si rivelano
intollerabili per l’economia di potere e del discorso,
‘regolarizzare le irregolarità’ significa essenzialmente
evitare che quelle condotte di mobilità possano disturbare,
alterare, interrompere l’architettura dei meccanismi di
disciplinamento e risultare impreviste.
La stessa nozione di verità passa in parte in secondo piano
rispetto all’idea di una esposizione e constatazione di fatti,
ossia di un’oggettività presentata più come il risultato di
un’evidenza fondata su saperi standardizzati che non come una
realtà inintelligibile da portare alla luce. Questa
esteriorità del regime di veridizione rispetto al soggetto,
ciò che potremmo definire una dislocazione della produzione di
verità rispetto al soggetto stesso – al migrante non viene
richiesto di legarsi a quel discorso che produce, né é
supposto essere un soggetto capace di verità – non significa
peraltro che ogni possibilità di resistenza sia preclusa. Al
contrario, il rifiuto di aderire o di conformarsi a uno dei
profili di mobilità, o il mandare in crisi tali categorie con
storie che impediscono di essere ricondotte fino in fondo
entro uno schema di intelligibilità ‘diagnostica’, fanno sì
che spesso il partage e l’economia morale delle condotte
migranti fallisca nel tentativo di ‘dire la verità sul tipo di
‘soggettività irregolare’ che si trovano di fronte. É
precisamente l’assenza di una “relazione significante” tra il
soggetto, la condotta, e il discorso prodotto su di sé che, a
differenza di quanto è in gioco nelle forme di confessione
secolare26, permette in parte ai soggetti di disimpegnarsi e
sganciarsi rispetto alla soggettività che il sapere
diagnostico-governamentale della razionalità umanitaria
ascrive. Rifiuto che può essere messo in atto attraverso ciò
che Fanon ha definito un’ “orchestrazione della bugia”27 o più
in generale resistendo alla possibilità che una ‘diagnosi’
possa essere effettuata: un impedire la presa da parte del
discorso categorizzante che si dispiega al livello dei corpi –
difficolta di attestare i segni di vulnerabilità o di violenza
– che al livello delle storie, delle confessioni senza verità
strategicamente articolate dai richiedenti asilo. L’elusività
di alcune storie e la loro radicale non linearità rendono
certe biografie ‘illeggibili’ né traducibili in profili (di
mobilità) o narrabili in storie dal regime di veridizione.
Alla base del dire-vrai come tecnologia specifica legata alla
produzione di soggettività in occidente, sta il presupposto
secondo cui l’individuo deve produrre un sapere su di sé,
instaurare un rapporto di sapere rispetto a se stesso. Il
soggetto confessore non é soltanto oggetto di un sapere
psicanalitico, giuridico o medico ma è esso stesso soggetto di
conoscenza attraverso una costante esplorazione di sé28, a
differenza del soggetto non-sapiente catturato dalle istanze
26 Cfr. Mal faire, dire vrai.27 F. Fanon, Condotte di confessione in Nord Africa, in Scritti sulla follia, Ombre Corte, Verona, 2012.28 Cfr. Del governo dei viventi, Lezione 6 febbraio 1980, dove Foucault definisceil regime di verità in termini di obbligazione e costrizione: “il regime diverità è ciò che costringe gli individui a un certo numero di atti diverità” (p.91), nel senso che i soggetti si trovano legati a manifestare sestessi come oggetti di verità. Su questo tema si veda anche D. Lorenzini,What is a regime of truth ?, in Foucaultbloghttp://www.fsw.uzh.ch/foucaultblog/blog/28/what-is-a-regime-of-truth
di sequestro e su cui può solo prodursi un sapere
normalizzante. Tuttavia, a fianco di questa produzione di
sapere del soggetto su di sé, troviamo, ad esempio nel
contesto del governo dei rifugiati, meccanismi di produzione
di un non-sapere radicale del soggetto rispetto al proprio
spazio e alla propria futura collocazione. Di fatti,
nonostante le molteplici conoscenze relativi ai loro diritti o
ai tempi delle procedure amministrative, questo sapere si
rivela essere una sostanziale ignoranza di fronte
all’effettivo funzionamento dei meccanismi e dei tempi del
sistema dell’asilo. Insieme a questo, lo spazio in cui anche
solo temporaneamente ai richiedenti asilo e rifugiati viene
concesso di stare o in cui vengono arenati per mesi in attesa
che la loro domanda venga processata, risulta sostanzialmente
inutilizzabile per loro: l’impossibilità di ottenere
un’indipendenza economica rende ad esempio ineffettivo ed
escludente la loro presenza in quello spazio. Di conseguenza,
l’impossibilita di un dire-vrai su di sé è accompagnato da un
fondamentale non-sapere sulle loro vite e riguardo allo spazio
in cui i rifugiati stessi sono arenati, bloccati o
temporaneamente sospesi.
Volgendo lo sguardo sul governo dei rifugiati per interrogare
il funzionamento e le genealogie del dire-vrai consente di
riarticolare l’asse governanti-governati e lo spazio del
regime di veridizione “connesso alla soggettività”29 insieme
alla dimensione del governo della popolazione. Come noto il
tema del governo emerge in Foucault nel 1978 precisamente al
29 Del governo dei viventi, p. 90.
punto di incontro tra governo delle popolazione e governo
delle condotte, poi nella riflessione sulle tecniche di dire-vrai
e sui processi di soggettivazione a esso collegati, il piano
della popolazione passa decisamente sullo sfondo a favore,
come già detto, delle relazioni governo di sé/governo degli
altri e in particolare secondo forme di relazione a due.
Invece, l’attenzione sulla tecnologia di governo dei rifugiati
e sulla partizione di condotte migranti, così come il
suggerimento a mettere in risonanza le lezioni dell’ ’80-’81
con i meccanismi di regolazione delle condotte descritte da
Foucault nel Corso del ’73, riportano in primo piano quel
livello di analisi. Di fatti, la stessa tecnica della
confessione senza verità non può essere compresa nel suo
funzionamento se non inserita al punto di giuntura tra governo
delle popolazioni migranti e governo delle condotte,
biopolitica delle popolazioni non-nazionali e delle condotte
di non-verità. Il governo dei rifugiati non è in fondo che il
tentativo di assegnare spazi di mobilità o di collocazione
nello spazio legittima e illegittima, ricollocando o
rigettando esistenze migranti, a partire dalle loro “biografie
irregolari”.
Di fronte alla squalificazione della messa in discorso delle
esistenze migranti, il rigiocare strategicamente le categorie
di cattura e di fissazione delle pratiche di mobilità è senza
dubbio una delle principali forme di resistenza
quotidianamente agite dai richiedenti asilo. Tuttavia, le
‘crisi’ dell’apparato di cattura categoriale e di partage
normativo delle pratiche di movimento vengono solitamente
spesso superate attraverso l’invenzione e la proliferazione di
nuovi profili di mobilità che cercano di stare al passo con la
singolarità dei percorsi di migrazione. E in ogni caso non è
nei termini di un’altra politica di verità, in opposizione a
quella governamentale, che è possibile interrompere ciò che
Arnold Davidson definisce “un regime di verità scientifica che
mira a governare la nostra condotta”30. Piuttosto, é rispetto
al regime di veridizione che le condotte di non-verità dei
migranti (talvolta) fanno saltare ogni possibile narrazione
normalizzante sulle loro vite: con la loro presenza non
prevista in alcuni luoghi o muovendosi in base a una
temporalità dissonante rispetto ai ritmi imposti dalle
politiche di mobilità selezionata o dai canali umanitari, le
condotte di “mobilità irregolare” invalidando le aspettative
statistiche e costringono i “meccanismi di sequestro” a
ricomporsi inventando nuove prese sul loro tempo. Di fatti, se
torniamo alle descrizioni nel Corso del ’73 è facile notare
come queste rendano possibile un’ inversione di prospettiva
nell’analizzare gli apparati di governo e di controllo della
mobilità: gli illegalismi su cui il potere disciplinare si
applica riguardano “tutto ciò che é dell’ordine
dell’irregolarità, della mobilità nello spazio”31, in modo
particolare laddove queste assumono una forma collettiva. I
dispositivi di sequestro che mirano a controllare e ad avere
presa sulla temporalità delle condotte migranti corrispondono
a un meccanismo di regolazione, imbrigliamento e30 A. Davidson, La fin de l’herméneutique de soi, in Lorenzini, Revel, Sforzini (a cura di), Michel Foucault: éthique et vérité, Vrin, Paris, 2013.
31 La société punitive, p. 193.
capitalizzazione di pratiche di rifiuto e di movimento; vanno
a definire una “penalizzazione dell’esistenza”, o meglio delle
esistenze irregolari la cui presenza nello spazio è fuori
posto. In tal modo, anziché partire dalle tecniche di
soggettivazione con cui i migranti vengono ripartiti in
differenti profili di mobilità, si può provare a invertire lo
sguardo soffermandoci su come alcune pratiche di
soggettivazione e di movimento vengono catturate, regolate o
irregolarizzate attraverso gli apparati di sequestro.
Questa traiettoria nello spazio delle condotte migranti invita
a complicare le genealogie della soggettività e del dire-vrai
moderni che, con Foucault, siamo interessati a tracciare
all’interno di una prospettiva di storia del presente,
concentrandosi su meccanismi ed esistenze ai confini di quel
“noi” sottinteso da Foucault nel suo riferirsi alle società
occidentali32. Infatti, i potenziali rifugiati non
rappresentano l’altro del soggetto-cittadino o delle
soggettività politiche; essi emergono come condotte di governo
a partire dal partage tra migranti e rifugiati, e dalla
moltiplicazione di differenti gradi di (non)protezione che
danno luogo a una cartografia morale instabile delle biografie
irregolari accettabili o intollerabili.
32 Sulla riattualizzazione dell’idea di ‘storia del presente’ si vedaJ.Revel, “What are we at the present time?” Foucault and the question of the present, inFuggle, Lanci, Tazzioli (a cura di) Foucault and the history of ourpresent, Palgrave, London, 2014, in cui Revel sottolinea il compito diintrodurre una discontinuità all’interno del presente stesso. Un’analisidelle genealogie del dire-vrai e delle forme di soggettivazione che partedall’impossibiltà del dire-vrai nel contesto del governo dei rifugiatipermette precisamente di introdurre tale discontinuità come differenzacostitutiva nel funzionamento e nella formazione delle società occidentali.