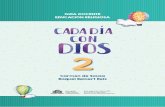La tutela penalistica della libertà religiosa nell'ordinamento italiano
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
8 -
download
0
Transcript of La tutela penalistica della libertà religiosa nell'ordinamento italiano
© Copyright 2015 - Università degli Studi Europea di Roma
G. Giappichelli Editore - 10124 Torinovia Po, 21 - Tel. 011-81.53.111 - Fax 011-81.25.100http://www.giappichelli.it
ISBN/EAN 978-88-348-4988-0ISSN 2282-5320
Stampatore: Stampatre s.r.l., di A. Rinaudo, A. Volponi & C., via Bologna 220, 10123 Torino.
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail [email protected] e sito web www.clearedi.org.
La presente Rivista Scientifica, che consta di quattro sezioni (Diritto civile, Storia del diritto, Diritto penale, Diritto costituzionale), sottopone i contribu-ti, pervenuti alla redazione, a referee anonimi, di volta in volta individuati in seno al Comitato scientifico.
Direzione
Alberto Maria Gambino; Antonio Palma; Mauro Ronco; Giuseppe Valditara; Fi-lippo Vari.
Coordinamento: Giuseppe Valditara
Alberto Maria Gambino (Sezione di diritto civile)
Antonio Palma (Sezione di storia del diritto)
Mauro Ronco (Sezione diritto penale)
Filippo Vari (Sezione di diritto costituzionale)
Comitato Scientifico Internazionale
Frans A.M. Alting von Geusau (Em. Univ. di Tilburg), Francesco Amarelli (Univ. “Federico II” di Napoli), Antonio Baldassarre (Pres. Em. Corte Costituzionale, già Univ. Luiss di Roma), Mirzia Bianca (Univ. “Sapienza” di Roma), Onorato Bucci (Univ. del Molise), Francesco Paolo Casavola (Pres. Em. Corte Costituzionale, già Univ. “Federico II” di Napoli), Giovanni Cocco (Univ. di Cagliari), S. Em. Francesco Coccopalmerio (Pres. Pontificio Consiglio Testi Legislativi), Alessandro Corbino (già Univ. di Catania), Luigi Cornacchia (Univ. del Salento), Fabrizio Criscuolo (Univ. della Calabria), Stefano Delle Monache (Univ. di Padova), Andrea Errera (Univ. “Magna Graecia” di Catanzaro), Lourdes Fernández del Moral Domínguez (Univ. “Parthenope” di Napoli), Agostino Gambino (Em. Univ. “Sapienza” di Roma), Mary Ann Glendon (Univ. di Harvard), Gábor Hamza (Univ. “Eötvös Loránd” di Budapest), Lelio Lantella (già Univ. di Torino), Aldo Loiodice (Univ. “Aldo Moro” di Bari), Franciszeck Longchamps de Bérier (Univ. di Cracovia), Giovanni Luchetti (Univ. “Alma Mater Studiorum” di Bologna), Marco Maugeri (Univ. Europea di Roma), Cesare Mirabelli (Pres. Em. Corte Costituzionale, Univ. “Tor Vergata” di Roma), Enrico Moscati (Univ. Europea di Roma), Andrea Nicolussi (Univ. “Cattoli-ca del Sacro Cuore” di Milano), Mauro Orlandi (Univ. “Tor Vergata” di Roma), Ja-vier Paricio (Univ. “Complutense” di Madrid), Nicola Picardi (Em. Univ. “Sapienza” di Roma), Michael Rainer (Univ. di Salisburgo), Saverio Ruperto (Univ. “Sapienza” di Roma), Achille Saletti (Univ. di Milano), Pasquale Sandulli (già Univ. “Sapienza” di Roma), Padre Paolo Scarafoni (Univ. Europea di Roma), Sandro Schipani (già Univ. “Sapienza” di Roma), Andrea Simoncini (Univ. di Firenze), Carlo Venturini (Univ. di Pisa), Wolfgang Waldstein (Univ. di Innsbruck).
Comitato di Redazione
Emanuele Bilotti; Lorenzo Franchini; Carmelo Leotta; Mario Palma. Redazione
Via degli Aldobrandeschi, 190 – 00163 Roma – Tel. +39 06-665431. Amministrazione
presso la casa editrice G. Giappichelli Editore S.r.l.Via Po, 21 - 10124 Torino - Tel. 011-8153111 - Fax 011-8125100www.giappichelli.it • e-mail: [email protected]
Indice
pag. Prefazione Alberto Maria Gambino XI
Parte I Diritti umani, diritto naturale e diritto penale: una visione transcostituzionale Mário Ferreira Monte 3 A concretização de um direito penal europeu. Contributo para a cidadania europeia Joana Whyte 11 Ipotesi metodologiche sulla interculturalità costituzionale Michele Carducci 21 Prävention durch Strafrecht – ein probates Mittel gegen die allgegenwärtige Angst vor terroristischen Anschlägen? Bettina Weisser 33 Poena publica: appunti sul monopolio pubblico della coercizione penale Luigi Cornacchia 53 Intolerancia justificada como función del derecho penal Carlos Pérez del Valle 73
Indice VIII
pag. O afastamento de um cidadão da União por “razões imperativas de segurança pública” (ou o lado lunar da cidadania da União). Uma amostra da recente jurisprudência do Tribunal de Justiça Alessandra Silveira e Sophie Perez Fernandes 97 La tutela penalistica della libertà religiosa nell’ordinamento italiano Carmelo Domenico Leotta 123
Immigrazione, cittadinanza e status. Il contributo della scienza civilistica Alberto Maria Gambino 157
La finanza religiosamente compatibile come modello di economia etica Andrea Nuvoli 167
Parte II
Il Patto di Famiglia. Le ragioni dell’istituto (o le ragioni di un insuccesso) Antonio M. Palmieri 179
Appunti per un seminario sul patto di famiglia Claudia Confortini, Valerio Pescatore, Attilio Zimatore 193
L’oggetto del patto di famiglia Vincenzo Verdicchio 225
Patto di famiglia e tutela dei legittimari Enrico Moscati 259
Patto di famiglia e patti successori Daniele De Bonis 273
Indice IX
pag. Patto di famiglia: problemi aperti e profili di criticità Giuseppe Minniti 283
Profili comparatistici della successione nell'impresa Emanuele Bilotti 305
La tutela penalistica della libertà religiosa nell’ordinamento italiano *
di Carmelo Domenico Leotta 1. I «delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti» nel codice penale. 1.1. La disciplina originaria. 1.2. Il Titolo IV dopo l’entrata in vigore della Costituzione. 1.3. La giuri-sprudenza costituzionale tra il 1957 e il 1975: l’approccio conservativo. 1.4. La giurisprudenza costituzionale dopo la riforma dei Patti lateranensi (1988-2005). 1.5. I «delitti contro le confes-sioni religiose» dopo la l. 24 febbraio 2006, n. 85. 2. La tutela penalistica contro gli atti discri-minatori compiuti per motivi (anche) religiosi e contro i gruppi (anche) religiosi. 2.1. La repres-sione degli atti discriminatori commessi per motivi (anche) religiosi. 2.2. La tutela dei gruppi reli-giosi contro i fatti di distruzione (genocidio). 3. L’opportunità della tutela penale della libertà reli-giosa. 3.1. La rilevanza della libertà religiosa nelle fonti costituzionali. 3.2. La tutela specifica della libertà religiosa: la distinzione tra il “credere una fede” e il “pensare un’idea”.
Il presente contributo ha ad oggetto l’esposizione della disciplina penalistica italiana a tutela del sentimento religioso o, per meglio dire, della libertà religio-sa 1 e dei gruppi religiosi, nonché l’enunciazione, per sommi capi, delle ragioni
* Versione ampliata ed annotata della relazione al Convegno Diritti fondamentali, libertà re-ligiosa e integrazione, svoltosi presso l’Università degli Studi Europea di Roma, il 15 marzo 2012.
1 In dottrina si è distinto tra tutela della libertà religiosa e tutela del sentimento religioso: nel primo caso «il bene non è una fede o una credenza, ma un diritto di libertà. Le fattispecie non proteggono un valore ideale, a cui si ritiene che sia dovuto un particolare rispetto, da manifestazioni del pensiero of-fensive o vilipendiose ma libertà fondamentali, oggi riconosciute e garantite dalla Carta costituzionale, da impedimenti, turbative, minacce o violenze […]. La condotta che limita o impedisce la libertà non può consistere in meri giudizi di valore, opinioni di contenuto offensivo» (cfr. N. MARCHEI, “Sentimento reli-gioso” e bene giuridico tra giurisprudenza costituzionale e novella legislativa, Giuffrè, Milano, 2006, 14-15). Con la seconda espressione ci si riferirebbe, invece, alle fattispecie che «tutelano in sé e per sé e nei suoi contenuti, una “religione”, una “fede” o un “convincimento” religiosi (che si connotano diversamente in relazione ai diversi titolari, singoli o collettività che siano) da vilipendi perpetrati con un comporta-mento materiale o con qualsiasi mezzo di esternazione del pensiero vale a dire con una “espressione grafica, orale, mimica di dileggio”» (cfr. ivi, 13). In questa sede si preferisce, tuttavia, considerare anche le fat-tispecie di vilipendio come espressioni lesive della libertà religiosa e, precipuamente, della libertà reli-
Carmelo Domenico Leotta 124
che inducono a ritenere opportuno conservare nell’ordinamento interno una tutela penale specifica della libertà religiosa, senza che la stessa sia genericamen-te assorbita nelle norme repressive dei delitti contro l’onore e la libertà morale.
Nel procedere lungo il percorso ora tracciato, si prenderanno le mosse dalle norme contenute nel Titolo IV del Libro II c.p., Dei delitti contro il sentimento re-ligioso e contro la pietà dei defunti, da ultimo riviste dagli artt. 7-10, l. 24 febbraio 2006, n. 85, Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione 2. La novella del 2006, portando a termine un cammino intrapreso negli anni Ottanta dalla Corte Costituzionale, all’insegna del principio di pari tutela delle confessioni reli-giose, ha finanche modificato la rubrica del Capo I (artt. 402-406 c.p.), oggi inti-tolato Dei delitti contro le confessioni religiose e non più Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi, come nella dizione originaria. Il Capo I ora compren-de, in riforma delle norme del 1930, le offese a una confessione religiosa mediante il vilipendio di persone (art. 403 c.p.), le offese a una confessione religiosa median-te vilipendio (art. 404, 1° co. c.p.) o danneggiamento di cose (art. 404, 2° co. c.p., ipotesi criminosa introdotta nel 2006) e la turbatio sacrorum, espressione con cui si intende la turbativa o l’impedimento di funzioni religiose (art. 405 c.p.).
Il successivo Capo II, Dei delitti contro la pietà dei defunti (artt. 407-413 c.p.), raggruppa ulteriori figure delittuose: la violazione di sepolcro (art. 407 c.p.), il vi-lipendio delle tombe (art. 408 c.p.), il turbamento di funerale o servizio funebre (art. 409 c.p.), il vilipendio di cadavere (410 c.p.), la distruzione, la soppressione o la sottrazione (art. 411 c.p.), l’occultamento (art. 412 c.p.) e l’uso illegittimo (art. 413 c.p.) dello stesso. Tra le fattispecie del Capo II, l’unica modifica legisla-tiva intervenuta dal 1930 ad oggi ha riguardato l’art. 411 c.p., a cui l’art. 2, l. 30 marzo 2001, n. 130 ha aggiunto il 3° e il 4° co., tipizzando (al 4° co.) la disper-sione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto.
Agli strumenti di tutela predisposti dal codice si aggiungono le sanzioni intro-dotte con leggi penali speciali che reprimono le condotte discriminatorie in materia (anche) religiosa e le condotte volte alla distruzione del gruppo (anche) religioso. Si
giosa positiva, dal momento che il legame tra il fedele e la Divinità e quello tra il fedele e la cosa o la persona sacra o consacrata, sono la proiezione dell’adesione libera al credo e, quindi, della scelta reli-giosa. La lettura qui proposta trova conforto in Corte Cost., 10 novembre 1997, n. 329, in Giur. Cost., 1997, 3335-3341, con nota redazionale di R. D’ALESSIO (cfr. ivi, 3341-3343) e osservazione di F. RIMOLI, Tutela del sentimento religioso, principio di eguaglianza e laicità dello Stato (cfr. ivi, 3343-3350), dove la Consulta afferma che «la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l’esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede» (cfr. ivi, 3339-3340).
2 In Gazz. Uff. n. 60 del 13 marzo 2006.
La tutela penalistica della libertà religiosa nell’ordinamento italiano 125
tratta di fonti adottate in ottemperanza di obblighi internazionali che non tutelano esclusivamente il fedele o il gruppo religioso dal momento che, accanto alla qualifi-cazione religiosa si colloca, in entrambi i casi, quella razziale, etnica e nazionale. Più precisamente, le norme antidiscriminatorie sono dettate dalla l. 13 ottobre 1975, n. 654, Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966
3, novellata dal d.l. 26 aprile 1993, n. 122, Misure urgenti in materia di discriminazio-ne razziale, etnica e religiosa (c.d. decreto Mancino) 4, conv. con modif. dalla l. 25 giugno 1993, n. 205 5. Anche la disciplina penale antidiscriminatoria, così come quella codicistica del Titolo IV del Libro II, è stata rivisitata dalla l. 24 febbraio 2006, n. 85 (art. 13).
La tutela dei gruppi religiosi dai tentativi di distruzione fisica integrale o parziale è offerta, invece, dalla l. 9 ottobre 1967, n. 962, Prevenzione e repressio-ne del delitto di genocidio 6.
Una specifica previsione in tutela della libertà religiosa si rinviene, infine, nel codice penale militare di guerra: si tratta dell’art. 213 che, facendo salve le mi-sure d’ordine prescritte dall’autorità militare, sanziona con la pena della reclu-sione militare fino a un anno, l’impedimento, la turbativa ovvero la limitazione arbitraria della libertà di religione o di culto dei prigionieri di guerra (1° co.), nonché l’offesa alla religione professata dal prigioniero, mediante vilipendio di questa, commesso in sua presenza (2° co.) 7.
1. I «delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti» nel codice penale
1.1. La disciplina originaria Il Titolo IV del Libro II c.p. si compone originariamente di dodici articoli
(402-413), ulteriormente suddivisi nel Capo I, Dei delitti contro la religione del-
3 In Gazz. Uff. n. 337 del 23 dicembre 1975, suppl. ordinario. 4 In Gazz. Uff. n. 97 del 27 aprile 1993. 5 In Gazz. Uff. n. 148 del 26 giugno 1993. 6 In Gazz. Uff. n. 272 del 30 ottobre 1967. 7 L’art. 213 è compreso nella Sezione II titolata Dei reati contro i prigionieri di guerra del Ca-
po V, Dei prigionieri di guerra, del Titolo IV, Dei reati contro le leggi e gli usi della guerra, del Li-bro III, Dei reati militari, in particolare. Il c.p.m.g., come quello di pace, è stato emanato con r.d. 20 febbraio 1941, n. 303 (in Gazz. Uff. n. 107 del 6 maggio 1941, suppl. ordinario).
Carmelo Domenico Leotta 126
lo Stato e i culti ammessi (402-406) 8 e nel Capo II, Dei delitti contro la pietà dei defunti (407-413) 9.
La disciplina del Capo I, come voluta dal legislatore all’indomani della solu-zione della questione romana (1860-1929), presenta tre caratteri fondamentali:
a) accorda una tutela privilegiata alla religione cattolica apostolica romana, riconosciuta religione dello Stato dallo Statuto albertino, promulgato nel 1848 dal Re di Sardegna Carlo Alberto (1798-1849), e successivamente dai Patti late-ranensi dell’11 febbraio 1929. Tale preferenza si concretizza sul piano normati-vo con l’inserimento dell’art. 402 c.p. che sanziona il vilipendio generico contro la religione dello Stato (e non contro le altre confessioni) e con la previsione, all’art. 406 c.p., di una riduzione di pena se i fatti di cui agli artt. 403-405 c.p. sono commessi, anziché contro il culto cattolico, contro un culto ammesso dal-lo Stato 10. Infine la preferenza per la religione cattolica è confermata dall’art.
8 Come già si è detto, l’art. 10, 2° co., l. 24 febbraio 2006, n. 85 ha modificato la rubrica del Capo
I del Titolo IV in Delitti contro le confessioni religiose. L’art. 402 c.p., già prima della riforma, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Cost., 20 novembre 2000, n. 508, in Giur. Cost., 2000, 3965-3970, con nota di R. D’ALESSIO (cfr. ivi, 3970-3972) e osservazioni di M. OLIVETTI, In-costituzionalità del vilipendio della religione dello Stato, uguaglianza senza distinzioni di religione e laicità dello Stato (cfr. ivi, 3972-3979); B. RANDAZZO, Vilipendio della religione: una dichiarazione d’incostituzionalità “obbligata”? (cfr. ivi, 3979-3990); P. CAVANA, La caducazione del delitto di vilipen-dio della religione di Stato. Luci ed ombre di un’incostituzionalità annunciata (cfr. ivi, 3990-4003).
9 Per un sintetico commento coevo alle disposizioni del 1930 cfr., tra gli altri, M. PIACENTI-
NI, voce Religione (Delitti conto il sentimento religioso e la pietà dei defunti), in M. D’AMELIO (a cura di), Nuovo Dig. ital., Utet, Torino, 1939, vol. XI, 339-351; più distesamente E. FLORIAN, Delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti, in ID. (coordinato da), Trattato di diritto penale, IV ed., Vallardi, Milano, 1936, 179-275.
10 L’art. 1 dello Statuto albertino dichiara che la religione cattolica apostolica romana è la so-la religione dello Stato, mentre gli altri culti sono semplicemente tollerati. Pur di fronte a questa affermazione formale con le Regie Lettere Patenti del 17 febbraio 1848, n. 673 i valdesi sono pa-rificati ai cattolici nel godimento dei diritti civili e politici; la parificazione avviene anche nei confronti degli ebrei con il r.d. 29 marzo 1848, n. 688 Regio decreto per l’emancipazione degli Israeliti, che con il d.lgt. 15 aprile 1848, n. 700 sono anche ammessi al servizio di leva militare. L’articolo unico della l. 19 giugno 1848, n. 735 prevede che «La differenza di culto non forma ec-cezione al godimento dei diritti civili e politici, ed all’ammissibilità alle cariche civili e militari». Ta-le riconoscimento viene ritenuto dal legislatore del Regno di Sardegna compatibile con la tutela privilegiata della religione cattolica. In sede penale, il Codice penale albertino, emanato con r.d. 6 ottobre 1839, n. 280, prevede al Libro II, Titolo I una serie di Reati contro il rispetto dovuto al-la Religione dello Stato (artt. 159-169); la disciplina differenziata è confermata dal Capo III del Regio editto sulla stampa del 26 marzo 1848, n. 695 e dal Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna del 1859 che, al Libro II, Titolo II, Dei Reati contro la Religione dello Stato e gli altri culti, offre tutela in via privilegiata alla confessione cattolica (art. 183-187) e, in via ridotta ai culti ammessi (art. 188). Il Codice Zanardelli, promulgato con r.d. 30 giugno 1889, n. 6133, di-sciplina, invece, in regime di uguaglianza, la materia al Libro II, Titolo II, Capo II, Dei delitti con-
La tutela penalistica della libertà religiosa nell’ordinamento italiano 127
724 c.p. che sanziona come contravvenzione la bestemmia pronunciata contro la «Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato».
b) Il Titolo IV del Libro II c.p., in particolare il Capo I, persegue una finali-tà di tutela spiccatamente pubblicistica; infatti la «religione […] – dichiara Al-fredo Rocco (1875-1935) nella Relazione che accompagna il Progetto definitivo di un nuovo codice penale – ha un contenuto che trascende il patrimonio morale individuale, per assurgere ad interesse generale; è insomma non tanto un fenomeno attinente alla coscienza individuale, quanto un fenomeno sociale della più alta im-portanza, anche per il raggiungimento dei fini etici dello Stato. L’idea religiosa è una delle idee-forze, dei valori morali e sociali, che reggono il mondo» 11. Sono chiari segnali della natura pubblicistica del bene protetto, tra gli altri, la proce-dibilità d’ufficio e la collocazione della materia dopo i delitti contro l’ammini-strazione della giustizia e prima di quelli contro l’ordine pubblico. La religione è, quindi, instrumentum regni, ma non solo: ciò che sta a cuore al legislatore fa-scista è, innanzitutto, il superamento della dottrina liberale – «derivazione dalle teorie scaturite dalla Rivoluzione francese» 12 – la quale propugna «l’agnosticismo dello Stato in materia religiosa, considerando il complesso dei fedeli come associa-zioni private» 13. Nel suo insieme, il sistema di norme del 1930, pur rifiutando la rubrica del codice Zanardelli del 1889, «Delitti contro la libertà dei culti» (artt. 140-144), non intende comunque privare di tutela l’interesse del singolo fedele, ma senz’altro lo subordina all’«interesse giuridico collettivo» 14.
c) La tutela originaria prevista dal codice Rocco non intende nemmeno sa-crificare la «libertà di coscienza e di pensiero in ordine alle credenze religiose» 15,
tro la libertà dei culti (artt. 140-144), facendo menzione generica dei culti ammessi nello Stato. Con l’art. 2, lett. b), r.d. 15 luglio 1923, n. 3288, conv. in l. 31 dicembre 1925, n. 2309, si
recupera il concetto di religione dello Stato, prevedendo la diffida di polizia a carico del respon-sabile di un giornale o di un’altra pubblicazione che abbia vilipeso la religione di Stato; successi-vamente l’art. 232, r.d. 6 novembre 1926, n. 1848 (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) reintroduce la sanzione penale per la bestemmia, non prevista dal codice Za-nardelli, con aggravio di pena se il fatto è commesso contro la religione cattolica. Per approfon-dire cfr. V. MORMANDO, I delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti, in G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Trattato di diritto penale, Parte speciale, Cedam, Padova, 2005, vol. V, 31-45 e l’ampia bibliografia ivi menzionata.
11 Cfr. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale, vol. V, Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la Relazione del Guardasigilli On. Alfredo Rocco, parte II, Relazione sui Libri II e III del Progetto, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1929, anno VII, par. 431, 189.
12 Cfr. ivi, par. 430, 188. 13 Cfr. ivi, par. 429, 188. 14 Cfr. ivi, par. 432, 189. 15 Cfr. ivi, par. 433, 189. Cfr. E. FLORIAN, Delitti contro il sentimento religioso, cit., 188.
Carmelo Domenico Leotta 128
beni anch’essi menzionati dal Guardasigilli. Lo Stato, in ossequio al principio di separazione tra il potere civile e religioso, si mantiene, inoltre, totalmente estra-neo dalla materia dei «delitti concernenti l’organismo interno della religione» 16, quali la simulazione di sacerdozio, il concubinato dei chierici, il matrimonio dell’ordinato o del professo.
Il testo originario del Capo I, Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi (art. 402-406 c.p.), costruisce su di una siffatta scelta politico-criminale quattro figure di vilipendio, a cui si aggiunge la turbatio sacrorum. Il vilipendio generico della religione dello Stato (art. 402 c.p.), commesso pubblicamente, apre la lista, pur fungendo da norma sussidiaria, ed è punito con la pena deten-tiva fino a un anno. Seguono l’offesa alla religione dello Stato recata attraverso il vilipendio di fedeli (anch’essa consumata pubblicamente), punita con la re-clusione fino a due anni (art. 403, 1° co., c.p.); l’offesa mediante vilipendio a ministro di culto, punita con la reclusione da uno a tre anni (art. 403, 2° co., c.p.) 17; l’offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose oggetto di culto o destinate al culto, commesso in luogo di culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica se il fatto è commesso in occasione di funzioni religiose, compiute in un luogo privato da un ministro del culto cattolico (art. 404 c.p.). Chiude la lista la turbatio sacrorum (art. 405 c.p.), consumata da chi impedisce o turba l’eser-cizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, compiute con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Quest’ultimo delitto è puni-to con la reclusione fino a due anni.
A tutela dei culti ammessi – che l’art. 1, 1° co., l. 24 giugno 1929, n. 1159 definisce «culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all’ordine pubblico o al buon costu-me» e a cui il 2° co. garantisce il libero esercizio, anche in forma pubblica – l’art. 406 c.p., come già si è detto, estende i precetti di cui agli artt. 403-404 c.p., (con esclusione, pertanto, del vilipendio generico), ma diminuisce la pena.
La bestemmia, infine, non compare tra i delitti del Titolo IV e, per sanzio-narla, il legislatore del 1930 introduce una norma ad hoc, l’art. 724 c.p., qualifi-candola come contravvenzione contro la polizia dei costumi.
16 Cfr. Progetto definitivo di un nuovo codice penale, cit., par. 433, 189. 17 La fattispecie di cui all’art. 403, 2° co., c.p. di offesa mediante vilipendio al ministro di
culto è figura autonoma (non fattispecie aggravata) e non richiede il requisito della pubblicità. Cfr. P. SIRACUSANO, Sub art. 403 c.p., in M. RONCO, B. ROMANO, Codice penale commentato, IV ed., Utet Giuridica, Torino, 2012, 1987. La struttura della norma successiva alla riforma del 2006 conserva quella originaria del 1930.
La tutela penalistica della libertà religiosa nell’ordinamento italiano 129
1.2. Il Titolo IV dopo l’entrata in vigore della Costituzione Con l’entrata in vigore della Costituzione e l’affermazione del principio di
uguaglianza dinnanzi alla legge di tutti i cittadini (art. 3) e di tutte le confessio-ni religiose (art. 8) emerge ben presto il problema della compatibilità tra la di-sciplina del 1930 con la Carta del 1948.
Con riferimento alle fattispecie del Capo I si propongono tre diverse solu-zioni: a) l’abrogazione tacita; b) l’incostituzionalità per contrasto con l’art. 25, 2° co., Cost. (principio legalità, sotto il profilo della determinatezza della fatti-specie penale) e con l’art. 21 Cost. (diritto alla libera manifestazione del pensie-ro); c) l’incostituzionalità per contrasto con il principio di uguaglianza di cui agli artt. 3 e 8 Cost.
a) La tesi dell’abrogazione tacita, pur trovando accoglimento in alcuni pre-cedenti giurisprudenziali, non senza l’avallo di prestigiose voci della nostra dot-trina 18, rimane sostanzialmente isolata e non è fatta propria né dalla Corte Co-stituzionale né dalla Corte di Cassazione.
b) La tesi dell’incompatibilità con l’art. 21, che proclama il diritto alla libera manifestazione del pensiero, e con l’art. 25, 2° co., Cost., sotto il profilo della indeterminatezza della fattispecie (corollario del principio di legalità), riguarda soprattutto il vilipendio generico di cui all’art. 402 c.p. e la bestemmia di cui all’art. 724 c.p. Tuttavia già con la sentenza 27 giugno 1975, n. 188, la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità degli artt. 403 e 405 c.p. per contrasto con gli artt. 3, 21 e 25 Cost., oltre a dichiarare l’inammissibilità, per manifesta irrilevanza, della questione con riferimento all’art. 3, pure esclude il contrasto con le due altre norme costituzionali richiamate 19. In particolare, il giudice delle leggi, qualificato il sentimento religioso nella sua espressione sia individuale che comunitaria come bene tutelato ex artt. 2, 8, 19 Cost. ed indi-rettamente ex artt. 3, 1° co. e 20 Cost., ritiene la sanzione penale del vilipendio di cui all’art. 403 c.p. compatibile con un corretto esercizio della libertà di ma-
18 Cfr., in particolare, Trib. Roma, 29 maggio 1949, in Il Foro penale, ott.-dic. 1949, fasc. V,
col. 532-538, con nota di E. LIGNOLA, Il delitto di offese alla religione dello Stato mediante vili-pendio di persone in relazione alla nuova Costituzione (ivi, col. 532-537). In dottrina contro la tesi dell’abrogazione tacita i reati di cui agli artt. 402 e 724 c.p. cfr. F. STELLA, Il nuovo Concordato tra l’Italia e la Santa Sede: riflessi di diritto penale, in Jus, 1989, 104-105. A favore, invece, della caducazione dell’art. 402 c.p. cfr. V. CRISAFULLI, Articolo 7 della Costituzione e «vilipendio della religione dello Stato». Nota a Cass. pen., Sez. III, 16-1-1950, n. 99, in Arch. pen., 1950, II, 412-423 (nota da 415).
19 Cfr. Corte Cost., 8 luglio 1975, n. 188, in Giur. Cost., 1975, 1508-1513. Più precisamen-te la q.l.c. dell’art. 403 c.p. è sollevata con riferimento agli artt. 3, 21 e 25 Cost.; quella dell’art. 405 con riferimento all’art. 3 Cost.
Carmelo Domenico Leotta 130
nifestazione del pensiero in materia religiosa, poiché «il vilipendio […] non si confonde né con la discussione su temi religiosi, […] né con la critica e la confuta-zione pur se vivacemente polemica; né con l’espressione di radicale dissenso da ogni concezione richiamantesi a valori religiosi trascendenti, in nome di ideologie imma-nentistiche o positivistiche od altre che siano» 20.
Così è da escludersi anche il contrasto dell’art. 403 c.p. con l’art. 25, 2° co., Cost. (indeterminatezza della fattispecie), prevedendo le norme censurate fatti-specie a forma libera «che richiamano con locuzioni generiche, ma di ovvia com-prensione, concetti di comune esperienza o valori etico-sociali oggettivamente accer-tabili dall’interprete» 21.
Ancora con la sentenza 18 ottobre 1995, n. 440 22, a distanza di oltre dieci anni dalla riforma dei Patti lateranensi del 1984, la Corte Costituzionale, ri-prendendo i propri precedenti dell’8 luglio 1988, n. 925 23 e del 9 febbraio 1989, n. 52 24 (entrambi relativi all’art. 724 c.p.) continua ad escludere che la dizione “religione dello Stato” contenuta nella norma censurata (e, fin alla rifor-ma del 2006, nelle fattispecie del Titolo IV) possa essere carente sotto il profilo della determinatezza, dal momento che, nonostante sia venuta meno la defini-zione normativa di “religione dello Stato”, con tale locuzione si può, senz’altro, ancora intendere la religione cattolica.
c) Se, come si è ora detto, la Consulta ritiene compatibile la tutela del sen-timento religioso, come prevista dal codice Rocco, con la disciplina degli artt. 21 e 25 Cost., la tesi del contrasto con i princìpi di uguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione (art. 3, 1° co., Cost.) e di uguaglianza delle con-fessioni religiose davanti alla legge (art. 8, 1° co., Cost.) rappresenta, a partire
20 Cfr. ivi, 1513. 21 Cfr. ivi, 1512. 22 Cfr. Corte Cost., 18 ottobre 1995, n. 440, in Giur. Cost., 1995, 3475-3482, con nota re-
dazionale di R. D’ALESSIO (cfr. ivi, 3482-3483) e osservazioni di F. RAMACCI, La bestemmia con-tro la Divinità: una contravvenzione delittuosa? (cfr. ivi, 3484-3487); M. D’AMICO, Una nuova figura di reato: la bestemmia contro la «Divinità» (cfr. ivi, 3487-3499); R. VENDITTI, Reato di be-stemmia e pluralità di religioni (cfr. ivi, 4517-4522); G. DI COSIMO, Sulla discussa tutela penale del sentimento religioso (cfr. ivi, 4522-4531); A. GUAZZAROTTI, Perché imporre l’incriminazione della bestemmia? Diritto penale «religioso» e incompetenza dello Stato in spiritualibus (cfr. ivi, 4531-4541) e P. LILLO, Corte costituzionale e art. 724 c.p.: cronaca di una incostituzionalità an-nunciata e dichiarata (cfr. ivi, 4542-4554).
23 Cfr. Corte Cost., 8 luglio 1988, n. 925, in Giur. Cost., 1988, 4294-4303, con osservazione di P.G. GRASSO, Laicismo di Stato e punizione del reato di bestemmia (cfr. ivi, 4304-4306); G. MARINI, Ancora sulla legittimità costituzionale dell’art. 724 comma 1 c.p. (cfr. ivi, 4307-4311) e di S. LARICCIA, Tutela penale dell’«ex Religione dello Stato» e princìpi costituzionali (cfr. ivi, 4311-4319).
24 Cfr. Corte Cost., 9 febbraio 1989, n. 52, in Giur. Cost., 1989, 305-306.
La tutela penalistica della libertà religiosa nell’ordinamento italiano 131
dal 1988, la strada percorsa dai giudici delle leggi in vista della parificazione di tutela dei fedeli di ogni confessione 25.
Già all’indomani dell’entrata in funzione della Corte Costituzionale (1956) viene, infatti, sollevata la questione di costituzionalità dell’art. 404 c.p., sospet-tato di violare gli artt. 7 e 8 Cost. La questione è respinta con la sentenza 28 novembre 1957, n. 125 26, la quale inaugura un trend che rimane sostanzial-mente costante fino alla sentenza 8 luglio 1975, n. 188 (inclusa). Nell’analisi della giurisprudenza costituzionale sugli artt. 402-406 e 724 c.p. occorre, per-tanto, distinguere, come di seguito si farà, due periodi fondamentali: il primo dal 1957 al 1975, il secondo dal 1988 al 2005; a fare da spartiacque si pone, storicamente, la riforma dei Patti lateranensi del 1984 27.
1.3. La giurisprudenza costituzionale tra il 1957 e il 1975: l’approccio conservativo
La prima stagione della giurisprudenza costituzionale sui delitti contro il
sentimento religioso si colloca tra il 1957 e il 1975: la Corte, pronunciando una serie di decisioni che pur presentano alcune differenze d’impostazione, assume un approccio conservativo rispetto alla disciplina del codice Rocco e ritiene che la tutela differenziata delle confessioni si giustifichi in virtù sia della composi-zione religiosa del popolo italiano perlopiù cattolico (criterio sociologico-quantitativo) sia della disciplina dei Patti lateranensi, richiamati dall’art. 7 Cost., che riconoscono la confessione cattolica apostolica romana come religio-ne dello Stato (criterio normativo) 28.
La sentenza che apre il trend è Corte Cost., 28 novembre 1957, n. 125, rela-tiva all’art. 404 c.p.; fanno seguito Corte Cost., 18 dicembre 1958, n. 79 che
25 Nel senso della incostituzionalità della disciplina della tutela penale della religione per viola-zione del principio di uguaglianza cfr. M. ROMANO, Secolarizzazione, diritto penale moderno e siste-ma dei reati, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1981, 495-496 che scrive prima della riforma del Concor-dato. Per approfondire cfr. V. MORMANDO, I delitti contro il sentimento religioso, cit., 53-66.
26 Cfr. Corte Cost., 30 novembre 1957, n. 125, in Giur. Cost., 1957, 1209-1216, con osser-vazione di P. GISMONDI, La posizione della Chiesa cattolica e delle altre confessioni nel diritto costi-tuzionale ai fini della tutela penale (cfr. ivi, 1209-1215). L’annotatore ritiene che la differenza di tutela sia inopportuna de jure condendo, ma dichiara di condividere la tesi della Corte secondo cui la Costituzione non sanziona la parità tra le confessioni, accentuandone anzi le differenze (cfr. ivi, 1211-1212).
27 Per un percorso sulla giurisprudenza costituzionale cfr., tra gli altri, G. SALCUNI, Sub artt. 402-406 c.p., in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (diretto da), Trattato di di-ritto penale, parte speciale, Utet giuridica, Torino, 2008, vol. III, 873-876.
28 Per approfondire cfr. V. MORMANDO, I delitti contro il sentimento religioso, cit., 58-66.
Carmelo Domenico Leotta 132
rigetta la questione di costituzionalità dell’art. 724 c.p. 29, Corte Cost., 31 mag-gio 1965, n. 39, sull’art. 402 c.p. 30 e Corte Cost., 27 febbraio 1973, n. 14, sul-l’art. 724 c.p. Con tale ultima sentenza la Consulta, oltre ad affermare che la tutela penale offerta dall’art. 724 c.p. non solo non contrasta con la Costituzio-ne, ma in essa trova fondamento, già introduce un importante elemento di ce-sura rispetto al passato, invitando il legislatore ad estendere la tutela penalistica del sentimento religioso a vantaggio dei culti diversi da quello cattolico 31.
La prima stagione della giurisprudenza costituzionale si può ritenere conclu-sa con la sentenza 8 luglio 1975, n. 188, con cui la Consulta dichiara inammis-sibile per manifesta irrilevanza la questione di costituzionalità degli art. 403 e 405 c.p., in relazione all’art. 406, per contrasto con l’art. 3 Cost. 32.
Il criterio sociologico-quantitativo trova nello stesso periodo accoglimento nella giurisprudenza di legittimità 33.
1.4. La giurisprudenza costituzionale dopo la riforma dei Patti lateranensi (1988‐2005)
Nel 1985 lo Stato italiano dà esecuzione all’Accordo di modificazione del
Concordato lateranense del 18 febbraio 1984, da cui deriva, tra l’altro, che la religione cattolica non sia più considerata sola religione dello Stato 34.
29 Cfr. Corte Cost., 30 dicembre 1958, n. 79, in Giur. Cost., 1958, 990-993, con osservazione
di C. ESPOSITO, La bestemmia nella Costituzione Italiana (cfr. ivi, 990-992), il quale condivide il merito della pronuncia, ma non le motivazioni, posto che, a suo dire, il principio di uguaglianza non comporta «pari, generale ed indifferenziato trattamento positivo o tutela» (cfr. ivi, 991).
30 Cfr. Corte Cost., 31 maggio 1965, n. 39, in Giur. Cost., 1965, 602-614 con indicazione di ampia bibliografia sul tema (cfr. ivi, 604-609) e osservazione di P. GISMONDI, Vilipendio della confessione cattolica e disciplina costituzionale delle confessioni (cfr. ivi, 609-613).
31 Cfr. Corte Cost., 27 febbraio 1973, n. 14, in Giur. Cost., 1973, 69-78, con osservazione di A. BALDASSARRE, È costituzionale l’incriminazione della bestemmia? (cfr. ivi, 70-78).
32 La stessa sentenza, come si è detto poco sopra, dichiara non fondata la censura di incosti-tuzionalità rispetto all’art. 25, 2° co., Cost., sotto il profilo della indeterminatezza della fattispe-cie, come pure rispetto all’art. 21 Cost., in riferimento al diritto di libera manifestazione del pensiero.
33 Cfr., ad esempio, Cass., pen. Sez. III, 16 febbraio 1966, n. 466 in Riv. pen., 1968, II, fasc. 1 (gen. 1968), 94; Cass. pen., Sez. VI, 4 giugno 1969, n. 1349, in Dir. eccl., 1970, II, 71-73; Cass. pen., Sez. VI, 1° luglio 1969, n. 1576, in Cass. pen. mass. ann., 1971, 81-83.
34 La l. 25 marzo 1985, n. 121 autorizza la Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato latera-nense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede. La legge entra in vigore il 3 giugno 1985 con lo scambio degli strumenti di ratifica. Il primo punto del protocollo addiziona-
La tutela penalistica della libertà religiosa nell’ordinamento italiano 133
Si apre una nuova stagione della giurisprudenza costituzionale, anticipata dall’ordinanza del 10 aprile 1987, n. 147 con cui la Corte, chiamata a sindacare la costituzionalità dell’art. 402 c.p., restituisce gli atti al Tribunale di Firenze, dal momento che, dopo la modifica dei Patti lateranensi ratificata con legge del-lo Stato, spetta al giudice a quo verificare il permanere di rilevanza della que-stione sollevata 35.
Segna la svolta definitiva, nonostante la lettera del dispositivo (ancora un ri-getto), Corte Cost., 8 luglio 1988, n. 925, sull’art. 724 c.p., censurato in rela-zione agli artt. 2, 3, 7, 8, 19, 21, 25 Cost. La Corte, pur dichiarando non fon-data la questione e richiamando i propri precedenti conservativi sulla contrav-venzione di bestemmia, afferma apertis verbis che la modifica del Patti latera-nensi «renderebbe ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basasse soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni reli-giose» 36. Incombe, pertanto, «al legislatore […] l’obbligo di addivenire ad una re-visione della fattispecie, così da ovviare alla disparità di disciplina con le altre reli-gioni» 37.
Nel 1995, stante l’inerzia legislativa, la questione di costituzionalità dell’art. 724 c.p. per contrasto con gli artt. 3, 8 e 25 Cost. torna alla Consulta e viene decisa con la nota sentenza 18 ottobre 1995, n. 440 che affronta sia la questio-ne della indeterminatezza della fattispecie sia quella dell’uguaglianza di tutela.
Sotto il profilo della indeterminatezza, da cui la lamentata violazione del-l’art. 25, 2° co., Cost., non sono accolte le censure del giudice rimettente relati-ve all’impossibilità di definire, a seguito della riforma del 1984, il sintagma “re-ligione dello Stato” poiché, a dire della Corte, la norma incriminatrice continua a riferirsi alla religione cattolica, già religione dello Stato.
Più complesso il testo della sentenza in merito al contrasto tra la disparità di tutela tra le diverse confessioni ed il principio di uguaglianza di cui agli artt. 3 e 8 Cost.: la Corte, con un’operazione chirurgica – che, nonostante le rassicurazioni rese in sentenza, estende il precetto penale, in violazione del divieto di pronunce additive in malam partem 38 – spezza in due parti l’enunciato «Chiunque pubbli-
le prevede: «Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti latera-nensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano». Con successiva l. 20 maggio 1985, n. 206 si dà esecuzione del protocollo del 15 novembre 1984 per la disciplina della mate-ria degli enti e beni ecclesiastici.
35 Cfr. Corte Cost., 10 aprile 1987, n. 147, in Giur. Cost., 1987, 991-992. 36 Cfr. Corte Cost., 8 luglio 1988, n. 925, cit., 4302. 37 Cfr. ivi, 4303. 38 Cfr., in senso critico rispetto alla sentenza in commento, I. CARACCIOLI, Manuale di dirit-
to penale. Parte generale, Cedam, Padova, 1998, 39-40. Anche F. PALAZZO, La tutela della reli-gione tra uguaglianza e secolarizzazione (a proposito della dichiarazione di incostituzionalità della
Carmelo Domenico Leotta 134
camente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato» e, ritenendo la specificazione «venera-ti nella religione dello Stato» riferita solo ai Simboli e alle Persone e non anche alla Divinità, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 724, 1° co., c.p. limitata-mente alle parole «o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato».
L’effetto è la ridefinizione dei confini della fattispecie originaria, da un lato ristretti per quanto riguarda l’indicazione del destinatario dell’invettiva o delle parole ingiuriose, che può essere solo la Divinità e non più i Simboli o le Perso-ne; dall’altro ampliati per quanto riguarda la specificazione della Divinità, che non è più solo quella venerata dalla religione cattolica, ma da qualsiasi confes-sione religiosa.
La sentenza del 1995 segna l’inizio di una serie di pronunce di accoglimento che, nell’arco di otto anni, dal 1997 al 2005, non lasciano indenne nessuna del-le fattispecie comprese nel Capo I del Titolo IV.
Così Corte Cost., 10 novembre 1997, n. 329 dichiara l’illegittimità costitu-zionale, per violazione degli artt. 3, 1° co., e 8, 1° co., Cost., dell’art. 404, 1° co., c.p., (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose), nella parte in cui commina la reclusione da uno a tre anni anziché la pena diminuita ex art. 406 c.p., stabilita qualora il fatto sia commesso a danno di un culto diverso da quello cattolico. La decisione, muovendosi nella direzione di una totale parità di trattamento tra i diversi fenomeni religiosi, manifesta a chiare lettere il prin-cipio per cui, «non valendo il numero» 39, la libertà di professare la propria reli-gione deve abbracciare ogni esperienza religiosa. La Corte, lungi dall’avanzare una equiparazione o una riduzione dell’esperienza religiosa a mera manifesta-zione del libero pensiero, ha cura di precisare che «la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso mo-do l’esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione indivi-duale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede della diverse confessioni» 40. Il regime di pari tutela volto a garantire la dignità di ogni fedele è, a sua volta, applicazione del principio di laicità o non-confessionalità dello Stato che «non significa indifferenza di fronte all’esperienza religiosa ma comporta equidi-stanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose» 41.
bestemmia), in Cass. pen., 1996, 47-57, pur dando un giudizio sostanzialmente positivo sulla sentenza, ritiene che la Corte abbia esteso i confini della fattispecie. Sull’avvenuta estensione del-la fattispecie cfr., più di recente, M. CROCE, La libertà religiosa nella giurisprudenza costituziona-le, in Diritto pubblico, 2006, n. 2, 423.
39 Cfr. Corte Cost., 10 novembre 1997, n. 329, cit., 3339. 40 Cfr. ivi, 3339-3340. 41 Cfr. ibidem.
La tutela penalistica della libertà religiosa nell’ordinamento italiano 135
Trascorsi tre anni, Corte Cost., 13 novembre 2000, n. 508 dichiara costitu-zionalmente illegittimo l’art. 402 c.p., (Vilipendio della religione dello Stato) che prevede l’ipotesi residuale del cosiddetto vilipendio generico, consumabile solo a danno della religione cattolica. L’art. 402 c.p. è dichiarato contrario al dettato co-stituzionale perché viola i princìpi di uguaglianza «senza distinzioni di religione» (art. 3, 1° co., Cost.) e di uguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti al-la legge (art. 8 Cost.); legittima, invece, e rispettosa del principio di laicità, è «la possibilità di regolare bilateralmente e quindi in modo differenziato, nella loro specifi-cità, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica tramite lo strumento concordatario (art. 7 della Costituzione) e con le confessioni religiose diverse da quella cattolica tra-mite intese (art. 8)» 42. Alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 402 c.p. non si accompagna un giudizio, neppure implicito, di non meritevolezza di tutela pe-nale del sentimento religioso; il giudice delle leggi ritiene piuttosto che, sebbene «il ripristino dell’uguaglianza violata possa avvenire non solo eliminando del tutto la norma che determina quella violazione, ma anche estendendone la portata per ricom-prendervi i casi discriminati, e sebbene il sopra evocato principio di laicità non impli-chi indifferenza e astensione dello Stato dinnanzi alle religioni, ma legittimi interventi legislativi a protezione della libertà di religione, in sede di controllo di costituzionalità di norme penali si dà solo la prima possibilità» 43, vale a dire l’espunzione, attraverso una pronuncia di accoglimento, della norma discriminatoria dal sistema delle fon-ti.
Sull’art. 405 c.p., (Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico), inter-viene a seguire Corte Cost., 1 luglio 2002, n. 327, dichiarandone l’illegittimità nella parte in cui, per i fatti previsti, commina pene più gravi, anziché le pene più miti stabilite dall’art. 406 c.p. per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti. La Corte, con una breve e snella decisione, richiama i princìpi della sen-tenza 10 novembre 1997, n. 329 sull’art. 404 c.p. e afferma l’incompatibilità tra il principio di laicità e il giudizio di minor gravità sulla condotta turbativa o impeditiva dell’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose compiuta a danno di culti diversi da quello cattolico 44.
Giunti ormai alla vigilia della riforma legislativa, cade anche la disciplina originaria dell’art. 403 c.p., (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone). Con la sentenza 18 aprile 2005, n. 168, la Consulta nulla aggiunge ai criteri già enunciati a partire dal 1997 e dichiara la norma costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica, me-
42 Cfr. Corte Cost., 13 novembre 2000, n. 508, cit., 3969. 43 Cfr. ivi, 3969-3970. 44 Cfr. Corte Cost., 1 luglio 2002, n. 327, in Giur. Cost., 2002, 2522-2525, con nota reda-
zionale di P. SPIRITO.
Carmelo Domenico Leotta 136
diante vilipendio a chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclu-sione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena dimi-nuita stabilita dall’art. 406 dello stesso codice 45.
In sintesi, gli interventi della Corte Costituzionale sulla disciplina originaria del codice Rocco conducono:
all’abrogazione dell’art. 402 c.p., Vilipendio della religione dello Stato, che sanzionava il vilipendio generico solo contro la religione cattolica (Corte Cost., 13 novembre 2000, n. 508);
alla parificazione del regime sanzionatorio degli artt. 403 c.p. Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone (Corte Cost., 18 aprile 2005, n. 168), 404 c.p. Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose (Cor-te Cost., 10 novembre 1997, n. 329) e 405 c.p. Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico (Corte Cost., 1° luglio 2002, n. 327) con quello più lieve pre-visto dall’art. 406 c.p. per gli altri culti;
all’estensione della punibilità per la contravvenzione di bestemmia di cui all’art. 724 c.p. che diviene rilevante, a seguito di Corte Cost., 18 ottobre 1995, n. 440, se pronunciata contro la Divinità di qualsivoglia confessione. Diviene, invece, penalmente irrilevante la bestemmia pronunciata contro i Simboli o le Persone della religione cattolica. Il d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 provvederà, infine, a depenalizzare la fattispecie.
1.5. I «delitti contro le confessioni religiose» dopo la l. 24 feb‐braio 2006, n. 85
All’esito degli interventi della Corte Costituzionale di cui si è appena detto,
la riforma legislativa del 2006 del Libro II, Titolo IV, Capo I, c.p., da allora in-titolato Dei delitti contro le confessioni religiose, ribadisce il principio della pari tutela delle confessioni ed interviene sul precetto secondario, privilegiando la pena pecuniaria. Nel segno della continuità si pone, invece, la scelta di conser-vare l’incriminazione del vilipendio come pure avviene in altri ambiti su cui va a intervenire la medesima novella 46.
Brevemente:
ex art. 403 c.p., come sostituito dall’art. 7, l. 24 febbraio 2006, n. 85, il
45 Cfr. Corte Cost., 18 aprile 2005, n. 168, in Giur. Cost., 2005, 1379-1383, con nota reda-
zionale di A. ODDI. 46 Il riferimento è agli artt. 291-292 c.p. che sanzionano rispettivamente il vilipendio alla na-
zione e alla bandiera.
La tutela penalistica della libertà religiosa nell’ordinamento italiano 137
delitto di offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone (questa la nuova rubrica), punito, fino al 2006, con la reclusione fino a due anni 47, è ora punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro. La condotta deve essere consu-mata pubblicamente (1° co.). Il 2° co. prevede, come già ante riforma, una fatti-specie autonoma (e non semplicemente una forma aggravata del delitto base) 48, integrata se il fatto è commesso contro un ministro di culto e punita allora con la reclusione da uno a tre anni 49, ora con la pena pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro. Ai fini della consumazione, non si richiede che il fatto di cui al 2° co. sia commesso pubblicamente;
ex art. 404 c.p., come sostituito dall’art. 8, l. 24 febbraio 2006, n. 85, sono punite le offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose. L’articolo in questione prevede due fattispecie, entrambe commesse su cose oggetto di culto, consacrate al culto o destinate necessariamente all’esercizio del culto. La prima, descritta dal 1° co., è un delitto di vilipendio in senso stretto, punito, secondo la disciplina originaria, con la reclusione da uno a tre anni 50, ed ora con la multa da 1.000 a 5.000 euro. Il fatto tipico, come sotto il vecchio re-gime, deve essere commesso in luogo di culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico o, ancora, in luogo privato in occasione di funzioni compiute dal mini-stro di culto (1° co.). La novella meglio determina il precetto rispetto alla formu-lazione previgente, stabilendo che il vilipendio sia arrecato con «espressioni ingiu-riose»; non sembra, invece, rechi modifiche la sostituzione con la formula «offen-dendo […] vilipende» di quella previgente «offende […] mediante vilipendio». L’art. 8 della novella del 2006 introduce, poi, una nuova fattispecie all’art. 404, 2° co., c.p. che punisce con la reclusione fino a due anni chi pubblicamente e intenzio-nalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose oggetto di culto, consacrate o destinate al culto. La previsione della nuova fattispecie di danneggiamento ha reso necessaria la modifica della rubrica che ora recita Offese ad una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose;
ex art. 405 c.p. è punibile fino a due anni di reclusione 51, come sotto la disciplina del 1930, la turbatio sacrorum, vale a dire la condotta di chi impedi-
47 Si tenga conto che la pena sarebbe comunque dovuta applicarsi diminuita ex art. 406 c.p., a seguito di Corte Cost., 18 aprile 2005, n. 168, cit.
48 Così P. SIRACUSANO, Sub art. 403 c.p., cit., p. 1987. 49 La pena sarebbe comunque dovuta applicarsi diminuita ex art. 406 c.p., a seguito di Corte
Cost., 18 aprile 2005, n. 168, cit. 50 La pena sarebbe comunque dovuta applicarsi diminuita ex art. 406 c.p., a seguito di Corte
Cost., 14 novembre 1997, n. 329, cit. 51 La pena sarebbe comunque dovuta applicarsi diminuita ex art. 406 c.p., a seguito di Corte
Cost., 1° luglio 2002, n. 327, cit.
Carmelo Domenico Leotta 138
sce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa che si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Nulla di nuovo anche per quanto riguarda l’aggravante del ricorso al-la violenza alle persone o alla minaccia che comporta, anche oggi, la reclusione da uno a tre anni.
Ancora, la l. 24 febbraio 2006, n. 85:
non ripristina il vilipendio generico, di cui all’art. 402 c.p.; non modifica il Capo II del Titolo IV, in materia di delitti contro la pietà
dei defunti; non reintroduce il reato di bestemmia di cui all’art. 724 c.p. che continua
a rilevare come illecito amministrativo ex art. 57, d.lgs. 30-12-1999, n. 507.
Esula dal presente contributo uno studio analitico delle fattispecie elenca-te 52. Superfluo dire che oggi, anche in considerazione della varietà del fenome-no religioso in Italia 53, uno dei profili certamente più problematici nell’appli-cazione delle fonti supra elencate è quello di individuare la corretta o quanto-meno la più calzante accezione ai fini penalistici del sintagma “confessione reli-giosa”, a cui il legislatore del 2006 non ha inteso rinunciare.
2. La tutela penalistica contro gli atti discriminatori compiuti per motivi (anche) religiosi e contro i gruppi (anche) religiosi Nella seconda parte di questo studio saranno richiamate le fonti extracodici-
stiche introdotte dal legislatore italiano con finalità di tutela contro gli atti di discriminatori per motivi (anche) religiosi e contro gli atti di distruzione del gruppo (anche) religioso. Pur essendo la legge contro il genocidio (1967) pre-
52 Per approfondire cfr., in particolare, G. SALCUNI, Sub artt. 402-406 c.p., cit., 873-917 e
D. BRESCIANI, Sub artt. 407-413 c.p., in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, Trattato di diritto penale, cit., vol. III, 905-981; C. SGROI, Sub artt. 402-413 c.p., in G. LAT-
TANZI, E. LUPO, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Giuffrè, Milano, 2010, vol. VIII, 511-622; P. SIRACUSANO, Sub artt. 402-406 c.p., in M. RONCO, B. ROMANO, Codice pe-nale commentato, cit., 1977-2000 e A. GULLO, Sub artt. 407-413 c.p., in ivi, 2000-2021. Infine cfr. G. PICA, I reati contro la libertà di religione e la pietà dei defunti, in S. ALEO, G. PICA, Diritto penale. Parte speciale, Cedam, Padova, 2012, vol. I, 429-445. Cfr. anche V. PACILLO, I delitti contro le confessioni religiose dopo la legge 24 febbraio 2006, n. 85, Giuffrè, Milano, 2007.
53 Per un’autorevole indagine sul fenomeno religioso in Italia, cfr. M. INTROVIGNE, P. ZOC-
CATELLI, Enciclopedia delle religioni in Italia, Elledici, Leumann (Torino), 2013; F. GARELLI, Re-ligione all’italiana. L’anima del paese messa a nudo, Il Mulino, Bologna, 2011.
La tutela penalistica della libertà religiosa nell’ordinamento italiano 139
cedente rispetto a quella contro le discriminazioni (1975, con successive modi-fiche del 1993 e del 2006), è da quest’ultima che si prenderanno le mosse, data la maggiore rilevanza ai fini applicativi.
2.1. La repressione degli atti discriminatori commessi per moti‐vi (anche) religiosi
Gli atti discriminatori compiuti per motivi razziali, etnici, nazionali e reli-
giosi sono sanzionati dall’art. 3, l. 13 ottobre 1975, come novellato dapprima dall’art. 1, d.l. 26 aprile 1993, n. 122 (decreto Mancino), conv. con modif. dalla l. 25 giugno 1993, n. 205, e, da ultimo, dall’art. 13, l. 24 febbraio 2006, n. 85.
La l. 13 ottobre 1975, n. 654, promulgata in attuazione della International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination delle Na-zioni Unte del 21 dicembre 1965, prevede nell’attuale versione dell’art. 3 le se-guenti fattispecie 54:
l’istigazione e la consumazione di atti discriminatori (non violenti) per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, puniti, alternativamente, con la re-clusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro (ex art. 3, 1° co., lett. a);
l’istigazione, la consumazione di atti violenti e di provocazione alla violen-za per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, puniti con la reclusione da sei mesi a quattro anni (ex art. 3, 1° co., lett. b);
la partecipazione e l’assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi con finalità di incitamento alla discriminazione o alla violenza per mo-tivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, puniti con la reclusione da sei mesi a quattro anni (ex art. 3, 3° co., primo e secondo periodo), con la previsione di un’aggravante ad effetto speciale per promotori e dirigenti (reclusione da uno a sei anni ex art. 3, 3° co., terzo periodo).
Condotte di minor gravità sono previste e punite dall’art. 2, d.l. 26 aprile 1993, conv.: trattasi dell’inosservanza del divieto di compiere, in pubbliche riu-nioni, manifestazioni esteriori e di ostentare emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni vietate di cui all’art. 3, l. 13 ottobre 1975, n. 654, nonché
54 Per uno studio analitico delle fonti menzionate sia consentito rinviare a C.D. LEOTTA, Sub
l. 13 ottobre 1975, n. 654, in A. GAITO, M. RONCO, Leggi penali complementari commentate, Utet Giuridica, Torino, 2009, 2592-2614; IDEM, Sub d.l. 26 aprile 1993, n. 122, in ivi, 2615-2637; IDEM, voce Razzismo, in Dig. discipl. penal., Utet Giuridica, Torino, 2008, IV agg., tomo II, 850-884 e alla bibliografia ivi indicata.
Carmelo Domenico Leotta 140
dell’inosservanza del divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive, qualora ivi ci si rechi con simboli di matrice discriminatoria.
L’art. 3 del decreto Mancino prevede, a seguire, una circostanza aggravante ad effetto speciale, tale per cui, per i reati punibili con pena diversa da quella dell’er-gastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, raz-ziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è au-mentata fino alla metà. A tale effetto sono collegate ulteriori sanzioni sul piano processuale, quali, in particolare, la procedibilità d’ufficio per fatti ordinariamente procedibili a querela e il ricorso al rito direttissimo, fatte salve le speciali esigenze di indagine (art. 6, d.l. 16 aprile 1993, n. 122 conv.). Di estrema rilevanza, infine, la previsione di cui all’art. 1, 2° co., lett. e), l. 31 luglio 2006, n. 241 che esclude per i delitti aggravati ai sensi dell’art. 3 del decreto Mancino l’applicazione dell’indulto. La circostanza in parola assume una particolare efficacia repressiva quando va ad aggravare il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis, c.p. (ancora rivisitato dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con modif. dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di contrasto alla violenza di genere): in tale frangente, l’art. 3, d.l. 16 aprile 1993, n. 122 conv. non solo comporta un aggravio di pena, ma pure con-sente la procedibilità ex officio dello stalking, altrimenti procedibile, nella forma ba-se, a querela della persona offesa (art. 612-bis, 4° co., c.p.).
Rinviando ad altre sedi per gli opportuni approfondimenti (eventualmente anche in senso critico 55) della disciplina antidiscriminatoria sopra richiamata – perlopiù applicata in repressione di episodi di razzismo – ci si accontenta in que-ste pagine di evidenziare come il legislatore del 1993, intervenendo sulle norme allora vigenti, abbia optato per un’inequivocabile scelta politico-criminale di am-piamento della tutela accordata al fedele. La novella, in primo luogo, ha preso, in-fatti, espressamente in considerazione il fenomeno religioso, intervenendo su di una fonte (l’art. 3, l. 13 ottobre 1975, n. 654) che, nella sua formulazione origi-naria, sanzionava esclusivamente la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale, l’istigazione e la commissione di atti discriminatori o di violenza o di provocazione alla violenza «nei confronti di persone perché appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale», senza far menzione dei fatti commessi per motivi religiosi. In ciò, il decreto Mancino ha confermato l’opzione già anticipata dall’art. 2, 5° co. l. 8 marzo 1989, n. 101, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane 56, in base al quale il «disposto
55 Per uno studio sui profili di costituzionalità rispetto all’art. 21 Cost. si rinvia, in particola-
re, a L. SCAFFARDI, Oltre i confini della libertà di espressione. L’istigazione all’odio razziale, Ce-dam, Padova, 2009.
56 In Gazz. Uff. 23 marzo 1989, n. 69, suppl. ordinario.
La tutela penalistica della libertà religiosa nell’ordinamento italiano 141
dell’art. 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si intende riferito anche alle manife-stazioni di intolleranza e pregiudizio religioso». In secondo luogo, lo stesso decreto, intervenendo sulle norme del 1975, ha “spostato” il bene protetto dalla dimen-sione pubblica a quella essenzialmente personale/individuale 57.
Sono questi due segnali di una chiara volontà di accordare più ampia tutela al fe-nomeno religioso non tanto né principalmente in vista della conservazione dell’or-dine pubblico materiale, quanto piuttosto per garantire in via prioritaria la protezio-ne della libertà religiosa, di cui sono titolari il singolo fedele ed i gruppi di fedeli.
2.2. La tutela dei gruppi religiosi contro i fatti di distruzione (genocidio)
In attuazione degli obblighi internazionali sanciti nella Convention on the
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, approvata dalle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948, il Parlamento approva la l. 9 ottobre 1967, n. 962 che tutela l’esistenza del gruppo religioso (insieme al gruppo nazionale, etnico e razziale) dinnanzi al rischio di distruzione totale o parziale (genocidio) 58.
Il delitto base di genocidio di cui all’art. 1 è previsto come delitto di attenta-to sia nella forma degli «atti diretti a cagionare lesioni personali gravi» a membri del gruppo protetto, puniti con la reclusione da dieci a diciotto anni (1° co.), sia nelle due successive forme degli «atti diretti a cagionare la morte o lesioni per-sonali gravissime», puniti con la reclusione da ventiquattro a trent’anni (2° co., primo periodo).
Il fatto tipico, che deve sempre essere accompagnato sul piano soggettivo, dal dolo di distruzione del gruppo, può inoltre essere realizzato attraverso le se-guenti condotte:
57 Sulla nuova definizione del bene tutelato, a seguito del d.l. 26 aprile 1993, n. 122 conv., cfr. G. DE FRANCESCO, Commento al d.l. 26/4/1993, n. 122, conv. con modif. dalla l. 25/6/1993, n. 205. Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, in Legislazione pen., 1994, II, 181. Per un commento cfr. anche S. RIONDATO (a cura di), Discriminazione raz-ziale, xenofobia, odio religioso. Diritti fondamentali e tutela penale. Atti del Seminario di studio svoltosi a Padova, il 24 marzo 2006, Cedam, Padova, 2006.
58 Per un commento alla disciplina italiana sia consentito rinviare a C.D. LEOTTA, Sub l. 9 ottobre 1967, n. 962, in A. GAITO, M. RONCO, Leggi penali complementari commentate, cit., 1422-1459 e alla bibliografia ivi indicata. Per un commento, in italiano, alla disciplina internazionale cfr. E. FRONZA, Il crimine di genocidio, in E. AMATI, V. CACCAMO, M. COSTI, E. FRONZA, A. VALLINI, Introduzione al diritto penale internazionale, 2a
ed., Giuffrè, Milano, 2010, 377-410 e C.D. LEOTTA, Il genocidio nel diritto penale internazionale. Dagli scritti di Raphael Lemkin allo Statuto di Roma, Giappichelli, Torino, 2013. Nella dottrina internazionale cfr., per tutti, W. SCHABAS, The Genocide in International Law. The Crime of Crimes, 2nd ed., Cambridge University Press, New York, 2009.
Carmelo Domenico Leotta 142
imposizione di condizioni di vita atte a determinare la distruzione del grup-po (reclusione da ventiquattro a trent’anni ex art. 1, 2° co., secondo periodo);
deportazione di persone appartenenti al gruppo (reclusione da quindici a ventiquattro anni ex art. 2);
imposizione o attuazione di misure tendenti ad impedire o a limitare le nascite nel gruppo (reclusione da dodici a ventuno anni ex art. 4);
sottrazione di minori di anni quattordici appartenenti al gruppo naziona-le, etnico, razziale o religioso, per trasferirli ad un gruppo diverso (reclusione da dodici a ventuno anni ex art. 5).
Non si richiede, invece, il dolo della distruzione nel delitto di imposizione a persone appartenenti al gruppo di marchi o segni distintivi indicanti la appar-tenenza al gruppo stesso (punito con la reclusione da quattro a dieci anni ex art. 6). In questo caso la circostanza di aver commesso il fatto al fine di predisporre la distruzione totale o parziale del gruppo è qualificata come aggravante ad ef-fetto speciale (pena della reclusione da dodici a ventuno anni ex art. 6, 2° co.).
Sono, infine, condotte penalmente rilevanti l’accordo per commettere geno-cidio (art. 7), l’istigazione e l’apologia di genocidio (art. 8). La giurisprudenza interna è intervenuta in almeno due casi sull’interpretazione dell’art. 8, 2° co., che sanziona l’apologia di genocidio, da ultimo richiedendo, ai fini di un giudizio di penale responsabilità, l’idoneità in concreto del fatto a cagionare l’evento 59.
Anche alla luce dell’applicazione giurisprudenziale che fino ad oggi ha in-teressato il giudice italiano, pare corretto affermare che, all’interno del nostro ordinamento, l’incriminazione del genocidio, oltre ad ottemperare un preciso obbligo internazionale, rileva essenzialmente in materia dei cosiddetti reati di opinione e assume una funzione lato sensu simbolica. Ciò che, tuttavia, merita di essere sottolineato è il significato che il gruppo religioso in quanto tale as-sume, anche sul piano storico-giuridico, come oggetto originario di una tutela che le fonti internazionali del secolo XX hanno poi esteso a favore delle mi-noranze, bene protetto per antonomasia dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro il genocidio. Le fattispecie da questa tipizzate (art. 2), riprese negli Sta-tuti del Tribunale internazionale per la ex-Jugoslavia (art. 4) e del Tribunale per il Rwanda (art. 2) e, infine, nello Statuto della Corte penale internazionale del 1998 (art. 6), a ragione possono considerarsi l’evoluzione sul lungo periodo del-le disposizioni previste, a partire dal XVII secolo, dagli Stati europei in vista
59 Cfr. Ass. Milano, 14 novembre 2001, in Cass. pen., 2003, 1006-1013, con nota di E.
FRONZA, Brevi note sulla teoria della «istigazione indiretta» in tema di apologia (cfr. ivi, 1013-1021). Diversa interpretazione si rinviene nel precedente Cass. pen., Sez. I, 29 marzo 1985, n. 507 in Foro it., 1986, II, col.19-23 con nota di G. FIANDACA (cfr. ivi, coll. 19-21).
La tutela penalistica della libertà religiosa nell’ordinamento italiano 143
della tutela delle confessioni religiose 60. Più precisamente, lo stesso concetto giuridico di minoranza nasce nell’Europa insanguinata dalle guerre di religione, in risposta all’esigenza di tutela del singolo fedele e delle comunità di fedeli e, da qui, è successivamente esteso, a partire dal XIX secolo, ai gruppi etnici, na-zionali e razziali 61.
3. L’opportunità della tutela penale della libertà religiosa L’analisi delle fonti fin qui menzionate consente di abbozzare, nelle prossime
pagine, alcune (pur provvisorie) considerazioni a sostegno dell’opportunità di una tutela penalistica del sentimento religioso e della libertà religiosa in quanto tali 62 e non come mera estrinsecazione della libertà morale o del diritto al-l’onore della persona 63.
60 Cfr. W. SCHABAS, Genocide in International Law, cit., p. 18. 61 Cfr. P. DONINI, Le minoranze, Jaca Book, Milano, 1998. 62 Sulla distinzione tra i due concetti, cfr. nota 1. 63 Favorevoli in dottrina alla tutela penalistica della materia religiosa F. MANTOVANI, voce
Persona (delitti contro la), in Enc. dir., Annali, Giuffrè, Milano, 2008, vol. II, tomo II, 866, con la precisazione, de jure condendo, che quand’anche si volessero far rientrare tali fattispecie non tra i delitti contro la persona, ma tra i delitti contro i rapporti civili e sociali, «il bene da tutelare è il diritto personale a non subire offese alla propria libertà e al proprio sentimento religioso». M. ROMA-
NO, Principio di laicità dello Stato, religioni, norme penali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2007, 495 stigmatizza la «laicità concepita in un’accezione forte, secondo il modello classico, [la quale] confi-nando la religione nella sfera totalmente privata, tende a respingere l’idea che possa concedersi un rea-le spazio all’emersione pubblicistica della materia religiosa», secondo il modello della laïcité alla francese. È preferibile, secondo l’autorevole studioso, un modello post-moderno di laicità che «non rifugge già in radice, non nega e non teme il realistico riconoscimento di uno spazio pubblico al-le religioni» (cfr. ivi, 495-496). Lo Stato, allora, potrà legittimamente dettare norme penali a tu-tela della religione, nel rispetto della pari dignità di tutela. In ID., Secolarizzazione, diritto penale moderno, cit., 496-497, Romano, scrivendo prima della riforma del Concordato, esclude che il sentimento religioso sia meritevole di tutela specifica come fatto di coscienza, «poiché ciò varreb-be a discriminare come negative le forme di areligiosità o di ateismo attivo» (cfr. ivi, 496), ma am-mette la tutela penale contro il vilipendio alle religioni ove si determini il pericolo concreto per la tranquillità pubblica. L’Autore, inoltre, non ritiene problematica la punibilità della turbatio sacrorum, poiché la stessa rileva come «considerazione legislativa del fenomeno religioso nella di-mensione tutta naturale e antropologica del “sacro”, quale esternazione di un rapporto uomo-Dio, uomo-Trascendenza, uomo-“Altro”» (cfr. ibidem). Per un’attenta ricostruzione del bene giuridico protetto, da individuarsi nella libertà religiosa positiva, da cui l’opportunità della tutela accorda-ta dalla legge civile e penale, cfr. il chiaro insegnamento di M. RONCO, Libertà religiosa e diritto penale, in L. ANTONINI (a cura di), Il traffico dei diritti insaziabili. Atti del Convegno interna-zionale “Virtù e torti del diritto nella società post moderna”, Treviso, gennaio 2006, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2007, 195-206. Per una tutela penalistica specifica del sentimento re-
Carmelo Domenico Leotta 144
ligioso cfr. anche F. STELLA, Il nuovo Concordato, cit., 97-105. In termini particolarmente chiari sull’opportunità della tutela penale del fatto religioso, pur con la precisazione che una scelta di depenalizzazione non sarebbe in sé incostituzionale, cfr. P. LILLO, Corte costituzionale e art. 724 c.p., cit., 4553-4554, ove si evidenzia che è proprio il carattere laico dello Stato a far sì che il fat-to religioso, che l’Autore definisce «uno dei fondamentali “beni di civilità”» (cfr. ivi, 4553), non sia, per lo Stato, fatto irrilevante ma piuttosto fenomeno che concorre «all’affermazione del pro-gresso spirituale della società» (cfr. ivi, 4554). Ancora sull’opportunità di una tutela specifica della coscienza religiosa, anche se non necessariamente penalistica, cfr. G. DI COSIMO, Sulla discussa tutela penale, cit., in particolare 4526-4531; infine cfr. G. FLORA, Tutela penale delle confessioni acattoliche, libertà di critica e principio di tolleranza religiosa. Nota a Trib. Venezia, 10 marzo 1992, in Foro it., 1992, II, coll. 705-711. Anche A. SERENI, Sulla libertà penale della libertà reli-giosa, in Cass. pen., 2009, 4499-4516 si esprime in senso favorevole all’intervento penale in ma-teria religiosa. L’Autore, tuttavia, critica il modello imperniato sulla fattispecie di vilipendio che difenderebbe il bene “religione” piuttosto che la “libertà religiosa” e propone un modello fondato sulla figura degli atti persecutori commessi per motivi, tra gli altri, religiosi o contro gruppi an-che religiosi.
Contrari alla tutela penale del sentimento religioso, pur per ragioni non sempre coincidenti: G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. I, Zanichelli, Bologna, 2012, Va ed., 454, i quali ritengono che il legislatore del 2006 «avrebbe anche potuto optare – come sarebbe stato auspicabile – per un modello laico e secolare di diritto penale, escludendo dagli oggetti della tutela pe-nale il fenomeno religioso, considerato sia sotto il profilo istituzionale, sia sotto il profilo psicologico come sentimento»; G. FIANDACA, Laicità del diritto penale e secolarizzazione dei beni tutelati, in Studi in memoria di P. Nuvolone, Milano, 1991, I, 165-194 già sostiene una scelta di tipo aboli-zionistico, anche considerato il fatto che le eventuali esigenze residue di tutela, comunque sem-pre da valutarsi alla luce del criterio della dannosità sociale, potrebbero essere soddisfatte da fatti-specie poste a tutela dell’onore e della libertà morale, di riunione e di domicilio. Una tutela spe-cifica sarebbe per Fiandaca incompatibile con il modello dello Stato laico, perché comporterebbe un riconoscimento simbolico-culturale del fatto religioso in sé. Contro la tutela penale specifica della libertà religiosa cfr. V. MORMANDO, I delitti contro il sentimento religioso, cit., in particolare 91-92 e 118-124; P. SIRACUSANO, Pluralismo e secolarizzazione dei valori: la superstite tutela pe-nale del fattore religioso nell’ordinamento italiano, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2009, 621-638: a di-re dell’Autore, il principio di laicità comporta la tutela di tutte le opzioni in materia di fede, comprese quelle agnostiche e atee, per concludere nel senso dell’inettitudine dello strumento pe-nalistico (cfr. ivi, 637). Nel senso che la tutela della libertà religiosa possa essere affidata a fatti-specie di genere, poste a tutela dell’onore, cfr. A.G. CANNAVALE, C. LAZZARI, La tutela delle reli-gioni e il codice penale, in D. BRUNELLI (a cura di), Diritto penale della libertà religiosa, Giappi-chelli, Torino, 2010, 104: gli Autori ritengono che gli artt. 403 e 404, pur non violando l’art. 21 Cost., non costituiscano un rimedio costituzionalmente obbligato alla tutela del fedele, es-sendo piuttosto il frutto di una scelta di discrezionalità legislativa. Sull’opportunità di una ten-denziale equiparazione tra tutela del sentimento religioso e onore cfr. M. MANTOVANI, L’oggetto tutelato nelle fattispecie penali in materia di religione, in Indice penale, 2006, n. 1, 270-271, il quale propone l’eliminazione del Capo I del Titolo IV e la sussunzione dei fatti di cui all’art. 403 c.p. sotto l’art. 594 c.p., nonché dei fatti di cui all’art. 404 c.p. sotto l’art. 635 c.p.; nello stesso senso, S. LARICCIA, Tutela penale dell’«ex Religione dello Stato», cit., 4319. Similmente an-che G. SALCUNI, Sub art. 402-406 c.p., cit., 877-878, il quale, oltre a ritenere che la tutela del sentimento religioso debba essere assorbita nella tutela dell’onore, afferma che nella stessa deve rientrare anche la tutela della «professione di ateismo militante» (cfr. ivi, 878). Infine cfr. F. RI-
La tutela penalistica della libertà religiosa nell’ordinamento italiano 145
La tesi ora proposta, che trova conferma nell’intervento normativo della l. 24 febbraio 2006, n. 85, si fonda su differenti ordini di motivi che dicono rela-zione, innanzitutto, alla rilevanza costituzionale ed internazionale del bene pro-tetto, quindi all’impossibilità di assimilare l’esercizio positivo della libertà reli-giosa ad una semplice opzione di carattere culturale o ideale, qual è la profes-sione di ateismo (ancorché vissuta non come mera forma di indifferentismo re-ligioso). Infine, in via subordinata, non mancano a favore della conservazione della tutela penalistica dell’esperienza religiosa, esigenze di ordine pubblico, in parte amplificate dai fenomeni immigratori e dal radicamento dell’integralismo religioso. (Quest’ultimo profilo, tuttavia, non sarà approfondito nel presente studio) 64.
3.1. La rilevanza della libertà religiosa nelle fonti costituzionali La libertà religiosa è bene di rango costituzionale contemplato dagli artt. 2,
3, 7, 8, 19, 20 Cost. e «viene considerata la prima, in ordine di tempo, tra le li-bertà civili rivendicate nei confronti del potere politico»
65
. Ritenuta, insieme alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), «strumento fondamentale e
MOLI, Tutela del sentimento religioso, cit., 3349, secondo cui il sentimento religioso non è merite-vole di una tutela specifica da parte dell’ordinamento perché mancherebbe di specificità rispetto alla risposta del non credente. Per un caso di equiparazione di tutela della religione e del-l’“ideologia”, si rinvia alla disciplina tedesca del § 166 StGB, come riformato dalla legge 25 giu-gno 1969, ove è punito chi pubblicamente o mediante la diffusione di scritti vilipende il conte-nuto della confessione religiosa o ideologica di terzi, in modo idoneo da turbare la pace pubblica (per un commento cfr. M. MANTOVANI, L’oggetto tutelato, cit., 260-266). A favore di una siffat-ta soluzione anche F. FINOCCHIARO, Sub art. 19, in G. BRANCA (a cura di), Commentario alla Costituzione. Artt. 13-20, Zanichelli, Bologna, 1977, 298-301: l’Autore ritiene che sia incostitu-zionale punire l’offesa ad un’idea religiosa, ma che sia ammissibile la tutela delle cerimonie, dei fedeli, dei ministri e delle cose destinate al culto, a condizione che sia rispettato un principio di uguaglianza tra i fedeli e i cittadini. Tuttavia la stessa tutela penale dovrebbe essere riservata an-che agli atei: «Se sono delitti di azione pubblica le offese rivolte a chi professa una religione, non v’è motivo, una volta affermato che le norme penali de quibus mirano a tutelare la libertà religiosa, per non riservare lo stesso trattamento agli atei, posto che la libertà garantita dalla norma costituzionale in esame […] è anche libertà di non credere, meritevole dello stesso rispetto riservato alla libertà di credere» (cfr. ivi, 300).
64 Per approfondire si rinvia a M. ROMANO, Principio di laicità dello Stato, cit., 496-499, do-ve l’Autore, pur precisando che «non si tratta […] di tutelare le rappresentazioni di una fede di una data religione, né di privilegiare idealità trascendenti rispetto a visioni agnostiche» (ivi, 499), evidenzia la necessità di conservare il presidio penalistico di tutela della religione, soprattutto in vista di esigenze di pacifica convivenza.
65 Cfr. M. RICCA, Sub art. 19 Cost., in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, Commenta-rio alla Costituzione, Utet Giuridica, Torino, 2006, vol. I, 421.
Carmelo Domenico Leotta 146
privilegiato per lo sviluppo della persona» 66, la stessa assurge nel nostro ordina-mento a diritto inviolabile, irrinunciabile e indisponibile 67, non come mera ap-plicazione di un presunto principio di indifferentismo dello Stato in materia di religione, quanto, piuttosto, come conseguenza di una scelta originaria che ammette la rilevanza nel pubblico della dimensione spirituale dei singoli e delle comunità
68
. Da qui il «riconoscimento che la maturazione della coscienza indivi-duale in materia religiosa (qualunque sia l’approdo conclusivo) costituisce parte di una più generale maturazione spirituale e intellettiva della persona; dimodoché ne-gare, o dimidiare, l’autonomia di tale processo di maturazione equivale a negare, o dimidiare, lo sviluppo della persona in quanto tale» 69.
Per meglio comprendere la portata dell’art. 19 Cost. è necessario richiamare la distinzione, comune tanto al diritto quanto alle altre scienze sociali, tra liber-tà religiosa negativa e positiva 70. Se l’enfasi sulla prima è tipica della prima metà del secolo XX, periodo nel quale si qualifica la libertà religiosa come “diritto pubblico soggettivo” 71 al fine di descrivere lo spazio di autolimitazione dello Sta-to sulla coscienza individuale, la riflessione costituzionalistica più recente sugge-risce di uscire dalla «cittadella dell’idea negativa di libertà» 72, ritenendo che «la libertà, e la libertà religiosa in particolare, non può dissociarsi dalle sue proiezioni pratiche, come tali destinate ad intersecare l’ambito delle relazioni interindividuali e ad occupare un loro spazio sulla scena pubblica» 73.
Alla luce di tali riflessioni, è utile per il penalista avere contezza dell’ampia portata della tutela costituzionale della libertà religiosa: pur movendo dal pre-supposto per cui questa è negata ab imis se manca il previo riconoscimento della facoltà individuale di astensione o di rifiuto dal credere (libertà religiosa negati-va) 74, a ben vedere la stessa si compie pienamente nel triplice facere previsto
66 Cfr. C. CARDIA, voce Religione (libertà di), in Enc. dir., Agg. II, Giuffrè, Milano, 1998, 919. 67 Cfr. ivi, 923. 68 Cfr. ivi, 919. 69 Cfr. ibidem. 70 Nello stesso senso si esprime anche il magistero della Chiesa Cattolica. Cfr. CONCILIO
ECUMENICO VATICANO II, Dichiarazione sulla «libertà religiosa» Dignitatis humanae, 7 dicembre 1965, n. 2: «Il contenuto di una tale libertà [religiosa] è che gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte di singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potestà umana, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza, né sia impedito».
71 Cfr., per tutti, F. RUFFINI, Corso di diritto ecclesiastico italiano. La libertà religiosa come di-ritto pubblico soggettivo, Bocca, Torino, 1924.
72 Cfr. M. RICCA, Sub art. 19 Cost., cit., 427. 73 Cfr. ibidem. 74 Chi scrive condivide l’idea secondo cui l’art. 19 Cost. “copre” anche il diritto dell’ateo di
La tutela penalistica della libertà religiosa nell’ordinamento italiano 147
dall’art. 19 Cost., cioè nella professione del credo, nella diffusione della fede (propaganda) e nell’esercizio del culto (libertà religiosa positiva) 75.
La rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti – per cui è corretto affermare che lo Stato «è garante e responsabile perché la maturazione della coscienza si realizzi nelle migliori condizioni possibili di libertà e di autonomia» 76 – ne rende, altresì, ammissibile la copertura penalistica. Trattasi di una scelta di politica criminale senz’altro compatibile con il dettato della Carta del 1948 77, rispettosa sia dei prin-cìpi di extrema ratio e sussidiarietà sia, più in generale, del principio personalistico che informa l’intero ordinamento penale. Se è vero, infatti, come è stato autore-volmente affermato, che la Costituzione individua le «clausole qualificanti il tipo del nostro ordinamento, […] fissa i limiti di scelta del legislatore penale rispetto ai valori da tutelare e le direttrici di sviluppo del nostro diritto penale in ordine ai valori da conse-guire» 78, la tutela penalistica del sentimento religioso e della libertà religiosa si rivela rimedio coerente all’interno di un ordinamento, qual è il nostro, fondato sulla cen-tralità della persona e volto a proteggere, accanto ai beni della vita quantificabili materialmente, ogni manifestazione meritevole della personalità individuale e dei gruppi, quale estrinsecazione della dignità umana 79.
non credere (cfr. in tal senso, ad esempio, F. GAMBINI, Sub art. 19 Cost., in S. BARTOLE, R. BIN, Commentario alla Costituzione, 2a ed., Cedam, Padova, 2008, 148-149). Tuttavia, la libertà reli-giosa trova il proprio compimento e la propria pienezza nel diritto di professare la fede, di prati-care il culto e di diffondere il credo.
75 Tra la dottrina penalistica, per una critica della libertà religiosa colta nella sua sola dimen-sione negativa, cfr. M. RONCO, Libertà religiosa e diritto penale, cit., 199, dove l’Autore scrive che la libertà religiosa si colloca sullo stesso piano del diritto alla vita.
76 Cfr. C. CARDIA, voce Religione (libertà di), cit., 919-920. Sul tema cfr. anche M. RICCA, Sub art. 19 Cost., cit., 427, che scrive: «A dispetto dell’assunzione in sede normativa di declinazioni esclusivamente negative della libertà religiosa, allo Stato sarebbe impossibile rispettare una politica del tutto astensiva in merito alle manifestazioni del sentimento religioso. La religione ha in sé una valenza pedagogica che ne proietta i contenuti su tutti gli aspetti della vita; essa è tanto contemplazione, quanto azione».
77 Contra cfr. V. MORMANDO, I delitti contro il sentimento religioso, cit., in particolare 92, se-condo cui i «reati in materia religiosa, quindi, non superano il test di compatibilità rispetto ai prin-cipi costituzionali, e i “valori” da essi veicolati risultano eccessivi, in relazione ai valori sovraordinati, come quello di laicità, cosicché non è possibile ravvisare alcun obbligo di una loro tutela penale». A dire dell’Autore la tutela penalistica della religione si pone in dissonanza con la Costituzione perché rivela «la tendenziale attitudine a reprimere forme di manifestazione di dissenso nei confronti delle “istituzioni” latamente intese» (cfr. ivi, 91).
78 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale, Va ed., Cedam, Padova, 2013, XLV. Per una tratta-zione approfondita della rilevanza costituzionale (esplicita o implicita) dei beni degni di prote-zione penale cfr. F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in A. AZZARA, E. EULA (diretto da), N.mo Dig. it., Utet, Torino, 1973, vol. XIX, 7-93, in particolare 16-21 e 93.
79 Per un’autorevole trattazione del principio personalistico nel diritto penale cfr. F. MAN-
TOVANI, Persona (delitti contro la), cit., in particolare 841-849.
Carmelo Domenico Leotta 148
L’opzione ora proposta trova conferma nella giurisprudenza del giudice delle leggi che, da un lato, ben si guarda dal far discendere dal principio di laicità un atteggiamento di indifferenza dello Stato dinnanzi al fenomeno religioso 80, dal-l’altro, ricorrendo a sentenze di accoglimento cosiddette sostitutive (e non inte-ramente caducatorie) relativamente agli artt. 403, 404 e 405 c.p., ha evitato, negli anni, interventi del tutto ablatori sulle principali norme del Libro II, Tito-lo IV, Capo I, c.p., così conservando la tutela penale del bene protetto 81. In un siffatto contesto, si colloca la stessa sentenza di accoglimento parziale del 18 ot-tobre 1995, n. 440, sull’art. 724 c.p., che, anche a costo di un (pur discutibile) pronunciamento estensivo della punibilità della bestemmia, ha evitato l’abroga-
80 Cfr. Corte Cost., 14 febbraio 1973, n. 14, cit., 76, espressamente a proposito della tutela penalistica; Corte Cost., 12 aprile 1989, n. 203, in Giur. Cost., 1989, I, 890-903, con nota di A. SACCOMANNO (cfr. ivi, 903-908) e osservazione di L. MUSSELLI, Insegnamento della religione cat-tolica e tutela della religione, (cfr. ivi, 908-911), pur non affrontando il tema della tutela penali-stica ribadisce, in via generale, che il «principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost., implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale» (cfr. ivi, 899). Più di recente e di nuovo con riferimento alla tutela penalistica, cfr. Corte Cost., 13 no-vembre 2000, n. 508, cit. che, pur abrogando, perché incostituzionale, l’art. 402 c.p. e dunque riducendo il quantum di tutela penalistica, chiarisce: «Sebbene il ripristino dell’uguaglianza violata possa avvenire non solo eliminando del tutto la norma che determina quella violazione ma anche estendendone la portata per ricomprendervi i casi determinati, e sebbene il sopra evocato principio di laicità non implichi indifferenza o astensione dello Stato dinanzi alle religione, ma legittimi interven-ti legislativi a protezione della libertà di religione (sent. n. 203 del 1989), in sede di controllo di co-stituzionalità di norme penali si dà solo la prima possibilità» (cfr. ivi, 3969-3970). In tal modo la Consulta ha dato un segnale inequivocabile nel senso della opportunità della tutela penalistica, necessariamente ispirata ad un regime di parità. In dottrina evidenziano come il nostro Costi-tuente si è ispirato all’atteggiamento «di chi, ritenendo necessaria la distinzione tra l’ambito politi-co-civile e l’ambito religioso, tuttavia non rivendica il proprio disinteresse o il proprio rifiuto dell’uno a svantaggio dell’altro» P. CATALANO-P. SINISCALCO, Laicità tra diritto e religione. Documento in-troduttivo al XIV Seminario, in Index, (Nel nome di Giorgio La Pira), 1995, 462.
81 Nei precedenti della Corte Costituzionale sul Titolo IV del Libro II c.p. si rinviene ripetu-tamente l’affermazione del rilevanza costituzionale della libertà religiosa o del sentimento religio-so nel quadro dei diritti costituzionali. Cfr., oltre a Corte Cost., 14 febbraio 1973, n. 14, cit., 77 secondo cui l’incriminazione della bestemmia, quale strumento di tutela del sentimento religio-so, «non è in contrasto con le norme costituzionali, ma anzi trova in esse fondamento», Corte Cost., 27 giugno 1975, n. 188, cit., 1513, che dichiara non fondata la questione di costituzionalità de-gli artt. 402 e 405 c.p. con riferimento all’art. 21 Cost., posto che la libera manifestazione del pensiero trova un limite ragionevole nel sentimento religioso, «da considerare tra i beni costitu-zionalmente rilevanti». Più di recente, Corte Cost., 10 novembre 1997, n. 329, cit., 3339-3340 chiarisce che, dopo la pronuncia della sentenza della stessa Corte Cost., 18 ottobre 1995, n. 440, «la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l’esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede».
La tutela penalistica della libertà religiosa nell’ordinamento italiano 149
zione integrale della norma censurata, preferendo optare per un accoglimento parziale. Fa ragionevolmente eccezione, in questo quadro, la sentenza 13 no-vembre 2000, n. 508, sull’art. 402 c.p. (vilipendio generico), la cui espunzione dell’ordinamento, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità, ha genera-to una riduzione, ma non un’estinzione di tutela, trattandosi di norma di chiu-sura prevista per la sola confessione cattolica.
Valga, infine, richiamare, accanto ai profili costituzionali interni, la rilevanza che alla libertà religiosa accordano le fonti internazionali e, in particolare, l’art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948; l’art. 18 dei Patti sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966; la Dichiara-zione sull’eliminazione di tutte le forme di intolleranza religiosa, adottata con risoluzione delle Nazioni Unite 36/55 del 25 novembre 1981 e, in ambito eu-ropeo, l’art. 9 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali del 4 novembre 1950, nonché l’art. 10 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000 (Carta di Nizza), successivamente proclamata, il 12 dicembre 2007, a Strasburgo, dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione 82.
3.2. La tutela specifica della libertà religiosa: la distinzione tra il “credere una fede” e il “pensare un’idea”
Se la rilevanza costituzionale del bene protetto giustifica già di per sé la san-
zione penale contro le offese alla libertà religiosa, restano da approfondire le ra-gioni che militano a favore di una sua tutela specifica, senza che essa sia generi-camente assorbita in quella del diritto all’onore o della libera manifestazione del pensiero. Infine, per i motivi di cui si dirà nel prosieguo, neppure è auspicabile l’inclusione della cosiddetta “professione di ateismo” all’interno della tutela pe-nalistica della libertà religiosa 83 : oggetto precipuo di tutela del Titolo IV del Libro II del codice penale è, infatti, la libertà religiosa positiva, in quanto bene dotato di propria specificità e autonomia rispetto al diritto di libera manifesta-zione del pensiero.
Può essere di aiuto, al fine di vagliare il fondamento della tesi ora esposta, prendere le mosse da una più approfondita individuazione degli elementi pecu-liari dell’atto di fede e dell’esperienza cultuale, beni protetti dalle norme incri-minatrici in commento. Investigando la distinzione tra il “credere una fede” e il
82 Per un studio sulle fonti europee cfr. M.L. RUSSO, La libertà religiosa nel sistema di prote-zione europeo dei diritti fondamentali, Edizioni Lussografica, Caltanissetta, 2011.
83 Contra, ad esempio, F. FINOCCHIARO, Sub art. 19, cit., 300.
Carmelo Domenico Leotta 150
“pensare un’idea”, si possono, così, trovare validi suggerimenti nelle indagini della filosofia e della sociologia della religione, là dove tali discipline descrivono i tratti specifici dell’atto religioso o della religione tout court.
Una delle voci più note della filosofia italiana del Novecento definisce, ad esempio, la religione come «credenza in una garanzia soprannaturale offerta all’uomo per la propria salvezza; e le tecniche dirette ad ottenere o conservare que-sta garanzia» 84. Quest’ultima «è soprannaturale nel senso che va al di là dei li-miti cui possono giungere i poteri riconosciuti propri dell’uomo; che agisce o può agire anche là dove tali poteri sono riconosciuti impotenti; e che il suo modo d’azione è misterioso o imperscrutabile» 85. Il credo comporta, allora, il ricono-scimento di un’esistenza altra da sé, tale per cui il «termine religione, preso nel senso più ampio, così da potersi applicare ad ogni religione, dice rapporto di di-pendenza dell’uomo nei confronti di uno o più Esseri superiori, da cui l’uomo sa di dipendere e a cui presta il culto» 86. Più di recente, alla domanda «Che cosa intende colui che pensa che Dio c’è?» 87, un filosofo tedesco vivente – che defini-sce provocatoriamente la credenza su Dio una «diceria», seppur «immortale» – ha offerto una risposta particolarmente chiara e sintetica: «Chi crede che Dio c’è, crede che la situazione contingente, il mondo della nostra esperienza, incluso se stessi, abbia una “profondità”, una dimensione che sfugge all’esperienza, anche a quella introspettiva. Questa dimensione è il luogo dove ciò che è scaturisce dalla sua origine» 88. Il credere comporta l’approccio ad una verità sintetica, non analitica, data dalla «essenziale e necessaria unità tra due predicati, che empiri-camente si presentano spesso separati, e soltanto alcune volte, e in modo contingen-te, insieme: l’unità dei predicati “potente” e “buono”» 89. Credere, poi, even-tualmente in un Dio che sia anche creatore «significa credere che l’essere delle cose e la vita dei mortali non sono né necessari né conseguenza di un universale
84 Cfr. N. ABBAGNANO, voce Religione, in Dizionario di Filosofia, Utet, Torino, 2a ed.,1971, ristampa 1984, 742.
85 Cfr. ivi, 742-743. 86 Cfr. A.M. MOSCHETTI, P. GRASSI, voce Religione, in V. MELCHIORRE (diretta da), Enci-
clopedia filosofica, Bompiani, Milano, 2006, vol. X, 9579, ove gli Autori specificano ulterior-mente che il «fenomeno religioso, pertanto, implica due elementi: uno oggettivo, cioè il complesso del-le relazioni tra la divinità e l’uomo, e l’altro soggettivo, cioè la coscienza della dipendenza e la conse-guente disposizione dell’uomo a rendere alla divinità il culto che le spetta. Questo secondo elemento si suole anche indicare con il termine religiosità».
87 Cfr. R. SPAEMANN, Das unsterbliche Gerücht. Die Frage nach Gott und die Täuschung der Mo-derne, Klett-Cotta, Stuttgart, 2007; trad. it. La diceria immortale. La questione di Dio o l’inganno della modernità, a cura di L. Cappelletti e S. Kritzenberger, Cantagalli, Siena, 2008, 19.
88 Cfr. ibidem. 89 Cfr. ibidem.
La tutela penalistica della libertà religiosa nell’ordinamento italiano 151
principio di inerzia, ma che, in ogni momento, provengono dall’origine» 90. Il contributo della sociologia è parimenti prezioso. Magistrale ancora oggi è
la definizione (non sospettabile di “religiosità”) di Émile Durkheim (1858-1917). Questi, pur ritenendo che caratteristica della religione non sia tanto la presenza di una divinità – il sociologo francese è convinto, piuttosto, che il fe-nomeno religioso sia la trasfigurazione della società stessa e che gli interessi reli-giosi siano la forma simbolica degli interessi sociali e morali – afferma che la «religione è un sistema solidale di credenze e di pratiche relative a delle entità sacre, cioè separate, interdette; credenze e pratiche che uniscono in una medesima comuni-tà morale, chiamata chiesa, tutti gli aderenti» 91. La definizione ora riportata (pur, per altri aspetti, minimalista) mette in luce, ai nostri fini, almeno tre aspetti fondamentali del fatto religioso: innanzitutto la circostanza che la religione sia basata sulla dialettica sacro/profano la differenzia radicalmente da un sistema morale che si fonda, precipuamente, sul binomio bene/male 92. Stante tale fon-damentale distinzione, si comprende, quale ulteriore profilo, la centralità del culto, modo per rapportarsi tra sacro e profano o per consentire la metamorfosi dal profano al sacro 93. Il terzo carattere è, infine, per Durkheim, l’essere “chie-sa”, «società i cui membri sono uniti per il fatto di rappresentarsi allo stesso modo il mondo sacro e i suoi rapporti con il mondo profano, e di tradurre queste rappresen-tazioni comuni in pratiche identiche» 94.
Se al contributo di Durkheim si potrebbe eccepire un carattere di vetustà, ba-sti dire che, nell’odierno contesto secolarizzato, il concetto di religione appare tut-tora irrinunciabile financo ai sociologi di marca funzionalista-radicale perché è l’unico in grado di esprimere efficacemente l’idea del soprannaturale, il rapporto trascendenza/immanenza, la non esaustività e la contingenza del mondo 95.
Non potendo indugiare oltre su profili che in altri ambiti del sapere trovano la loro “collocazione naturale”, le definizioni del fenomeno religioso qui propo-
90 Cfr. ivi, 20. 91 Cfr. É. DURKHEIM, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Alan, Paris, 1912; trad. it. Le
forme elementari della vita religiosa, a cura di M. Rosati, Meltemi, Roma, 2005, 97. 92 Cfr. ivi, 86-89. Per Durkheim, «la cosa sacra è, per definizione, quella che il profano non de-
ve, non può impunemente toccare» (ivi, 90). 93 Cfr. ivi, 89-92. Anche la magia ricorre ai riti, ma per profanare le cose religiose (cfr. ivi,
93), per questo la religione è generalmente ostile alla magia. 94 Ivi, 94. 95 Cfr. S. BELARDINELLI, L’altro Illuminismo. Politica, religione e funzione pubblica della veri-
tà, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2009, 68-71, dove l’Autore spiega come, persino per il pensie-ro funzionalista radicale (il riferimento è in particolare a Niklas Luhmann), la «religione manife-sta […] la non esaustività e la contingenza del mondo, rappresenta l’irrappresentabile, il trascenden-te, attraverso determinate “formule di contingenza”, la più importante delle quali è Dio».
Carmelo Domenico Leotta 152
ste già possono suggerire, sul piano giuridico, anche al di fuori della sfera pret-tamente penalistica, i motivi di una tutela specifica dell’esperienza religiosa, la cui ragion d’essere riposa sui profili altamente caratterizzati e caratterizzanti del-la stessa. Questi sono il riconoscimento di una dimensione di dipendenza dell’uomo rispetto all’Altro, la possibilità per l’uomo o per la natura di avere una qualche forma di rapporto con il sacro e, infine, l’approdo ad una prospet-tiva soteriologica/escatologica 96. Sul piano dell’agire, poi, ciò che rileva princi-palmente è l’esercizio del culto (più che il rispetto della morale), come mezzo di contatto tra l’uomo e il soprannaturale.
Se i caratteri di cui si è ora detto già consentono, in via generale, di cogliere, all’interno di una data realtà sociale, la quidditas del fatto religioso rispetto ai fenomeni di manifestazione del pensiero, ulteriori argomenti a sostegno della tutela penale specifica della libertà religiosa positiva si possono ricavare valutan-do, alla luce del modello personale/relazionale di descrizione del reato, la pecu-liarità dell’offesa di cui solo il credente (e non anche il libero “pensatore”) può essere vittima. Adottando il paradigma teorico-descrittivo ora richiamato – se-condo il quale «il nucleo del reato non sta nel disvalore della condotta, unilateral-mente considerata, né nel disvalore dell’evento, pure unilateralmente inteso, bensì nella negazione [da parte del reo] del valore della relazionalità» 97 – si consideri come l’offesa recata all’uomo nel rapporto che questi ha con la divinità, o anche solo che con essa presume di avere, danneggi gravemente, e talora in via defini-tiva, la relazione intersoggettiva tra i membri di una comunità umana. Infatti, la relazione con l’Altro viene intesa dal credente come relazione primaria, fondati-va di sé, della propria identità individuale e della successiva esperienza sociale con l’“uguale” e con il “diverso”. Non stupisce, pertanto, che il credente – così come il pensiero religioso ebraico coglie mille anni prima della nascita del Cri-stianesimo 98 – percepisca l’offesa alla religione non solo come un male rivolto ad un’entità degna di venerazione (vilipendio) o come un impedimento al rap-porto con il mistero (turbatio sacrorum), ma anche come atto offensivo rivolto a sé, in quanto soggetto che tale entità venera.
Tutto ciò, a ben vedere, non avviene se l’offesa è rivolta ad un’idea o ad un pensiero, con cui la vittima vilipesa non instaura alcuna relazione, per quanto
96 Cfr. in tema, il recente saggio di M. RIESEBRODT, The promise of salvation: A Theory of Re-
ligion, The University of Chicago Press, Chicago, 2010, dove l’Autore ritiene peraltro l’insuperabilità del concetto stesso di religione.
97 Cfr. M. RONCO, Commentario sistematico al Codice penale, vol. II, tomo I, Il reato, Zani-chelli, Bologna, 2011, 74-75.
98 Cfr. Sal 69, 10: «gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me». Il salmo è attribuito al re Davide, vissuto nell’XI sec. a.C.
La tutela penalistica della libertà religiosa nell’ordinamento italiano 153
un’idea possa informare le proprie scelte morali ed esistenziali: l’idea si pensa, si propaganda, per un’idea si può morire o far morire, ma l’idea non si colloca propriamente nel mondo dell’essere né le si rende il culto, al contrario di quan-to accade nell’esperienza religiosa. Per questo, colui che offende la libertà reli-giosa e il sentimento religioso altrui agisce in modo totalmente differente rispet-to a chi “oltraggia un pensiero”: offendendo l’Altro, si ferisce ben più profon-damente il valore della relazionalità umana perché si aggredisce l’intimità esi-stenziale della persona-credente, in sé irriducibile al senso dell’onore o alla liber-tà morale.
Sulla base delle riflessioni fin qui svolte, le quali confermano la legittimità e la meritevolezza della tutela penale della libertà religiosa (come pure del senti-mento religioso, se si preferisce ritenere autonomi i due concetti 99), pare a chi scrive riduttivo, a sostegno di posizioni abrogazioniste, lamentare un’asserita ca-renza di dannosità sociale degli atti incriminati 100. A prescindere dal merito di una siffatta premessa – oggi sembra, piuttosto, che il tema religioso abbia forti implicazioni in tema di convivenza sociale – la scelta del legislatore deve, co-munque, orientarsi, in subiecta materia, considerando in primis la natura dei beni coinvolti: personalissimi, indisponibili, irrinunciabili e degni di specifica protezione perché fondati sullo stesso principio di dignità personale.
Parimenti lascia perplessi la pretesa di assimilare alla tutela penalistica della religione quella della professione di ateismo sulla base del presupposto, in sé corretto, secondo cui sotto l’ombrello dell’art. 19 Cost. vi è lo spazio per qualsi-voglia atteggiamento dell’uomo di fronte al credo 101, principio quest’ultimo ri-conosciuto anche da Corte Cost., 2 ottobre 1979, n. 117 102, con superamento
99 Cfr. nota 1. 100 Così, ad esempio, G. FIANDACA, Laicità nel diritto penale, cit., 183-184. 101 Cfr. P. SIRACUSANO, Pluralismo e secolarizzazione, cit., 637, il quale ritiene che l’unica
possibile prospettiva di tutela nello Stato laico sia «quella che si fonda su una considerazione pari-taria di tutte le opzioni individuali in materia di fede, quindi anche delle opzioni agnostiche ed atee». Il giudizio finale dell’Autore è comunque quello della inettitudine del precetto penale nella gestione dei conflitti religioso-identitari. G. SALCUNI, Sub art. 402-406 c.p., cit., 878, partendo dal presupposto secondo cui il bene da tutelare non è la confessione religiosa, ma il singolo cre-dente, conclude nel senso che «la tutela penale del sentimento religioso dovrebbe essere estesa a tutti quei credi che non sono assimilabili alle religioni in senso tradizionale», rendendosi strumento per «tutelare tutti i convincimenti dei singoli in merito alla propria fede, oppure, alla propria professione di ateismo militante».
102 Cfr. Corte Cost., 2 ottobre 1979, n. 117, in Giur. Cost., 1979, 816-827 con un’os-servazione di M. BRANCA, In tema di illegittimità conseguenziale (ivi, 822-826). La q.l.c. viene sollevata dal Pretore di Torino con riferimento all’art. 366, 2° co., c.p. che sanziona, tra l’altro, il rifiuto del teste di prestare giuramento. Nel caso di specie, il teste, poi imputato, aveva rifiutato di prestare giuramento in un processo civile, stante la formula allora vigente «davanti a Dio» (art.
Carmelo Domenico Leotta 154
della precedente giurisprudenza 103. Invero, come autorevolmente si è detto, «la piena ricomprensione dell’opzione ateistica (e delle altre opzioni in materia religio-sa) nella libertà di coscienza non implica un’artificiosa assimilazione tra ateismo e religione» 104, se solo si considera che «per la propria insopprimibile natura, l’ateismo, e con esso l’indifferentismo e l’agnosticismo, non compiono riti, e non si strutturano in confessioni ateistiche (o di altro genere), dal momento che ad essi manca quell’adesione primaria ad una dimensione trascendente che costituisce il presupposto della fenomenologia confessionale» 105.
La considerazione delle differenze che intercorrono tra il fatto religioso e l’esercizio del libero pensiero rendono, pertanto, ragione delle posizioni della dottrina, di ieri come di oggi, secondo cui «la realtà sociale “confessione religiosa” postula un minimo di riti, di simboli, di ministri, e relative esigenze di rispetto, di protezione da offese avversarie, che nessuna tendenza o scuola filosofica postula. Per queste è sufficiente la libertà di espressione, quella di propaganda e soprattutto la li-bertà di stampa e d’insegnamento; invece le confessioni religiose hanno bisogno di altre protezioni» 106, tra cui devono includersi quelle specifiche dettate dalla legge penale. Il giudizio può ritenersi immutato anche dopo la riforma dei Patti late-ranensi, posto che «la normativa costituzionale italiana pone su un piano di totale parità le opinioni religiose e le opinioni non religiose […] ma non sancisce l’omologazione delle organizzazioni filosofiche alle confessioni religiose» 107.
Anche nell’ambito penalistico, una soluzione assimilatrice che tuteli indiffe-rentemente fenomeno religioso, professione di ateismo (militante e non) e qual-
251, 2° co., c.p.c.). Tralasciando in questa sede i profili prettamente tecnici sulla dichiarazione di incostituzionalità cosiddetta conseguenziale, la Consulta dichiara l’incostituzionalità dell’art. 251, 2° co., c.p.c. nella parte in cui dopo le parole «il giudice istruttore ammonisce il testimone sul-la importanza religiosa» e dopo le parole «consapevole della responsabilità che con il giuramento as-sumete davanti a Dio», non è contenuto l’inciso «se credente».
103 Cfr. Corte Cost., 6 luglio 1960, n. 58, in Giur. Cost., 1960, 752-758, con cui la Corte riget-ta la questione di incostituzionalità dell’art. 449 c.p.p. sollevata con riferimento all’art. 21 Cost.; cfr. anche Corte Cost., 25 maggio 1963, n. 85, in Giur. Cost., 1963, 704-708, con cui la Corte ri-getta la questione di incostituzionalità sull’art. 251 c.p.c., non ravvisando contrasto con gli artt. 8, 19, 21 Cost.
104 Cfr. C. CARDIA, voce Religione (libertà di), cit., 921. 105 Cfr. ibidem. Anche M. RICCA, Sub art. 19 Cost., cit., 432, ritiene che «credere in una divi-
nità e ragionare sulla divinità sono atteggiamenti cognitivi e psicologici profondamente differenti». Ciò non esclude che anche l’ateismo rientri nella tutela di cui all’art. 19 Cost. L’Autore, tuttavia, non affronta espressamente il problema della tutela penalistica del sentimento religioso.
106 Cfr. A.C. JEMOLO, Lezioni di diritto ecclesiastico, 3a ed., rist. integrata, Giuffrè, Milano, 1961, 123.
107 Cfr. C. CARDIA, Princìpi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana, 3a
ed., Giappichelli, Torino, 2010, 137.
La tutela penalistica della libertà religiosa nell’ordinamento italiano 155
sivoglia altra posizione ideologica, come avviene nel modello tedesco (§ 166 StGB), non terrebbe in adeguato conto la differenza fondamentale che intercor-re tra la risposta di fede e la risposta ateistica alla domanda, pur comune, dell’esistenza di Dio e non sarebbe rispettosa, a parere di chi scrive, né degli atei, ai quali sarebbe attribuito un atteggiamento lato sensu “religioso” del crede-re senza professare la fede né dei fedeli, che vedrebbero ridotto il proprio credo ad una forma di manifestazione del pensiero, obliterando del tutto la dimensio-ne del culto 108.
* * *
In chiusura, pare opportuno ribadire che la tutela offerta dalle norme codici-
stiche e dalle leggi speciali di cui si è fatta fin qui menzione è volta precipua-mente a tutelare la libertà religiosa positiva, vale a dire la libertà del credente di credere, di esercitare il culto, da solo e con altri, in privato e in pubblico, non-ché il diritto di non essere vilipeso o impedito nel godimento di tale libertà.
All’interno di un siffatto quadro, il pari trattamento sotto il profilo della pe-na delle offese recate a qualsivoglia confessione, si fonda sulla pari dignità di ogni uomo, essere personale e razionale, potenzialmente sempre capace di aprir-si, con un atto di libertà, verso il mistero e il divino. Affermare che ogni mani-festazione di libertà religiosa, rispettosa dei limiti costituzionali del buon co-stume (art. 19), debba essere tutelata in egual misura dal precetto penale non comporta in alcun modo derive indifferentiste dinnanzi alle diverse esperienze religiose che connotano il pluralismo contemporaneo; egual tutela non signifi-ca, infatti, negazione del ruolo storico che una religione (e non altre) può aver assunto per lo sviluppo sociale, intellettuale, artistico ed economico di uno Sta-to-comunità. Neppure significa che, all’interno di determinati spazi, allo Stato-istituzione non sia consentita «la possibilità di differenziazioni legittime nel trat-tamento delle confessioni e nella disciplina di determinate situazioni. […] si danno [infatti] ipotesi nelle quali acquista un residuo rilievo pratico il consenso, maggiore o minore, che una confessione religiosa può vantare rispetto ad altre» 109. All’intelli-
108 Ritiene M. ROMANO, Principio di laicità dello Stato, cit., 497 che il mancato inserimento, anche a seguito della novella del 2006, del riferimento al pensiero a-religioso ed agnostico tra gli oggetti di tutela delle norme penali a protezione della religione non comporti «alcuna discrimi-nazione ideologica». Per uno studio sull’art. 21 Cost. cfr. l’ampio lavoro di A. PACE, M. MANET-
TI, La libertà di manifestazione del proprio pensiero, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO, Commentario alla Costituzione, Zanichelli, Bologna, 2006.
109 Cfr. C. CARDIA, voce Religione, cit., 925. L’autore si riferisce, ad esempio, ai servizi di as-sistenza spirituale nelle strutture carcerarie, ospedaliere e militari. Nello stesso senso cfr. P.F. GROSSI, Note introduttive per uno studio su tolleranza e diritto di libertà religiosa, in Il diritto costi-
Carmelo Domenico Leotta 156
genza politica del legislatore spetta individuare tali ipotesi, nel rispetto del prin-cipio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.
Questa, infine, la ragione per cui, se la disciplina originaria del codice Rocco meritava senz’altro di essere superata, perché traduceva more geometrico, attra-verso una diversa quantificazione della pena, la rilevanza sociale di un credo ri-spetto agli altri, neppure è auspicabile un ritorno al modello culturale del codice Zanardelli che, come chiaramente appariva dalle parole di Tommaso Villa (1832-1915), allora vicepresidente della Camera dei deputati, invocando il no-me altisonante della libertà dei culti, intendeva circoscrivere la tutela penale del-la religione all’interno della sfera privata indivuduale, affinché la stessa non si ergesse a potere concorrenziale allo Stato 110.
Diversamente il riconoscimento da parte dello Stato della religione per quel-lo che essa è – fenomeno individuale e sociale, privato e pubblico, che pone a proprio fondamento il senso della divinità, della trascendenza e della chiesa – non solo è compatibile con il carattere laico delle istituzioni, ma, come di re-cente si è detto, assurge a funzione essenziale della laicità stessa, scongiurando il rischio di sostituire il credo con la religione civile e di ridurre le chiese in più o meno efficienti agenzie di solidarietà sociale 111.
tuzionale tra princìpi di libertà e istituzioni, 2a ed., Cedam, Padova, 2008, 112 e F. VARI, Note su religione e sfera pubblica tra Costituzione italiana e Convenzione europea “dei diritti dell’uomo”, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica, 12-3-2012, 6-7: se i poteri pubblici li-vellassero il trattamento di tutte le confessioni religiose, in contrasto con la realtà sociale, assu-merebbe in realtà un atteggiamento confessionale.
110 Dichiarava il Villa: «Lo Stato e quindi il legislatore non può immaginare ed ammettere reati di religione in genere, o contro una religione determinata, senza riconoscere nella religione stessa, e nelle organizzazioni che ne derivano, un ente giuridico il quale potrebbe ben anco rivestire carattere politico a suo danno» (Relazione alla Camera dei Deputati, 141, cit. in Progetto definitivo di un nuovo codice penale, cit., 188).
111 Cfr. S. BELARDINELLI, L’altro Illuminismo, cit., 68-71.