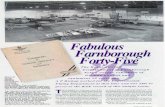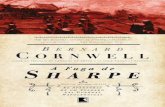1 ewerton de freitas ignácio nostalgia, fuga, prisão: campo e ...
Tolstoj e la fuga dal romanzo
Transcript of Tolstoj e la fuga dal romanzo
F. D'INnNo, T. EecmroN, P Guuons, F. Gnrconr,
P Jounnr, G. Mezzom, J. M. Pozunro YveNcos,
D. RrsnccHNt, J. Wrnrnnnnrn
Il bene e il maleI etica nel roman zo moderno
a cura di Peoro TonroNnsr
l
I
I
l
I
BUIZONI EDITORE
"Riguardo aAnna Karenina, vi assicuro che quest'opera è perme una schiÎezza che non esiste più, e mi fa solo rabbia che vi siano
persone a cui essa possa essere utile a qualcosa,, scrive Tolstoj in unai.tt.ru del maggio 1881, a quattro anni dall'uscita del romanzo t' Èuna delle manifestazioni di intolleranza verso la sua opera che Tol-
stoi sembra vivere dopo la composizione di ogni suo romanzo. Lin-tera opera di Tolstoj è infatti scandita da una serie di fughe progres-
sive dal rom nzo, che si ripetono ciclicamente alla fine degli anni'50, '60 e '70 dell'800 secondo uno sviluppo costante. Nascono dalprocesso stesso della composizione romanzesca, e si manifestano inun awicinamento ai modelli della cultura popolare, in un impegnonell'attività pedagogica, in un intensificarsi del lavoro pubblicistico.
Gli anni '50 dell'800 sono per Tolstoj soprattutto un periodo disperimentazione della forma romanzesca. Infanzia, Adolescenza eGiouineza, La uita di un proprietario terriero russo e le altre pro-
se brevi del periodo fanno parte di più ampi progetti che si esauri-
scono solo con la composizione del primo îomaÍ:zo compiuto di Tol-
stoj, Felicitàfamiliare (1859). Dall'insoddisfazione per la sua opera -.una porcheria non solo dal punto di vista letterario, ma anche uma-
n9' - ha innio la sua prima fuga dal romaÍrzo, con I'abbandono del
mondo letterario pietroburghese, I'impegno con i figli dei contadinidella sua tenuta, il lavoro alla scuola e al giornale diJasnaiaPolianaz'Solo nel 1863 Tolstoj torna al romaÍtzo con quell'ampio progetto che
da I decabrísti lo porterà alla pubblicazione di Guerra e pace (1865-
1869). Ma anche questa volta, dopo l'uscita dell'opera, l'allontana-
1 lettera di L. N. Tolstoi a V V Stasov del 1.5'1881, in L' N. Torsrol, Polnoe so'
branie soèinenij lRaccolta completa delle operel, a cura di V G. Òertkov, Moskva
1953, t. 63, p. 6L.In seguito, ove non esistano traduzioni in italiano dei brani citati,
farò riferimento a questa edizione in 90 volumi dell'opera di Tolstoi con l'abbrevia-
zione Pss.2 Letrera a V P Botkin del3.5.1859, in L. N. To$roJ, Pss, t. 60, p. 296.
175
l
DaunNo RnsnccHINI
mento dal romanzo è violento. Tolstoj abbandona non solo il mondoletterario, malavita pubblica. Si rinchiude per alcuni anni nella tenu-ta di Jasnaja Poljana, studia il greco, lavora all'Abbecedanb. Solo nel1872 torna a un progetto romanzesco, Ma il rifiuto più categorico eviolento del romanzo si realnza proprio durante la composizione diAnna Karenina (1875-7877).Dalla fine degli anni'7} fino alla fine de-gli anni '90 Tolstoj non pubblicherà più alcun romanzo. Nonostante ilsuccesso della sua opera, le riflessioni filosofiche e religiose sembra-no portarlo verso altre mete. Solo nel 1BB9 inizierà, a lavorare a Re-
surrezione (1899), I'ultimo romanzo,-che porterà avanti per un de-cennio tra dubbi e inceftezze proprio sulla sua forma costitutiva.
Da alcuni annila critica hainiziato nuovarnente a prestare atten-zione agli scritti filosofico-religiosi di Tolstoj della fine degli anni '70 3.
I,e riflessioni che hanno portato alla "conversione" tolstojanadellST9sono state in genere considerate indipendenti dalla sua produzioneletterana, e incapaci di gettar luce sul suo sviluppo artistico. Ritengo,al contrario, che questi scritti siano fondamentali per far emergere unaconcezione tolstojana del romanzo rimasta a lungo implicita e, per al-cuni aspetti, poco chiara allo stesso autore. È opportuno chiedersi:perché dopo la fine di Anna l(arsnína Tolstoj abbandona così a lun-go il romanzo? Per quali ragioni, nonostante il grande successo dell'o-pera,la forma romanzesca non viene più consideratadaTolstoj in gra-do di esprimere le sue riflessioni filosofiche? E più in generale perchéTolstoj mostra un atteggiamento così incostante verso il romanzo?
Iettere a Stracbou
1. Per gettar luce su questi interrogativi occorre concentrarel'attenzione sulla corrispondenza che Tolstoj intrattiene con I'amicoNikolaj Strachov tra il febbraio del 1875 e I'aprile del t876. Le sue let-tere costituiscono un importante momento di chiarificazione dei
3 Cfr., oltre allo studio di N. rùlErserrN, L'éuolution religieuse de Tolstoi:, Librai-rie des Cinq Continents, Paris 1960, R. GusrelsoN, Leo Tolstoy, Resident and Snan-ger A StudJ) in Fiction and Tbeologt, Princeton University Press, Princeton 1986, P
C. Bonr, Tolstoj oltre la letteratura, Edizioni cultura della pace, Firenze 1991 e, sem-pre dello stesso autore, ilbellavoro I'ahro Toktoj,Il Mulino, Bologna 1995.
176
TorsroJ E LA zucA DAL Rolv
presupposti filosofici e religiosi soÚesi al suo modo di sentire la vi-
ta. In esse non vi SonO intuizioni nuove - tutto sembra ritornare ci-
clicamente nell'opera di Tolstoj -, m vi sono i segni di una nuova
consapevolezzaedi una più chiara esplicitazione delle sue idee. ven-
gono scritte nel momento in cui - secondo quanto Tolstoj afferma in
la Confessione - in1g:iano a chiarirsi in lui le ragioni della crisi del
suo sisiema di valori, iniziata dopo la fine di Guerra e pace, che lo
porterà alla *conversione' del 1879 a. Ma vengono scritte anche nel
pieno della composizione diAnna Karenina'Sin dalle prime lerrere del febbraio 1,875 emerge chiaramente
come queste riflessioni filosofiche ostacolino la stesura del romanzo.
A metà febbraio Tolstoj riceve dall'amico A. A. Fet una lettera entu-
siastica sui primi capitoli di Anna Karenina:
Che maestria nell'introdurre i personaggi, che meraviglia la descrizio-
ne del ballo. E che magnifica invenzione I'intreccio! Il personaggio levin è
Iev Nikolaevic, I'uomo non lo scrittore, ma in lui c'è anche V Perfil'ev' e Su-
chotin con il suo raziocinio 5.
Eppure Tolstoj è del tutto insoddisfatto della sua opera' In que-
sta fase il romanzo era già, impostato, l'idea principale - un romanzo
<su una donna perduta> - chiara, abbozzato il profilo generale, ma
bisognava ancorastenderne una buona parte6. Eppure già dalla fine
di luglio del 1874 Tolstoj ^werte
che l'opera cominciava a diventar-
gli *odiosa e ripugnante', e adesso comunica a Fet che gli era di-
i.ntuta odel tutto indifferente' 7. Alla fine di febbraio scrive all'amico
N. N. Strachov che gli aveva corretto le bozze:
a L.Tonro;, La confessione, a cvÍa di G. Pacini, SE, Milano L995, pp' 55-80'5 t€rrera di A. A. neti f. N. Tolsto, de120.2.1875, in L. N. Torsrol , Pss,t.62, p. t49.6 cfr. il diario della moglie di Tolstoi, Sof 'fa AndreevnaTolstaia, de|24.2.1870
.Ieri mi ha detto che gli è venuta in mente I'idea di un tipo di donna sposata, del-
l,alta società, una donna perduta. Ha detto che il suo compito è quello di rendere
questa donna degna di cómpassione, non colpevole". Dneuniki S. A Tolstoi, 1860-
iSOl lOiuio di S. A. Tolstaial, Moskva 1928, p.32. Sulle tappe di evoluzione della
st.rurà del romanzo cfr. L. N. ToIsroJ, Pss, t. 20, pp' 577-643'7 lctteraa P D. Golochvastov del 29.7 't874, in L' N' Torsrol, Pss, t' 62, p' 103;
Lettera a A. A. Fet del22.2.1875, in Pss, t. 62, p' 149'
DAMTANo RnenccHrNrr
Ci sono molte parti deboli. Ve le nomino: I'arrivo di Anna a casa e la..r.fta a casa. Ia discussione in casa Scerbackij dopo il dottore fino alla spie-gazione tra le due sorelle. Il salotto di Pietroburgo, e altre 8.
Nel giugno il lavoro sul romanzo si interrompe del tutto. La co-noscenza diretta con il filosofo Vladimir Solov'ev, che va a trovarlo a
JasnajaPoljana, stimola una riflessione filosofica e religiosa che diven-tera per Tolstoj sempre più urgente, rendendo sempre più difficile lacomposizione del romaÍrzo. Ad agosto Tolstoj scrive a Strachov:
Non ho preso la penna in mano per due mesi e sono molto soddisfattodella mia estate. Adesso mi metto alavorare alla mia noiosa, volgare Anna I(a-renina, e prego solo Iddio che mi dralaforza di liberarmene prima possibile.Voglio dar spazio - ho molto bisogno di tempo - non tanto ai miei lavori pe-dagogici, ma ad altn lavori che adesso mi prendono di più. [...] Laver cono-sciuto il filosofo Solov'evmi hadato nuovi stimoli, ha smosso in me i miei die-viti" filosofici, ha rafrorzato e chiarito quei pensieri che mi sono più necessariper affrontare il resto della mia vrta e la morte, che mi sono di conforto e.
Da questo momento la riflessione filosofica prende il soprav-vento. E in questo periodo che Tolstoj inizia ad uscire da quellaprofonda crisi iniziata dopo la fine di Guerra e pace. Come scrive inIa Confessione,la sua vita si era fetmata, aveva awertito un baratro,l'impressione di un'improwisa manc nza di senso della sua esisten-zA.: <<La mia vita ha un qualche senso che non verrà distrutto dallamorte che mi attende ineluttabile?" 10. Tirtto gli era apparso privo disenso: la Îamiglia, la sua proprietà, lo scrivere. La stesura di AnnaI(arenina si era interrotta bruscamente. E ora iniziava a trovare al-cune risposte nella filosofia, prima grazie alla letturz di Scho-penhauer, poi grazie a Vladimir Solov'ev11.
8 Lettera a N. N. Strachov del 23-24.2.1875, in L. N. Torsrol, Pss, t. 62 p. 150.Tolstoi intende i capp. 22-23 della prima parte; i capp. I-2 della seconda parte e ilcap. 6 della seconda parte dell'edizione definitiva. Questi capitoli in seguito verran-no più volte modificati.
e lrttera a N. N. Strachov del 25.8.1875, in L. N. Torsro;, pss, t. 62, p. 197.10 L. N. Torsro.J, La confessione, cit., p. 34.11 Sulf influenza di Schopenhauer su Tolstol cfr. B. ElcnnNneuu, ToktoJ i Sbpen-
gauer, in "Uteraturnf sovremennik,, n. l1 (1935); S. Mcl,aucHuN, Sorne Aspects of
178
TorsroJ E tÀ. FUGA DAL RoMANzo
In una lunga lettera a strachov del novembte L875 Tolstoj con-
fida all,amico la sua fiducia nella filosofia. Lavera conoscenza - scri-
ve - non è nella scienza, ma nella filosofia. Solo la filosofia, e la reli-
gione come forma superiore di conoscenza fìlosofica, coglie lavitain|,uttala sua complessità, perché la coglie nella sua interezza, senza
procedere per dèfinizioni e dMsioni progressive come fala scienza.
Glistessioggettidicuisioccupalafilosofia_|avita,|,anima,|avo-lontà, I'intelletto - non possono essere sezionati, divisi in parti. I fenomeni
che sono oggetto delle scienze, sono fenomeni da noi conoscibili nel mon-
do esterno, indirettamente, mentre quelli che sono oggetto della filosofia li
conosciamo nel nostro mondo interiore direttamente, e li possiamo ossef-
vare nel mondo esterno solo perché li conosciamo dal mondo interiore, e
questi fenomeni possono essere oggetto della filosofìa solo se sono presi
nella loro interezza, owero come noi li conosciamo direttamente 12.
l'avita,|,aníma, l'intelletto non possono essere divisi in parte,
sezionati, ma solo colti nella loro interezz grazie a un sentimento
interiore. Da ciò Tolstoj deduce che I'espressione di una conoscen-
za filosofica della vita non può awenire secondo una concatenazio-
ne logica di concetti, ma in base a un principio di armonia. Laveta
conoscenza <non si raggiunge mediante deduzioni logiche, ma solo
mediante I'unione armonica in un unico insieme di tutti quei con-
cetti non logici, si raggiunge in modo istantaneo, senza deduzioni e
dimostrazioni' ra. In ùta t.tt.t" a Strachov della fine di gennaio 1876
Tolstoj prosegue la discussione con una deflnizione della vita che ri-
pete più volte:
Definisco la vita come il distacco di una parte che si ama da tutto il re-
sto [. . . ] . Senza questa definizione della vita si atriva a quel circolo per cui
I'uomo diventa Dio, il centfo di tutto. Lavita è il distacco di una parte dal
resto. I-uomo conosce solo ciò Che è vivo. Per questo per chi vive è com-
prensibile solo ciò che è vivo, simile a sé' firtto ciò che gli appate morto è
Tolstoy,slntellectualDeuelopment:Tolstoyandkbopenbauer,inucalifofniaSlavicStudies', u,1970, PP. L87-245.
t2 lrettera a N. N. srrachov del 30.11.1875, in L. N. Torsrol, Pss, t. 62, p. 223.
13 Ivi, P.224.
179
DAMTANo RrsncclrNr
vivo, ma incomprensibile. È proprio questo I'ineffabile, e non solo ciò concui I'uomo è a contatto, ma anche tutto ciò che lo circonda 14.
Tloviamo qui le stesse idee che erano emerse a tratti nelleopere precedenti di Tolstoj, da Infanzia a Guerra e pace, che era-no alla base delle impressioni del principe Andrej sul punto di mor-te, o del sentimento dellavita di Platon Y:arataev. Ma il fatto di riu-scire ad inserirle in un quadro di comprensione più ampio e coe-rente, di ritrovade nella vera filosofia, o nel semplice, irrazionalesentimento della vita dell'"autentico popolo lavoratore,, come scri-ve in Confessione, danno a Tolstoj una nuova fiducia, una nuova fe-de 15. Listintivo desiderio di vivere del popolo, di milioni di uominisenza nome, danno improwisamente un senso alla sua vita. È inquesto momento che Tolstoj ponel'io uiuo come fondamento del-la sua nuova fede, la base di una sapienza che non è precedente al-
la vita, ma è la vita stessa: "Conoscere Dio e vivere è la stessa cosa.Dio è la vit^,,r6.
Tolstoj capisce spesso in modo nuovo quello che aveva già ca-pito: questa concezione della vita è infatti speculare alla concezio-ne della storia che egli aveva sviluppato negli anni Sessanta inGuerra e pace. Lì era la storia ad essere un insieme indivisibile diconcause il cui senso si rivelava non a chi crede di indirizzarla, maa chi ne è partecipe. Qui la vita si presenta come parte di un tutto,il cui significato si chiarisce a chi agisce, non a chi prova ad analiz-zarla. Ma ogni volta che questa stessa idea gli appare in una luce di-versa è per lui una scoperta del tutto nuova, capace di dargli nuo-va energia. Solo allora - siamo a fine gennaio del 7876 - la com-posizione del romanzo riprende in modo deciso. Lo stretto legametra queste riflessioni e la ripresa della composizione diAnna Kare-nina è chiarissimo nella lettera a Strachov di metà febbraio. Tolstojscrive:
1a lvi, p.244,15 L. N. Torsroy, La confessione, cit., p. 56.16 L. N. TorsroJ , La confessione, ctt., p.78 con alcune modifiche. Su questo cfr.
P C. Bonr, L'altro Tolstoj, cit., pp. 35-41 e N. Wusenm, L'éuolution réligieuse de Tol-
stoî, cit., pp.84-147.
1
180
TorsroJ E I-a FUGA DAL RoMANZo
Tutta questa conoscenza in genere viene divisa nei concetti di vita, or-
ganismo, forza, unità, moltitudine, tempo, spazio, ma è tutto racchiuso inuna cosa sola: io uiuo, e ciò in cui consiste questa conoscenza 1) non può
essere conosciuto con la ragione 2) senza questa conoscenza non può esi-
stere nessun concetto logico [...].
Sono molto occupato con la Karenina. ll primo libro è arido, e direinon riuscito, ma adesso mando lebozze del secondo libro e questo so che
è buono 17.
2. Il chiarimento dei presupposti filosofìci su cui si regge la sua
vita non porta solo allanpresa del lavoro suAnna l(arenina, e a una
serie di nuovi imperativi etici che si chiariranno sempre più negli
scritti degli anni Ottanta, ma anche a uîa qiù esplicita presa di co-
Scienza della sua concezione del romaruo. È I Suo stesso processo
creativo a venir illuminato dal suo chiarimento. Lo vediamo in una
lettera a Strachov dell'aprile 1876, in cui Tolstoj si sofferma sulla sua
concezione dell'opera. Strachov nella lettera precedente avev pro-
posto un'interpretazione di Anna Karenina che a Tolstoj app re
cofretta, ma parziale. Tolstoj sottolinea così I'irriducibilità del signifi-
cato della sua opera a un'unica interpretazione:
se io volessi dire a parole tutto quello che volevo esprimere con ilromanzo, allora dovrei riscrivere un'altra volta quello stesso romanzo che
ho scritto. [...] In tutto, in quasi rutto quello che ho scritto ho sempre av-
vertito il bisogno di unire dei pensieri che, per esprimersi, sono concate-
nati úa di loro, mentre ogni singolo pensiero, espresso a patole singolar-
mente, perde il suo senso, e si alwilisce terribilmente se se ne prende
uno solo dalla connessione in cui si trova. La loro Stessa connessione non
è costituita da pensiero, credo, ma da qualche altra cosa, ed è impossibi-
le esprimere aparole, direttamente, il fondamento di questa connessio-
ne. È possibile solo indirettamente, descrivendo con immagini, azioni, si-
tuazioni 18.
17 Irettera a N. N. Strachov del 14.2.1876, in L. N. Torsto;, Pss, t' 62, p' 247 ' Tol-
stoi intende il primo libro del <<Mess4ggero russo" del 1876 owero i capp' 11-28 del-
laparte III e i capp. 1-16 della parte IV18 Lertera a N. N. Strach ov del 23.4.1876, in L. N. Torsro;, Pss, t. 62, p. 269.
181.
DAMIANo REBEcCHINI
Il graduale chiarimento della sua concezione della vita permet-te a Tolstoj di far emergere in modo più esplicito la sua stessa con-cezione del romanz o. Ii affermazione iniziale sull'irriducibilità del ro-manzo ad una sua definizione sembra in realtà richiamare alla me-moria una simile dichiarazione fatta da Tolstoj a proposito di Guer-ra e pace. Rispondendo alle osservazioni sulla forma inconsueta del-la sua opera egli allora aveva scritto:
Che cos'è Guerra e Pace? Non è un romanzo, ancor meno un poema,meno che mai una cronaca storica. Guerca e Pace è ciò che I'autore ha vo-luto e potuto esprimere in quella forma in cui è venuto a prendere espres-sione. Una simile dichiarazione di tÍascufanza, da parte dell'autore, delleforme convenzionali della prosa d'arte, potrebbe sembrare presuntuosa sefosse fatta per partito preso, e se non fosse sostenuta da altri esempi. tastoria della letteratura russa, da Pu5kin in poi, non solo presenta moltiesempi di opere che si discostano così dalla forma seguìta da quelle euro-pee, ma anzi non fornisce un solo esempio del contrario. A cominciare daLe anime rnorte di Gogol' fino alle Memorie da una casa di morti diDo-stoevskij, non c'è nel periodo nuovo della letteratura russa un solo esem-pio di opera artistica in prosa, che possa esattamente incasellarsi nella for-ma del romanzo le.
Per Guerra e pace Tolstoj aveva spiegatolaforma della sua ope-ra appellandosi ad una ttadizione romanzesca, come quella russa,che ai suoi occhi si presentava come antinormativa per eccellenza.In questo modo, richiamandosi alla specificità della sua tradizioneletteraria, Tolstoj non solo aveva difeso la propria libertà creativa, maaveva attribuito all'autore un ruolo centrale, come colui che orga-nizza libetantente la sua struttura.
Nel caso di Anna Karenina egli pone la questione in modo di-verso. Non presenta più la forma del suo rom nzo come un volon-tario allontanamento dalle convenzioni romanzesche, giustificatodalla propriatradizioneletterana. Egli, piuttosto, si interroga sul pro-cesso della composizione Íomanzesca, e lo definisce un processo di
1e L. N. Torsro;, Qualcbe parola a proposito del libro oGuerra e pace,, inlo,Guerra e pace. Thccuini per "Guena e pace>,vol.2, a cura di L. Pacini Savoy, M. B.Luporini, Sansoni editore, Firenze 1990, p.2259.
182
Tomrol E LA FUGA DAL RoMANzo
connessione di pensieri che <per esprirnersi> devono essere conca-tenati tra loro, e il cui fondamento non è razionalmente percepibilee non è logicamente comunicabile: "l,a loro stessa connessione nonè costituita da pensiero [...], ed è impossibile esprimere a parole, di-rettamente, il fondamento di questa connessione' 20.
Qui Tolstoj adotta per il romanzo il medesimo modello inter-pretativo che aveva sviluppato per la conoscenza filosofica. I-a vetaconoscenza fìlosofica - aveva scritto -, la stessa che fonda la logica,non può essere colta mediante una serie di definizioni logiche, haun suo fondamento irrazionale. Ailo stesso modo il significato del ro-m trzo non può essere colto mediante un taglio interpretativo, masolo nel suo insieme, nel processo stesso del suo farsi attraverso "im-magini, azioni, situazioni", ehaalla sua origine una serie di intuizio-ni irrazionali. te idee stesse per esplicitarsi - scrive - devono rima-nere connesse tra loro, Il processo di composizione romanzesca ini-zia cioè ad apparire agli occhi di Tolstoj come un processo quasi in-dipendente dalla volontà dell'autore. Ijautore sembra perdere il suoruolo demiurgico, di organizzatore consapevole della sua struttura.Si awicina così a una concezione del romanzo non dissimile da quel-la descritta da Bachtin per Dostoevskij.
Ia stessa costruzione dell'intreccio romanzesco innia ad esserconcepita da Tolstoj non più come un momento consapevole di co-stituzione del senso, ma come un processo indipendente dalla suavolontà, "inaspettato". Nel brano successivo a quello sopra citato Tol-stoj scrive infatti:
Voi sapete tutto questo meglio di me, ma ultimamente ciò mi ha inte-ressato in modo particolare. Una delle dimostrazioni più evidenti di quelloche ho detto è stato per me il suicidio di Vronskij, che a voi è piaciuto.Niente per me è mai stato più chiaro. Il capitolo su come Vronskii si com-portava dopo l'incontro con Karenin I'avevo già scritto datanto tempo. Hoinrziato a correggerlo e, in modo del tutto inaspettato per me, ma del tut-to chiaro, Vronskij si spara. E ora è evidente come per il seguito ciò fosse
organicamente necessario 21.
20 Iertera a N. N. Strachov del 23.4.1876, in L. N. TorsroJ, Pss, t. 62, p. 269.21 lbidem.
183
Denmo REBÉccHINI
La composizione dell'intreccio, così come viene presentata dal-
l'autore, non risponde alla necessità di espressione di un'idea cheprecede il romanzo. La sapienza si rcalizza nel fare - eral'idea che si
faceva ora sempre più chiara a Tolstoj. Allo stesso modo, la necessità
della costruzione di un determinato momento dell'intreccio si rea-
lizzanel processo stesso della stesura, in modo inatteso per lo stes-
so autore.In Guerra e pace era stato lo stesso Tolstol a vedere in questo
modo di procedere un suo limite: "Per quanto ci abbia provato all'i-nizio a inventare un intreccio romanzesco con un suo scioglimento
- aveva scritto in un abbozzo peî un'introduzione a Guerra e pace
- ho capito che non ero in grado e ho deciso di lasciare tutto alla
mia abitudine e alle mie forze" 22. E anche in questo caso si eîa ^ -
scosto dietro una tradizione letteraria che gli sembrava mettedo al
riparo da vincoli compositivi. Così aveva scritto in un abbozzo di in-troduzione ai primi capitoli del romanzo: <Noi russi in generale nonsappiamo scrivere romanzi nel senso in cui gli europei intendonoquesto genere di opere [...] con un intreccio, una tensione che si ac-
centua sempre più e un finale, felice o tragico, con cui l'interessedell'opera viene menorrz3. In Guerra e pace, tutta.dta, Tolstoj aveva
difeso il ruolo organizzatore dell'autore. E ripetutamente aveva af'fermato non solo il diritto di una sua assoluta libertà compositiva,ma anche quello di giudicare i suoi personaggi.
Nel corso della composizione di Anna Karenina, al contrario,si consolida una diversa concezione dell'autore come effetto di unapiù chiara concezione dellavita. Awertendo sempre più la vita, e sé
stesso, come parte di un tutto, Tolstoj tende a nascondere il ruolodell'autore, vuole limitare la distanza che lo divide dai suoi perso-naggi e far scomparire ogni trvccia della sua personalità dal roman-zo. Ma questa nuova concezione - e da qui la crisi che si innesta nelcorso della composizione del romanzo - entÍa rapidamente in colli-sione con i procedimenti fondamentali del suo stile, quei procedi-menti romanzeschi che egli aveva elaborato sin dalle prime opere.
22 L. N. Torsro;, Pss, t. 13, pp. 54 sgg.23 lbidem.
L84
Torsrol E LA FUGA DAL RoMANzo
Contraddizione in Anna Karenina
L. Sin dalle prime opere la citic contemporanea avevt notato
la straordinana capacità. analitica della prosa tolstojana: <nessuno
spinge I'analisi piùìvanti di quanto faccialrev Tolstol"24' A partire da
tnpnziaTolsto; aveva svilupputo t"t' serie di procedimenti letterari
pí.ii..f"r*enté efficaci ne1-rappresentare il mondo interiore dei
personaggi' la scomposizione del sentimento in tutte le sue compo-
nenti colìitutive; la rappresentazione della vita psichica dei perso-
naggi mediante una vóce della coscienza, o una serie di voci; varie
forìe di monologo inreriore; la rappresenrazione di piccoli movi-
menti involontari del corpo; la descrizione delle intonazioni, i sogni,
ecc.25. In Anna Karenina essi interagiscono in modo complesso'
Osserviamo ad esempio la scena in cui Anna è in treno per Pietro-
burgo di ritorno da Mosca. Haappenaconosciuto Vronskij e cerca di
nasèondere a se stessa il fatto che quell'incontro ha lasciato una trac-
cia profonda in lei:
..Dichecosamivergognoio?'sidomandòconoffesostupore'Lasciòil tibro e si ritrasse sullo icùenale della poltrona, stringendo forte con en-
tiamne le mani il tzgliacarte' Non c'era nulla di cui vergognarsi' Riandò a
tutti i suoi ricordi di Mosca. Erano tutti belli, gradevoli. Ricordò il ballo' ri-
cordòVronskijeilsuovisoinnamoratoesottomesso,ricordòtuttiisuoirapporti con lui: non c'era nulla di cui vergognarsi' E tuttavia proprio a que-
t,à?""r" dei ricordi la sensazione di vergogna si faceva più forte' come se
una voce interna, proprio a questo punto, quando lei si ricordava di Vron-
,tij, t" dicesse: "Càtdo, molto caldo, rovente'26'
Conlaprecisadescrizionediunaseriedimovimentiinvolonta-ri - il ritrarsi sul sedile, lo stringere forte con enffambe le mani il ta-
24 D. I. PISAREV , Tri smerti. Rasskaz grafa L' N' TolstoSo' in I' ÀI Tolstoj u rus-
skoj kritike [Tolstoj nella critica russa], Moskva t952' pp' 132-133'
25 per l'analisi di questi procediÀenti cfr. B. Elcnrueauu, Il giouane Tolstoj. La
teoria del metodo 1onìnk, De Donaro, Bati t968' cap' 2 pal 1' ma anche M' Au-
cor,srvwnx,Langage int&eur et anatyse pqcbolog'ique cbezTblstoy' "Revue des étu-
des Slaves', vol. 34, 1957, PP' 7-L4'26 L. N. To^roJ,*trn'xarenirn trad. di P Zveteremich,Garzanti, Milano 1989'
vol.1,parteI,cap.29'p.103'Conpiccolemodificherispettoallatraduzioneitaliana'
Deluerqo REBEccHtNI
gliacarte - Tolstoj segnala come dietro alla domanda di Anna si na-
sconda un disagio in netto contrasto con il tono di offeso stuporedella domanda. E, da una p rte, mediante il discorso indiretto libe-ro, egli sottolinea con una serie di ripetizioni il tentativo di Anna ditranqulllizzarsi passando in rassegna i suoi ricordi: *non c'era nulladi cui vergognarsi>>, <<erzno tutti belli, gradevoli", .non c'era nulla dicui vergognarsi,,. Dall'altra, con impietosa precisione, Tolstoj defini-sce esattamente il momento in cui la sensazione di Anna si acuisce e
la sua natura: una voce che dice "caldo, molto caldo, rovente". QuiTolstoj non ricorre ad una descrizione degli effetti complessivi dellasensazione, ma seziona le singole componenti - I'inquietudine, iltentativo di calmarsi, l'acuta bruciante percezione di una colpa-, ta-sformando un'impressione confusa in una voce chiara e stentoreadella coscienza, chre definisce con precisione l'effetto della percezio-ne: <caldo, molto caldo, rovente>.
Sebbene in Anna Karenina Tolstoj ricorra talvolta anche a pîo-cedimenti impressionistici, assai più rari in Guerra e pacella mag-gior parte delle volte egli definisce con la massima precisione le sen-
sazioni dei suoi personaggi. Luso delle *voci', ben distinte grafica-mente mediante virgolette, non solo per rappresentare i pensieri deisuoi personaggi, ma anche per le impressioni, è un chiaro segnaledella tendenza analitica dello stile tolstojano. IJimpressione, trasfor-matain <<voCe>>, viene ridottaaun semplice messaggio verbale di cuiTolstoj sottolinea solo la funzione denotativa. Ciò è evidente, adesempio, quando Tolstoj rappresenta le impressioni di Levin nel ten-tativo di cambiar vita: nTutte queste tracce della sua vita patevano af-
ferrarlo e dirgli: "No, tu non te ne andrai da noi e non sarai un altro,ma resterai quale eri: con i dubbi, con I'eterna scontentezza di te,con i vani tentativi di correggeîti",,zt. Tàlvolta Ia tendenza analiticatolstojana assume forme ipertrofiche, con un effetto quasi comico,ad esempio nella descrizione dello sguardo di Kitty che convinta diesser ricambiata daVronskij respinge Levin: ""Se mi si può perdona-re, perdonatemi" - diceva il suo sguardo - "sono così felice". "Odiotutti, e voi, e me stesso" - rispondeva 1o sguardo di lui" 28.
27 Ivi, vol. 1, parte I, cap.26, p.96.28 Ivi, vol. 1, parte I, cap.74, p. 57.
186
TorsroJ E LA FUGA DAL RoMANzo
La stessa cvp cità analitica, la stessa tendenza a definire e se-
zionare ogni singolo moto dell'animo la ritroviamo nella rappresen-
tazione di molti monologhi interiori. Come ha notato Lrdiia Ginz-
burg, il caso di monologhi illogici non è frequente in Anna Kareni-nA, <<inTolstoj predomina proprio il tipo di monologo interiore logi-
co,,2e. Anche il celebre monologo che precede il suicidio di Anna,
prototipo del flusso di coscienza novecentesco, è costituito da asso-
ciazioni visive libere intramezzate da momenti di riflessione interio-re fortemente logiche: .."Bene, ottengo il divorzio e sarò la moglie diVronskij. Ebbene, Kitty smetterà di guardarmi così come mi guarda'
va oggi? No. E Sereza smetterà di domandare o di pensare ai mieidue mariti? No. E fra me e Vronskij quale nuovo sentimento farò na-
scere? È possibile ormai, non una qualsiasi felicità, ma anche soltan-
to non tormentarsi? No e no." Si rispose senza la minima esitazio-
ne,,30. V Vinogradov scrive che la sintassi di Tolstoj talota sembra ri-
cordare quella delle dimostrazioni matematiche, tanto è costruita inmodo stringentemente logico 31.
2. Se da una parte, dunque, i procedimenti romanzeschi elabo-
rati sin dall'inizio da Tolstoi tendono a privilegiare la componenteanalitica del linguaggio, dall'altra a p rtire da Anna Karenina essi
sempre più entrano in conflitto con una concezione della vita e del
romanzo che li rifiuta.lavera conoscenza - aveva scritto Tolstoj nel-
le lettere a Strachov - coglie I'oggetto nella sua interezza, non pro-
cede mediante analisi, definizioni, divisioni: ,,la vita, l'anima, la vo-
lontà, I'intelletto non possono essere sezionati, divisi in parti" 32. Al-
lo stesso modo, il processo creativo - così come Tolstoi iniziava sem-
pre più a riconoscere - deve procedere mediante connessioni' deve
mantenere i legami tra le idee, tra le impressioni, non recidedi, per-
ché queste, isolate, perdono di senso. Agli occhi di Tolstoj il compi-
2e L. GtNzeunc , O literaturnonT Seroe [Sull'eroe letterario], I'eningrad L979,
p. 178.30 L. N. ToLsroJ , Anna Karenina, cit., vol. 2, parte 7, cap. 30, p.767.3r V VrNocneoov , O jazyke Tolstogo [Sulla lingua di Tolstoi] , in Literaturnoe na-
sledstuo, t.35-36, parte I, Moskva t936, p. l4I.32 Lettera a N. N. Srrachov del 30.11.1875, in L. N. TorsroJ, Pss, t. 62, p. 223.
187
DelrieNo RrsrccHiNl
to dell'autore doveva ridursi sempre più a mantenere tali connes-
sioni, egli doveva ritrarsi dall'opera, cancellare ogni traccia di sé,
scomparire dal piano narrativo. Ma questo imperativo finiva per mi-nare il fondamento stesso della poetica romarrzesca di Tolstoi: la po-
sizione del suo n rratoÍe. È questo il nucleo della contraddizioneche gli si rivela durante la composizione diAnna Karenina. Per sen-
tirsi veramente parte di un tutto, ed esprimere questo sentimentonella sua opera, Tolstoj doveva astenersi dall'analizzare e giudicare ilmondo a cui dava vita. Lanalisi e il giudizio presupponevano infattiuna posizione del naîratoîe esterna e ben distanziata rispetto all'og-getto di osservazione, una posizione al di sopra di ogni cosa, in aper-
to contrasto con il desiderio tolstojano di partecipare al flusso dellavita. Per essere fino in fondo <parte di un tutto" Tolstoj doveva ri-nunciare al suo narratoÍe onnisciente e giudicante.
La posizione del narratore tolstojano si era ben consolidata so-
prattutto con Guerra e pace 33. Uimponente struttura di quell'operapoteva trovare una sua unità solo grazie alla solida posizione di unnarratore onnisciente che dall'alto osservava e giudicava gli eventi e
i suoi personaggi. Già in Guerra e pace Tolstoj percepiva lavita co-
me <parte di un tutto", tuttavia questo sentimento non aveva aîcoraintaccato la posizione del suo narratore. Egli aveva incarnato tale
sentimento della vita in alcuni suoi personaggi, come Andrej, Pierre
o Platon Karalvev. Così I'intuizione di essere <parte di un tutto" ave-
va condizionato la struttura assiologica di certi personaggi, la lorofluidità, il fatto di essere <<come fiumi" - secondo le parole di Tolstoi
- rappresentati <come processo e non come risultato" secondoÒernysevskijtn. La loro caratterizzazione psicologica e sociale nonaveva esaurito lo spettro delle loro azioni e reazioni. Vi era sempre,in fondo a loro, un sostrato di universale umanità che li rendeva più
33 Nei suoi precedenti progetti romanzeschi, da Infanzia fino a Felicità fami-liare,Tolstoj aveva scelto narratori e punti di vista che di romanzo in romanzo si al-
lontanavano sempre più dal loro oggetto di osservazione. Solo con Guena e pace Tol-
stoi arri a un narratore del tutto al di fuori della vicenda e veramente onnisciente.:a Sulla "fluiditò dei personaggi tolstojani cfr. B. EJcHENeauv, Il giouane Tolstoj.
La teoria del metodo formale, De Donato, Bart 1968, pp. 4I-42 e pp.77-78. Ma an'che lo stesso Tolstoi in Reszrrezione e taccuini, a c:ura di L. Pacini Savoy e M. B. Lu-
porini, Sansoni editore, Firenze 1990, partel, cap. 59, p.251.
188
TorsroJ E I-q, FUGA DAr RoMANzo
simili che diversi, e che si ùvelava in alcuni momenti della vita - co-
me la morte di Andrej. Ma la posizione del narratore rimaneva quel-
la solida di un Dio onnisciente e giudicante. Come si vede bene nel-
la carattenzzazione che il narratore offre di Platon l(atataev:
Platon non capiva e non poteva capire il significato delle parole sin-
gole, tolte dal discorso in cui si trovavano. Ogni sua parola e ogni suo azio-
ne erano il manifestarsi di quell'attività a lui ignota, che era la sua vita. Ma
anche la sua vita come lui la intendeva non aveva alcun senso se presa diper sé. Aveva senso soltanto come parte di un intero, ed era questo interoche egli sentiva sempre35.
A partire da Anna Karenina la posizione del narratore di Tol-
stoj inizia ad entrare in crisi. Da una parte, egli awerte il bisogno diun narratore che si îitragga dalla propria opeta e che non giudichi,dall'aJtranon sa rinunciare ad un punto di vista fisso e al di sopra dei
suoi personaggi, che prenda una posizione esplicita verso di loro.In tutto il romanzo troviamo infatti ripetuti segni della tenden-
za del îarîatofe tolstojano a giudicare i suoi personaggi. Essi a voltesi manifestano in dichiarazioni esplicite del narratore. Anna comuni-ca a Vronskij di essere incinta: "Sì, ha capito tutta I'importanza diquest'awenimento, il significato di questo fatto - pensò, e gli strin-
se la mano con gratitudine. Ma sbagliaua pensando cbe egli capis'se il significato della notizia così come lei, donna, lo capivar' 36. An-
na si arrabbia perché Karenin minaccia di non concederle il figlio se-
reZa: *Non è un uomo, ma una macchina, e una macchina c ttivaquando si arrabbia, - aggiunse lei, ricordandosi di Aleksej Aleksan-
drovic t...1 e non perdonandogli nulla di quella terribile colpa di cuiessa era colpeuole di fronte a lLti,,31 '
Lesplicito giudizio del narratore appare evidente nella scelta dicerte similitudini e metafore. Nel celebre passaggio in cui Vronskij si
unisce carnalmente ad Anna, la similitudine dell'assassino che la pu-gnala finisce per esser interprefzta proprio come un giudizio del nar-
35 L. N. Tors:roj , Guerra e pa'ce, a cura di I. Sibaldi' Mondadori, Milano 1999, t.
IV parte l, cap. \3, p.1514.36 L. N. TorsroJ, Anna l(arenina, cit., vol. L, parte ll, cap' 22, p' l9L.37 lvi, vol. L, parte Il, cap.23, p. 193.
789
DeuraNo RrssccurNr
ratore: "E con accanimento, quasi con passione, I'assassino si getta suquesto corpo e lo trascina e lo taglia; così anche lui copriva di baci ilviso di lei e le spalle. Iei gli teneva la mano e non si muoveva'38.
I-irrompere della personalità e del giudizio tolstojano si manife-sta in modo particolarmente evidente a livello sintattico e lessicale. Èstato notato come dal punto di vista della struttura sintattica AnnaI(arenina rappresenti una fase di passaggio tra Guer'ra e pace e leopere degli anni '80 3e. I periodi di Anna Karenina sono in generepiù semplici e meno articolati di quelli di Guerra e pace, ma nonhanno ancoÍ^ raggiunto l'essenzialità tipica della prosa del decenniosuccessivo. Anche dal punto di vista lessicale rimangono ancora mol-ti calchi dal francese. Nelle parti nNrative il romaruo presenta unastruttura sintattica piana, che tende ad evitare le subordinate e i pe-riodi lunghi e complessi, più frequenti in Guerra e pace, arrivandotalora ad una semplificazione quasi didascalica della frase. Lintona-zione del narî toÍe, in armonia con il suo punto di vista onnisciente,è in genere stabile, distaccata e non ha una forte ampiezza di modu-lazione o una grande varietà di timbri. Risuona come la voce calma esonora di un <<Dio sereno>, secondo le parole di Prousta0.
Eppure, vi sono dei momenti in cui questa stabilità si rompe. Sitrztta, in particolare, delle fasi in cui i personaggi vivono processi dicomprensione della vita. È qui che Tolstoj passa dalla sua narrazionedistaccata al discorso indiretto libero. Qui la sintassi piana di Tolstojsi rompe, assistiamo aduna serie di ripetizioni, di costrutti anaforici,di ripetizioni di parola a fine e inizio periodo (anadiplosi), spesso se-condo uno schema costante a1. È qui che si mostra il giudizio e lapersonalità tolstojana. La npetizione - uno dei procedimenti chiave
38 lvi,vol. l,partell,cap. 11,p. 1,53.3e Cfr. V VNocRADov, O jazyke Tolstogo, in Literaturnoe nasledstuo, tt. 35-36,
parte I, Moskva 1936, p. 146 e S. Scuurrzr, Tbe Structure ofAnna Karenirut, Ardis,Ann Arbor O,Ii) 1982, pp.57-58.
a0 M. Pnousr, Contre Sainte-Beuue, pasticbes et mélanges. Essais et articles,Gallimard, oBibliothèque de la Pléiade", Pans I97I, p. 657.
a1 Cfr. sulle ripetizioni in Tolstoy B. M. Eycnnxmuu , Leu Tolstoj, vol. 2, kningrad193I, p. 377 parla di una degge delle ripetizioni,' in Tolstoj; S. Scrurrzr, The Struc-ture of Anrta Karenina, cit., pp. 64-72 e N. SaNrovrrcH, Creating and Recouering Ex-perience. Repetition in Tblstolt, Stanford U! Stanford 1998.
l
190
TorsroJ E LA zucA DAt RoMANzo
di Guena e pace - in Anna Karenina sembra assumere un ruoloimportante soprattutto in questi momenti di comprensione.
Levin era sposato da tre mesi. Era felice, ma non della felicità che si
aspettava. A ogni passo, trovava una smentita ai suoi sogni, o un nuovo ina-
spettato incanto. Levin era felice, ma entrato nella vita familiare, a ogni pas-
so vedeva che essa non era affatto come se laimmagSnava. A ogni passo egliprovava quello che provava un uomo che [...] 4'z.
Yiavia che la sensazione si definisce si accumulano ripetizioni,anafore, il discorso si trasforma in discorso indiretto libero. La strut-tura piana, che inizialmente Tolstoj impone al suo periodo, gradual-
mente si complica. E dietro al ritmo crescente della frase fa capolinoil volto scuro di Tolstoj, con le sue critiche, il suo giudizio: "Levin di-menticava che anche Kitty aveva dei compiti da svolgere 1...]"43. Inquesti particolari momenti di comprensione Tolstoj compare dietroai suoi personaggi con la sua vecchia sintassi, le accumulazioni, i co-
strutti anafonci, la sua intonazione. E ciò awiene non solo con Le-
vin, ma anche con Anna, Karenin, Kitty:
Kitty fece conoscenza con la signora Stahl, e questa conoscenza, in-sieme con l'arniczia perVarenka, non soltanto ebbe su di lei un forte in-flusso, ma contribuì a consolarla nel suo dolore. [a consolava il fatto che,
grazie a questa conoscenza, le si era rivelato un mondo completamente
nuovo, che non aveva niente in comune con il suo passato, un mondo ele-
vato, meraviglioso, dalla cui altezza si poteva guardare con tranquillita il pas-
sato. Le si era rivelato che, oltre allavita istintiva, cui fino allora Kitty si era
abbandonata, c'era una vita dello spirito. Questa vita le veniva ivelata dalla
religione, ma da una religione che non aveva niente in comune con quella
che Kitry conosceva dall'infanzia, da quella religione che si esprimeva nella
messa e nei vespri allaCasa delle vedove, dove [...] aa.
42 L. N. ToLsroJ, Anna Karenina, trad. di P Zveteremich, Garzanti, Milano1989, vol.2, parte\ cap. 14, p. 487 con alcune modifiche che mantengono le ripe-tizioni presenti nell'originale.
43 lhidem.aa Ivi, vol. 2, p îte ll, cap. 33, p. 227.I'a traduzione è stata modificata mante-
nendo le ripetizioni presenti nell'originale.
191
DairanNo R-egrccFttNt
Così se Flaubert, o Dostoevskij, ricorrono al discorso indirettolibero per scomparire dietro ai loro personaggi, Tolstoj se ne serve
per comparire dietro a loro, per segnalare al lettore i momenti che
sente come più importantia5.La forte presenza della personalità tolstojana non si registra sol-
tanto sul piano della narrazione, a livello sintattico e lessicale, ma aÍr'
che, e in modo assai evidente, nella struttura dell'intreccio. fintrec-cio di Anna Karenina, nato da un frammento puSkiniano sotto gli
auspici dell'equilibrio e del controllo compositivo, ha certamente
uno sviluppo più armonico di quello di Guerra e pace a6' Ti;ttavia, se
in origine si doveva sviluppare secondo una sola linea natrativa -quella di Anna-Karenin-vronskij - nel corso stesso della composizio-
ne del romanzo si arricchisce di una linea nattativa nuova - quella le-
gata a Levin - che si dilata sempre più fino a prendere decisamente ilsoprawento. Da metà del romanzo, owero dalla quinta parte, lo spa-
zio dedicato alle vicende di Levin aumenta sensibilmente, a discapito
di quello dedicato ad Anna. Alla fine del romanzo contiamo settanta-
due capitoli dedicati a Levin rispetto ai quarantasei dedicati ad An-
naa7. Sebbene Tolstoj fosse consapevole della vicinanza diLevin adal-cuni aspetti della sua personalità - glielo aveva scritto anche Fet, "Le-vin è Lev Nikolaevic, l'uomo, non lo scrittore, - egli pare non far nul-
la per nasconderlo . Anzi, nell'ultima parte del romanzo' quasi intera-
mente dedicataa Levin, fa confluire in modo diretto ed esplicito mol-
te delle riflessioni che erano emerse nella corrispondenza con Stra-
chov e che verranno esposte in Confessione' Qui Tolstoj sembra qua-
si non resistere al bisogno di riversare ampie porzioni della sua espe-
rienza e personalità nella sua opera. Così quella che era statal'ideainiziale del romanzo - rappresentare <un tipo di donna sposata, del-
4t Sulle diverse funzioni del discorso indiretto libero nel romanzo ottocente-
sco cfr. F. Monrrrr, Il secolo serio, in Il romanzo. La CUltUra del romanzo, a cura di
F. Moretti, vol. 1, Einaudi, fbrino 2001, pp. 717-725'a6 Sul rapporto con il frammento puskiniano cfr. B. M. EJcuaNeauÀ4, Leu Tolstoj.
Semidesjatyegody,Leningradlg74 (Leningtad7960), parte III, cap.2.Trad. ingl' B'
Erxnnuneuu, Tolstoy ín tbe Seuentbies, Ardis, Ann Arbor (Mi) 1982'47 sullo sviluppo delle due linee narrarive, quella dedicata a Anna e quella di
Levin, cfr. in part. S. ScHurrzr, Tbe Structure ofAnna Karenina, Ardis, Ann Arbor
(Mi) 1982, pp.77-43.
192
TorsroJ É t-A, zucA DAL RoMANzo
I'alta società, una donna perduta>, rendeda onon colpevole, ma de-
gna di compassions,>a8 - alla fine del romarzo viene formulata da Tol-
stoi in termini diversi, più ampi, diventa un romanzo sull'idea fami-
liare: .<In Guerra e pace ho amato l'idea nazionale, in Anna Kareni-nA amo I'idea familiare' dirà dopo la fine del Íom nzo4e'
3. Durante la composizione di Anna Karenina si verifica così
una forte collisione tfa la nuova concezione tolstojana dell'autore,emersa nelle lettere a Strachov, e i vecchi procedimenti fondamen-
tali del suo stile. Essa emerge in modo chiaro agli occhi di Tolstoj
proprio durante la scrittura dell'opera, determinando un brusco
cambiamento nel suo atteggiamento verso il rom nzo. Aspirando asentirsi parte di un tutto, Tolstoj vorrebbe ridurre al massimo la pre-
senza dell'autore nella sua creazione, vorrebbe limitare la distanza
che lo separa dai suoi personaggi e astenersi da ogni giudizio. Ep-
pure, nel corso stesso della composizione, egli si rende conto che
scrivere per lui vuol dire soprattutto analizzare, definire, sezionare,
e che non riesce a privarsi del suo n tfafofe onnisciente e giudican-
te. Capisce che in fondo egli lascia tracce troppo evidenti della sua
personalità attorno ai suoi personaggi, nella nartazione. E questo ilcentro della contradd2ione che emerge in Anna l(arenina, ed èquesto che determina la sua fuga dal ÍomaÍrzo.
Il percorso di fuga
1. Già nel 1857 Tolstoj appunta sul diario ,,la,patola evangelica
non giudicare è profondamente vera anche nell'arte: racconta, raf-
figura, ma non giudicare" 50. Se dunque I'imperativo di non giudica-
re è presente sin dall'inizio,la ricerca della forma artistica più ade-
guata si manifesta solo dopo la conclusione del primo romanzo, Fe-
licitàfamiliare.Inunaserie di articoli dei primi anni'60 Tolstoj ini-
8 Dneuniki S. A Tolstoi, 1860-1891, Moskva 1928, p.32.ae Diario di s. A. Tolstaja del3.3. 1877, in Dneuniki s. A Tolstoj, 1860-1891,Mo-
sl<tra 1928, P.369.to L. N. TorsroJ, Pss, t. 47, p. 203.
L93
DenraNo RrsnccHrxr
zia a delineare alcuni principi di una poetica assai diversa da quellafino ad allora messa in pratica. Per il momento si tratta solo di rifles-sioni teoriche, che espone ad esempio in Cbi deue imparare a scri-uere, i figli deí contadiní da noi o noi dai figli dei contadini?(1862) o nell'articolo Sulla lingua dei libri per il popolo (1862). Neemerge l'aspirazione a un prosa equillbrata, permeata dal sensodella misura e del controllo, che si fondi su un'idea che deve emer-gere dall'intreccio e non dalle parole del narratore, su un intrecciolineare, una sintassi piana, un lessico preciso, sintetico, mai astratto.Ne emerge un nuovo orientamento verso la propria tradizione cul-turale: non più di tipo analitico e critico verso i modelli della cultu-raalta di provenienza occidentale, ma di tipo mimetico verso un'am-pia e universale cultura popolare.
Per metter in pratica questi nuovi principi Tolstoj tuttavia aspet-terà dieci anni, con la fine di Guerra e pace. È in questo periodo, al-l'inizio degli anni '70, che iniziala composizione dell'Abbecedarío eche nasce la prima opera in uno stile completamente nuovo, Il pri-gioniero del Caucaso (1872). Si tratta di un'opera dal valore pro-grammatico - "è questo il modello dei procedimenti e della linguacon cui sto scrivendo e seguiterò a scrivere per gli adulti" scrive Tol-stoj 51. Si tratta di un'opera che per la sua tematica - la vrta militare,il rapporto con i popoli più selvaggi - è rivolta al suo vecchio pub-blico, un pubblico colto: la nuova poetica tolstojana, dunque, non èlegata necessariamente ad un nuovo destinatario. Per l'AbbecedarioTolstoj si dedica allo studio del greco antico, rielaborale fiabe di Eso-po, fiabe indiane, persiane, arabe. Egli si nasconde dietro al punto divista dei bambini, degli animali, dietro ai proverbi russi, *cerca scam-po da se stesso>, come ha scritto Pier Cesare Bori 52. Nel Prigionierodel Caucaso arriva ad una forma narrativa epurata da ogni ttaccia disoggettività e di giudizio. Nessuna caratterizzazione psicologica, nes-suna digressione, nessuna descrizione minuziosa dei dettagli, è unpuro disegno di intreccio. Un tratto accomuna questo intenso lavo-ro, è la scomparsa del vecchio narratore tolstojano, con le sue into-nazioni, i suoi periodi lunghi e articolati, le sue ripetizioni. "Non
t1 Ivi, t. 61, p.278.t2 P C. Boru, I'ahro Tolstoj, cir., p. 17.
794
TorsroJ E r-\ FUGA DAr RoMANzo
scrivo e non scriverò mai più certe verbose insulsaggini come Guer-rA e pace>> scrive Tolstoj nella primavera del 787253. E già nell'edi-zione di Guerra e pace del 1873 decide in parte di eliminare, in par-
te di mettere in appendice le riflessioni filosofiche del romanzo, se-gno che non le riteneva più elemento essenziale della sua opera. La
moglie nel diario sottolinea il bisogno di sintesi e chiarezza di Tol-
stoj: "$6gn2 un'opera così pura, bella, in cui non vi sia nulla di su-perfluo, come tutta laletteratura gÍeca, come I'arte greca.. . Dice chenon è difficile scrivere qualcosa. È difficile non scrivere' í. È inte-ressante f interpretazione che lo stesso Tolstoj dà al suo nuovoorientamento poetico, in cui sembra riÎarsi ancora una volta a un ri-fiuto delle tradizioni della letteratura alta, rappresentata da Pu5kin.
Ho mutato i procedimenti del mio stile e la mia lingua, ma, lo ripeto,non perché ho giudicato razionalmente che questo fosse necessario. Maperché anche PuSkin mi pare ridicolo, per non parlare poi delle nostre elu-cubrazioni, mentre mi è cara la lingua che parla il popolo e che ha suoniper esprimere tutto quello che uno scrittore voglia esprimere 55.
Boris Ejchenbaum spiega I'abbandono del romanzo da parte diTolstoj dopo Guerra e pace come una teazione alle critiche ricem-te per la sua opera 56. se questa citcostanza ha avuto un peso, vi ètuttavia dietro alle sue nuove posizioni una serie di atteggiamentiche si ripresentano in modo ciclico dopo tutti i suoi romanzi, anchequelli di maggior successo comeAnna Karenina. Non è il rifiuto ca-
tegorico del genere romanzesco, ma è il rifiuto di un genere chesembra spingerlo ad analizzare e a giudicare. Subito dopo la fine diAnna Karertina, ad esempio, Tolstoj pensa di riprendere il progettodi un romanzo sull'epoca di Nicola I e sui decabristi con I'intenzio-ne di "capire tutti e solo descrivere>, <<senza giudicare nessuno". Af-îerma di voler <osservare la storia del 74 dicembre senza giudicarenessuno, né Nicola I, né i congiurati" 5'. Mà, a dispetto del lavoro di
53 L. N. Torsro; , Pss, t. 67, p. 247.t4 Cit. in B. M. EJcHEMAUM , Leu Tolstoj. Semidesjatye gody,Lenngrad 1974, p. 67 .
5s Inttera a N. N. Srnecnov del25.3.1872 in L. N. Totsroy, Pss, t. 61, pp. 277-278.56 B. M. EJcHrNreAuÀ4, Leu Tolstoj. Sernidesjatye gody,l-eningrad 1974, cap.2.51 Cfr. il diario della moglie S. A. Tolstaia del 25.I0.L877 in Dneuniki S. A Tol-
stoj, 1860-1891, Moskva 1928.
195
DAMTANo RrsrccHrNr
pîepaîazione, non riesce a scriverne nemmeno una pagina, segnoche non era in grado di arnvare ad un nart tore "indifferente,. E apartire d^L7879 inrziauna lunga serie di scritti pubblicistici in cui sv!luppa le sue nuove posizioni etiche. Così quelle esperienze e rifles-sioni che non avevano più potuto trovare la via del romanzo, trova-no ora quella della pubblicistica.
Al tempo stesso, dal 1881, innialacomposizione di una lunga se-rie di racconti popolari, molti dei quali rielaborazioni di fiabe russe, incui inizia ad incrnare le sue nuove più radicali concezioni etiche. An-che questa volta assume un atteggiamento mimetico verso la culturapopolare. Spesso si fa raccontare quelle storie da un cantastorie, neannota il lessico, la sintassi. Scompare la preserua debordante del vec-chio narratore tolstojano, scompare ogni forma di analisi psicologica,i periodi complessi, le ripet2ioni. Arriva ad uno stile di una straordi-nana purezza, come nel racconto Di cbe cosa uiuono gli uomini(1881), il primo bellissimo racconto dopo la fine di Anna Karenina.
Il ritorno al romanzo passa attraverso un lungo percorso, daglistudi teologici alla traduzione dei vangeli Q'indagine sulla teologiadogmatica, L'unifícazione e traduzione dei Vangeli, 1BB0), allacomposizione dei racconti e del teatro per il popolo (1881-188D, adun' intensissima arrività pubblicistica (tra cui C onfe ssione, L87 9 -IBB2 ;In cbe consiste la miafede,lBB2-1884; Cbe cosa dunque dobbiamofare?, 1884-1885; Sulla uerità nell'arte, 1887; ecc.) 5s. Nella primaopera letteraria di ampio respiro, La morte dí luan ll'iÒ (1884-1886),Tolstoj evita di ricorrere a un naîratore onnisciente, racconta la sto-ria "della morte normale di una persona normale, descrivendola dalsuo punto di vista" 5e. Subito dopo ricorre al teatro con Ia potenzadelle tenebre (1886). Ancora nel 1888 scrive a Òertkov: nNon c'è ra-gione di scrivere nel modo in cui scrivevo prima [. . . ] , bisogna inve-ce parlare in modo più chiaro, più semplice, in modo più sintetico ecomprensibile. Se solo Dio lo volesse, ed io lo vorrei, ma ancora nonci riesco"60. Solo agliinizi degli anni Novanta, dopo la composizione
t8 In questo e nei seguenti capoversi le date corrispondono al periodo dicomposizione e non di pubblicazione.
5e lerrera a L. D. Urusov del 20.8.1885, in L. N. ToLSroJ, pss, t.63, p. Zg2.Ó Lettera aV G. Òertkov dei 10.6.1888, in L. N. Torsro;, pss, t. 86, p. 161.
I
196
TorsroJ E LA FUGA DAr RoMANZo
della sonata a Kreutzer (1887-1889) , inizia nuovamente apensaÎe a
un romanzo. Ed è significativo che anche questa volta, come già con
Anna Karenina, ma oîa in modo ancota più consapevole, Tolstoj
concepisca il romanzo Come uno spazio in cui, dopo aver osservato
e ana\zzatolavita, si ripristinino le connessioni tra i fenomeni. Nel
1891 scrive nel diario: "sì, iniZiare adesso a scrivere un romanzo
avrebbe senso. I miei primi, precedenti romarui erano frutto di una
creazione inconsapevole.DaAnna Karenina, owero per più di die-
ci anni, io ho smembrato, distinto, analizzato. Ora so distinguere
ogni cosa, e posso di nuovo mischiade e lavorare in quel miscu-
gho'er. Ma anche questa volta, nonostante i propositi inizlali, la ten-
denza del suo n fîatore ad intervenire e a giudicare i suoi perso-
naggi emerge nel corso della composizione in modo sempre più evi-
dente. E, con il procedere del romanzo, aumenta la sfiducia verso la
forma romanzesca. Due anni dopo, nel 1895, scrive nel diario: "Laforma del romanzo non solo non è eterna, ma sta passando. Mi ver-
gogno di scrivere ciò che non è mai esistito. Se vuoi dire qualche co-
sa dilla direttamente' 62. E ancota nel 1897 in una lettera al figlio scri-
yg; *[Il mio romanzo] negli ultimi tempi mi è diventato odioso' Ia
fiction è una cosa spiacevole. È tutta un'invenzione, falsità. Mentre
quanta verità inespressa mi brucia nell'animo" 63.
2. Così, dopo ogni rom^nzo Tolstoj sviluppa una poetica della
prosa alternativa^ quella îomanzesc : un intrecciO lineare, ÚfrafiaÎ-
razione distaccata e priva di giudizi, una sintassi semplice e che ri-
duca al massimo le ripetizioni, una totale assenza di analisi psicolo-
gica, E questa nuova poetica va contro i principali procedimenti let-
ierari che egli avevaelaborato spontaneamente a partife da Infanzia
- I'analisi psicologica, la scomposizione dei moti dell'anima, i mono-
loghi interiori, le digressioni del nafratore, ecc. Rinunciare a questa
parte del lavoro creativo è per lui come rinunciate a una parte di sé,
a quella parte logico -raziona)e di cui ha orrore perché gli impedisce
di ientirsi parte di un tutto, di un ordine superiore che tutto ab-
6i L. N. Tonrol , Pss, t, 52, P. 6.62 lvi, t. 52, p.93.63 L. N. ToLSroJ, Pss, t. 68, p. 230.
197
DeunNo Rrnrccnnl
braccia. Già durante la composizione di Anna l(arenina scrive aStrachov: .Per me il male è tutto ciò che è logico" e. E pochi anni do-po, a qualcuno che gli chiedeva di poter risfampareArtna Karenina,egli risponde: <Sono nella stessa situazione di qualcuno a cui chie-dessero il permesso di fare dei propri escrementi del cibo" 65. AnnaKarenina è quella parte disé di cui egli cerca di liberarsi - la sua ten-denza all'analisi, alla definizione, alla scomposizione della vita - ele-menti che oramai ai suoi occhi dovevano rimanere al di fuori delromanzo. Così, a partire daAnna Karenina, Tolstoj matura una con-cezione dell'autore e della creazione letterana, effetto di una piùchiara concezione della vita, che entra in contrasto con i procedi-menti letterari che aveva elaborato sin dalle prime opere, determi-nando una fuga dal romanzo e spingendolo a cercare nuove strade.
Alla luce di queste considerazioni anche latradaionale divisioneoperata dalla critica dell'opera tolstojana in tre periodi, secondo unalinea evolutiva che va dall'elaborazione dei principali procedimentiromanzeschi negli anni'50, il grande periodo delromaruo degli anni'60 e'70, e il periodo dell'abbandono della letteratura per l'attività fi-losofica e pubblicistica a partte dagli anni '80, non sembra del tuttoadeguata66. Essa tradisce una visione <romanzocentrica' della lettera-tura che non era di Tolstoj, e insinua una logica evolutiva che sembraassente dal suo percorso. Sembra più giusto parlarc invece di uno svi-luppo ciclico del suo percorso creativo, con I'alternarsi costante diuna poetica del romanzo, ispirata a principi della massima libertàcompositiva e critica verso la tradnione romanzesca occidentale, euna poetica di tipo mimetico verso la cultura popolare universale,ispirata ai principi della chiarezza, della misura,.della sintesi.
e Lettera a N. N. Strachov del l2-13.17.L876, t. N. TotsroJ, Pss, t. 62, p.290.6t I€rt. V V Stasov del 1.5.1881 in L. N. Tomro;, Pss, t. 63, pp. 6I-62.6 Cfr., tra gli altri, N. S. Tnuetcro.J, L'euoluzione letteraria di Leu Tolstoj, in La
cultura nella tradizione russa del XIX e XX secolo , a cura di D'Arco Silvio Avalle, Ei-
naudi, Torino 1980, pp. 186 sgg.; L. KNare, Tbe Deuelopment of Style and Tbeme inTolstolt, in Tbe Cambridge Companion to Tolstoy, a cura di D. Tussing Orwin, Cam-bridge University Press, Cambridge 2002, pp. 161 sgg.
198