Nel ventre di Napoli rinasce il passato- La Galleria Borbonica
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Nel ventre di Napoli rinasce il passato- La Galleria Borbonica
Periodico romano di approfondimento culturale: arti, lettere, spettacolo
“...non più una cul-tura che consoli nel-le sofferenze, ma unacultura che proteggadalle sofferenze, chele combatta e le eli-mini...”
Elio Vittorini, 1945
“Scrivere non è descri-vere. Dipingere non èrappresentare.”
George Braque
VE
SP
ERT
ILLA
- Ann
o X
I - n
°5se
ttem
bre-
otto
bre
2014
-pre
zzo
5 eu
ro
2
VESPERTILLA
Direttore Responsabile: Serena Petrini
Direttore Editoriale: Luigi Silvi
Condirettore: Ilaria Lombardi
Vicedirettori: Serena Epifani, Francesca Martel-lini
Segretaria di Direzione: Maria Pia Monte-duro
Hanno collaborato a questo numero: Michela Barbieri, Concita Brunetti, Luca Buon-giorno, Giulia Capogna, Federica Clementi, Mi-caela De Filippo, Serena Epifani, Marina Humar,Francesca Martellini, Bruna Monaco, Maria PiaMonteduro, Sofia Orsino, Sibilla Panerai, LauraRuzickova, Luigi Silvi, Ofelia Sisca, Vito Tritto.
La collaborazione sotto ogni forma è gratuita
Impaginazione grafica: Maria Pia Monte-duro
Editing: Serena Epifani, Francesca Martellini
Editore:Associazione Culturale ANTICAMentevia Sannio 21, 00183 Roma
INFO [email protected]@tiscali.it
Pubblicazione registrata presso il TribunaleCivile di Roma n. 335-05.08.2004
Stampa:Copypoint - via de’ Funari 25 00186 Roma
Doganalisti specializzati in Mostre d’Ar tePadova Rovigo Vicenza
Tutte le operazioni doganal i e le istanzepr esso la Sovr intendenza al le Bel le Ar t iper r epert i ar cheologic i e opere d’ar tepr ovenient i da l l ’estero e inv iat i a l l ’e-stero per esposiz ioni e scambi cul tural i .
PADANA SPEDIZIONI S.A.S.SPEDIZIONI E TRASPORTI INTERNAZIONALI
Padana Spedizioni S.a.S.
35127 Padova-Zona Industriale-Corso Stati Uniti, 18
Telefono (049)8702322 - Telefax (049)8702327
e-mail [email protected]
Codice fiscale e Partita I.V.A. 00289000283
3
SOMMARIO
ARCHEOLOGIA
SUBSTRATO CULTURALE COMUNE DELLE POPOLAZIONI DELL’A DRIATICO ORIENTALEAdriatico senza confini. Via di comunicazione e crocevia dei popoli nel 6000 a.C., Castello di Udine (Udine), di Luigi Silvi PAG. 4ROGHI DELLE TERREMARE COME QUELLI DELLA PIANURA DI ILIOLe urne dei forti. Storie di vita e di morte in una comunità del bronzo, Palazzo dei Musei, Museo Civico Archeologico Etnolo-gico (Modena),di Luigi Silvi PAG. 20CULTURA FALISCA SOLO APPARENTEMENTE MINOREFalisci popoli delle colline. Materiali falisci e capenati al Museo Archeologico Nazionale di Firenze, Museo Archeologico Na-zionale (Firenze), di Luigi Silvi PAG. 26COMPUTO DEL TEMPO NELLA ROMA CLASSICARivoluzione Augusto. L’imperatore che riscrisse il tempo e la città, Palazzo Massimo alle Terme, di Serena Epifani PAG. 34INSULA VOLUSIANA, di Marina Humar PAG. 52NEL VENTRE DI NAPOLI RINASCE IL PASSATO, di Marina Humar PAG. 70
M ISCELLANEA
GLORA E FAMA DURATUREGli Este e la Gloria. Ambizioni e rinunce, Musei Civici - Sala Boni (Modena), di Luigi Silvi PAG. 90TRATTATI DI RESPIROEUROPEOPer il bene della pace. Il lungo cammino verso l’Europa dalla Pace di Bologna alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo (1530-1789), Palazzo Ducale - Sala dello Scrutinio (Venezia), di Luigi Silvi PAG. 116IL PATRIMONIO STORICO DI V ILLA TORLONIA: BUNKER E RIFUGI ANTIAEREI, di Marina Humar PAG. 130
L ETTERATURA
GRIDO DEL SOLDATO FERITOLa Paura e altri racconti della Grande Guerra, Federico De Roberto, di Laura Ruzickova PAG. 142FORZA UNIVERSALE E TRASCENDENTELa danza della vita, Alejandro Jodorowsky, di Laura Ruzickova PAG . 146IL RISPETTO DI SE STESSILa regola dell’equilibrio, Gianrico Carofiglio, di Maria Pia Monteduro PAG 150
4
Ar cheologia
Il periodo di riferimento della mostra si carat-terizza per cambiamenti economici cruciali,quali l’introduzione dell’agricoltura e dell’al-levamento. Si assiste anche in quest’area aquella che è stata definita la “prima grande ri-voluzione economica della storia dell’uma-nità”: l’uomo infatti, da parassita della natura(cacciatore, pescatore, raccoglitore), diventaproduttore (agricoltore, allevatore) e si seden-tarizza, abbandonando il nomadismo al se-guito degli spostamenti dei branchi di grandimammiferi. Utilizza strumenti di pietra levi-gata e recipienti in ceramica: nascono così iprimi villaggi stabili antesignani delle città. Ipaesaggi naturali lentamente si antropizzanoe si trasormano in spazi coltivati e abitati,dove l’uomo diventa artefice dell’ambiente efattore ecologico determinante, lasciandoovunque il segno del proprio passaggio edella sua interazione con la natura, co-struendo così un nuovo legame tra sé e l’am-biente. Le comunità umane radicate sulterritorio esprimono la loro identità, il loropensiero, il loro atteggiamento estetico e spiri-tuale attraverso la lavorazione e l’abbelli-mento dei materiali e degli oggetti d’uso, inparticolare attraverso la decorazione del va-sellame fittile. Si intravede attraverso gli og-getti di culto una koinè caratterizzata da unacomunicazione non verbale di segni e simboli,espressioni emblematiche di credenze e ideo-logie. Obiettivo della mostra è mettere in evi-denza le analogie riconoscibili in questamacroarea tra il 6000 e il 4000 a.C. Intento di-chiarato dei curatori dell’esposizione è anchequello di dare un contributo, attraverso l’in-dividuazione e il riconoscimento di origini co-muni, al superamento di differenziazionisecolari tra le popolazioni che vivono in que-ste terre. Il materiale esposto proviene da de-cenni di ricerche e propone vasellame ancheantropomorfo e zoomorfo in pietra e in cera-mica (questa con decorazioni geometriche in-cise), strumenti in pietra, tra cui una vastaserie di punte di lancia e di asce - di cui unaimmanicata - e conchiglie con foratura inten-zionale, utilizzate probabilmente come monili.I siti sono geograficamente distanti tra loro,ma le comunità neolitiche sono legate da rap-porti intensi, da una radice culturale comunee da un unico substrato culturale appunto. Inparticolare la decorazione della ceramica co-stante e senza differenze sostanziali è segnaledi questi aspetti comuni, dell’identità cultu-rale e spirituale e di una storia collettiva.
Luigi Silvi
SUBSTRATO CULTURALE COMUNE DELLE POPOLAZIONI DELLADRIATICO SENZA CONFINI. VIA DI COMUNICAZIONE E CROCEVIA DI POPOLI NEL 6000 A.C., Castello di Udine (Udine)
Aska, 6000-4000 a.C., da Smilcic.
20
Ar cheologia
ROGHI DELLE TERRAMARE COME QUELLI DELLA PIANURA DI ILIOLE URNE DEI FORTI. STORIE DI VITA E DI MORTE IN UNA COMUNITÀ DEL BRONZO, Palazzo dei Musei, Museo Civico Archeologico Etnologico (Modena)
21
Ar cheologia
Gli scavi della Necropoli della Terramara di Casinalbo presso Mo-dena hanno svelato aspetti relativi non solo alla morte, ma anchealla vita di una delle comunità della Pianura Padana tra il 1650 eil 1150 a.C. In questo periodo la Pianura del Po era occupata dallacosiddetta civiltà delle terramare: abitati quadrangolari su areedi terreno sopraelevato, circondate da fossato e fortificate con ar-gini, dotate di abitazioni elevate con assiti lignei per evitare l’umi-dità. L’economia era basata sull’agricoltura intensiva, inparticolare la cerealicultura, sull’allevamento di bovini, ovini esuini (la caccia era marginale) e su un raffinato artigianato delbronzo, realizzato da figure specializzate di artigiani. Un lungoperiodo di siccità e un eccessivo sfruttamento del terreno furonole cause principali di una crisi che in pochi decenni portò al col-lasso la civiltà delle terremare. La necropoli, finora indagata perun quinto, ha rivelato la presenza di settecento tombe a incinera-zione, che sono state tutte scavate. In mostra vengono illustrati irisultati delle ricerche lungo un percorso che espone i reperti pro-venienti da Casinalbo, ma anche da altri contesti relativi all’Etàdel Bronzo nell’area padana dell’Emilia Romagna, del Veneto edel Piemonte. Il materiale esposto è corredato da immagini, rico-struzioni e strumenti multimediali. La Necropoli di Casinalbo ècostituita principalmente da tombe a pozzetto entro cui era siste-mata l’urna cineraria contenente i resti del defunto. Sono stati in-dividuati sentieri che isolano nuclei di sepolture e aree rituali,dove si svolgevano le cerimonie precedenti e successive ai roghifunebri. Roghi questi simili a quelli descritti da Omero nell’Iliadein occasione dei funerali di Patroclo e di Ettore. È stato possibilericostruire la cerimonia funebre: la salma veniva esposta su unapiattaforma lignea per essere sottoposta ai rituali che precede-vano la cremazione; sulla pira venivano posti oggetti che defini-vano lo status sociale (spade e/o pugnali per maschi adulti,spilloni e pendagli per le donne). Dopo il rogo le ossa venivanoraccolte, lavate e sottoposte all’ossilegio, selezione per l’urna: leultime a essere riposte erano quelle del cranio per riproporre par-zialmente la forma anatomica del defunto. Gli oggetti personalivenivano ridotti in frammenti minuti, atto simbolico per decre-tarne la perdita di funzione, e utilizzati per offerte votive. Le sin-gole sepolture avevano come segnacolo un grande ciotolo. Lacerimonia si componeva di quattro fasi: le celebrazioni precedential rogo (lamentazioni, canti, cortei, banchetti, libagioni di vino), lacremazione, il distacco dal defunto e altri riti successivi. La ne-cropoli era percorsa da sentieri in terra battuta larghi due metri,che s’incrociavano ortogonalmente, e isolavano sepolture carat-terizzate da legami parentelari, con i maschi e le femmine in po-sizione diverse. Tale disposizione corrispondeva a quella degliabitati. La quantità e la qualità di offerte di cibo deposte sul luogo,e la presenza di bronzo nelle ceneri, denotano una società domi-nata da un ceto guerriero. Studi archeologici avanzati hanno con-sentito di ricostruire l’assetto demografico, l’organizzazione dellasocietà e le condizioni di vita degli abitanti. L’aspettativa di vitaera bassa; si è riscontrata un’alta mortalità infantile; dei nati, unosu tre raggiungeva l’adolescenza, pochissimi erano i sessantenni.Ogni donna aveva in media sei figli, due dei quali morivano neiprimi tre anni, uno o due arrivavano a venti, e due o tre diventa-vano adulti. La necropoli viene “messa in scena” con una rico-struzione che consente al visitatore di camminare sullariproposizione del sentiero che la attraversava e di assistere allecerimonie, riproposte con filmati, con cui la comunità accompa-gnava i defunti nel mondo ultraterreno.
Luigi Silvi
ME QUELLI DELLA PIANURA DI ILIOi Musei, Museo Civico Archeologico Etnologico (Modena)
22
Ar cheologia
Porzione della Necropoli della Terramare di Casinalbo ricostruita nel Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena.
24
Ar cheologia
Urna cinerararia, 1450-1200 a.C., dalla Necropoli della Terramara di Casinalbo, Modena, Museo Civico Archeolo-gico Etnologico.
25
Ar cheologia
Urna cinerararia, 1200 a.C. ca, dalla Necropoli della Terramara di Casinalbo, Modena, Museo Civico ArcheologicoEtnologico.
26
Ar cheologia
Nel vasto panorama dei gruppi etnici mi-nori dell’Italia antica, uno in particolare haattirato l’attenzione degli studiosi senzamotivi, all’apparenza, eclatanti. L’ethnos fa-lisco è stato oggetto, sin dal XIX secolo, diun’attenzione che può sembrare eccessivarispetto alla sua reale consistenza storica eterritoriale. I Falisci erano schiacciati tra La-tini, Etruschi e Sabini, allora le tre maggioripotenze dell’Italia centrale. Al di là dellastrenua difesa fino al suicidio alla romaniz-zazione, i Falisci rivestono un ruolo di fattomarginale nell’Italia preromana. La posi-zione di confine però li rende, oltre chestato cuscinetto tra i tre popoli maggiori epiù ambiziosi, catalizzatore culturale. Ilnome della popolazione, dal termine in-doeuropeo pal/tal che indica un’altura arro-tondata, è in stretto collegamento conl’ambiente occupato, spiccatamente colli-nare, e situato nel punto di convergenzadelle principali vie commerciali. Tale posi-zione di quasi perenne assedio fu rafforzatadalla natura fieramente “indipendente”degli abitanti. Luogo di passaggio obbli-gato, diviene sorta di tessuto spugnoso epermeabile, dove tutto transita e viene trat-tenuto a costituire una contaminatio onni-comprensiva. Ne nacque una culturaoriginale dagli esiti propri, caratterizzatadal gusto “sovraccarico”, che faceva proprigli stimoli provenienti dai popoli vicini inun prodotto “multietnico”. Da questo, lafortuna dei Falisci. L’Ager Faliscus occupavala regione tra i Monti Cimini, il Tevere, illago di Vico e quello di Bracciano, per un’e-stensione di 400 chilometri quadri; confi-nava a nord con l’orvietano, a ovest con ilterritorio di Tarquinia, a sud con quello diVejo e con l’Ager Capenas (Agro Capenate), aest con Umbri e Sabini. Corrispondeva inparte all’attuale provincia di Roma, in partea quella di Viterbo: era contiguo al territo-rio degli Etruschi di Vejo e, oltre il Tevere, aquello dei Latini e dei Sabini. Secondo latradizione, i Falisci ebbero origine da Hali-sco, figlio di Agamennone. Furono assog-gettati da Roma nel III secolo a.C. Lacapitale era Falerii, oggi Civita Castellana,considerata colonia argiva, risalente al IXsecolo a.C.; era collegata con Fidene. I Fali-sci subiscono sul piano culturale l’influssodeterminante di Etruschi e Latini. La lingua
falisca è un dialetto latino, con forti in-fluenze etrusche; l’alfabeto, di provenienzaetrusca, ha importanti punti di contatto conquello latino: il futuro terminante in fomanca nei dialetti tosco-umbri, si trova in-vece con la forma bo in latino. Il popola-mento si organizza lungo il corso del fiumeTreja in abitati piccoli e medi, dipendenti daFalerii. Dall’VIII secolo a.C. si distinguonoaltri centri di dimensioni minori: Cor-chiano, Vignanello, Fescenium (Narcepresso Calcata). Nel VII-VI secolo a.C. è co-stante il riferimento alla cultura etrusca-ti-berina: tombe a camera con arredi edecorazioni interne in tufo. Anche la morfo-logia vascolare è improntata a modelli etru-sco-meridionali, con impasto lucidorossastro, decorato a graffito con motivigeometrici, o derivati dalla cultura figura-tiva orientalizzante, rielaborati in un pecu-liare stile fantastico. Dal V secolo a.C. nasceuna tradizione coroplastica per le decora-zioni templari (Falerii e Narce); dalla finedel IV secolo a.C. si sviluppano vasi a fi-gure rosse, la cui produzione viene detta fa-lisca, derivata da quella attica.L’esposizione consente di conoscere lagrande quantità di materiali, provenientidai depositi del Museo Archeologico di Fi-renze, coinvolta pesantemente nell’allu-vione del 1966. È l’occasione per lasistemazione e la riedizione di oltre otto-cento reperti, ricostituendone i contesti, tra-mite il confronto con i dati di acquisizione.La mostra presenta un’ampia selezione dicorredi funebri falisci e capenati, acquisitida Luigi Adriano Milani negli ultimi annidel XIX secolo. La collazione, tra documentid’archivio e materiali stessi, ha consentitodi ricostruire, nella loro interezza, nume-rosi complessi, databili tra la fine dell’etàdel bronzo e la romanizzazione dell’area.Sono stati realizzati dei diorami in 3D didue delle tombe di Narce, sulla base dei di-segni inviati dagli scavatori a Milani. Da se-gnalare il “gossip” archeologico sullacosiddetta “guerra dei Musei”, che videcontrapposti, alla fine del XIX secolo, ilMuseo Nazionale Etrusco di Villa Giulia aRoma e il Museo Centrale dell’Etruria a Fi-renze, combattuta a colpi di offerte agli an-tiquari e di interpellanze parlamentari.
Luigi Silvi
CULTURA FALISCA SOLO APPFALISCI-IL POPOLO DELLE COLLINE. MATERIALI FALISCI E CAPENATI AL MUSEO ARCHEOLOGICO
27
Ar cheologia
APPARENTEMENTE MINOREOGICO NAZIONALE DI FIRENZE, Museo Archeologico Nazionale (Firenze)
31
Ar cheologia
Corredo della Tomba 13 di Corchiano, VII secolo a.C., Firenze, Museio Archeologico Nazionale.
34
Ar cheologia
La gestione dei calendari presso i romaniantichi era appannaggio del pontifex maxi-mus , ossia del cittadino che rivestiva lamassima carica religiosa. A lui spettava lagestione dei Fasti Consolari e delle inter-calazioni. Il più antico calendario, di tipolunare, era attribuito a Romolo: contavadieci mesi, quattro di 31 giorni e sei di 30,per un totale di 304. Secondo la tradizione,fu successivamente riformato da Numa. Inorigine celato al popolo, il calendario fupubblicato per la prima volta nel 304 a.C.presso il Foro. A causa dell’arbitrio deisuoi predecessori e all’omissione di alcuneintercalazioni, con la conseguenza che aun certo punto non si ebbe più coincidenzatra calendario e tempo astronomico, Giu-lio Cesare, nelle vesti di pontifex maximus,dovette intervenire riformandolo ancorauna volta e in maniera importante – si con-sideri che quello attuale, modificato daAugusto nell’8 a.C. e da Gregorio XIII nel1582, si basa ancora sul calendario giu-liano. Ottaviano Augusto, anche lui ponti-fex maximus dal 12 a.C., mise dunque manoal computo del tempo, anche se mosso daaltri scopi. La mostra vuole sottolineareproprio tale aspetto: la rivoluzione messain atto dal princeps grazie al quale compa-riranno, accanto a quelle antiche puntual-mente celebrate, le nuove feste associate amomenti topici della vita di Augusto e diquella dei componenti la sua famiglia. Eproprio qui stava la novità. Se prima delsuo intervento il calendario celebrava sol-tanto feste in onore degli dèi, adesso com-parivano ricorrenze che riguardavanol’imperatore e il suo entourage. Facendoneun uso spregiudicato, Augusto inserì festi-vità legate a vittorie, nascite, matrimoni,benemerenze, cariche religiose e civili. Perillustrare tali ricorrenze sono d’ausilio iFasti di Ovidio e il Feriale Cumanum, fontinelle quali si segnalano i seguenti eventi,
che trovano puntuali confronti nelle ResGestae Augustae : 7 gennaio, l’imperatoreAugusto assume i fasci per la prima volta;8 gennaio, viene dedicata una statua dellaGiustizia Augusta; 11 gennaio, l’impera-tore Augusto sconfigge i nemici e per laterza volta dai tempi di Romolo chiude iltempio di Giano; 13 gennaio, una corona diquercia viene posta sopra la porta dellacasa dell’imperatore per decreto del Se-nato, poiché egli ha restituito la repubblicaal popolo romano; 14 gennaio, giorno im-puro per decreto del Senato perché in que-sta data nasce Antonio; 16 gennaio,l’imperatore viene chiamato Augusto; 17gennaio, i pontefici, gli auguri, i quinde-cemviri sacris facicundis, i settemviri epulo-num immolano vittime al Numen diAugusto presso l’altare che gli dedicò Ti-berio Cesare; 29 gennaio, commemora-zione di un avvenimento ignoto che hacome protagonista Augusto pontifex maxi-mus; 30 gennaio, viene dedicata l’ara dellaPace Augusta in Campo Marzio; 5 feb-braio, l’imperatore, pontifex maximus, nellaventunesima tribunicia potestà, consoleper la tredicesima volta, viene chiamatodal Senato e dal popolo “padre della pa-tria”; 6 marzo, l’imperatore diviene ponte-fice massimo; 15 aprile, Aulo Irzio, avendocome collega Caio Cesare, vince a Modena;16 aprile, Cesare per la prima volta vienechiamato imperator; 28 aprile, una statua eun altare di Vesta sono dedicati nella casadell’imperatore Augusto; 26 giugno, l’im-peratore adotta Tiberio Cesare; 29 giugno,ricostruzione del tempio di Quirino sulcolle; 4 luglio, viene disposta la costru-zione dell’altare della Pace Augusta nelCampo Marzio; 1 agosto, l’imperatore Au-gusto libera la repubblica da un tristissimopericolo (probabilmente in riferimento allaconquista dell’Egitto); 10 agosto, viene di-sposta la costruzione degli altari alla
COMPUTO DEL TEMPO NELLA ROMA CLASSICARIVOLUZIONE AUGUSTO. L’IMPERATORE CHE RISCRISSE IL TEMPO E LA CITTÀ, Palazzo Massimo alle T
35
Ar cheologia
NELLA ROMA CLASSICAsimo alle Terme
Fasti Prenestini, 3-9 d.C., marmo, Roma, Museo Nazionale Romano, Palazzo Massimo alle Terme.
36
Ar cheologia
Rilievo con rappresentazione dei segni zodiacali, prima età imperiale, marmo bianco a grana fine, h cm 30, lar-ghezza cm 27,2, profondità max cm 5,7, Roma, Museo Nazionale Romano, già nella collezione del Museo Kircheriano.
37
Ar cheologia
madre Cerere e a Opi Augusta in seguito aun voto; 14 agosto, trionfo di Augusto; 18agosto, dedica del tempio intitolato alDivo Giulio presso il Foro; 19 agosto,primo consolato di Cesare; 28 agosto, l’aradella Vittoria viene dedicata all’internodella Curia; 1 settembre, inaugurazionedel tempio dedicato a Giove tonante inCampidoglio; 2 settembre, l’imperatoreAugusto, figlio del Divo Cesare, vincepresso Azio; 3 settembre, Augusto riportauna vittoria in Sicilia; 17 settembre, onoricelesti vengono decretati dal Senato alDivo Augusto; 23 settembre, nascita del-l’imperatore Augusto; 9 ottobre, viene de-dicato il tempio di Apollo sul Palatino; 12ottobre, Augusto di ritorno dalle provincetransmarine entra a Roma e viene dispostala costruzione dell’altare della Fortuna Re-duce; 19 ottobre, il Divo Augusto assumela toga virile; 23 ottobre, l’imperatore Au-gusto vince a Filippi e nella battaglia suc-cessiva è ucciso Bruto; 15 dicembre, vienededicata l’ara della Fortuna Reduce. La ri-scrittura del calendario rappresentò difatto uno degli strumenti di cui Augustodispose per affermare il proprio potere.Tale rivoluzione si inserisce pertanto nelpiù ampio disegno messo a punto da Otta-viano Augusto, divenendo efficace stru-mento di propaganda: gli eventi cheriguardavano l’imperatore erano proiettatisulla vita dei cittadini romani, i quali ave-vano il diritto di prendervi parte. Il calen-dario scandiva, oltre al tempo, la vitaassociativa della città e i romani tuttierano chiamati a partecipare in prima per-sona. La trasformazione del calendario ri-voluzionò il tempo pubblico, sociale ereligioso della Roma antica, che fu riorga-nizzata anche dal punto di vista topogra-fico. La piccola esposizione sui fastinell’antichità classica si inserisce nell’am-bito delle iniziative per il bimillenario au-gusteo promosse dalla città di Roma,all’interno di una istituzione museale checonserva notevoli reperti della prima etàimperiale. Si pensi, per esempio, ai prege-
voli affreschi della Villa di Livia e a quellidalla Villa della Farnesina, che fu abitatasecondo gli studiosi da Giulia, figlia diAugusto. Si tratta di una mostra allestitasfruttando le risorse del museo che laospita (come, per esempio, le lastre deiFasti Antiates e dei Fasti Praenestini) epochi reperti arrivati in prestito da altriluoghi. Una mostra di interesse scientificoche però si esaurisce ben presto con i suoiventi pezzi, pensata in queste dimensioni“per non annoiare”. Il catalogo colmasenza dubbio le lacune di un evento realiz-zato in maniera veloce; tuttavia, la sensa-zione di chi visita la mostra è di essere difronte a un’occasione nella quale si sa-rebbe potuto sviluppare più diffusamenteun tema articolato come quello dei calen-dari. Al “tutto qui?” pensato da chi giungeentusiasta a vedere la mostra dove Augu-sto dovrebbe essere protagonista, si ag-giunge la confusione nella ricercaall’interno dell’intero percorso espositivodei pezzi riferibili alla prima età impe-riale, peraltro neanche messi in evidenzacon l’ausilio, per esempio, di una segnale-tica creata ad hoc. Insomma, nell’ambitodelle iniziative per la celebrazione del bi-millenario della morte di Augusto, che in-vero hanno deluso in generale leaspettative – si è pur sempre a Roma –, siintuisce a Palazzo Massimo la difficoltà diporre in collegamento, al di là dell’aspettocronologico, la rivoluzione augustea delcalendario oggetto della mostra e le moda-lità abitative dell’aristocrazia romana illu-strate da affreschi e mosaici di notevoleinteresse, attestati nel museo romano. Ilvolumetto Le donne di Augusto , che sullosfondo degli affreschi della Villa di Liviae di quelli della Casa della Farnesina trattadella terza moglie di Augusto e di Giulia,pubblicazione uscita insieme con il cata-logo della mostra, si rivela come unospreco di risorse, non fornendo nulla dinuovo né sulle domus né sui personaggiche le abitarono.
Serena Epifani
38
Base con rami di platano e bucrani, età augustea, marmo bianco a grana fine, lunense, h cm 73, larghezza cm 95, profondità cm 76, Roma, Museo Nazionale Romano, Palazzo Massimo alle T
40
Ar cheologia
Rilievo con rappresentazione della triade capitolina, tardo I secolo a.C., marmo; h cm 77, larghezza cm 103, già collezione Albani, ora Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, Antikensammlung, Staatliche Museen Zu Berlin-Prsischer Kulturbesitz © ph.Johannes Laurentius.
41
Ar cheologia
zione Albani, ora Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, Antikensammlung, Staatliche Museen Zu Berlin-Preus-
42
Ar cheologia
Rilievo con raffigurazione del tempio di Quirino, età flavia, marmo pentelico, h max cm 40, larghezza max cm31, profondità max cm 17, Roma, Museo Nazionale Romano, Palazzo Massimo alle Terme.
43
Ar cheologia
Rilievo con Vittoria e trofeo, ultimo trentennio del I secolo a.C., marmo greco; h cm 55, larghezza cm 44, Roma,Museo Nazionale Romano.
44
Lastra con Luperci, età augustea, lastra fittile, h max cm 35, larghezza max cm 29,5, spessore cm 2,5 (cm 3-3,2 in corri-spondenza della testa più sporgente), Roma, Museo Nazionale Romano, Palazzo Massimo alle Terme.
45
Ritratto di Augusto con corona civica, circa 40 d.C. marmo, h cm 45, presenti tracce di colore, Saintes, Museo Ar-cheologico, Collections des Musées de la Ville de Saintes, Jean-Bernard Forgit, Ville de Saintes.
46
Ar cheologia
Ritratto di Livia, 20-10 a.C., marmo bianco a grana fine, h cm 30,5, Roma, Museo Nazionale Romano, PalazzoMassimo alle Terme.
52
Ar cheologia
INSULA VOLUSIANA
Insula Volusiana, resti complesso edilizio, Roma, vico Jugario, II secolo d.C., (foto Marina Humar).
53
Ar cheologia
Nella zona del Foro Boario su via Petrosellisorge un edificio sede del XII Dipartimentosviluppo infrastrutture e manutenzione ur-bana, che conserva al suo interno il com-plesso edilizio dell’Insula Volusiana.Riportata alla luce alla fine degli anni ’30del ‘900, i suoi resti sono stati per moltianni trascurati e dimenticati, per la pre-senza nelle vicinanze della più importantee più conosciuta area sacra di Sant’Omo-bono, con i due templi dedicati alla For-tuna e alla Mater Matuta, divinità veneratagià in età regia. Finora c’erano state pochis-sime notizie riguardanti quest’area: glistudi di Antonio Maria Colini del 1937 con-tenevano soltanto qualche accenno alla via-bilità della zona e al diverticoloproveniente dal vicus Iugarius, indaginisuccessive si limitarono alla topografia del-l’area fino al 1982 quando il Professor Sil-vio Panciera riprese in esame l’epigrafeincisa su un cippo di travertino, rinvenutonel complesso edilizio e ancora conservatoin situ, che ha dato il nome all’insula. L’epi-grafe, pubblicata nel Corpus InscriptionumLatinarum (CIL VI 40887), fa riferimentoalla concessione da parte di Augusto disuolo pubblico per la costruzione del com-plesso. Il cippo che misura cm 82 x 63 x 46,in origine era stondato nella parte supe-riore, ora appare scheggiato e lacunoso.IMP [CAESAR DIVI F] / AVG [COS] VI [IA]D[TRIBVIT] / TI CLAVD CAESAR AV[G]/ GERM PONTIF MAX TRIB / PO[T]ESTVIII IMP XV P P/L VITELLIVS CENSO-RES/COGNITA CAVSA AD / TRIBVTIO-NEM DIVI / AVG PERTINENTEM AD /INSVLAM VOLVSIANAM/CON[FI]RMA-VERVNT - Imp(erator) Caesar divi f(ilius)/Aug(ustus) co(n)s(ul) VII adtribuit/ Ti(berius)Claud(ius) Caesar Aug(ustus)/ Germ(anicus)pontif(ex) max(imus) trib(unicia)/ potest(ate)VIII imp(erator) XV p(ater) p(atriae)/ L(ucius)Vitellius censores/ cognita causa ad /tributio-nem divi/ Aug(usti) pertinentem ad insulam
Volusianam confirmaverunt. (Traduzione -L’imperatore Cesare Augusto figlio del di-vino console per la VII volta concesse (ilsuolo pubblico) - Tiberio Claudio CesareAugusto Germanico pontefice massimo(l’anno della) VIII tribunicia potestàXV(volte) imperatore padre della patria eLucio Vitellio censori riesaminata la que-stione confermarono la concessione deldivo Augusto alla pertinenza dell’insulaVolusiana). Nella formula onomastica del-l’imperatore Gaius Iulius Caesar Ottavianusvi è il titolo di Augustus che gli fu conferitoil 16 gennaio del 27 a.C., data a cui ri-manda anche la citazione del VII consolato.La prima concessione di suolo pubblico perla costruzione dell’insula può esserequindi datata perciò agli anni 27 e succes-sivi fino al 25 a.C. anno dell’VIII consolato.Il testo tuttavia risale all’età dell’Impera-tore Claudio (41-54d.C.) e più precisamenteagli anni 47-48 per il riferimento alla XVacclamazione imperatoria e alla carica dicensor insieme a Lucio Vitellio il vecchio,uomo politico nato a Nuceria Alfaterna (5a.C.-51 d.C.). Per quanto riguarda il pro-prietario del complesso in esame, si puòipotizzare fosse il ricco e potente Lucio Vo-lusio Saturnino, di antiche origini, che ri-coprì per molti anni la prefettura urbanaed ebbe una lunga carriera politica. Vienericordato anche da Tacito negli Annali(3,30,2) come primus adcumulator per leenormi ricchezze accumulate che costitui-rono enorme prestigio per la sua famiglia.La gens Volusia era una famiglia senatoriapoliticamente molto importante, si trasferìa Roma da Cingoli nel Piceno nel I secoloa.C. e incentivò l’insediamento della colo-nia di Lucus Feroniae. Quintus Volusius,padre di Lucius Volusius Saturninus, feceedificare la sua villa presso Fiano romanonel 50 a.C. fu ampliata dal figlio. Recente-mente il complesso edilizio nei pressi delvico Iugario è stato oggetto di uno studio
VOLUSIANA
54
Ar cheologia
più approfondito da parte del Diparti-mento di Scienze dell’Antichità, con la di-rezione scientifica di Eugenio La Rocca. Siè proceduto a un rilievo planimetrico e ariprese aeree e fotografiche dell’area ar-cheologica. Nel cortile dell’edificio, oraadibito a sede degli uffici, dove è stato rin-venuto il cippo con l’iscrizione, è visibileancora un tratto di strada basolata con di-rezione Nord-Sud sulla quale si affaccianoi resti di alcune costruzioni laterizie del IIsecolo d.C. Ad ovest della strada sono con-servate le vestigia di un porticato laterizioad arcate, di cui due sono conservate perintero, mentre delle altre rimangono solola parte inferiore dei pilastri. A Est sonoidentificabili quattro ambienti di età impe-riale, che si affacciavano sul diverticolo.Uno di questi, di m 6,40 x 2,60, delimitatoda due setti murari con direzione Est-Ovest, conserva lacerti del pavimento mu-sivo a tessere bianche e nere con motivigeometrici a squame, il tutto chiuso dacornici alternate bianche e nere di varia di-mensione. Il motivo a squame consente didatare il mosaico alla metà del III secolod.C. I resti del complesso edilizio sono didifficile lettura, sia per la stratificazionedelle strutture, dall’età imperiale quellamedioevale e quella moderna, sia per laframmentarietà della conservazione. Tuttala zona, oggetto di scavi recenti, fu ampia-mente utilizzata in età imperiale, vi furonocostruite insulae e tabernae, riportate allaluce anche nell’area di Sant’Omobono elungo la via che si dirige verso il Palatinoe che possono essere messe in relazionecon il rifacimento del complesso portuale(inizio II secolo) lungo la riva del Tevere.Probabilmente al complesso di magazzinie insulae è collegabile e anche l’edificio chesi estendeva tra il vicus Iugarius e il vicusTuscus, rinvenuto durante gli scavi inpiazza della Consolazione. Il complesso siarticola in vari ambienti in opera lateriziacon volte a botte o a crociera, alcuni pavi-menti in opus spicatum o con mosaici a mo-tivi geometrici. Altri ambienti concaratteristiche simili al complesso de-scritto sono tornati alla luce sotto l’exOspedale della Consolazione, oggi sededel Comando dei Vigili urbani.
Marina Humar Insula Volusiana, resti complesso edilizio, Roma, vico Jugario, II
56
Ar cheologia
Insula Volusiana, complesso edilizio resti di murature, Roma, vico Jugario, II secolo d.C., (foto Marina Humar).
Insula Volusiana, complesso edilizio resti di colonna, Roma, vico Jugario, II secolo d.C., (foto Marina Humar).
60
Insula Volusiana, complesso edilizio resti arcata del portico, Roma, vico Jugario, II secolo d.C., (foto Marina Humar).
62
Insula Volusiana, complesso edilizio resti portico con arcate, Roma, vico Jugario, II secolo d.C., (foto Marina Humar).
Insula Volusiana, resti complesso edilizio cippo di travertino con epigrafe (dettaglio), Roma, vico Jugario, II secolo d.C., (foto Marina Humar).
68
Insula Volusiana, complesso edilizio cippo di travertino con epigrafe (dettaglio), Roma, vico Jugario, II secolo d.C., (foto Marina Humar).
71
Ar cheologia
Napoli è una città che si è sviluppata con-temporaneamente in positivo e in negativo.Il suo sviluppo urbano è in stretta rela-zione con la città sotterranea rimasta se-greta per secoli, visitare il sottosuolo èscoprire il passato della città attraverso levestigia archeologiche, le opere architetto-niche e i capolavori di ingegneria idrau-lica. Il sottosuolo di Napoli è costituito datufo, pozzolana e lapillo, notevole risorsaper l’edilizia della città e per tutte le operedi fortificazione. Oltre i noti percorsi della“Napoli sotterranea”, ai quali si accede dapiazza San Gaetano e da piazza Trieste eTrento e quello di San Lorenzo Maggiore,in cui sono visibili i resti dell’antico mer-cato di Neapolis, è da poco possibile per-correre il Tunnel Borbonico, a cui si accededa Vico del Grottone, alle spalle di piazzadel Plebiscito o più comodamente dal par-cheggio Morelli in piazza Vittoria. Il tun-nel, che doveva unire Palazzo Reale conpiazza Vittoria, vicino al mare, in caso dipericolo, sarebbe stato una sicura via difuga per la famiglia reale. Fu commissio-nato nel 1853 all’architetto Alvino dal redelle Due Sicilie Ferdinando II di Borbone(1810-1859), noto anche per la costruzionedella Ferrovia Napoli-Portici, prima in Ita-lia. Il viadotto, passando sotto il “monte”Echia, alto circa 60 metri sul livello delmare, doveva essere anche un percorso mi-litare per le truppe poste a difesa della reg-gia. Lo scavo, con sezione trapezoidale nelmasso tufaceo, prevedeva due gallerie, cia-scuna di quattro metri di larghezza, sepa-rate da un parapetto e con marciapiedilaterali di due metri, che dovevano essereilluminate da lampioni a gas. “StradaRegia o galleria reale” era il nome dellagalleria diretta a Chiaia, mentre l’altra, indirezione opposta, si sarebbe chiamata“Strada Regina”, ma lo scavo di quest’ul-tima non fu mai iniziato. Da via DomenicoMorelli, un tempo via Pace, fu iniziato loscavo di due condotti, uno pedonale e l’al-tro carrabile, fino a incrociare un cunicolo,pertinente l’acquedotto della Bolla. Per evi-tare di interrompere l’erogazione dell’ac-qua, furono fatti impegnativi interventiidraulici e fu approfondito lo scavo dellegallerie, ma, proseguendo nei lavori, iltunnel incrociò anche le Cave Carafa, uti-
lizzate per la costruzione degli edifici so-praterra già dal ‘500 e alla fine del ‘700sfruttate per costruire la chiesa della Nun-ziatella, dei Padri Gesuiti, poi divenutacollegio militare. Per la presenza di pro-blemi statici, l’architetto Alvino fu co-stretto a creare, per sicurezza, dei modulitrasversali in muratura, costituiti da archi.Lungo il percorso le gallerie rasentaronoanche due cisterne pertinenti alla reteidrica seicentesca. Per ovviare problemi dirifornimento dell’acqua alla zona sopra-stante di Pizzofalcone, venne realizzato, al-l’altezza di otto metri dal fondo dellacisterna, un ponte e furono innalzati muriin laterizi per evitare eventuali allaga-menti, causati dalla presenza di altri pozzi.Lo scavo però non arrivò mai al Palazzoreale: fu portato avanti solo fino a piazzaCarolina, alle spalle di piazza del Plebi-scito e rimase così senza uscita. Erano pre-visti due pozzi di areazione, ma solo unofu terminato e contro le intrusioni, furonoinnalzati due archi in muratura di dodicimetri. Tutti questi lavori, che durarono treanni, furono realizzati a mano, come è pos-sibile dedurre dai segni lasciati dai picconisulle pareti. Il 25 maggio 1855 vi fu l’inau-gurazione del primo tratto alla presenzadel Re Ferdinando II, ma lo scavo non fupiù continuato, sia per motivi economiciche politici, che culminarono con la cac-ciata del re e la successiva caduta delRegno delle due Sicilie. Il tunnel rimasecosì dimenticato fino alla seconda guerramondiale, quando le cisterne e le galleriesotterranee furono riutilizzate come rico-vero bellico e rese accessibili attraversouna scala a chiocciola in ferro, che ancorasi conserva. Dopo la guerra questo spaziodivenne un deposito del Comune di Napolie come tale fu utilizzato fino al 1970. Legallerie vennero colmate con le macerie deibombardamenti e dei crolli e divennero poideposito per i veicoli sequestrati e affidatial Comune. Tutto fu poi abbandonato finoal 2007, quando dei geologi cominciaronoa studiare il sottosuolo del centro dellacittà. L’accesso era reso complesso dallagran mole di detriti e rifiuti accumulati,alti più di otto metri. Furono così scopertiil ricovero bellico e gli accessi usati già nel‘600 dai “pozzari” per la manutenzione
OLI RINASCE IL PASSATO
dell’acquedotto. Furono ritrovati luce mo-toveicoli, vespe e lambrette, autoveicoli,tra cui una Fiat 508 Balilla, un’Alfa Romeocabriolet Pinin Farina e un Taxi- Fiat 1100verde e nera. Il pezzo più “spettacolare” èil pezzotto motoveicolo per il trasportodella merce, realizzato assemblando varipezzi di altri veicoli e per questo seque-strato. Sotto rifiuti di ogni genere sonoemersi anche pezzi di statue del regime,come quella di Aurelio Padovani, fonda-tore del partito Fascista napoletano, chenel 1934 era in piazza Santa Maria degliAngeli a Pizzofalcone. Il geologo GianlucaMinin, presidente dell’Associazione Bor-bonica sotterranea, pensò di rendere visi-bile a tutti la Galleria Borbonica e gliambienti limitrofi e iniziò con altri volon-tari l’opera di riqualificazione dell’area.Oggi l’Associazione organizza visite gui-date alla Galleria Borbonica: per accederviviene utilizzata una scala del ‘700, che i“pozzari” usavano per scendere nei cuni-coli dell’acquedotto Carmignano, cheriforniva d’acqua la città ed in particolarela zona di Pizzofalcone. Scesi i 75 gradinie percorsa la galleria, si entra negli am-bienti utilizzati come rifugio bellico. Visono conservati e rimessi in funzione l’an-tico impianto elettrico, con isolanti in por-cellana e lampadine da 12 watt, e unasirena per la segnalazione delle incursioniaeree. La penombra e il suono della sirenaprovocano un senso di angoscia. In un am-biente sono conservate brande in ferro eoggetti relativi a un’infermeria da campo,alcuni servizi igienici e alcuni giocattoliche attestano la presenza anche dei bam-bini nel rifugio. Entrando da Vico delGrottone, si raggiunge una piccola ci-sterna, percorrendo un cunicolo che recatestimonianze dell’attività dei “pozzari”,che hanno lasciato sulle pareti croci incisenella malta. Un secondo cunicolo porta alponte dei Borboni e alla grande cisterna,alla quale si accede con una scala in ferro.Si percorre poi su una zattera la falda ac-quifera sotterranea che scorre nella galle-ria mai terminata e abbandonata dellalinea tranviaria rapida di Napoli. Percor-rendo infine un tratto della Galleria Bor-bonica, si esce attraverso la scala achiocciola utilizzata per accedere ai rifugidurante la guerra. Accessibile a tutti emeno “faticoso” è il percorso con ingressodal parcheggio Morelli.
Marina Humar
72
Ar cheologia
Galleria Borbonica, archi di sostegno.
90
Miscellanea
Modena è città profondamente legata alle libertàcomunali e la continuità di presenza di un go-verno cittadino ha limitato, spingendolo in unazona di penombra, il potere superiore del Ducatoestense. Dopo la devoluzione di Ferrara allo StatoPontificio, gli Estensi trasferiscono la capitale delDucato a Modena nel 1598. Ma l’impressione piùdiffusa è che la città offra un’immagine che nonriconosce nella sua completezza il merito di casad’Este di averla resa una capitale padana, in par-ticolare con il Palazzo Ducale del XVII secolo,degno delle maggiori corti europee. La mostracon tema “la gloria” propone le figure di quattroduchi vissuti tra XV e XIX secolo, emblematici dialtrettanti aspetti della gloria politica e militare.La loro celebrità muta in rapporto al mutare dellasituazione storica e politica, e in funzione dellevirtù e delle caratteristiche personali. Alfonso I(1476-1534), il cui ducato coincide con una fasedurante la quale il Ducato godette di maggior ma-gnificenza e prosperità, quando la capitale era an-cora Ferrara; egli rappresenta la durevolezzadell’onore militare. Alfonso I, figlio di Ercole Iebbe fama di grande condottiero in vita e talefama gli sopravvisse: diviene simbolo della glo-ria conquistata sui campi di battaglia alla guidadelle proprie truppe. La sua figura entra nelPantheon dinastico estense assieme a quelle delcapostipite Azzo, di Borso, di Ercole I e la sua im-magine viene ricordata accanto a quella deigrandi uomini d’arme. Alfonso passa alla storiaper aver sconfitto a Polesella nel 1509 la Serenis-sima le cui navi si erano impunemente addentratelungo il corso del Po verso Ferrara. Quale mece-nate sostenne Ludovico Ariosto, Tiziano e DossoDossi. Sono esposti un ritratto (1534-1536), operadi Nicolò Luteri detto Battista Dossi, un altro(1524-1528) di Dosso Dossi; un’edizione a stampadel Liber de vita et rebus gestis Alphonsi Atestini Fer-rariae princpis di Paolo Giovio; sempre del GiovioElogia virorum bellica virtute illustrium e il De re mi-liari di Sextus Iulius Frontinus, Vegetius ed Aelia-nus del I secolo d.C. che ebbe larga fortuna pertutto il Medio Evo. Alfonso III (1591-1644), poiFra’ Giovanni Battista da Modena, sceglie di ve-stire l’abito cappuccino e di abdicare a favore delfiglio Francesco I, caso eclatante tra le dinastieprincipesche italiane; ultimo duca degli Este natoa Ferrara, dal temperamento energico e natural-mente portato al comando, sposò Isabella di Sa-voia, da cui ebbe quattordici figli. Durante gliultimi anni del ducato paterno, Alfonso ebbe cre-scente influenza nell’amministrazione e dimostròinclinazione e attitudini al governo. La morte di
Isabella a soli 35 anni lo lasciò in stato di profondaprostrazione che lo spinse a prendere i voti. Ri-chiamato a Modena, si ingerì nell’attività di go-verno del figlio, finché non si ritiròdefinitivamente in un convento della Garfagnana.Esposto un suo ritratto (1635) di Matteo Loves;un’opera di Nicolò Azzi che lo ritrae sul catafalcoe un’altra che raffigura nella stessa condizione lamoglie Isabella. Francesco III (1698-1780) è legatoall’avvenimento più infausto della storia della suadinastia. Nel 1746 vendette all’Elettore di Sasso-nia Augusto III i cento migliori capolavori dellaquadreria estense, segno questo delle difficoltà incui versava il ducato; sposò Carlotta Aglae, figliadi Filippo d’Orléans, reggente di Francia, e co-strinse il figlio a un matrimonio dinastico conMaria Teresa Cybo Malaspina: aggiunse così alducato anche quello di Massa, ottenendo in talmodo uno sbocco al mare. Sulla piazza, dove oggisorgono i palazzi che ospitano i musei, riuscì nel1764 a realizzare una propria statua equestre, pereccellenza emblema dell’eroicità dell’effigiato e in-dicante sin dall’antichità classica il condottiero vit-torioso. Il tanto agognato monumento fu distruttosolo ventidue anni dopo dalla furia dei rivoluzio-nari francesi: di esso si conserva solo un piede,esposto in mostra. Francesco IV (1779-1846),primo duca d’Austria-Este; organizzò il ducatomilitarmente, rendendosi inviso alla popolazione.La mostra propone due tele di Gaspare Venturini,Allegorie di casa d’Este (1592-1593), due dipinti cheassieme ad altri, ora dispersi, decoravano la bi-blioteca di Cesare d’Este (1562-1628) a Palazzo deiDiamanti a Ferrara. Il programma decorativoesaltava le virtù del principe e gli effetti del buongoverno; dei due qui esposti uno raffigura l’aquilaestense in trionfo su una quadriga accompagnatadalle virtù e da geni alati sonanti trombe, nell’al-tro esseri deformi e mostruosi sono calpestati dafigure allegoriche tra le quali al centro la Gloriadei principi. Ancora scettri, bastoni di comando emazze d’armi, simboli del potere, esaltano virtùbelliche, eroismo, gloria in battaglia e le onorifi-cenza che ne sanciscono il riconoscimento pub-blico. Un’edizione del 1513 del De Bello Gallico diGiulio Cesare riferita alla gloria militare e alle dotidi stratega di Alfonso I e per le stesse ragioni il Dere militari di Valtruvio, scritto dall’autore in latinotra il 1446 e il 1475 per commissione di Sigi-smondo Pandolfo Malatesta signore di Rimini: l’o-pera, notissima, diffusa e apprezzata, contienesplendide immagini di macchine da guerra, ope-razioni e apparati militari.
Luigi Silvi
GLORIA E FAMA DURAGLI ESTE E LA GLORIA. AMBIZIONI E RINUNCE, Musei Civici – Sala Boni (Modena)
91
Miscellanea
MA DURATURE
Scettro a mo’ di “mazza d’arme”, manifattura asutriaca, XV secolo, diaspro sanguigno, cm 1 x 151, Modena, Galleria Estense.
92
Miscellanea
Mazza d’arme, manifattura europea (Italia del Nord?), XVI secolo, acciaio, cm 58,5, Miodena, Galleria Estense.
Bastone di comando, manifattura italiana, XVI secolo, legno, cm 1 x 72, Modena, Galleria Estense.
Roberto Valturio (Rimini 1405, Rimini 1475), De re militari, 1483, Modena, Biblioteca Estense Universitaria.
94
Miscellanea
Sextus Julius Frontinus...De re militari, Flauius Vegetius...De re militari. Modena, Bilbioteca EstenseUniversitaria.
95
Miscellanea
Gaius Julius Caesar (Roma 100 a.C., Roma 44 a.C.), Commentariorum de bello Gallico, Libri VIII, Ve-nezia,1513, Modena, Biblioteca Estense Universitaria.
96
Gaspare Venturini (Ferrara notizie dal 1576 al 1593), Allegiorie di Casa d’Este, 1592-1593, olio su tela, cm 37 x 115 ciascuno, Modena, Galleria Estense.
Battista Dossi (Battista di Nicolò Luteri detto) (documentato Ferrara 1517, Ferrara 1548), Ritratto di Alfonso I d’Este,1534-1536 ca, olio su tela, cm 147 x 113,5, Modena, Galleria Estense.
99
Dosso Dossi (Giovanni di Nicolò Luteri detto) (Tramuschio 1486 ca, Ferrara 1542), Ritratto di Ercole I d’Este, oliosu tela, cm 83 x 69, Modena, Gallerisa Estense.
100
Miscellanea
Paolo Giovio (Como 1483, Firenze 1552), Elogia virorum bellica virtute illustrium, Modena, Biblio-teca Estense Universitaria.
101
Matteo Loves (Colonia 1600 ca, Cento ? post 1662), Ritratto di fra Giovan Battista da Modena, giàduca Alfonso III d’Este, 1635, olio su tela, cm 280 x 176, Modena, Galleria Estense.
102
Miscellanea
Nicolò Azzi (documentato alla metà del secolo XVII), Fra Giovanni Battista da Modena già Alfonso III d’Este sul catafalco
104
Miscellanea
Pittore emiliano del XVII secolo, Isabella di Savoia d’Este sul catafalco, olio su tela, cm 123,5 x 227, Modena, Museo Civico d’Arte.
Alfonso Maresti (Ferrara ante 1708), Teatro geneologico et istorico dell’antche e illustri famiglie di Ferrara (di-segno per statua equestre del duca Ercole I d’Este su basamento sorretto da due colonna), 1681, Modena, BibliotecaEstense Universitaria.
107
Miscellanea
Per la solenne dedicazione della statua equestre innalzata dal pubblico di Modena all’immor-tale memoria dell’Altezza Serenissima di Francesco III gloriosamente regnante appalusi poe-tici... Modena 1774, Modena, Biblioteca Estense Universitaria.
Giovanni Temini (?, prima metà del XVII sec.), Serenissimus Franciscus Estensis Mutinae, Regii et Caet.adux, MDCXXXXIII..., calcografia, cm 42,7 x 28,2, Modena, Galleria Estense.
Giovanni Antonio Cybei (Carrara 1706, Carrara 1784), Modello per monumento equestre del duca France-sco III d’Este, 1772 ca, gesso patinato e bronzo, h cm 85, base cm 53 x 27, Modena, Galleria Estense.
Giovanni Antonio Cybei (Carrara 1706, Carrara 1784), Frammento del monumento equestre del duca Francesco III d’Este,
112
Ignoto del XVII secolo, Ritratto equestre del duca Francesco II d’Este. 1680-1690, legni di diversa essenza, osso,madreperla, inserti metallici, h cm 52, Modena, Galleria Estense.
113
Miscellanea
Andrea Baratta (Carrara 1639, Carrara 1700 ca), Ritratto equestre del duca Francesco II d’Este, 1685, marmo,h cm 110, Modena, Galleria Estense.
114
Miscellanea
Pietro Tenerani (Carrara 1789, Carrara 1869), Francesco IV d’Austria-Este inuniforme, 1846, gesso, cm 59, Modena Galleria Estense.
115
Miscellanea
Pietro Tenerani (Carrara 1789, Carrara 1869), Francesco IV d’Austria-Este in abito al-l’antica, 1846, gesso, cm 59, Modena Galleria Estense.
116
Miscellanea
TRATTATI DI RESPIRO EUROPEOPER IL BENE DELLA PACE. IL LUNGO CAMMINO VERSO L’EUROPA DALLA PACE DI BOLOGNA ALLA(Venezia)
1645, Venezia, Commissione del Doge Pietro Grimani e Antonio Diedo eletto ambasciatore ordina-rio all’Imperatore, Venezia, Biblioteca del Mueo Correr.
117
Miscellanea
La pace per la cultura europea è valore su-premo. L’Europa tutta è impegnata a realiz-zare strumenti politici, diplomatici elegislativi per impedire che una delle po-tenze continentali prenda il sopravventosulle altre, a ricercare quindi, attraverso trat-tati e accordi, una situazione di equilibrio ga-ranzia di pace, primariamente, ma anche disviluppo civile ed economico La mostra ve-neziana propone oltre settanta documenti eimmagini cartografiche dell’Europa, attintidal patrimonio documentario conservatopresso l’Archivio di Stato di Venezia, la Bi-blioteca e il Gabinetto cartografico del MuseoCorrer e dall’Archivio dell’Istituto Ellenicodi Venezia. Hanno collaborato alla realizza-zione di questo evento, oltre agli enti appenacitati, Centro Tedesco di Studi veneziani,Centro Pro Helvetia, Istituto Romeno di cul-tura e ricerca umanistica all’Università diWarwich, Fondazione Carlos Amberes e Isti-tuto Cervantes, Fondation Lombard Odier,Ecole Politecnique Fédérale de Lausanne, As-sociazione dei Cavalieri di San Marco e Assi-curazioni Generali di Venezia. Sono espostitrattati relativi alla Pace di Bologna (1529-1530) stipulata tra Impero, regno di Francia,Stato Pontificio e Venezia; quella di CateauCambrésis (1559) che mise fine alle guerred’Italia e al conflitto tra Asburgo e Francia;la pace di Ferrara (1644) che pose fine alla Iguerra di Castro tra Stato Pontificio e fami-glia Farnese siglata dagli stati italiani con lamediazione di Luigi XIV; quella di Westfalia(1648) alla fine della Guerra dei Trent’Anni;di Nimega (1678) tra Province Unite olandesie Regno di Francia; pace di Carlowitz (1699)che metteva fine alle guerra tra Lega Santa eImpero Ottomano; pace di Utrecht (1713) aconclusione della Guerra di Successione spa-gnola; pace di Rastatt (1714), appendice aquella di Utrecht stipulata tra Luigi XIV diFrancia e Carlo VI d’Asburgo; di Aquisgrana(1748) alla fine della Guerra di Successioneaustriaca. Si possono visionare i documentioriginali dei trattati che giungevano a Vene-zia grazie ai dispacci inviati dagli ambascia-tori della Serenissima. La mostra ripercorretre secoli di guerre per il predominio in Eu-ropa e quelle di religione, che appunto attra-
verso tali trattati tendevano a creare stabilità,mirando a un sistema di equilibrio tra Stati,quanto più duraturo possibile. Le potenzeeuropee sentivano forte la necessità di indivi-duare strumenti non bellici per evitareguerre distruttive. Alla base vi era il princi-pio, non ancora tramontato, che una pace du-ratura si fondasse su giustizia e sui valoriumanistici che ponessero il cittadino al cen-tro dell’azione di governo e legislativa diogni Stato. Vengono esposte anche le imma-gini dell’Europa, la continua ridefinizionedei confini, le corti d’Europa e quella vene-ziana, gli archivi della diplomazia: tre secoliattraversati da conflitti, ma segnati anche datrattati di alto respiro europeo. Fanno dasfondo le storie di Luigi XIV, di Carlo V, Pie-tro I il Grande, Maria Teresa d’Austria, am-basciatori, segretari, oratori, nunzi,monsignori, ministri plenipotenziari, tra iquali Jean-Baptiste Colbert, Giulio Mazza-rino, Armand-Jean du Plessis de Richelieu,Duca di Guisa, e Principe di Condè. La ras-segna è divisa in quattro sezioni: Imago Euro-pae, Venezia e le corti d’Europa: gli archivi delladiplomazia, L’Europa alla ricerca della pace, IGreci a Venezia: segni di convivenza pacifica. Larassegna prende avvio con una selezione dimateriale cartografico dalle raccolte delMuseo Correr; la cartografia nel corso dei se-coli ha contribuito a rafforzare e a mettere afuoco un disegno geografico familiare del-l’Europa; carte nautiche manoscritte di Siderida Candia e di Xenodocos di Corfù; raremappe cinquecentesche a stampa di Münstere Camocio, Sanudo e Ortelio, e quelle seicen-tesche di Bláeu, fino alle settecentesche peratlanti di Homann, Janvier e Zatta. Da sotto-lineare la presenza della Dichiarazione d’In-dipendenza delle colonie americane, fattapervenire al Senato da Giambattista Pizzonida Londra; nel 1795 l’Ambasciata venezianain Francia nella Parigi termidoriana fa perve-nire al Senato la Dichiarazione dei Diritti del-l’Uomo e del Cittadino. Tra le righe dei testiesposti si può leggere l’evoluzione delle leggie dei costumi alla luce della diplomazia edell’azione politica in funzione della ricercadella pace.
Luigi Silvi
ESPIRO EUROPEOLLA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO (1530-1789), Palazzo Ducale – Sala dello Scrutinio
118
Miscellanea
1669, Venezia, Indice della Secreta, dedicato a Domenico Contarini doge di Venezia, compilato da Antonio deNegri segretario e copiato da Giovanni Gasperini, con l’elenco delle serie archivistiche relative alla corrispon-denza trasmessa dagli ambasciatori al Senato, Venezia, Archivio di Stato di Venezia.
119
Miscellanea
1755, marzo 14, Vienna, Maria Teresa imperatrice e Francesco Loredan doge di Venezia stipulano accordi in materia di con-fini e servizio postale, Venezia, Archivio di Stato di Venezia.
1760, marzo 15, Venezia, Francesco Loredan, doge di Venezia, rilascia la commissione a Giovanni Domenico Almorò Tiepolo, eletto ambasciator
iepolo, eletto ambasciatore ordinario a Luigi XIV re di Francia, Venezia, Archivio di Stato di Venezia.
122
Miscellanea
1643, dicembre, Parigi, onorificenza concessa da Luigi XIV a Giovanni Grimani, ambasciatore straordinario , Venezia, Biblioteca Museo Corr
124
Miscellanea
Livio Sanudo, Europa, 1572, incisone su rame colorata, mm 360 x 532, Venezia, Museo Correr.
126
Miscellanea
Antonio Zatta editore, L’Europa divisa nei suoi principali Stati, 1775, incisione su rame colorato, mm 417 x 502, V
128
Miscellanea
Giorgio Sideri detto Callapoda da Candia, Europa, 1561, manoscritto su pergamena, inchiostro colori, mm 255 x 423, Venezia, Museo Corr
130
Miscellanea
Aperti al pubblico il bunker e i due rifugi antiaereifatti costruire a Villa Torlonia per Mussolini e perla sua famiglia. Negli anni 1929-1943 Giovanni Tor-lonia offrì al duce ospitalità e il Casino divenne no-bile residenza di Mussolini, mentre il principe sitrasferì nella Casina delle Civette, sempre all’in-terno della sua villa su via Nomentana. Quandol’Italia entrò in guerra nel 1940 fu necessario creareun sistema di sicurezza nella villa per proteggereil duce e la sua famiglia, in quanto l’Inghilterraaveva già preparato un piano ”Operation Dux”per bombardare sia Villa Torlonia che Palazzo Ve-nezia, dove si trovava lo studio di Mussolini; ilpiano fu bloccato da Churchill a pochi giorni dallasua attuazione. Inizialmente fu attrezzato un rifu-gio nella cantina, che si trovava sotto il “laghettodel Fucino”. Nella villa i Torlonia infatti avevanorealizzato, a imitazione del lago del Fucino, fattoprosciugare per sfruttare le terre emerse, un pic-colo specchio d’acqua artificiale, che però era facil-mente individuabile dagli aerei. Nel sotterraneo,illuminato da un impianto di luce elettrica a batte-ria, era istallato un sistema di filtraggio dell’aria,azionato a manovella, un telefono con una linea di-retta riservata al duce, reti, materassi e un gabi-netto. Il rifugio di 60 x 5 metri, era isolato con ported’acciaio e fu creata un’uscita di sicurezza attra-verso una scaletta a pioli in metallo, protetta in su-perficie da una piramide in cemento. Il sotterraneotuttavia si trovava lontano dal Casino nobile, doveMussolini e la sua famiglia risiedevano e, in caso diallarme, bisognava attraversare parte del parcoallo scoperto, perciò non era sicuro. Nel 1941 Mus-solini stesso pensò di far realizzare perciò un altrorifugio nel seminterrato sotto il salone da ballodella sua residenza. Fu necessario rinforzare il sof-fitto con uno strato di cemento armato alto più diun metro e istallare un sofisticato sistema di filtrag-gio e depurazione dell’aria, di cui restano solo al-cune fotografie. Durante i lavori di ristrutturazionedel rifugio, sono state ritrovate porte blindate an-tigas su cui era scritto il nome del costruttore: lasocietà Anonima Bergomi di Milano. È stato neces-sario per le porte un restauro accurato, essendo ilmetallo molto deteriorato. In uno dei corridoi delrifugio è anche tornato alla luce un sepolcro del IIsecolo d.C., che conteneva, insieme agli arredi fu-nerari, tre scheletri, uno di un uomo, uno di unadonna e uno di un bambino. Anche questo rifugioperò non dava sicurezza in caso di bombarda-menti aerei, perché lo strato di cemento non sa-rebbe stato sufficiente a proteggere i rifugiati. Lacostruzione di un vero bunker fu affidata allora dalduce all’ingegnere Parisella, maggiore dei Vigilidel fuoco di Roma, alla fine del 1942 e la direzionedei lavori al brigadiere D’Ubaldo. Le spese per rea-lizzare il bunker raddoppiarono i preventivi, sfio-rando le 500.000 lire, sia perché i lavori siprotrassero più del dovuto, sia perché durante lo
scavo furono rinvenuti resti archeologici, sia per-ché il terreno risultò friabile. Fu necessario quindiapprofondire lo scavo per le fondamenta e il 25 lu-glio 1943, quando il duce fu destituito, i lavori nonerano ancora terminati. Il bunker attualmente visi-tabile si trova ad una profondità di 6,5 metri sottouno strato di cemento armato di 4 metri, ha formaa croce e sezione cilindrica. Vi si accede dal piaz-zale davanti al casino, attraverso una ripida scaladi accesso. Le uscite di sicurezza, una lungo ilmuro della Tribuna con Fontana e l’altra attraversoun pozzetto con una scala a pioli, sempre all’e-sterno del palazzo, garantivano una via di fuga:per questo, anche se non terminato, fu utilizzato,come rifugio, dagli abitanti del quartiere Nomen-tano durante gli ultimi anni di guerra e di occupa-zione tedesca. I restauri del secondo rifugio e delbunker, terminati nel 2006, ne permisero subito l’a-pertura al pubblico, ma, a causa della presenza digas Radon negli ambienti sotterranei, dopo solodue anni, non furono più permesse le visite. Oggiil problema è stato risolto con un nuovo impiantodi aereazione ed è stato possibile garantire la ria-pertura delle strutture di Villa Torlonia. Nel rifugiosotto il Casino nobile sono esposti pannelli illustra-tivi con foto dei bombardamenti a Roma e lamappa della rete di sirene antiaeree, che ancorasono istallate su molti edifici, sia in centro che inperiferia. Interessanti, anche perché esposti per laprima volta, i manifestini lanciati sulla città dagliAmericani prima dei bombardamenti per allertarela popolazione. È previsto il restauro e la riaper-tura del bunker di Villa Ada e la creazione di unpercorso nei rifugi sotterranei. La convenzione trail Comune e i privati per i lavori di riqualificazionee di gestione dei rifugi antiaerei permetterà la ria-pertura senza oneri per il Campidoglio di altrestrutture. Mussolini aveva fatto costruire trebunker: oltre a quello di villa Torlonia e quellosotto Palazzo Venezia, un terzo fu costruito tra il1937 e il 1939, all’EUR sotto il Palazzo degli Uffici.In realtà questo doveva servire soprattutto per ifunzionari che dirigevano i lavori per l’Esposi-zione Universale E42, che non fu mai realizzata. Ilbunker si trova a 33 metri sotto il livello del mare,si estende per 475 metri quadrati e avrebbe potutoospitare 300 persone per un periodo di quattromesi. La struttura è oggi usata per mostre o eventioffrendo così la possibilità anche di visite guidate.Altri due bunker: sotto la Stazione Termini e sottola sede della Provincia a Palazzo Valentini, e quat-tro rifugi antiaerei: nei sotterranei del Vittoriano,nella caserma di via Genova, nel Palazzo dell’Eser-cito e di Villa Ada, fatto costruire per i Savoia. Ilrecupero di questi ambienti sotterranei, valoriz-zando un patrimonio finora trascurato, offrirà te-stimonianza su un periodo storico che non deveessere dimenticato.
Marina Humar
IL PATRIMONIO STORICO DI VILLA TORLONIA: BUNKER E RIFUGI ANTIAEREI
131
Miscellanea
ORLONIA: BUNKER E RIFUGI ANTIAEREI
Interno del rifugio del Casino Nobile di Villa Torlonia (foto Marina Humar).
134
Miscellanea
Uscita con scala a pioli del rifugio cantina del bunker di Villa Torlonia (foto Marina Humar).
140
Miscellanea
Rifugio del Casino Nobile di Villa Torlonia, raccolta manifestini (foto Marina Humar).
141
Miscellanea
Rifugio del Casino Nobile di Villa Torlonia, raccolta manifestini (foto Marina Humar).
142
Letteratura
GRIDO DEL SOLDALA PAURA E ALTRI RACCONTI DELLA GRANDE GUERRA, FEDERICO DE ROBERTO, e/o,
143
Letteratura
La Paura fa parte di una nutrita serie diracconti di guerra, scritti fra il 1919 e il1923, anni inquieti per l’Italia, e per Fe-derico De Roberto stesso. Antonio DiGrado ben tratteggia e descrive il pe-riodo nell’interessante introduzione allaraccolta di quattro racconti bellici, sceltie riproposti in occasione del centenariodella Grande Guerra. De Roberto già dal1909 pubblica regolarmente per Il Gior-nale d’Italia, al quale è stato attribuito ilmerito di avere inventato la terza pagina,della quale, attualmente, si piange moltola mancanza. Già durante la guerra, eancor più dopo, Il Giornale d’Italia è con-siderato e stimato, ma ritenuto vecchio,e, seppur cortesemente, sospinto verso imargini della vita intellettuale e cultu-rale. Sul punto di tornare in provincia,dove lo richiama il dovere verso unamadre castrante e soffocante, il maturoDe Roberto esplora i lati oscuri di Romae dei suoi giochi di potere per trarne ma-teria per il romanzo Imperio , opera la-sciata incompiuta. La Paura non portatraccia dei tormenti e delle contraddi-zioni sia dell’epoca, sia dell’autorestesso. Spicca, anzi, per lo stile essen-ziale e del tutto privo di retorica, la cuioggettività quasi cruda è una denunciadella guerra e della sua assurdità. Sullecime di monti disboscati soldati italianie soldati austroungarici vivono una sortadi tregua non scritta, bloccati nelle trin-cee che diventano un universo quasiastratto dal mondo, e dalla guerra stessa.Una routine di stampo carcerario, ma nelcomplesso tranquilla, viene sconvolta daun cecchino nemico che colpisce, uno auno, i soldati che si danno il cambio inuna postazione di vedetta, pericolosa-mente esposta al fuoco nemico. Forse perun cambio di truppe, quella che fino aora era stata una sorta di passeggiata daaffrontare con cautela, diventa un sicuro
cammino verso la morte. La crescenteconsapevolezza di andare incontro a unafine quasi certa è resa con frasi secche escandite, interrotte dalle fucilate del cec-chino e dal grido del soldato colpito.L’uso del dialetto da parte dei soldaticonferisce una nota di vivido realismo alracconto, e quasi commuovono i piccoligesti scaramantici degli uomini coman-dati a sostituire i compagni. L’ufficialeAlfani, pur mantenendo rigore e fer-mezza, dimostra umanità e sensibilità,chiede soccorso, cerca di interrompere lacatena mortale, ma gli viene imposto dicontinuare, suggerendogli, anzi, di usarei corpi dei caduti come barriera protet-tiva. La paura, così, assume la gigante-sca dimensione dell’inesorabile,dell’inspiegabile, il quesito universaledell’umano destino e della fine della vitadiventa forte e drammatico appunto per-ché non è mai apertamente posto. Il soloatto di ribellione è scegliere, almeno, didarsi autonomamente la morte, ed è conquesto gesto estremo dell’ultimo mili-tare assegnato ad andare in vedetta cheil racconto giunge a conclusione e all’a-pice dell’angoscia e dell’orrore. La breveantologia contiene anche Il Rifugio, sto-ria di un disertore strafottente e impu-dente, che verrà fucilato dopo svariatitentativi di comprenderlo e redimerlo, eal quale, forse, molti sparerebbero piùper il suo modo di fare che per la diser-zione stessa; La Retata , dai tratti comicisia per il dialetto romanesco usato per lanarrazione, sia per l’episodio della cat-tura di quarantanove austriaci, attiratidai manicaretti favoleggiati da un pri-gioniero italiano. Chiude la raccolta L’ul-timo voto , dove la moglie idealizzata eamatissima di un ufficiale si rivela, investe di vedova di guerra, donna freddae venale.
Laura Ruzickova
OLDATO COLPITOO, e/o, pagg. 144, € 14
146
Letteratura
La danza della realtà è un’opera del 2001, ristam-pata nel 2014 in occasione dell’uscita dell’omo-nimo film. Alejandro Jodorowsky regista dirigequindi per il cinema il più importante dei suoilibri, in omaggio, forse, a quella che fu la suaprima attività creativa, ovvero le poesie scritteancora da bambino. In questo libro l’autore ri-vela se stesso e il proprio cammino artistico eumano, sofferto e complesso, sublimato e sinte-tizzato nel rapporto con esoterismo e sciamane-simo. Il bambino sensibile e ribelle, discendentedi personaggi inconsueti e bizzarri, autentici ro-manzi viventi, si evolve in un uomo poliedrico,esplosivo, che prova ed esprime se stesso neipiù svariati percorsi creativi. Attore, regista,scrittore, poeta, fumettista, ha in sé anche ladanza, eredità del nonno, ballerino dal fisicostupendo, morto arso vivo in età ancor giovane.Questo nonno mai conosciuto, la madre bellis-sima e statuaria, il padre ex-circense sono la mi-nima parte della galleria di figure decisamentefuori dell’ordinario che Jodorowsky, fin da pic-colo, sembra calamitare intorno a sé. L’attivitàteatrale e cinematografica dell’autore non hannobisogno di presentazioni, e, anche se il libro, ov-viamente, ne ripercorre le tappe, le colloca al-l’interno di un processo che svela l’interioritàdell’autore, e apre orizzonti più complessi e av-vincenti, sorprendenti, e senza dubbio emozio-nanti. La magia, tratto fondante della vita diJodorowsky, è prima percepita istintivamente,ma diventerà precisa ricerca ad ampio raggio,con viaggi in ogni dove, incontri con uomini edonne “destinali”, studi in molteplici campi, edevolverà nella psicomagia, tecnica curativa checoniuga psicanalisi con rituali sciamanici, e ri-concilia l’uomo con se stesso e con la propriaparte più profonda e creativa. La danza dellarealtà è tipicamente sudamericano nello stile enel contenuto. È caratteristica degli autori diquel continente coniugare ironia e carnalità,terra e stelle, allegria esplosiva e solare, ombrebuie e violente dell’animo umano. Jodorowsky,cileno di nascita, anche se ebreo di originiucraine, scrive pagine dense, pervase di epica edi fiaba pressoché in ogni singola frase e avve-nimento descritto, sapientemente collocate ecollegate in una sorta, appunto, di danza, la co-reografia della quale è dettata da una forza uni-versale e trascendentale. Intenso e avvincente,il libro apre pagine inedite sulla vita di un per-sonaggio sul quale sembrava detto tutto il dici-bile, e offre una lettura diversa di quella chesembrava semplicemente un’esistenza caleido-scopica e provocatoria da artista “ maledetto”.
Laura Ruzickova
FORZA UNIVERSALE E TRASCENDENTLA DANZA DELLA REALTÀ, ALEJANDRO JODOROWSKY, Feltrinelli, pagg, 352, € 10
Alejandro Jodorowsky.
150
Letteratura
Gianrico Carofiglio ritorna al personag-gio di Guido Guerrieri , l ’avvocato cuitanti lettori si sono affezionati e con ilquale l’autore ha aperto il filone narrativodel thriller legale italiano. È il quintodella serie e nei romanzi precedenti Caro-figlio/Guerrieri aveva affrontato dalpunto di vista legale, ma ancor più daquello sociale, alcune piaghe purulentedella società attuale: in Testimone inconsa-
pevole (2002) affronta l’orrore della pedo-filia e del razzismo, in Ad occhi chiusi
(2003) la violenza sulla donna fino al fem-minicidio, in Ragionevoli dubbi (2006) iltraffico internazionale di droga, in Perfe-
zioni provvisorie (2010) l’uso personale distupefacenti e il non assumersi le proprieresponsabilità. In tutti questi romanzi èforte il senso morale che spesso attanaglial’avvocato Guerrieri : è giusto difenderequesto o quel cliente, c’è un limite per unavvocato davanti alla consapevolezza dicolpevolezza del proprio cliente? Maquello che sembra sempre sorreggere ilprotagonista è la fiducia nella Giustizia.Pur riconoscendo lungaggini, storture,assurdità burocratiche, piccoli maneggiper “tirare a campare” sotto sotto inGuerrieri c’è sempre la fiducia e il ri-spetto per il ruolo del giudice (non va di-menticato che lo stesso Carofiglio entrògiovanissimo in magistratura!). In que-st’ultimo romanzo, come un fulmine aciel sereno, Guerrieri viene contattato daun cliente insolito. Un giudice nel pienodi una folgorante carriera, suo ex-compa-gno di università, sempre primo neglistudi e nei concorsi, si rivolge a lui, per-ché lo difenda dalla più infamante accusa
che possa ricadere su un magistrato:quella di corruzione. Tramite questo casoGuerrieri/Carofiglio, con meno colpi discena rispetto ai gialli precedenti, si calain una disanima triste e impietosa dell’I-talia di oggi, dell’Italietta della corru-zione e del malaffare, del “tutti sonodisonesti, perché non posso esserlo ancheio”. Ma la cosa che più ferisce Guerrieri, econ lui il lettore, è scoprire la caterva diautogiustificazioni che chi è corrotto sidà, comprendere come ognuno sia prontoa scagionare se stesso, perdendo comple-tamente di vista un sano equilibrio tragiusto e sbagliato, tra vero e falso, tramenzogna e verità, tra onesto e disonesto.Ricco di dotte citazioni che ammaliano illettore, Carofiglio conduce il lettore inuna forma sottile e coinvolgente di autoa-nalisi , portandolo a spasso nella suaamata Bari (che diventa un luogo dell’a-nima sempre più affascinate, romanzodopo romanzo) per capire dove sta inognuno il l imite tra lecito e il lecito, tracapacità di fingere di non accorgersi dinulla e la voglia di denunciare tutti etutto. L’equilibrio che ognuno dovrebbetrovare tra il don Chisciotte idealista e so-gnatore e il sordido “inghiottitore dirospi” sempre maggiori è l’obiettivo cheGuerrieri si pone. Sa di non essere uneroe, sa di essere quanto meno restio a vi-vere da eroe. Ma quello che è troppo ètroppo. Ci sono dei limiti che non si pos-sono valicare, perché rompendo l’equili-brio, si rompe il rispetto verso se stessi. Esarebbe un danno irreparabile per il sin-golo e per la società.
Maria Pia Monteduro
IL RISPETTO DI SE STESSILA REGOLA DELL’EQUILIBRIO, GIANRICO CAROFIGLIO, Einaudi, pagg. 282, € 19





























































































































































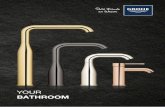








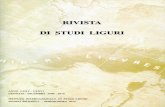
![La Terrasanta del Monte Ābū tra passato mitico e realtà presente [The Holy Land of Mount Ābū (= Arbuda) between Mythical Past and Present Reality]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6325afbb584e51a9ab0bb3b0/la-terrasanta-del-monte-abu-tra-passato-mitico-e-realta-presente-the-holy-land.jpg)





