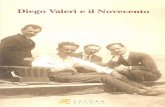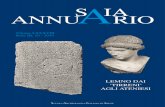L’arte Maya del Periodo Classico e il posizionamento spaziale del passato
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of L’arte Maya del Periodo Classico e il posizionamento spaziale del passato
Giancarlo Sette
L’arte Maya del Periodo Classico e il posizionamento spaziale del passato
Le placche da cintura regale, in giadeite
“Pieces of this type, when ornamented by incising, tend to feature an image on one face and a glyphic text
on the other. The image is usually that of a standing figure facing viewer’s left.” (Houston & Amaroli,
1988, pag. 4, “Oggetti di questo tipo, quando sono decorati da incisioni, tendono a riportare un'immagine su
un lato e un testo glifico sull'altro. Di solito, l’immagine è quella di una figura in piedi rivolta verso la
sinistra dell’osservatore”, trad. mia).
Questa osservazione si riferisce alle immagini incise su alcune placche da cintura in giadeite, che i sovrani
Maya del Periodo Classico (200 d.C. – 800 d.C.) portavano appese alla cintura. Solitamente, queste placche
erano raggruppate in numero di 3 ed erano legate a una maschera appesa alla cintura regale, maschera che
rappresentava un antenato o una divinità.
L’osservazione mi ha incuriosito e mi sono chiesto per prima cosa se il fatto che la figura sia di solito rivolta
a sinistra di chi osserva corrisponda alla realtà e secondariamente se questo avesse un particolare significato.
Si conoscono solo 3 placche intatte che riportano immagini simili: la cosiddetta Placca di Leida (c. 320
d.C.), ritrovata nel nord del Guatemala, oggi al Rijksmuseum voor Volkenkunde di Leida, Olanda, quella di
provenienza ignota (c. 435 d.C.), attualmente di proprietà del Museo Kimbell, Fort Worth, Texas, e quella
forse da Rio Azúl (Mora Marín, 2008, fig. 3) o da Tikal, esposta al Miho Museum di Kyoto, Giappone
(http://research.famsi.org/uploads/montgomery/354/image/JM00913UpvJadeCeltFr2.jpg) .
E’ molto probabile che queste ultime due facessero parte di uno stesso gruppo di 3.
Pag. 1
A sx, fig. 1: disegno del recto
della placca di Leida. Rinvenuta
nel 1864, a Bahia Graciosa
(Guatemala), il testo glifico
inciso sul verso porta una data nel
computo lungo corrispondente al
320 d.C.
Un più dettagliato disegno si
trova qui
http://research.famsi.org/uploads/
schele/hires/04/IMG0089.jpg
A dx, fig. 2: foto della placca del
Kimbell Art Museum, forse
proveniente Rio Azul o Tikal.
Il testo glifico inciso sul verso
porta una data corrispondente al
435 d.C. e nomina un personag-
gio, Machaak, ricordato anche
nella placca del Museo di Kyoto.
Vista anche la grande somiglian-
za stilistica delle incisioni sul
recto delle 2 placche, si pensa
facessero parte della stessa
“triade” da cintura regale e quindi
provengano dalla stessa località.
Nelle incisioni presenti su queste placche si nota bene dove e come esse erano collocate: le 3 placche
pendevano tra le gambe del sovrano, posizione che viene spiegata, tra l’altro, con l’omofonia tra le parole
Maya tun (pietra, giada) e ton (scroto, testicoli).
Oltre alle 3 placche intere appena presentate, se ne conoscono almeno 7 riconoscibilissimi frammenti: 1 pro-
veniente da Igualtepeque, Lago Güija, El Salvadòr (Houston & Amaroli, 1988, pag. 3), 1 conservato al
Dumbarton Oaks Museum di Washington D.C. (Schele & Miller, 1986, pag. 82), 4 conservati presso il
Museo del Jade di San José di Costa Rica (INS cat. nr. 4442, 4439, 4447 e 2007, León, 1982 pag. 239,
Balser, 1993, lam. 42, 43 e 46) e 1 identificato da Mora Marín (2008, fig. 3), rinvenuto a Cerro de las Mesas
(Belize), forse in origine proveniente anch’esso da Rio Azúl ma pesantemente rilavorato in Costa Rica (e
poi, tornato nei territori Maya…)
In tutti questi 10 oggetti è evidente che la figura umana incisa sul recto è rivolta verso la sinistra dell’osser-
vatore, anche se nei 7 frammenti la figura non è intera.
A parte quello identificato da Mora Marín, sul verso degli altri ci sono iscrizioni glifiche, parzialmente
leggibili, che portano: una data scritta con il sistema del computo lungo, il nome di una cerimonia, quello del
possessore, in genere un sovrano, e a volte, come nel caso della Kimbell e della Miho, anche il nome di un
nobile, subordinato al sovrano. Nei casi in cui è stato possibile identificare la cerimonia (le 3 intere, quella
nel Dumbarton Oaks Museum e 2 delle costaricensi), si tratta di un autosalasso da parte del sovrano o
l’intronizzazione dello stesso, che pure avveniva dopo un autosalasso.
Raffigurazioni molto simili sono scolpite su numerose stele che celebrano l’intronizzazione di un sovrano o
l’autosalasso di questi in occasione di particolari ricorrenze. In effetti, le placche da cintura sono statue-stele
in miniatura. Le stele ancora esistenti e leggibili sono veramente molte, elencarle ed esaminarle tutte è
virtualmente impossibile. Esaminiamone quindi alcune, relative appunto alla intronizzazione e/o
all’autosalasso.
Le stele dei Maya relative all’autosalasso
Una delle più antiche stele note che ritraggono un sovrano divinizzato è la stele 11 di Kaminaljuyú, datata al
Periodo Preclassico Medio, circa il 200 a.C.
Pag. 2
Fig. 3: Kaminaljuyú stele 11, Periodo Preclassico Medio, c. 200 a.C.
Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Città di Guatemala.
Assieme a motivi tipici del Periodo Classico (p. es. il giglio d’acqua sopra il
copricapo) questo bassorilievo mostra ancora chiari caratteri olmecoidi, come
la maschera indossata dal personaggio, (v. per es. il monumento 19 di La
Venta), e il motivo nell’angolo in basso a destra della gonna, che richiama la
caverna primigenia degli Olmechi (v. per es. il monumento 9 di Chalcatzingo).
Il sovrano, del quale si ignora il nome, è ritratto in piedi, di profilo, rivolto
verso la sinistra dell’osservatore. Indossa una maschera di uccello e porta
quelli che sono considerati i primi esempi dei segni della avvenuta cerimonia
dell’autosalasso. Dall’alto cala su di lui l’uccello celeste (personificazione
della divinità che in seguito sarà chiamata Itzamná), mentre sotto i suoi piedi
si aprono le fauci del mostro terrestre (il futuro Cauac). Quindi, il sovrano è
ritratto nel momento in cui si è trasformato nel legame spirituale tra il mondo
celeste e quello sotterraneo, venendo forse a personificare il dio-sole all’alba.
Qui, un disegno che ne evidenzia tutti i particolari
http://research.famsi.org/uploads/montgomery/hires/JM05714.jpg
Pag. 3
Fig. 5: Tikal, stele 31, Periodo Classico Iniziale, 445 d.C.
Museo delle Ceramiche di Tikal.
Fu la prima stele di Tikal a essere scolpita su tutte e 4 le facce, al
verso è stata scolpita la più lunga iscrizione glifica del Periodo
Classico Iniziale nota sino ad oggi.
Siyaj Chan K'awiil II, 17° sovrano di Tikal, è ritratto alla fine
della rito di autosalasso che precede l’accesso al trono, mentre sta
avendo la visione dell’antenato divinizzato.
Al di sopra di lui fluttua il ritratto del padre, Yaax N’un Ajyiin I,
la mano destra di Siyaj regge il ritratto del nonno, Jatz'om Kuh,
mentre sulcopricapo di Siyaj è ritratto il fondatore della dinastia,
Yax Ehb’ Xook.
Notare come la cintura di Siyaj Chan K'awiil II sia ornata con le
maschere di due divinità, probabilmente i due gemelli-eroi
Hunahpu e Xbalanque. Da ciascuna maschera pendono 3 placche,
del tutto uguali, nella forma, a quelle illustrate in precedenza.
I dettagli si vedono meglio in questo disegno
http://research.famsi.org/uploads/montgomery/333/image/JM000
852TikSt31LFr.jpg
Fig. 4: la cosiddetta Stele Hauberg, Periodo Preclassico Tardo o
Protoclassico, 197 d.C. (Schele, Mathews & Lounsbury, 1990)
Princeton University Art Museum
Questa stele è particolare sia per la scena rappresentata, sia per-
ché è molto piccola, misura solo 84 cm in altezza, il personaggio
al centro è alto circa 45 cm, copricapo escluso.
Non ne è nota la provenienza, stilisticamente sembra molto vicina
alle stele di Tikal datate allo stesso periodo.
Come si legge nei glifi 7, 8 e 9 della colonna a sinistra, Bac T’ul,
signore della città nominata nel 13° glifo, ha appena compiuto il
rito dell’autosalasso. Il 14° glifo dice che 52 giorni dopo egli
celebrò l’accesso al trono (Schele & Miller, 1986, pag. 191).
Il sovrano indossa la maschera del dio sole e lungo il suo corpo si
snoda il “serpente della visione”, probabile simbolo celeste e per-
sonificazione del “condotto” apertosi tra il sovrano e “l’ultramon-
do” in conseguenza del salasso: la sua mano destra è atteggiata
nella classica posizione dello spargimento di sangue e sotto di
essa c’è l’albero personificazione dell’axis mundi, lungo il quale
scende il sangue versato, personificato da tre esseri soprannaturali
(Schele, 1983, pag. 140).
Lungo il serpente si arrampicano 4 divinità, forse GI e GIII di
Palenque con i loro duali, la coda termina con una lama di ossi-
diana utilizzata per l’autosalasso e dalle fauci del serpente esce il
volto del divino antenato evocato (ibid., pagg. 143-144), segno
dell’avvenuta visione e della presa di contatto.
Tutti i dettagli si vedono meglio qui
http://research.famsi.org/uploads/schele/hires/11/SD7644.jpg
La scena della “ricerca della visione” con l’apparizione dell’antenato divinizzato tra le fauci del serpente
celeste (notare che in lingua Maya kan e k’an significano serpente e cielo, rispettivamente) è scolpita su
numerosi bassorilievi e la modalità di rappresentazione è la stessa appena vista. Forse i più famosi sono
quelli sulle architravi 15 (755 d.C.) e 25 (681 d.C.) provenienti da Yaxchilan (stato messicano del Chiapas) e
conservati al British Museum di Londra. La nobildonna in questo caso protagonista dell’autosalasso è rivolta
verso la sinistra dell’osservatore, là dove compare il serpente celeste la cui testa fluttua sopra il viso della
protagonista. Dalle fauci del serpente esce il viso dell’antenato divinizzato, invocato dal rituale.
Pag. 4
Fig. 6: Calakmul, Stele 51, Periodo Classico Tardo, 731 d.C.
Eretta sulla terrazza occidentale della Struttura 1 di Calakmul,
oggi al Museo Nacional de Antropología, Città del Messico
Benché danneggiata da saccheggiatori clandestini attorno al
1960, questa è comunque la stele meglio conservata del sito di
Calakmul, che dal 600 d.C. al 700 d.C. fu forse la più potente
città-stato della Penisola dello Yucatan.
E’ una delle poche stele firmate dall’autore, il cui nome com-
pare nell’iscrizione glifica sul verso assieme a quello del diret-
to responsabile dell’esecuzione, il sovrano in persona,
Yuknoom Took' K’awiil (Stuart, 2015).
Secondo l’iscrizione, il sovrano, sontuosamente abbigliato,
celebra, con il rituale per invocare il serpente delle apparizioni
sulla montagna (cioè la piramide nota come Struttura I), la fine
del katun 9.0.0.0.0, corrispondente al 731 d.C. Forse non si
trattò solo di un autosalasso, dato che il sovrano impugna una
lancia e sembra calpestare un prigioniero, probabile vittima del
sacrificio di sangue.
Notare anche qui la presenza di 3 placche pendenti dalla
maschera del dio sole che il sovrano porta alla cintura.
Fig. 7: Ceibal, stele 11, Periodo Classico Tardo, 830
d.C.
Aj Bolon Haabtal Wat’ul K’atel, signore di Ceibal e
alleato di Chan Ek' Hopet, sovrano della città di Ucanal,
celebra la sua intronizzazione, portando sul suo
abbigliamento il segno dell’avvenuto autosalasso.
Dopo un periodo di decadenza, durato dal 761 d.C.
all’829, Wat’ul K’atel descrive, nei glifi incisi sulla
stele, la rifondazione della città, alleatasi con Ucanal e
Caracol. Il nuovo signore, che probabilmente non
apparteneva alla precedente linea di sangue, esibisce il
glifo emblema di Ceibal, forse reclamando in questo
modo di essere il legittimo erede al trono, non ostante
l’iscrizione precisi che l’intronizzazione avviene sotto
gli auspici di Ek’ Hopet (Inomata & Triadan, 2013).
A partire dal Periodo Preclassico e fino al Tardo Classico, le stele erette dai sovrani Maya per ricordare i
loro riti di autosalasso e spargimento di sangue, celebrati in occasione delle intronizzazioni o di particolari
ricorrenze, sono moltissime, ma per quanto mi è noto seguono tutte uno stesso schema.
Come si vede dagli esempi illustrati in precedenza, nel corso dei secoli ci fu una notevole continuità nelle
modalità di rappresentazione del sovrano: egli è ritratto mentre guarda alla sua destra, cioè verso la sinistra
dell’osservatore, è abbigliato con una veste decorata, indossa gioielli di giada e porta i segni del sacrificio di
sangue oppure il sacrificio è descritto nel testo glifico che accompagna e descrive la scena.
Occorre tener presente un’altra importantissima osservazione:
“For the Maya, the purpose of state art was to construct symbolic arrays and thus to define models of social
reality whose purpose was generating social cohesion.” (Schele & Miller, 1986, pag. 106. “Per i Maya, il
fine dell'arte di Stato era di presentare esempi-quadro simbolici e definire in questo modo modelli di realtà
sociale il cui scopo era generare coesione sociale”, trad. mia., l’osservazione si riferisce alla cultura sociale
dei Maya a partire almeno dal Periodo Preclassico Tardo, fino all’inizio del Post-Classico, cioè dal 400 a.C.
al 900 d.C. circa.)
Queste rappresentazioni, scolpite o incise sulle stele, sulle placche in giadeite, sui pannelli posti all’interno
di celle templari o di edifici pubblici, erano veri e propri manifesti, destinati a proclamare e rendere evidenti
a tutti la legittimità del sovrano a regnare. Con l’offerta di sangue egli ne era legittimato dall’autorità dei
suoi antenati divinizzati: il sangue umano era l’unico alimento degli Esseri Ultraterreni e il sovrano, offrendo
ad essi il suo sangue e quello delle vittime sacrificali, procurava al suo popolo benessere e prosperità
attraverso la benevolenza degli stessi esseri divini, e al contempo manteneva inalterati l’esistenza e
l’equilibrio di tutto il Cosmo (Schele & Freidel, 2000).
Secondo i Maya del tempo, un diaframma invisibile separa gli esseri del mondo terreno da quelli del mondo
ultraterreno. Il diaframma era stimato particolarmente sottile all’interno della cella più interna del tempio
sommitale di una piramide.
L’autosalasso da parte del sovrano, catalizzato dai gioielli di giadeite che egli indossava ed eseguito nella
cella, scatenava le forze che riuscivano a dissolvere il diaframma, che si assottigliava ulteriormente ad ogni
ripetizione della cerimonia.
Era importantissimo il fatto che il sovrano appartenesse alla linea di sangue regale o che perlomeno fosse
legittimato da questa linea, perché solo il sangue regale possedeva forza sufficiente per sortire questo effetto,
anche se questa forza doveva essere accresciuta e catalizzata dai gioielli di giadeite e canalizzata dal luogo in
cui si svolgeva la cerimonia dell’autosalasso.
Ecco quindi che ogni nuovo sovrano cercava di rendere nota al popolo, attraverso una raffigurazione
simbolica comprensibile a tutti, la sua legittimazione a sedersi sul trono, ottenuta attraverso la procurata
visione dell’antenato divinizzato.
Vediamo come alcuni sovrani che ebbero difficoltà in tal senso risolsero la questione.
I bassorilievi con scene di intronizzazione
Quando Pacal il Grande (K’inich Janaa’b Pacal, 603 – 683 d.C.) venne intronizzato sovrano di Palenque nel
615 d.C., aveva solo 12 anni.
La linea diretta di sangue di Kuk’ Balam I, il fondatore intronizzatosi nel 431 d.C., si interruppe nel 583
quando a K’an Balam I succedette la figlia, Yohl Ik’nal, unica donna ufficialmente intronizzata a Palenque,
morta nel novembre del 604.
Seguendo la ricostruzione della linea di successione più accreditata (Schele e Freidel, 2000), nel gennaio del
605 le succedette il figlio maggiore, Ajen Yohl Mat, che nel 611 subì una gravissima sconfitta, forse da parte
di Calakmul, in seguito alla quale la dinastia regale venne delegittimata. Ajen Yohl Mat non venne deposto,
ma ridotto in condizione di vassallaggio e morì nell’agosto del 612.
Suo fratello minore, Janaab’ Pacal, era morto nel marzo precedente. Non essendoci più eredi maschi diretti,
si interruppe nuovamente la linea di sangue. La figlia di Janaab’ Pacal, Sak Kuk’, fu probabilmente una
donna dalla personalità molto forte, anche se non venne mai incoronata ufficialmente regina. Forse sotto lo
pseudonimo maschile di Muwaan Mat, nei burrascosi anni dal 612 al 615, governò Palenque in nome del suo
giovanissimo figlio, il futuro Janaab’ Pacal il Grande.
Pag. 5
Toccò a lei il compito di intronizzare il figlio, il quale probabilmente ebbe delle difficoltà a far riconoscere la
sua legittimità a regnare, visto il fatto che il precedente sovrano era suo prozio per parte di madre.
“Lady Kanal-Ikal and Lady Zac-Kuk were legitimate rulers because they were the children of kings and, as
such, members of the current royal lineage. The offspring of their marriages, however, belonged to the
father's lineage. Each time these women inherited the kingship and passed it on to their children, the throne
automatically descended through another patriline. This kind of jump broke the link between lineage and
dynasty in the succession." (Schele & Freidel, 2000: “Lady Kanal Ikal [vecchia dizione per Yohl Ik’nal, ndr]
e Lady Sac Kuk’ erano governanti legittime perché erano le figlie di re e, in quanto tali, membri del corrente
lignaggio regale. I figli dei loro matrimoni, però, appartenevano alla stirpe del padre. Ogni volta che queste
donne ereditarono il regno e lo passarono ai loro figli, il trono scese automaticamente attraverso un’altra
linea paterna. Questo sorta di salto ruppe il legame nella successione tra lignaggio e dinastia.” - Trad. mia.)
Vediamo come Pacal risolse la questione, attraverso un “manifesto” inciso su una lastra di pietra.
Seguendo l’interpretazione di Linda Schele (1994, pag. 1), Sak Kuk’ è vestita come la Prima Madre della
Creazione e dato che nel primo dei glifi del suo nome, scolpiti sopra la sua testa, è citato il dio GI della
triade di Palenque, ha anche il ruolo di Primo Padre.
Pacal siede sul Trono del Giaguaro, personificazione del primo dei 3 Troni delle Pietre della Creazione
(come si legge sulla stele C di Quiriguà, ndr), porta un pettorale con il segno “ik” che in questo caso ha il
valore fonetico di “nal”, cioè pannocchia di mais e quindi si riferisce a Hun Nal Ye, il dio giovane del mais,
e nella sua acconciatura oltre al giglio d’acqua (come in fig. 3, ndr) compare anche una personificazione di
K’awiil. Il testo glifico dietro di lui specifica che “K’ina Janaab’ Pacal, re divino di Bak” (K’ina è una delle
forme per K’inich, =dio splendente, Bak sta per B’aak, cioè ossa, uno dei nomi di Palenque, ndr), “è
diventato Hun Nal” oppure “ha ricevuto hunal (che sembra essere il nome del copricapo, ndr)”. Data
l’omofonia delle 2 espressioni, probabilmente si intendono entrambe le cose (ibid., pagg. 1-2).
Concludendo: 37 anni dopo la sua intronizzazione e ormai all’apice del suo prestigio e della sua fama, Pacal
sentì il bisogno di confermare e proclamare la sua legittimità a regnare. E lo fece confermare anche sul suo
sarcofago.
Non a caso, credo, Pacal guarda alla sua destra, cioè alla sinistra dell’osservatore, dove siede sua madre che
gli consegna l’insegna del potere, in veste di prima Madre e Primo Padre, i primi e più antichi antenati.
Pag. 6
Fig. 8 – Palenque, Tavoletta Ovale dal Palazzo,
652 d.C.
Janaab’ Pacal, raffigurato nel primo atto della
sua intronizzazione. Seduto su un trono a forma
di giaguaro bicefalo, vestito solo di un gonnel-
lino, ha una complicata acconciatura tra i capelli
(simile in piccolo a quella della fig. 3) e un
pettorale di giada con il segno Ik, soffio vitale.
Riceve dalla madre Sak Kuk’ una delle insegne
regali di Palenque, il cosiddetto copricapo “tam-
buro maggiore”, intessuto di tessere di giada e
portante sulla fronte una maschera personifica-
zione di K’awiil.
Sak Kuk’ è sontuosamente vestita, con gonna e
cappa ricoperte di tubetti di giada. Porta nell’ac-
conciatura la personificazione di K’awill, il dio
del lignaggio regale, a testimoniare la sua appar-
tenenza allo stesso e il suo diritto a proclamare il
figlio “legittimo sovrano di sangue”.
“The Maya solution to social crisis was not to manipulate economics or intensify agricultural technology;
instead, they adjusted ideology… They [the Maya] asserted through myth and symbol that differential social
ranking and ruling elite are the natural order of existence ordained by the gods.” (Schele & Miller, 1986,
pagg. 106-107. “La soluzione dei Maya a una crisi sociale non era di manovrare l'economia o intensificare la
tecnologia agricola; viceversa, essi adattavano l'ideologia... Essi [i Maya] affermavano attraverso mito e
simbolo che una differenziazione delle posizioni sociali e una classe dirigente sono l'ordine naturale
dell'esistenza stabilito dagli dei.” - Trad. mia)
Il modello presentato da Pacal probabilmente funzionò perché questo sovrano si era dimostrato talmente
all’altezza del suo compito che la sua “manovra” simbolica venne accettata di buon grado e replicata.
Suo figlio, K’inich K’an Joy Chitam II, salito al trono nel 702, copiò in un altro pannello il modello del
padre. Dato, però, che aveva un padre legittimato, coinvolse nel suo pannello sia la figura del padre, Pacal,
posto correttamente alla sinistra di chi guarda, sia quella della madre, Tz'akb’u Ajaw, posta all’altro lato.
Pacal è raffigurato nello stesso atteggiamento di sua madre nella Tavoletta Ovale, mentre porge al figlio, che
sta rivolto leggermente inclinato verso di lui, il copricapo “tamburo maggiore”.
Tz'akb’u Ajaw è ritratta con l’abbigliamento della madre di Pacal e nell’atto di porgere al figlio la
personificazione della lama di ossidiana con la quale attuare l’autosalasso.
Inoltre, nel lungo testo che circonda il pannello, K’an Joy Chitam II diventa la personificazione stessa del
K’awiil (Stuart, 2012, pag. 139).
Nel 721 d.C., anche il suo successore, K’inich Ahkal Mo' Nahb III, ebbe problemi nel farsi accettare come
legittimo sovrano, in quanto figlio di Tiwol K’an Mat, morto nel 680, che era figlio di Pacal (Martin &
Grube, 2008, pag. 172). La trasmissione del potere da K’an Joy Chitam ad Ahkal Mo' Nahb III, cioè da zio a
nipote, era probabilmente un caso spinoso, benché Ahkal potesse anche vantare che Pacal era suo nonno.
Seguendo l’esempio dello zio, Ahakl si fece ritrarre nel Pannello degli Schiavi nella stessa identica postura,
con ai suoi lati a suo padre e sua madre, i quali gli porgono gli stessi oggetti.
Pag. 7
Fig. 9: Pannello, parete nord della Casa A-D,
Palazzo di Palenque, c. 720 d.C. K’an Joy
Chitam II riceve il copricapo “tamburo mag-
giore” dal padre Pacal, alla sinistra dell’osser-
vatore, la madre, alla destra, gli porge la per-
sonificazione della lama di ossidiana con la
quale K’an Joy Chitam II eseguirà l’autosa-
lasso. Pacal siede sul Trono del Giaguaro, Joy
siede sul Trono dello Squalo/Acqua, la madre
sul Trono del Serpente, i tre troni della crea-
zione (v. Quiriguà stele C, in Looper, M.G.,
1995, e Schele & Villela, 1996).
Fig. 10: Pannello degli schiavi, 738 d.C. (?),
Palenque, Gruppo IV, attualmente nel Museo
Arqueológico de Palenque Dr. Alberto Ruz
Lhuiller.
K’inich Ahkal Mo' Nahb III nel 721 d.C.
riceve dal padre, morto nel 680, il copricapo
“tamburo maggiore” e dalla madre la
personificazione della lama di ossidiana, gli
stessi oggetti raffigurati nel pannello dello zio.
Le tre persone sono ritratte nella stessa
identica posizione di quelle del pannello di fig.
9, solo le acconciature e i troni sono diversi.
Un altro caso abbastanza simile è quello di Copan, la più meridionale delle grandi città Maya, dato che si
trova in Honduras. Ubicata in una zona abitata da genti non Maya almeno dal 1500 a.C., la sua fondazione
da parte dei Maya Ch’olan viene datata attorno al 100 d.C., ma la sua storia dinastica inizia nel 426 con Yax
K’uk’ Mo’ e termina, 15 generazioni dopo, con Yax Pasaj K’an Yopaat, morto nell’810. Un ultimo signore,
Ukit Took’, cercò di farsi intronizzare nell’822, ma pare non ci sia riuscito perché con tutta probabilità non
apparteneva alla stirpe del fondatore e “scomparve” quasi subito, tanto che prima dell’830 la città venne
praticamente abbandonata.
Yax Pasaj K’an Yopaat, 16° sovrano di Copan e comunemente noto come Yax Pac, ebbe dei grossi problemi
a far approvare e legittimare la sua ascesa al trono.
Per prima cosa, mentre si sa che la madre proveniva da Palenque, non si hanno notizie del padre, per cui è
possibile che non fosse discendente diretto del fondatore della dinastia, Yax K’uk’ Mo’.
In secondo luogo, al momento dell’intronizzazione Yax Pac, Copan stava attraversando da tempo un
periodo di instabilità politica, dovuto al fatto che, nel corso dei quasi 350 anni di ininterrotto governo, la
dinastia aveva dovuto concedere sempre maggiori privilegi alla nobiltà e i membri di questa erano
enormemente cresciuti di numero. Di conseguenza era enormemente cresciuto anche il numero dei grandi
complessi palaziali, fatto che aveva molto ridotto lo spazio coltivabile a disposizione, dato che Copan si
trova in una stretta valle, con poco territorio pianeggiante coltivabile.
L’élite nobiliare non produceva alcunché e doveva essere mantenuta dalla popolazione comune, che dovette
trovare terreni coltivabili sulle erte colline circostanti, in zone via via sempre più lontane e di difficile
accesso.
Di fatto, da almeno 2 generazioni il sovrano doveva ingraziarsi il favore dei nobili più influenti e
contemporaneamente affrontare il disagio della popolazione comune, situazione che condusse alla totale
delegittimazione della dinastia e all’abbandono del sito (Schele & Freidel, 2000).
Per dimostrare alla nobiltà e al popolo come fosse legittima la sua pretesa di accedere al trono, Yax Pac
utilizzò lo stesso sistema adottato a Palenque da Pacal e dai suoi successori, facendo scolpire due monumenti
che avevano un alto valore simbolico, quelli che a noi sono noti come “pannello del sedile del Tempio 11”,
attualmente al British Museum di Londra, e “altare Q”, che si trova ancora in situ.
A sua volta, Ukit Took’ cercò di replicare lo stesso modello, facendo realizzare l’altare L, che però non
venne portato a termine, a testimonianza dell’avvenuto decadimento del prestigio del sovrano.
Il bassorilievo scolpito sul pannello del Tempio 11 è identico a quello scolpito sui lati dell’Altare Q: si tratta
della teoria dei 16 sovrani di Copan, da Yax Kuk’ Mo’ a Yax Pac, elencati nell’ordine un cui sono saliti al
trono. L’unica differenza è che il pannello è lineare mentre l’altare è quadrangolare e quindi quest’ultimo
riporta la figura di 4 sovrani su ciascun lato.
Yax Kuk’ Mo’ e Yax Pac si trovano al centro della teoria, uno di fronte all’altro, raffigurati mentre il primo
consegna uno scettro, cioè l’insegna del comando, al secondo, suo 15° successore.
Yax Kuk’ Mo’ si trova alla sinistra dell’osservatore, dietro di lui è raffigurato il suo primo successore,
K'inich Popol Hol, poi il secondo e così via.
Pag. 8
Fig. 11: L’altare Q di Copan venne
fatto realizzare da Yax Pac nel 776
d.C. Si tratta di un blocco quadrango-
lare di pietra sui cui lati sono scolpiti
i ritratti dei 16 sovrani saliti al trono
di Copán dal 426 al 776.
Sulla facciata ovest, Yax Pac è raffi-
gurato al centro della teoria, mentre
riceve dal fondatore della dinastia,
Yax K’uk’ Mo’, lo scettro, insegna
del comando. Il fondatore siede di
fronte a Yax Pac, alla sinistra di chi
guarda e porge lo scettro con la mano
sinistra.
Giova notare che il testo glifico, scolpito sulla tavola soprastante il fregio, non descrive la accessione di Yax
Pac al trono, bensì la fondazione della dinastia da parte di Yax K’uk’ Mo’. E non mi sembra un caso il fatto
che Yax Pac, in cerca di legittimazione, abbia voluto l’altare Q alla base della scalinata principale del
Tempio 16, dentro il quale è la tomba chiamata Hunal, che si ritiene sia quella appunto di Yax K’uk’ Mo’.
L’esame dei resti ossei rinvenuti nella tomba, ha rivelato una frattura mai saldata all’ulna dell’avambraccio
destro (Martin and Grube, 2008, pag.193). Forse per questo motivo, sul bassorilievo dell’altare Q, Yax
K’uk’ Mo’è ritratto come mancino.
Come ho già accennato, nell’822 un personaggio noto col nome di Ukit Took’ tentò di farsi intronizzare ed è
dubbio se ci sia riuscito. L’unica opera da lui commissionata che ci resta è l’incompiuto Altare L.
I Maya del Periodo Classico e l’immaginaria linea passato – presente – futuro
Mi sembra di aver ormai risposto alla prima domanda che ho formulato all’inizio, e cioè se corrisponda al
vero che nelle raffigurazioni che li vedono protagonisti dell’autosalasso e/o dell’intronizzazione, incise sulle
placche da cintura e, più in generale, scolpite sui bassorilievi in pietra, i sovrani Maya sono sempre ritratti
rivolti verso la loro destra, corrispondente alla sinistra dell’osservatore.
In effetti, sono note 3 placche intere e 7 frammenti che riportano raffigurazioni riconducibili a questa
tipologia e su tutti questi oggetti il sovrano è ritratto rivolto verso la sua destra.
Per quanto riguarda i bassorilievi, ho illustrato gli esempi presenti su 4 stele, 4 pannelli e 2 altari e anche in
questi esempi il sovrano è ritratto rivolto verso la sua destra.
Pur non presentandoli, ne ho esaminati molti altri e la “regola” vi è sempre rispettata.
La seconda domanda che mi sono posto è se questa modalità di raffigurazione abbia un particolare
significato.
Ritorno su un concetto espresso da Linda Schele e Mary Ellen Miller.
“Per i Maya, il fine dell'arte di Stato era di presentare esempi-quadro simbolici e definire in questo modo
modelli di realtà sociale il cui scopo era generare coesione sociale” (Schele & Miller, 1986, pag. 106. trad.
mia.)
A questo proposito, ho osservato che le rappresentazioni di cui sto trattando sono veri e propri manifesti.
Quasi sempre, esse sono accompagnate da un testo glifico, che riporta la data in cui il rituale è stato
compiuto, lo descrive brevemente (in genere, si legge una espressione verbale corrispondente a “egli diede il
sangue” oppure “si sedette sul trono”) e nomina il protagonista e gli eventuali co-partecipanti, riportandone
anche i rispettivi titoli.
Tuttavia, penso che il testo glifico non fosse comprensibile alla stragrande maggioranza della popolazione a
cui era destinata la raffigurazione, perché quasi sicuramente solo i membri della élite nobiliare erano in
grado di leggere i glifi.
Pag. 9
Fig. 12: L’altare L di Copan, voluto
da Ukit Took’, successore di Yax
Pac, e non completato a causa del
collasso della struttura sociale di
Copan. Fu completato il rilievo solo
sulla faccia principale, che mostra
Ukit Took’, alla dx della foto,
ricevere lo scettro K’awiil da Yax
Pac, nella stessa posizione e
atteggiamento in cui quest’ultimo è
ritratto sulla faccia ovest dell’altare
Q.
Inoltre, il testo è in genere molto breve e non riporta gli impliciti significati e le conseguenze in termini
sociali del rituale celebrato e raffigurato: era la raffigurazione stessa a essere una forma di scrittura in senso
lato, una narrazione il cui svolgimento e i cui significati dovevano essere noti e comprensibili a tutti, la fonte
dell’interpretazione era costituita dal patrimonio culturale e sociale collettivo.
In un’opera d’arte il punto di vista dell’osservatore è sempre il più importante. A maggior ragione, lo era nei
casi in esame, data la loro natura di veri e propri proclami scolpiti nella pietra.
Come abbiamo visto, il protagonista di questi proclami è rivolto verso la sinistra di chi guarda.
Secondo le ipotesi formulate da C. G. Jung e gli studi compiuti Emil Jucker, pubblicati nel 1949 e
formalizzati da Karl Koch (1993), la sinistra è il luogo del passato.
Gli studi compiuti dai neurologi (v. per es. Di bono et al., 2012; Bottini et al., 2015; Bonato, Zorzi & Umiltà,
2012), dimostrano che gli esseri umani costruiscono una rappresentazione mentale dello scorrere del tempo
dal passato al futuro, sotto forma di una linea chiamata MTL (Mental Time Line).
Il verso di orientazione di questa linea sembra essere fortemente influenzato dal verso adottato nella
scrittura, per cui quanti scrivono da sinistra a destra costruiscono la MTL ponendo il passato a sinistra e il
futuro a destra, mentre quanti scrivono da destra a sinistra costruirebbero la MTL con lo stesso verso (in
questo caso, il condizionale è d’obbligo perché non ho rintracciato studi sistematici al riguardo).
La questione è aperta, dato che i mancini europei, che scrivono da sinistra a destra, sembrano costruire una
MTL orientata come quella di quanti scrivono da destra a sinistra, mentre dovrebbe avere il verso della loro
scrittura.
In ogni caso, in estremo oriente (Cina, Giappone, Corea) si scrive tradizionalmente dall’alto verso il basso e
da destra verso sinistra, ma la ideale collocazione sul corpo umano delle due forze yin e yang, comune alle
culture prevalenti in quelle zone, vede lo yin, cioè il passato, a sinistra e lo yang, cioè il futuro, a destra.
Tornando alle raffigurazioni oggetto di questo articolo, il protagonista delle scene della “visione del serpen-
te”, ovvero quello che riceve le insegne regali dalle mani di un antenato, guarda verso la sinistra dell’os-
servatore, dove compare l’antenato divinizzato, cioè un personaggio appartenente al passato.
Nelle scene in cui la visione non è evidenziata o non compaiono gli antenati, il protagonista ha comunque
appena celebrato o sta per celebrare quel rituale e guarda verso la sinistra dell’osservatore per fargli capire
che la visione, fonte legittimante del potere, è appena avvenuta o avverrà tra breve.
Quindi, anch’egli sta guardando verso il luogo del passato, in cui risiedono gli antenati.
I Maya sviluppavano i testi glifici sia orizzontalmente che verticalmente, ma il verso di scrittura/lettura è
quasi sempre da sinistra verso destra. Anche quando il testo è formato da colonne in cui i glifi vanno letti a
coppie che procedono dall’alto verso il basso, di ciascuna coppia si deve leggere prima il glifo di sinistra poi
quello di destra, quindi passare alla coppia sottostante. Rari sono gli esempi di testi con andamento da destra
verso sinistra.
In accordo con quanto accertato sperimentalmente dai neurologi e da Koch, quindi, probabilmente i loro
scribi svilupparono una MTL con il passato a sinistra.
Il fatto che la maggior parte degli osservatori fosse in grado di capire il messaggio, pur essendo con tutta
probabilità analfabeta, forse è una conferma che negli individui (destrimani) privi di una sovrastruttura
culturale, quale è il verso della scrittura, il passato viene collocato alla sinistra e la MTL ha il verso orientato
nel senso sinistra=passato -> destra=futuro.
Pag. 10
BIBLIOGRAFIA
Balser, Carlos
1993 – Jade Precolombino de Costa Rica, III ed. - Instituto Nacionál de Seguros, San José, Costa Rica
Bonato, Mario, Marco Zorzi, Carlo Umiltà
2012 - When time is space: Evidence for a mental time line - Neuroscience and Biobehavioral Reviews 36
(2012) 2257–2273
http://ccnl.psy.unipd.it/publications/publications_folder/when-time-is-space-evidence-for-a-mental-time-
line/at_download/file
Bottini, Roberto, Davide Crepaldi, Daniel Casasanto, Virgine Crollen, Olivier Collignon
2015 - Space and time in the sighted and blind, Cognition, 141, pp. 67 - 72
Di Bono, M. G., Casarotti, M., Priftis, K., Gava, L., Umiltà, C., & Zorzi, M. (2012, May 7).
2012 - Priming the Mental Time Line. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and
Performance. Advance online publication. doi: 10.1037/a0028346
Houston, Stephen & Paul Amaroli
1988 – The Lake Güija Plaque – Research and Reports on Ancient Maya Writing, Special Supplement, May
1988, Center for Maya Research, Washington D.C.
Mora-Marín, David
2008 - Notes on Three Foreign Artifacts from the Cerro de las Mesas Jade Cache - Mexicon XXX:20-22
Inomata, Takeshi & Daniela Triadan
2013 – The Terminal Classic Period at Ceibal and in the Maya Lowlands – In M- Charlotte Arnauld and
Alain Breton (editori): Millenary Maya Societies: Past Crises and Resilience, pp. 62-67, pubblicato in
versione elettronica da Mesoweb: http://www.mesoweb.com/publications/MMS/4_Inomata-Triadan.pdf
Koch, Karl
1993 – Il Reattivo dell’Albero, Giunti ed.
Looper, Matthew G.
1995 – The Three Stones of Maya Creation Mythology at Quiriguà – Mexicon 17(2): 24-30
http://vma.uoregon.edu/mexicon/xvii2Looper.pdf
León A., Moisés
1982 – Origen de dos colgantes de jade encontrados en Costa Rica según análisis de sus inscripciones -
Estudios de Cultura Maya. Vol. XIV, pp. 225 – 240
Martin, Simon & Nikolai Grube
2008 Chronicle of the Maya Kings and Queens: Deciphering the Dynasties of the Ancient Maya – Thames
and Hudson, London
Schele, Linda
1983 - The Hauberg Stela: Bloodletting and the Mythos of Maya Rulership – in Merle Greene Robertson
(gen.ed.), Fifth Palenque Round Table, The Pre-Columbian Art Research Institute, San Francisco, CA, pp.
135 - 149
1994 – Some observations on the Oval Palace Tablet at Palenque, Texas Notes on Precolumbian Writing,
Art and Culture, nr. 71 http://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/16105/TN%20no.%2071.pdf?sequence=2
Schele, Linda & David Freidel
2000 – Una Foresta di Re – Corbaccio ed. (1a ed. in inglese 1993)
Pag. 11
Schele, Linda and Khristaan D. Villela
1996 - Creation, Cosmos, and the Imagery of Palenque and Copan – in Martha J. Macri and Jan McHargue
(ed.) Eighth Palenque Round Table, 1993, vol. 10, San Francisco: Pre-Columbian Art Research Institute.
Mesoweb online publ. May 2003 http://www.mesoweb.com/pari/publications/RT10/Creation.pdf
Schele, Linda & Mary Ellen Miller
1986 – The Blood of Kings: Dynasty and Ritual in Maya Art – George Braziller, Inc., New York, & Kimbell
Art Museum, Fort Worth
Schele, Linda, Peter Mathews and Floyd Lounsbury
1990 – Redating the Hauberg Stela, Texas Notes on Precolumbian Writing, Art and Culture, nr. 1.
http://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/15043/TN%20No.%201.pdf?sequence=2
Skidmore, Joel
2008 - The Rulers of Palenque: A Beginner’s Guide. Third edition. Mesoweb
www.mesoweb.com/palenque/resources/rulers/PalenqueRulers-03.pdf
Stuart, David
2008 - A Childhood Ritual on The Hauberg Stela – Maya Decipherment, March 2008,
https://decipherment.wordpress.com/2008/03/27/a-childhood-ritual-on-the-hauberg-stela/
2012 - The Name of Paper: The Mythology of Crowning and Royal Nomenclature on Palenque’s Palace
Tablet - In Maya Archaeology 2, edited by C. Golden, S. Houston, and J. Skidmore, pp. 116-142.
Precolumbia Mesoweb Press, San Francisco
2015- Sculptors and Subjects: Notes on the Incised Text of Calakmul Stela 51 - Maya Decipherment,
January 2015, https://decipherment.wordpress.com/2015/01/07/sculptors-and-subjects-notes-on-the-incised-
text-of-calakmul-stela-51/
Crediti per foto e disegni
Fig. 1 – Foto di Pratyeka, da
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Leiden_Plate_%28Frontal_Design_Linework%29.sv
g, sotto licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
Fig. 2 - Foto da
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Possibly_Guatemala,_Maya_Culture,_Early_Classic_period_%28
A.D._250%E2%80%93600%29_-_Royal_Belt_Ornament_-_Google_Art_Project.jpg, concessa in pubblico
dominio.
Fig. 3 – Disegno dell’autore dell’articolo, ricavato da foto della stele.
Fig. 4 – Foto da https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mayan_Stela.jpg, concessa in pubblico dominio.
Fig. 5 – Foto di Greg Willis, ritagliata ai bordi per adattarla, da
https://en.wikipedia.org/wiki/Tikal#/media/File:Tikal_Stela_31.jpg, sotto licenza Creative Commons
Attribution-Share Alike 2.0 Generic, in origine pubblicata su Flickr come tikal-14
Fig. 6 – Foto da https://en.wikipedia.org/wiki/Maya_stelae#/media/File:Stele51CalakmulMuseum.JPG,
concessa in pubblico dominio
Fig. 7 - Foto di Teobert Maler, da
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/MalerSeibalStela.jpg, in pubblico dominio
Fig. 8 – Foto di Tato Grasso, da https://commons.wikimedia.org/wiki/File:0152_Palenque.JPG?uselang=it
concessa con licenza Attribution ShareAlike 2.5, ne ho ritagliato i bordi laterali
Figg. 9, 10, 11 e 12 – Foto dell’autore dell’articolo
Pag. 12