Pattern e architettura: Layering Spaziale, Cultura e Tecnologia
Il santuario di Tas Silg in età storica: contributo allo studio delle pratiche rituali e...
-
Upload
unisalento -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Il santuario di Tas Silg in età storica: contributo allo studio delle pratiche rituali e...
edizioni quasar
Scienze dell’antichità
18 – 2012
sapienza università di romadipartimento di scienze dell’antichità
ESTRATTO
dipartimento di scienze dell’antichità
Direttoreenzo lippolis
Comitato di Direzionemaria Giovanna Biga, savino di lernia, eugenia equini schneider,
Giovanna maria Forni, Gian luca Gregori, laura maria michetti, Frances pinnock, loredana sist, maurizio sonnino, eleonora tagliaferro
Comitato scientificorosa maria albanese (catania), Graeme Barker (cambridge),
corinne Bonnet (toulouse), alain Bresson (chicago), Jean-marie durand (paris), alessandro Garcea (lyon), andrea Giardina (Firenze), michel Gras (roma),
henner von hesberg (roma-dai), tonio hölscher (heidelberg), mario liverani (roma), paolo matthiae (roma), athanasios rizakis (atene), Guido vannini
(Firenze), alan Walmsley (copenhagen)
Redazionelaura maria michetti
sapienza università di roma
ESTRATTO
1. intRoduzione
La zona settentrionale del santuario di Tas-silġ è stata oggetto di nuove indagini a partire dal 1999, con l’obiettivo di completare l’esplorazione iniziata negli anni 60, precisando crono-logia e funzioni degli edifici allora messi in luce1.
nell’area ricadono una serie di installazioni importanti, quasi tutte indagate durante i primi anni dell’attività della Missione Italiana (Fig. 1). La struttura più a nord è il muro d (= us 4082)2 identificato già nella prima campagna di scavo3, e ascritto agli impianti di deli-mitazione e difesa del santuario. Al muro d è collegato un ambiente quadrangolare4, con un pavimento a lastre di calcare che si eleva ad una quota più alta della maggior parte dei piani pavimentali del santuario: anche questo ambiente è stato interpretato in relazione al sistema difensivo, proponendo di riconoscervi una “torre”5. Mentre l’area a nord del muro non è mai stata esplorata dalla Missione, fatta eccezione per una trincea realizzata nel 19636, la zona a sud fu oggetto di estese indagini fra 1964-1966 e 1968: esse permisero di identificare la struttura 437, datata al IV sec. a.c., l’adiacente struttura 388, e l’ampio spazio aperto (cortile 8)9 che si esten-de fino al vano 4. noto anche come “altare di Hera” a causa del rinvenimento di frammenti
* La ricerca è stata condotta nell’ambito del Progetto MIur-PrIn 2007 “Analisi stratigrafiche e metodi di elaborazione dei dati applicati allo studio dei contesti cultuali di età storica in area mediterra-nea (Malta, Asia Minore)” (codice 2007J3e2n5_003, responsabile prof.ssa Grazia semeraro), afferente al Progetto nazionale “Archeologia dei luoghi di cul-to nel Mediterraneo. Approcci integrati allo studio dei complessi monumentali e delle pratiche rituali” (2007J3e2n5, responsabile Prof.ssa Maria Pia rossi-gnani). Per l’elaborazione GIs dei dati e per la colla-borazione alla redazione dell’apparato grafico ringra-zio Barbara Pecere ed Alessandro Monastero. Le foto sono dell’autrice.
1 cfr. ciasca - RossiGnani et alii 2000.
2 Il sistema di numerazione misto (numeri e let-tere) adottato negli anni ‘60 è stato in parte sostituito negli anni recenti per facilitare le operazioni di elabo-razione dei dati e di redazione dei diagrammi strati-grafici (matrix). I numeri assegnati negli anni ‘60 sono di due cifre, la nuova numerazione comincia con il n. 4000.
3 ciasca 1964, pp. 53 ss.; ciasca 1993, p. 227.4 esplorato nel 1968, vd. ciasca 1969, pp. 46. 5 ciasca 1993, p. 227.6 Vd. nota 3.7 ciasca 1967, p. 29 ss.8 ciasca 1966, p. 38 ss.9 Inizio dello scavo nel 1964: vd. ciasca 1965, p.
49; scavo del 1965: ciasca 1966, p. 29 ss., 33 ss.
GRazia seMeRaRo
IL sAnTuArIo dI TAs-sILĠ In eTÀ sTorIcA. conTrIBuTo ALLo sTudIo deLLe PrATIcHe rITuALI e
deLL’orGAnIzzAzIone sPAzIALe: L’AreA seTTenTrIonALe*
ESTRATTO
108 G. semeraro Sc. Ant.
Fig. 1 – Tas-silġ. Pianta generale aggiornata con ubicazione degli interventi di scavo realizzati fra 1999 e 2005 nell’area nord.
ESTRATTO
18, 2012 Il santuario di Tas-silġ in età storica 109
iscritti con il nome della divinità greca, quest’ultimo fu esplorato quasi integralmente già nella prima campagna10. Grazie ai numerosi materiali rinvenuti negli strati accumulatisi all’interno, è possibile datarne l’uso e la successiva obliterazione fra I sec. a.c. e I sec. d.c. L’impianto della struttura va collegato al momento della grande ristrutturazione del santuario alla fine del II sec. a.c.11. nell’area antistante il vano 4 fu inoltre realizzato fra 1968 e 1970 uno dei pochi sondaggi stratigrafici in profondità, che permisero di esplorare la stratigrafia relativa alle fasi pre-repubblicane12. Lo scavo fornì dati interessanti sulle sequenze di IV sec. a.c. restituendo contesti importanti per lo studio delle produzioni ceramiche; l’esplorazione si fermò però al livello arcaico, lasciando intatti i depositi più profondi (vd. infra § 6).
Le prospettive della ricerca nella zona nord rivestono, pertanto, un notevole interesse ai fini della comprensione della topografia del santuario e delle varie fasi della sua frequenta-zione. I livelli finora esplorati si riferiscono prevalentemente alle fasi repubblicane e di I sec. d.c. da questa area, però, provengono molti materiali residuali relativi alle fasi protostoriche e arcaiche13, che documentano l’interesse delle stratigrafie ancora conservate per lo studio dei periodi più antichi del santuario. del tutto inesplorata è inoltre l’ampia zona che si sviluppa ad ovest della “torre” fino alle strutture a blocchi della zona occidentale, messe in luce durante la campagna del 197014.
negli anni fra 1999 e 2005 si sono realizzati vari interventi, alcuni dei quali funzionali alla conservazione e alla sistemazione dell’area, secondo un programma concordato vari anni fa con la soprintendenza che prevedeva innanzitutto la chiusura dei saggi e delle trincee più pro-fonde, per poter meglio proteggere le stratigrafie complesse del sito. nei successivi paragrafi si presenteranno dapprima, in modo sintetico, i vari interventi. nella seconda parte si fornirà una lettura complessiva, anche se preliminare, delle principali acquisizioni scientifiche. La presen-tazione degli interventi, contrassegnati da lettere dell’alfabeto, segue un ordine topografico, da nord a sud (Fig. 1).
2. inteRVento a: saGGio a noRd
nella zona più a nord dell’area archeologica, nei pressi del muro di cinta moderno, fu praticato, in epoca non precisata, un ampio saggio di forma quadrata (4,70 x 4,65 m), profondo circa m 3,40 (Fig. 1, A). non documentato, esso non risulta tra gli interventi effettuati dalla Missione e registrati nell’archivio dei dati di scavo degli anni ’60.
Per motivi di sicurezza si è deciso di richiudere il saggio. Prima di procedere è stata rea-lizzata la documentazione grafica delle sezioni. essa ha permesso di leggere e decifrare una sequenza stratigrafica di notevole interesse per ricostruire l’assetto del santuario nelle fasi pre-
10 ciasca 1964, p. 58 ss. (denominato vano F); ciasca 1965, p. 49 ss.; per le iscrizioni vd. ibid., pp. 61-62, tav. 20-22; sulla funzione della struttura vd. ciasca 1993, p. 231 s.
11 Vd. RossiGnani 2004-05; RossiGnani 2005; RossiGnani in questo volume.
12 Vd. ciasca 1969, p. 33; d’andRia 1973.13 Vd. per le fasi protostoriche cazzella - Mo-
scoloni 2004-05; per le fasi arcaiche vd. la relativa-mente consistente presenza in questa zona di materiali di importazione greca di età arcaica (seMeRaRo 2002).
14 daVico 1973.
ESTRATTO
110 G. semeraro Sc. Ant.
repubblicane (vd. infra § 7.2). nella sezione est (Fig. 2), si può vedere come, al di sopra di una serie di strati in discesa verso nord (us 5382 e us 5381), si collocano vari livelli di riempimento con la superficie orizzontale (5383, 5380, 5384). essi si riferiscono ad una azione di livellamen-to effettuata in età repubblicana, che ha prodotto come risultato un innalzamento del piano di frequentazione. In precedenza l’andamento del terreno in questa zona era in discesa, verso la valle che corre a nord del santuario: lo strato 5382, databile alle fasi pre-repubblicane, presenta infatti una superficie superiore in pendio verso nord.
3. inteRVento b. saGGio 2000 – PRosecuzione altaRe 43
I dati al momento più rilevanti per ricostruire l’assetto delle fasi repubblicane provengono dallo scavo realizzato nell’area retrostante il muro d (us 4082) (Fig. 1, B).
L’indagine è iniziata nel 1999 con un piccolo saggio effettuato per controllare la cronolo-gia del muro. Lo scavo ha permesso di identificare la prosecuzione della struttura 43, scoperta nel corso delle prime ricerche (1963-64). L’ampliamento dello scavo (Fig. 3) ha consentito di ri-portare alla luce i limiti della struttura e anche un tratto della pavimentazione esterna a lastre.
I principali risultati15 si possono sintetizzare qui nei seguenti punti:1 - È ora possibile riferire la struttura di recinzione a nord del santuario (muro d = us 4082)
alla fine II - I a.c. in coincidenza con la fase di ristrutturazione e trasformazione monu-mentale ben visibile nell’area centrale16.
15 Pubblicati in seMeRaRo 2004-05. 16 Vd. RossiGnani in questo volume.
Fig. 2 – Tas-silġ. Area nord. Intervento A: sezione lato est.
ESTRATTO
18, 2012 Il santuario di Tas-silġ in età storica 111
2 - nella fase tardo-repubblicana (I sec. a.c.) l’area esterna è caratterizzata da una frequenta-zione che sembrerebbe legata alla coltivazione di piante e arbusti. Molto importante a questo proposito è la scoperta di due buche agricole chiaramente
databili su base stratigrafica al I sec. a.c. (us 5055, 5059)17. Le buche sono riferibili alla colti-vazione di arbusti, probabilmente viti. È pertanto possibile ipotizzare all’esterno del recinto repubblicano un’area coltivata collegata al santuario. 3 - Alla fase repubblicana va anche riferita la distruzione della struttura 43. sono stati acqui-
siti elementi circa l’elevato dell’edificio, decorato all’interno con intonaci colorati, e la possibile presenza di una copertura piana.
4 - I nuovi dati permettono di proporre una ricostruzione ipotetica in base alla quale le strut-ture 43 e 38 appartengono con tutta probabilità allo stesso edificio, distrutto alla fine del II sec. a.c. dall’impianto della struttura di recinzione (muro d = us 4082).
4. inteRVento c. scaVo 2005- altaRe 38
strettamente legato al precedente è lo scavo effettuato nella primavera del 2005, nell’area corrispondente al cosiddetto “altare” 38 (Fig. 1, c). Abbiamo avviato questo intervento per ve-rificare l’ipotesi di ricostruzione in base alla quale entrambe le strutture fanno parte di un unico complesso. Lo scavo, non ancora concluso, ha finora permesso di acquisire elementi sull’as-setto dell’area durante le fasi repubblicane. A questo periodo appartengono numerosi livelli di scarico ricchissimi di resti faunistici, ceramica – fra cui soprattutto pentole – miste a terreno cineroso ricco di carboni e a pietre alterate dal fuoco (Fig. 4). Gli scarichi di questo tipo sono alternati a gettate di scaglie di calcare e coperti da grossi blocchi. In base alla composizione si può pensare che in quest’area siano stati accumulati intenzionalmente i resti di attività rituali svolte altrove nel santuario. Tali attività sembrano collegate soprattutto alla preparazione e al consumo di pasti rituali, legati al sacrificio di animali, tra cui bovini e pesci. Le pietre alterate
17 seMeRaRo 2004-05, p. 318, figg. 9-10.
Fig. 3 – Tas-silġ. Area nord. Intervento B. struttura 43 (parte nord) durante lo scavo.
Fig. 4 – Tas-silġ. Area nord. Intervento c. scarico di età repubblicana durante lo scavo (2005).
ESTRATTO
112 G. semeraro Sc. Ant.
dal fuoco possono essere attribuite alle strutture di focolare usate nell’ambito delle pratiche di culto. Gli scarichi sembrerebbero così realizzati con tutta “l’attrezzatura” rituale utilizzata nei sacrifici, compresi i focolari accesi per cuocere i cibi. I resti faunistici e botanici rinvenuti in questo scavo sono ancora in fase di analisi18, ma possiamo confrontarli con quelli provenienti dagli scavi anni ‘60 nella stessa area e con i dati dal saggio 2000 (intervento B): essi provano l’ampia presenza negli scarichi di essenze come l‘olivo e come il mirto, usato probabilmente per le proprietà odorose, come legno da combustione.
Questi elementi andranno utilizzati in una riflessione più ampia sulle pratiche cultuali specifiche del culto praticato a Tas-silġ, in un momento in cui il santuario assume una nuova veste “architettonica”, fortemente segnata da esperienze di contatto con il mondo romano.
5. inteRVento d. “toRRe” – MuRo di deliMitazione
un piccolo saggio di scavo è stato effettuato nel 2005 all’interno di una trincea corrispondente al lato sud dell’ambiente quadrangolare (cd. “torre”) addossato al muro di recinzione (Fig. 2, d).
nella trincea, che risulta documentata nella pianta generale della campagna effettuata nel 196819, fu identificata la fondazione a blocchi squadrati relativa al muro d (us 4082), posta ad una quota di circa 1 metro più bassa rispetto al pavimento del vano.
Anche l’intervento recente in questa zona è stato determinato da esigenze legate alla pro-tezione e conservazione dei resti archeologici. Infatti, all’interno della trincea si era accumulato il terreno caduto dalle sezioni, insieme ad alcune lastre del pavimento di calcare (Fig. 5), che pure erano state oggetto di restauro nel 2000, ad opera dei tecnici dell’Istituto centrale del restauro. L’intervento del 2005 ha permesso di ripulire e studiare la parete della trincea e di realizzare un piccolo ma interessantissimo saggio di scavo (Fig. 6). Per evitare ulteriori crolli si è deciso di regolarizzare il taglio della sezione e di realizzare provvisoriamente una protezione
18 Presso i Laboratori di Bioarcheologia dell’uni-versità del salento, a cura dei gruppi di ricerca coor-dinati da Jacopo de Grossi Mazzorin e da Girolamo
Fiorentino.19 ciasca 1969, fig.1.
Fig. 5 – Tas-silġ. Area nord. Intervento d. La trincea prima dello scavo.
Fig. 6 – Tas-silġ. Area nord. Intervento d. Lato nord trincea durante lo scavo.
ESTRATTO
18, 2012 Il santuario di Tas-silġ in età storica 113
6. inteRVento e. saGGio 1970
L’intervento (Fig. 1, e) ha interessato la continuazione dello scavo in uno dei saggi realizzati dalla Missione fra 1968 e 1970, e pubblicati nei volumi annuali della serie Missione a Malta.
Anche in questo caso il programma di intervento prevedeva la chiusura per motivi di sicurezza e per garantire la conservazione delle stratigrafie. A scavo finito, infatti, le pareti del saggio sono state foderate con tessuto speciale (geodren) secondo le indicazioni dei tecnici dell’Istituto centrale per il restauro, e riempito con il terreno di risulta dello scavo.
dal punto di vista scientifico20 questo saggio ci ha permesso di documentare le stratigra-fie precedenti il IV sec. a.c. fino ai livelli caratterizzati da materiale tipo Borg in-nadur, con risultati di un certo interesse per quanto riguarda la successione dei livelli arcaici. Lo scavo è
in blocchi di calcare che potrà essere facilmente rimossa qualora si dovesse progettare una di-versa sistemazione dell’area. Per il momento, però, essa svolge la funzione di evitare ulteriori crolli e danni alle strutture.
La lettura della sezione ha permesso identificare gli strati di riempimento collegati alla costruzione della “torre” e di datarli alla fase repubblicana (Fig. 7: us 5322, 5325, 5326). Ad un periodo precedente, riferibile al IV sec. a.c., risalgono invece due strutture (us 4524, 5320), visibili in sezione al di sotto degli strati di riempimento. si tratta delle fondazioni di due muri realizzati con blocchi di calcare. È stato possibile leggere tali strutture solo per un breve tratto, poiché esse continuano al di sotto della spessa stratificazione creata al momento della costru-zione dell’ambiente quadrangolare (“torre”). si tratta di dati interessanti, in quanto indicativi dell’estensione della fase pre-repubblicana nell’area nord. Al IV sec. a.c. si riferisce anche un deposito votivo, ricco di materiali ceramici, identificato in occasione della pulizia dell’angolo nord-ovest della “torre”. Questo contesto sarà oggetto di indagini dettagliate nel prossimo futuro: esso costituisce una ulteriore riprova dell’interesse che l’esplorazione della zona nord riveste ai fini dello studio delle fasi pre-repubblicane.
20 Vd. relazione in seMeRaRo 2004-05.
Fig. 7 – Tas-silġ. Area nord. Intervento d. sezione lato nord.
ESTRATTO
114 G. semeraro Sc. Ant.
stato infatti condotto fino al livello di roccia naturale, a m. 2,95 dalla quota attuale del terreno. Gli stati più antichi si riferiscono ad azioni di scarico: materiali ceramici molto frammentati misti a resti faunistici e botanici sono stati gettati lungo il pendio di roccia che scende verso nord. I dati di questo intervento sono legati al problema della datazione della fase tardo Borg in-nadur e alla frequentazione del santuario da parte dei Fenici già nell’VIII sec. a.c.
7. osseRVazioni conclusiVe
I dati ricavati dagli interventi effettuati fra 1999 e 2005 consentono di aggiungere alcuni interessanti elementi alla ricostruzione delle fasi di età protostorica e storica, incluso il periodo repubblicano, attestate nell’area nord del santuario. nei successivi paragrafi (7.1-3) si cercherà di fornire una lettura di insieme, che costituisce il risultato della sintesi fra gli elementi già noti dagli scavi degli anni ’60 e i dati delle nuove ricerche.
7.1. Fase repubblicana: fine II-I sec. a.C.I principali monumenti visibili nella zona nord (Fig. 8) si riferiscono al momento della
ricostruzione del santuario, databile alla fine del II - inizi del I sec. a.c. In questo periodo si ridefinisce il limite nord dell’area costruendo il muro d (= us 4082) e la “torre”. Tra queste strutture e il vano 421 si estende un ampio spazio aperto, il cortile 8, caratterizzato da un pia-no pavimentale di calcare compattato, identificato e in parte scavato negli anni ’60. I risultati dell’intervento c (vd. § 4) permettono di identificare nella zona a ridosso del muro d, un’area di scarico dove venivano depositati i resti dei sacrifici e dei pasti rituali. sulla base dei dati di scavo degli anni ’60 si può ricostruire l’estensione verso est dell’area di deposito, in quanto livelli di scarico ricchi di terreno carbonioso, pietre, ceramica e resti faunistici furono rinvenuti nell’area dei vani 38 e 43 e del cortile 822.
dalla lettura incrociata dei dati di scavo degli anni ’60 e di quelli provenienti dai più recen-ti interventi emerge l’ipotesi di ricostruzione presentata in Fig. 9, che propone di riconoscere la presenza, a ridosso del muro d, di una estesa area usata per depositare i resti dei sacrifici.
La zona esterna al muro sembra invece utilizzata per scopi agricoli, come mostrano le buche per arbusti: sono necessarie però ulteriori ricerche per definire l’estensione dell’area coltivata e per precisare la presenza di altre attività: accanto alle buche si è infatti identificata una zona dove anche nel I sec. a.c. si continua a scaricare materiali dell’area sacra. un discor-so a parte merita la “torre”, un ambiente sopraelevato e collegato al muro di recinzione, che necessita di ulteriori indagini per definirne meglio la planimetria e la funzione: sulla base dei dati dell’intervento d (§ 5) è possibile identificare una partizione interna, indicata dal cavo di asportazione del muro interno. Per completarne lo studio è però necessario estendere lo scavo nell’area ad ovest, mai esplorata.
21 scavato anch’esso negli anni ’60, vd. supra, § 1, n. 10.
22 ciasca 1966, pp. 32-33.
ESTRATTO
18, 2012 Il santuario di Tas-silġ in età storica 115
Fig. 8 – Tas-silġ. Area nord. Planimetria con le strutture di età repubblicana.
Fig. 9 – Tas-silġ. Area nord. Ipotesi di ricostru-zione 3d della fase repub-blicana.
ESTRATTO
116 G. semeraro Sc. Ant.
7.2. Fase pre-repubblicana: IV sec. a.C.Per quanto riguarda le fasi precedenti molto importanti sono i dati degli interventi A, B,
c e d (vd. § 2, 3, 4, 5). una serie di edifici, realizzati con grandi blocchi di calcarenite, occupa-vano durante il IV sec. a.c. la fascia nord del santuario. Allo stato attuale si possiede una mag-giore quantità di dati per ricostruire l’edificio scoperto nel saggio B. si tratta di una struttura a pianta allungata (vano 43), probabilmente coperta, con un recinto antistante (vano 38). Ac-canto si ergevano altri edifici, come quello riconoscibile al di sotto della torre. È però difficile ricostruire con precisione lo sviluppo planimetrico e l’assetto di queste strutture poiché esse furono radicalmente distrutte durante la fase repubblicana.
L’intervento A ha permesso di riconoscere un’attività di trasformazione databile in età repubblicana, quando fu realizzato un grande riempimento per riportare il livello del terreno ad una quota uniforme, la stessa del piano dove sono scavate le buche agricole. In preceden-za il terreno era in discesa, presentando quindi una pendenza più vicina al pendio naturale. Possiamo ipotizzare, su questa base, che il santuario pre-repubblicano non avesse un limite costruito, un muro, come quello realizzato in età romana, ma fosse definito dal pendio naturale degradante verso la piccola valle che ancora oggi caratterizza il paesaggio a nord del santuario, oltre il muro di cinta moderno (Fig. 10). Questa peculiarità naturale può aiutare a ricostruire un “paesaggio cultuale”, risalente almeno al IV sec. a.c., molto più integrato con l’ambiente naturale23. La ristrutturazione di età romana costituisce uno stacco netto anche da questo pun-to di vista.
Qual’era la funzione degli edifici di IV sec. a.c., che vengono decisamente obliterati dalla ristrutturazione di età romana? È arduo rispondere a questa domanda a causa del livello di conservazione delle strutture. Anche nel caso dell’edificio meglio leggibile, il vano 43, i dati relativi ai livelli di frequentazione di IV sec. a.c. sono estremamente difficili da ricom-porre, perché furono distrutti in età repubblicana. Le ipotesi relative alla funzione si devono perciò fondare su indizi labili. sulla base degli elementi al momento disponibili (planimetria e caratteri dell’elevato), si può avanzare l’ipo-tesi che l’edificio appartenesse alla serie delle strutture ricettive del santuario (es. sale per riunioni, o per il consumo dei pasti rituali), piuttosto che a quelle squisitamente riservate al culto (sacelli o tempietti). Il vano 43 è inol-tre caratterizzato da un orientamento diverso da quello degli altri edifici pre-repubblicani, soprattutto dell’area centrale: tale peculiari-tà può forse essere spiegata pensando ad uno spazio cultuale con caratteristiche proprie, ad es. un temenos dedicato al culto di specifiche
23 L’assenza di muri di temenos ricorre in nume-rosi santuari del Mediterraneo: cfr. fra tutti il santua-
rio di Hera alla Foce del sele, in cui il limite è con tutta probabilità costituito dal fiume sele.
Fig. 10 – Tas-silġ. La campagna a nord del sito archeo-logico.
ESTRATTO
18, 2012 Il santuario di Tas-silġ in età storica 117
divinità24, forse diverse da quella venerata nel tempio e nell’area centrale. Questo insieme di dati induce a riflettere sull’entità della ristrutturazione di età repubblicana e sul grande im-patto esercitato su un’intera area del santuario. L’acquisizione più importante è costituita dal fatto che il santuario pre-repubblicano si estendeva ben al di la del limite che assume, con il muro d, solo a partire dalla fine del II - inizi del I sec. a.c.
7.3. Fase protostorica e arcaica.Per concludere un rapido accenno ai dati dell’intervento e (§ 6), già pubblicati negli atti
del convegno di roma 200525.L’intervento ha permesso di scavare stratigraficamente i livelli arcaici, precedenti l’im-
pianto di IV sec. (periodo al quale si era fermato lo scavo effettuato nel 1970), arrivando fino ai livelli di VIII-VII sec. a.c. Questa datazione si basa sul rinvenimento di ceramica tipo “red-slip”, di ceramica acroma di importazione dal Levante (coppette carenate) associati a minuscoli frammenti di importazione greca. negli stessi livelli compare ceramica ad impasto locale rive-stita di colore rosso, del tipo Borg in-nadur tardo, mentre dai livelli a contatto con la roccia proviene ceramica tipica Borg in-nadur26.
con questo saggio scendiamo nelle fasi dell’impianto del santuario di Astarte alla fine dell’VIII sec. a.c. sebbene i dati siano condizionati dalla limitata entità del saggio, essi ci con-fortano sulle potenzialità che le stratigrafie di Tas-silġ circa la comprensione di questo com-plesso periodo.
Grazia semeraroUniversità del Salento
riferimenti bibliografici
ciasca 1964: A. ciasca, Lo scavo, in Missione Archeologica Italiana a Malta. Rapporto preliminare della campagna di scavo 1963, roma 1964, pp. 53-77.
ciasca 1965: A. ciasca, Lo scavo, in Missione Archeologica Italiana a Malta. Rapporto preliminare della campagna di scavo 1964, roma 1965, pp. 41-71.
ciasca 1966: A. ciasca, Lo scavo, in Missione Archeologica Italiana a Malta. Rapporto preliminare della campagna di scavo 1965, roma 1966, pp. 25-45.
ciasca 1967: A. ciasca, Lo scavo, in Missione Archeologica Italiana a Malta. Rapporto preliminare della campagna di scavo 1966, roma 1967, pp. 25-41.
24 come spesso accade nei santuari della vicina sicilia e del mondo greco.
25 seMeRaRo 2004-05.26 Tali dati sono stati presentati e discussi nel
Workshop Ceramics of the Phoenician-Punic World
(Valletta 8-12 gennaio 2007): M.P. RossiGnani - G. seMeRaRo, The problems of pottery productions in Malta from the Iron age until the Bizantine period. The research projects of the Italian Archaeological Mission.
ESTRATTO
118 G. semeraro Sc. Ant.
ciasca 1969: A. ciasca, Lo scavo, in Missione Archeologica Italiana a Malta. Rapporto preliminare della campagna di scavo 1968, roma 1969, pp. 29-46.
ciasca 1993: A. ciasca, Some considerations regarding the sacrifical precincts at Tas-Silġ, in Journal of Mediterranean Studies 3, 1993, pp. 225-244.
ciasca - RossiGnani et alii 2000: A. ciasca - M.P. RossiGnani et alii, Scavi e ricerche della Missione Archeologica Italiana a Malta, in Malta Archaeological Review IV, pp. 51-67.
cazzella - Moscoloni 2004-05: A. cazzella - M. Moscoloni, Gli sviluppi culturali del III e II millennio a.C. a Tas-Silġ: analisi preliminare dei materiali dagli scavi 1963-70 e della loro distribuzione spaziale, in ScAnt 12, 2004-05, pp. 263-284.
d’andRia 1973: F. d’andRia, Saggio stratigrafico nell’area Nord, in Missione Archeologica Italiana a Malta. Rapporto preliminare della campagna di scavo 1970, roma 1973, pp. 29-41.
daVico 1973: A. daVico, Note sulle strutture, in Missione Archeologica Italiana a Malta. Rapporto preliminare della campagna di scavo 1970, roma 1973, pp. 73-85.
RossiGnani 2004-05: M.P. RossiGnani, Il santuario in età tardo-ellenistica, in ScAnt 12, 2004-05, pp. 355-366.
RossiGnani 2005: M.P. RossiGnani, Il santuario di Hera-Astarte a Malta in età ellenistica, in x. lafon - G. sauRon (eds.), Théorie et pratique de l’architecture romaine. Études offertes à Pierre Gros, Aix-en-Provence, pp. 259-268.
seMeRaRo 2002: G. seMeRaRo, Osservazioni sui materiali arcaici di importazione greca dall’arcipelago maltese, in M.G. aMadasi Guzzo - M. liVeRani - P. Matthiae (a cura di), Da Pyrgi a Mozia, Studi sull’archeologia del Mediterraneo in memoria di Antonia Ciasca (Vicino oriente-Quaderno 3/2), roma 2002, pp. 489-531.
seMeRaRo 2004-05: G. seMeRaRo, Nuove ricerche nel santuario di Astarte a Tas Silg: l’area Nord, in ScAnt 12, 2004-05, pp. 73-85.
abstRact
A summary of the recent archaeological research in the northern area of Astarte sanctuary in Tas-silġ is presented in this paper. Five trenches are described and the most relevant data discussed. during the republican period the area was occupied by a great deposit, where the remains of the sacrificial activi-ties were discharged. The deposit is particularly rich in ceramic materials and organic finds, mixed with ashes and structures altered by the action of fire. of particular interest for the definition of the layout of the sanctuary in the pre-republican phases is the study of the so-called altars (38 and 43) and the data brought to light from the trench A.
ESTRATTO
edizioni quasar di severino Tognon s.r.l.via Ajaccio 41/43 – 00198 Roma
www.edizioniquasar.it
per informazioni e [email protected]
Issn 1123-5713IsBn 978-88-7140-535-3
Finito di stampare nel mese di ottobre 2013presso Global Print – Gorgonzola (MI)
ESTRATTO



















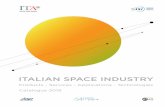








![PRELOŽNIK A., GUŠTIN M.: Cinturoni da parata: esempi di contatti tra l’area veneta e la Dolenjska nell’età del ferro. - Archeologia Veneta 35, 2012 [2013], s./p. 118-127.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63161c373ed465f0570be358/preloznik-a-gustin-m-cinturoni-da-parata-esempi-di-contatti-tra-larea.jpg)





