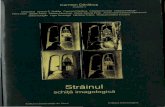Essere o avere? Oltre le regole tradizionali per comprendere la selezione dell’ausiliare nel...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Essere o avere? Oltre le regole tradizionali per comprendere la selezione dell’ausiliare nel...
Chiara Zamborlin
(2005) Essere o avere? Oltre le regole tradizionali per comprendere la selezione dell’ausiliare nel passato prossimo. Applicazione glottodidattica delle nozioni di ruolo semantico e di verbo inaccusativo. Insegnare Italiano in Giappone (Atti della IV Settimana della Lingua Italiana nel Mondo), pp. 39-72. Tokyo: Istituto Italiano di Cultura.
Attraverso una proposta glottodidattica ‘concreta’, in questo contributo intendiamo dimostrare che possedere nozioni ‘astratte’ di linguistica teorica può rivelarsi effettivamente vantaggioso nell’insegnamento di una seconda lingua. La linguistica teorica (in particolare quella generativo trasformazionale) è in grado di spiegare fenomeni grammaticali di cui la grammatica di stampo scolastico-tradizionale non riesce a rendere conto. Nel caso specifico, in questo lavoro si vedrà che la conoscenza delle nozioni di ‘ruolo semantico’ e di ‘verbo inaccusativo’ può consentirci di enunciare una regola generale, sintetica e agevolmente interiorizzabile, capace di giustificare i criteri di selezione dell’ausiliare nei tempi composti dell’italiano. Nel quadro teorico offerto dalla grammatica tradizionale, per contrasto, una regola analoga non appare formulabile. Saper fornire una giustificazione teoricamente fondata dei fenomeni grammaticali –soprattutto di quelli ritenuti troppo sbrigativamente ‘inspiegabili’— può altresì servire a attuare un didattica efficace, sia qualitativamente che quantitativamente. Si vedrà, infatti, che capire e saper spiegare i fenomeni grammaticali partendo da un quadro teorico di riferimento attendibile, può servire a migliorare due competenze didattiche fondamentali: sul piano qualitativo, la competenza di predisporre materiali adeguati; sul piano quantitativo, la competenza di economizzare, aiutando gli apprendenti a riflettere sulla lingua e ad acquisire la grammatica con il minimo sforzo possibile.
0 IntroduzioneLa riflessione sulla lingua costituisce una fase essenziale dell’apprendimento linguistico, durante la quale l’allievo organizza sistematicamente le conoscenze sui meccanismi di funzionamento della
2
lingua che apprende.1 Uno dei dilemmi della grammatica italiana, che in questa fase gli apprendenti stranieri affermano di non riuscire facilmente a risolvere, riguarda la scelta corretta dell’ausiliare nella costruzione del passato prossimo (il primo dei tempi composti studiati), con i verbi che sono comunemente definiti ‘intransitivi’. Chiariamo, innanzi tutto, che cosa si intende generalmente per ‘verbo ausiliare’. Come spiega Serianni (1991: 391), nella categoria tradizionale di ausiliare comprendiamo quei verbi che, accanto al loro uso e significato autonomo, svolgono una funzione vicaria nei confronti di qualsiasi altro verbo.2 Gli “ausiliari propriamente detti” (Serianni 1991: 391) sono essere e avere i quali hanno la funzione di realizzare una determinazione morfologica relativa al tempo e alla diatesi, ovvero, di formare i tempi composti con valore di passato e, nel caso del solo verbo essere, di costruire la forma passiva. Generalmente si afferma che, nella formazione dei tempi composti dell’italiano, la scelta dell’ausiliare non comporta dubbi con i verbi transitivi (tra i quali essere e avere sono in rigorosa distribuzione complementare per indicare rispettivamente la diatesi passiva e il tempo passato), né con i verbi riflessivi. Tuttavia, per quanto riguarda i verbi intransitivi, pare che non si possa offrire una regola che consenta di stabilire quale ausiliare usare con ciascuno di questi verbi (cfr. Serianni
1 In psicolinguistica ci si riferisce a questa fase con il termine di ‘sistematizzazione’. In prospettiva glottodidattica, tuttavia, appare più adeguato usare il termine di riflessione sulla lingua per una serie di ragioni così espresse da Balboni (1998: 104-105): “Il concetto di riflessione sulla lingua pone l’accento sulla volontarietà dell’atto del “riflettere” – volontà dell’allievo che riflette e dell’insegnante che stimola e guida la riflessione – che differenzia la riflessione sulla lingua dalla sistematizzazione della psicolinguistica, che può essere (e di fatto generalmente è) inconsapevole. Questa attenzione posta sulla riflessione attiva, ha consentito di superare la prima fase dell’approccio comunicativo – soprattutto nella sua realizzazione nozionale-funzionale degli anni Settanta – che aveva rifiutato qualsiasi cittadinanza glottodidattica alla grammatica”. Quello che è importante ribadire, è che il concetto di riflessione sulla lingua implica un movimento a spirale secondo cui le regole della grammatica non costituiscono mai il punto di partenza ma un punto di arrivo che deve essere raggiunto dall’allievo induttivamente, vale a dire, attraverso la scoperta. Le regole della grammatica, inoltre, non devono essere mai fornite in schemi pieni, rigidi e preconfezionati, da applicare negli esercizi, bensì in schemi aperti da strutturare in itinere (cfr. Balboni 1997).
2 Nella la categoria di ‘ausiliare’ Serianni (1991) include anche i verbi ‘modali’ (es. potere, dovere, volere) e quelli ‘fraseologici’ (stare per, cominciare a, finire di).
3
1991: 392; Dardano & Trifone 1985: 200). In questo contributo mi limiterò ad analizzare le difficoltà che gli allievi stranieri incontrano nel comprendere la scelta dell’ausiliare durante lo studio iniziale del passato prossimo italiano, mentre gli esempi applicativi che fornirò si basano su alcune sperimentazioni condotte con studenti universitari di madrelingua giapponese. Procederò in questo modo:
1. Riferendomi alle descrizioni reperite in vari testi classici di riferimento (Katerinov 1992, Lepschy & Lepschy 1993, Rohlfs 1969), mostrerò che basandoci su esse, una regola generale in grado di spiegare i criteri di selezione dell’ausiliare con ciascun verbo intransitivo non appare formulabile. Lo scopo di questo contributo è, tuttavia, di mostrare che tale limite può essere superato, dal momento che una regola c’è.
2. Si cercherà pertanto di enunciare una generalizzazione sintetica, prendendo spunto da alcuni concetti di linguistica teorica (cfr. Brugè 2000, 2003, Graffi 1999, Haegeman 1994, Salvi 1988, Tsujimura 1997) che verranno definiti nel corso dell’esposizione. Questi primi due momenti costituiscono la fase di programmazione didattica (I) e (II).
3. Lo stadio successivo riguarderà la fase di applicazione, in cui le conoscenze teoriche discusse nei primi due passaggi saranno impiegate nella didattica operativa. La nuova generalizzazione, costituirà il fondamento di una proposta glottodidattica costruita seguendo un approccio semantico, e incardinata sui principi neurolinguistici di bimodalità e di direzionalità.3 Questa didattizzazione si propone di essere un punto di riferimento per la progettazione di qualsiasi tipo di attività sul passato prossimo ed è rivolta agli insegnanti di italiano come LS/L2, indipendentemente dalla tipologia delle loro classi e dal metodo didattico che riterranno opportuno adottare.
3 La nozione di riflessione sulla lingua trae origine da questi due principi di neurolinguistica (cfr. Danesi 1988; 1998). Essi si riferiscono alle due modalità di percezione e di rielaborazione dei dati della realtà che contraddistinguono il cervello umano, vale a dire, la modalità dell’emisfero destro che è analogica, visiva, globale e simultanea, e quella del sinistro che è logica, verbale, analitica e sequenziale. Nell’apprendimento linguistico sono coinvolte entrambe (in questo senso si parla di bimodalità). Il percorso delle informazioni, tuttavia, segue una direzione precisa, coinvolgendo sempre prima l’emisfero destro e poi quello sinistro (direzionalità). Ne consegue che, in glottodidattica, un approccio che privilegi il focus sulle forme grammaticali prima del contatto con il testo va “contro natura” (Balboni 2000: 15).
4
1 Fase di programmazione didattica (I): Alla ricerca di una regola nell’ambito della grammatica tradizionaleCon il termine di ‘grammatica tradizionale’ si indica sia la grammatica normativa che la grammatica descrittiva. Un’impostazione normativa è quella che si propone di determinare quale sia la norma di una determinata lingua (un esempio rappresentativo è la grammatica di Fornaciari 1881). Chiaramente, un’impostazione di questo genere non è ritenuta attualmente proponibile in un modello umanistico di didattica grammaticale che consideri il discente come un soggetto pensante, capace di scoprire le regole e di organizzarle in un suo sistema di conoscenze. La grammatica normativa, inoltre, concepisce la lingua come un’entità cristallizzata la cui norma è basata sugli esempi della tradizione letteraria. La grammatica descrittiva, al contrario, si basa su un corpus ampio di produzioni linguistiche, dalla cui analisi giunge a trarre generalizzazioni, allo scopo di spiegare il sistema grammaticale della lingua che descrive. Molte delle grammatiche di italiano L1 e L2/LS si basano su questo approccio le cui regole generali, tuttavia, sono caratterizzate da una notevole frammentarietà. Gli esempi inclusi di seguito ne danno una prova.
1.1 Regole di una grammatica descrittivaTra le grammatiche descrittive di riferimento ho scelto Lepschy & Lepschy (1993: 132). Il testo descrive il fenomeno che ci proponiamo di studiare, in questi termini:
[1] Di regola, i transitivi si coniugano con l’ausiliare avere e gli intransitivi con l’ausiliare essere. Diamo una lista di alcuni verbi comuni che vanno con essere: accadere, andare, arrivare, bastare, bisognare, cadere, comparire, costare, dipendere, diventare, entrare, essere, morire, nascere, parere, partire, piacere, restare, rimanere, riuscire, scappare, sembrare, sparire, spiacere, stare, succedere, uscire, venire. [2] Ma si noti che un intransitivo come dormire e verbi come mangiare e bere usati intransitivamente richiedono avere. [3] I verbi impersonali normalmente si coniugano con essere: ‘è capitato’, ‘è successo’; [4] ma gli impersonali che si riferiscono al tempo che fa, possono andare con essere o con avere: ‘è piovuto’ o ‘ha piovuto’, ‘era nevicato’ o ‘aveva nevicato’. [5] I cosiddetti verbi pronominali o riflessivi (cioè quelli che hanno un pronome riflessivo) vanno con l’ausiliare essere […].
5
Abbiamo dunque almeno cinque regole, per nulla interconnesse, che servono a illustrare un unico fenomeno grammaticale. Notiamo che non è provvista alcuna spiegazione che motivi la ragione per cui i verbi messi in lista al punto [1] si coniughino con essere; non siamo inoltre in grado di reperire una giustificazione che renda conto del fatto che alcuni intransitivi, come quelli menzionati al punto [2], selezionino il verbo avere. Se è vero che, di norma, gli intransitivi richiedono come ausiliare il verbo essere, la spiegazione di Lepschy & Lepschy (1993) ci porta a dedurre che verbi quali dormire (nonché tutti i verbi transitivi come “mangiare e bere usati intransitivamente”, cfr. [2]) sono da includere nella categoria delle eccezioni. Applicata all’insegnamento dell’italiano LS/L2, questo tipo di spiegazione comporta chiaramente dei problemi. Nella predisposizione di materiali didattici e nella programmazione glottodidattica in generale, tale prospettiva ci porterebbe, infatti, ad adottare una soluzione inconcludente, ovvero: a fornire una regola di riferimento molto generica (cfr. punto [1]) e a compilare, di conseguenza, liste di verbi che si comportano contro la regola stessa.
1.2 Regole di una grammatica storicaDelucidazioni più utili al nostro scopo sono, a mio avviso, reperibili nella Grammatica storica delle lingua italiana e dei suoi dialetti di Rohlfs (1969). Dall’opera si apprende che le origini del passato prossimo italiano rimontano all’epoca latina classica. Rohlfs (1969: 119) spiega che la costruzione in (1), con i verbi transitivi, esprimeva originariamente uno stato o un effetto continuativo:
(1) Epistolam scriptam habeo. Ho una lettera che è stata scritta.
Solo in epoca tarda la stessa costruzione venne estesa ai verbi intransitivi:
(2) Habeo dormitum. Ho dormito.
La struttura esse + participio passato, nel senso di perfetto, era invece già presente negli antichi deponenti: natus sum, mortus sum, ausus sum, iratus sum. Va inoltre notato che, di fronte al participio passato costruito con habere, il quale esprimeva un’attività, quello costruito con esse indicava l’effetto dell’azione, come condizione raggiunta [e.g. ‘Sono
6
arrivato’ = ‘Sono uno che è giunto (a riva)’], metteva cioè in evidenza non il tempo, bensì l’aspetto verbale (in questo caso, l’inizio di un nuovo stato, o la conclusione di un’azione). Ma veniamo alla spiegazione fornitaci sui criteri di selezione dell’ausiliare nei tempi composti. Apprendiamo da Rohlfs (1969: 119) che nel toscano, la fase espressa in (2) si realizzò solo in parte:
[1] Mentre i verbi transitivi vengono tutti costruiti con avere, gli intransitivi vogliono in parte essere in parte avere. […] [2] Tra gli intransitivi formano i tempi composti con avere: abbaiare, aderire, ascoltare, assistere, camminare, cavalcare, cenare, cessare, dimorare, dormire, girare, godere, guerreggiare (e tutti gli altri verbi in –eggiare), marciare, miagolare, muggire, nutrire, nuocere, parlare, piangere, pranzare, ridere, riposare, schiamazzare, sonnecchiare, starnutire, tacere, tardare, tremare, viaggiare. [3] Altri verbi intransitivi vengono costruiti con avere quando vengono usati transitivamente, per esempio ‘aveva salito il colle’ […]. [4] Il toscano usa essere con i verbi che seguono: andare, arrivare, avvenire, cadere, calare, campare, correre, costare, crescere, divenire, diventare, entrare, fuggire, giacere, giungere, ire, morire, nascere, partire, passare, piacere (e dispiacere), procedere, restare, rimanere, riuscire, salire, saltare, scendere, scoppiare, sorgere, sortire, stare, tornare, uscire, venire, quando [alcuni di?] questi verbi non siano usati in senso transitivo. [5] In questo caso richiedono avere, cfr. per esempio ‘abbiamo calato la vela’, ‘ha cresciuto i prezzi’ […]. [6] Con essere vengono inoltre costruiti i verbi personali, per esempio ‘mi è accaduto, apparso, avvenuto, bastato, bisognato, parso, piaciuto (e dispiaciuto), rincresciuto, sembrato, toccato, valso’. […] [7] Infine vogliono essere tutti i verbi intransitivi formati dall’unione d’una preposizione e un aggettivo (o sostantivo), esprimenti l’inizio di uno stato, per esempio imbiancare, rimboschire, impigrire, inasprire, ingentilire, intorpidire, ingrossare, dimagrire, invecchiare. [8] In certi casi l’uso oscilla. Alcuni verbi vogliono avere, quando sia espressa solo l’azione, mentre quando sia espresso un fine vogliono essere, per esempio ‘ho corso a lungo’, ‘sono corso a Roma’, ‘ho volato alto’, ‘è volato sul mare’.4 [9] Con cominciare s’usa avere quando viene indicata soltanto l’azione, è invece usato essere quando vien posto in rilievo lo stato: ‘tu hai cominciato a seccarmi’, ‘le vacanze sono cominciate’. Similmente si spiega la differenza ‘tra le campane hanno sonato a festa’ e ‘sono suonate le sei’.
4 “Qui sta pure il motivo”, aggiunge Rohlfs (1969: 121) in nota, “per cui camminare, che esprime soltanto l’azione, vuole avere, mentre andare, in quanto verbo di moto verso un luogo, si coniuga con essere.
7
Di nuovo, la spiegazione ci offre una serie troppo vasta di regole, che comporta non pochi problemi per l’applicazione didattica. Tuttavia vorrei dare rilievo ai passaggi espressi in [8] e [9] che sono, secondo me, rilevanti, dato che mi conducono verso l’approccio cui intendo arrivare. Si noti che, mentre la costruzione con avere è detta esprimere un’attività, quella con essere è detta indicare l’effetto dell’azione espressa dal predicato. Tale effetto può intendersi sia come meta, che come stato.
1.3 Regole di una grammatica di italiano per stranieriOsserviamo infine le regole proposte in un testo di grammatica italiana per stranieri. Tra tutti, scegliamo il classico Katerinov (1992: 29-30), il quale spiega in questi termini il problema che stiamo cercando di risolvere:
[1] Il verbo ausiliario avere si usa: a) con i verbi transitivi (‘ho chiamato’, ‘avrò letto’ […]). b) con alcuni verbi intransitivi
5 Questa interpretazione semantica è ricollegabile anche a Leone (1970, citato in Serianni 1991: 392), secondo cui i verbi che nei tempi composti selezionano avere implicherebbero un soggetto attivo, in quanto atteggiano l’azione verbale “in dipendenza del soggetto”, mentre con verbi che selezionano essere “ci si limita a cogliere lo stato in cui il soggetto viene a trovarsi” (Leone 1970: 24). Di conseguenza, riguardo al fatto che alcuni intransitivi selezionino essere e altri avere, una regola generale che spieghi il fenomeno in modo più persuasivo può essere già abbozzata: i verbi intransitivi richiederebbe essere quando il loro participio può adoperarsi come attributo; richiederebbero invece avere quando l’uso attributivo non è possibile (Serianni 1991: 392). Nel primo caso possiamo formare frasi del tipo: (i) a Il treno arrivato in ritardo. b La guerra scoppiata tra le due nazioni.Nel secondo caso, appare invece evidente che i participi non possono fungere da attributo:(ii) a *Il cane abbaiato. b *Gli studenti viaggiati in Italia.È tuttavia innegabile che in conformità all’approccio glottodidattico umanistico che intendiamo seguire, questi giudizi di (a)grammaticalità possono essere elicitati solo nella didattica grammaticale dell’italiano come L1. La generalizzazione abbozzata sopra non può essere proposta come regola generale tout court nella didattica dell’italiano a stranieri, dal momento che appare ancora opaca e incompleta, ma soprattutto perché non lascia spazio al lavoro di induzione che deve essere necessariamente svolto da parte di chi apprende.
8
(dormire, ridere, sorridere, bussare, ecc.) […]. c) con alcuni verbi intransitivi di moto (viaggiare, camminare; passeggiare, ecc.) che non indicano la meta o il punto di partenza del movimento, ma solo il movimento stesso. [2] Il verbo ausiliario essere si usa: a) con i verbi intransitivi, soprattutto quelli di moto (‘sono andato’, ‘sarà arrivato’, ‘era scappato’ […]) che indicano la meta o il punto di partenza del movimento. b) con i verbi riflessivi […] e c) con la forma passiva. [3] Nei tempi composti alcuni verbi prendono sia l’ausiliario essere che l’ausiliario avere. Se questi verbi vengono usati transitivamente prendono l’ausiliaro avere [es. Ho sceso le scale di corsa]; se invece gli stessi verbi vengono usati intransitivamente prendono l’ausiliario essere [es. Sono sceso in cantina] […]. [4] Alcuni verbi intransitivi di moto prendono tutti e due gli ausiliari. Coniugati nei tempi composti con avere esprimono l’azione in sé. Coniugati con essere esprimono un’azione con un preciso punto di partenza e di arrivo. Es. volare: ‘Il pilota è così esperto perché ha volato molto’ (= ha passato molte ore in volo); ‘Appena appresa la notizia è volato subito da lei’. [5] Per alcuni verbi che esprimono fenomeni atmosferici la scelta dell’ausiliario (essere o avere) non provoca un cambiamento di significato sostanziale. Si coniugano con avere per dare risalto all’azione in sé, alla sua durata. Es. ‘Ha piovuto tutta la notte’. […] Si coniugano con essere quando si vuole constatare l’azione avvenuta: ‘Stamattina è piovuto’ 5. [6] Un'altra categoria di verbi, infine, si coniuga con tutti e due gli ausiliari. Es. vivere: ‘Ha vissuto a Roma per venti anni. / È vissuto a Roma per venti anni’ 6; ‘Ho durato fatica a convincerlo. / Questa storia è durata troppo’.
La spiegazione non consente ancora di predisporre un quadro di riferimento complessivo che faciliti all’allievo straniero il compito di stabilire quando usare essere e quando avere con i verbi intransitivi. Le regole di Katerinov (1992), come quelle fin qui esplorate, ci forniscono descrizioni corrispondenti al vero ma che, essendo frammenti sconnessi tra loro, trasmettono una visione del fenomeno confusa, oltremisura complicata e, con ogni probabilità, demotivante. Dal punto di vista della progettazione didattica, se ci basassimo su questa panoramica di
5 “Si dice è piovuto, è grandinato è nevicato, se si pensa all’azione in sé, mentre se si accentua la durata dell’azione si dice ha piovuto tutta la notte, ha nevicato due ore” (Rolhfs 1969: 122).
6 Rolhfs (1969: 121-122) attribuisce questo comportamento all’influenza del francese: “Influssi francesi paiono aver diffuso la costruzione con avere nei verbi vivere, sfilare, esplodere, che normalmente si costruiscono con essere”.
9
spiegazioni, l’unico espediente che ci resterebbe da escogitare sarebbe quello di programmare a priori raggruppamenti o liste di verbi completamente indipendenti tra loro, che gli allievi non avranno altra scelta che imparare a memoria.
2 Fase di programmazione didattica (II): Dalla grammatica tradizionale alla grammatica predittivaPer comprendere – prima di far comprendere – i criteri che determinano con ciascun verbo la scelta dell’ausiliare nei tempi composti dell’italiano, dobbiamo ricercare nuove nozioni che ci aiutino ad approntare un quadro teorico composto da poche generalizzazioni sintetiche, ma scientificamente fondate, e non da molteplici regole indipendenti che risulterebbero poco adatte a costruire una visione di insieme organica. D’accordo con Brugè (2000: 55) ritengo che nella didattica grammaticale, soprattutto in contesti di LS/L2, sia “molto importante che gli studenti non si trovino di fronte a una lista di regole apparentemente slegate tra loro e in rapporto di 1 a 1 (es. regola > fenomeno grammaticale)” bensì a nozioni generali che possono essere condivise o meno dal sistema della L1. In fase di programmazione didattica, uno dei compiti più ardui per l’insegnante è quello di orientarsi nella selva delle descrizioni fornite dai libri di grammatica, per guidare gli apprendenti a una riflessione attiva sul funzionamento della lingua, sfruttando il più possibile il piacere della scoperta delle regole. Il metodo su cui si basa la grammatica predittiva può, a questo proposito, venirci in aiuto. Per ‘grammatica predittiva’ intendiamo un modello di ragionamento che considera la lingua come una capacità cognitiva umana e che la esplora secondo il metodo ipotetico deduttivo delle scienze sperimentali. Se la verifica dimostra che la regola generale di cui disponevamo non è del tutto soddisfacente, verrà formulata un’ipotesi alternativa fino a quando si riuscirà a descrivere il fenomeno che ci si propone di comprendere e di spiegare (cfr. Brugè 2003: 55).
3.1 Falsificazione della regola tradizionaleLa generalizzazione che possiamo trarre dalle descrizioni di stampo scolastico tradizionale sopra esposte, può essere schematizzata nella Tabella 1:
10
Tabella 1 Esempio di regolare generale
REGOLA GENERALE (1)REGOLA GENERALE (1)Il verbo ausiliare avere si usa: Il verbo ausiliare essere si usa:
- Con i verbi TRANSITIVI.- Con alcuni verbi INTRANSITIVI di moto che non indicano la meta o il punto di partenza del movimento, ma solo il movimento stesso (viaggiare, camminare, passeggiare, ecc.).- Con alcuni verbi INTRANSITIVI c h e p o n g o n o l ’ a t t e n z i o n e sull’azione in sé, non sul suo fine (es. bussare, dormire, lavorare, pensare, ridere, tacere, telefonare, ecc.).
- Con i verbi INTRANSITIVI che indicano la meta o il punto di partenza del movimento(es. andare, partire, uscire, salire, ecc.), o che mettono in rilievo il suo stato (es. rimanere, stare, esistere, ecc.).- Con i verbi RIFLESSIVI.
Così formulata, tuttavia, la generalizzazione è troppo dispersiva. Basandoci su essa, inoltre, non siamo in grado di rendere conto del motivo per cui verbi come nascere, morire, diventare, piacere, bastare, succedere, affondare, ecc. selezionino essere. Tali verbi, infatti, non possono necessariamente venire intesi come verbi che indicano la meta o il punto di partenza di un movimento, o che mettono in rilievo uno stato. Perché dunque si coniugano essere e non con avere?Per ‘falsificare’ questa generalizzazione, ovvero per dimostrarne la scarsa applicabilità glottodidattica, partiamo innanzi tutto dalla definizione classica di ‘verbo transitivo’ e di ‘verbo intransitivo’. Serianni (1991: 379) ci dice che una descrizione consueta, “scientificamente poco fondata” ma –a sua detta – “indubbiamente utile dal punto di vista descrittivo”, raggruppa i verbi in due classi: i verbi transitivi, che ammettono un complemento oggetto, e i verbi intransitivi, che non lo ammettono. Nel primo caso l’azione transiterebbe su un complemento diretto, nel secondo no. A questo punto ci imbattiamo in altre due importanti nozioni da (ri)definire: quelle di ‘soggetto’ e di ‘oggetto diretto’. Brugè (2003: 40) afferma che “la grammatica tradizionale attribuisce a tali funzioni grammaticali caratteristiche di tipo semantico che si distinguono per una particolare rigidità”. Di norma, infatti, il soggetto è definito come la persona o l’entità che determina o compie l’azione espressa dal verbo. L’oggetto diretto è invece definito come la persona o l’entità che subisce
11
l’azione espressa dal verbo.
2.2 Un salto: Dalla grammatica tradizionale alla teoria dei ruoli semanticiProviamo a fare un salto per cambiare prospettiva. Osserviamo sia i verbi che le nozioni di ‘soggetto’ e di ‘oggetto diretto’, non più dal punto di vista tradizionale ma da quello della teoria linguistica dei ruoli semantici (cfr. Haegeman 1994).7 In questo quadro teorico i verbi sono classificati in zero-mono-bi e tri valenti, vale a dire, a seconda degli elementi che saturano la loro valenza, i quali vengono denominati ‘argomenti’. Si dirà pertanto che un verbo come amare è bivalente perché ha due argomenti, che tradizionalmente sono definiti come soggetto e oggetto diretto:
MARTINA ama IL SUO CANE
Un verbo come dare è trivalente, perché possiede tre argomenti, tradizionalmente detti soggetto, oggetto e complemento indiretto:
IO ho dato IL LIBRO ALLO STUDENTE
Un verbo come dormire è monovalente perché possiede un argomento solo (tradizionalmente, il soggetto):
Dormono LE CIME DEI MONTI
Un verbo come piovere, infine, è avalente, dato che non possiede argomenti:
Piove
A rischio di semplificare in modo eccessivo, usando una metafora di Haegeman (1994), possiamo dire che la teoria dei ruoli semantici considera i verbi come il copione di una rappresentazione teatrale, in cui determinati ruoli devono essere assegnati ad attori. Gli argomenti di un verbo fungerebbero da attori della scena verbale e i ruoli semantici rappresenterebbero le parti previste dal copione.
7 Per una sintesi cfr. Zamborlin (2002).
12
Basandoci sulla lista di Haegeman (1994: 49-51), possiamo dire che i ruoli semantici generalmente riconosciuti sono quelli riportati nella Tabella 2.
Tabella 2 Denominazione e funzione dei principali ruoli semantici
Argomento Ruolo semanticoAGENTEEs. Il cane ha rincorso la palla.Es. La palla è stata rincorsa dal cane.
Dà intenzionalmente inizio all’azione espressa dal predicato.
ESPERIENTEEs. Gianni ha avuto freddo tutta la notte.
Sperimenta uno stato (psicologico) espresso dal predicato.
SOURCE/ORIGINE/STRUMENTOEs. Il tifone ha danneggiato il tempio.Es. Il tempio è stato danneggiato dal tifone.
Rappresenta l’entità da cui qualcosa viene mosso come risultato dell’azione espressa dal predicato.
LOCATIVOEs. Il congresso si terrà a Firenze.
Rappresenta il luogo in cui l’azione o lo stato espressi dal predicato sono situati.
BENEFICIARIO/BENEFATTIVOEs. Gianni ha regalato un orologio a Lia.
Beneficia dell’azione espressa dal predicato.
GOAL/METAEs. La palla è rotolata in strada.
Esprime l’entità o il luogo verso cui l’attività espressa dal predicato è diretta.
PAZIENTEEs. Il cane ha riportato la palla.Es. La palla è stata riportata dal cane.
Subisce l’azione espressa dal predicato.
TEMAEs. La palla è caduta nel fiume.
Rappresenta l’entità mossa dall’azione espressa dal predicato.
Diremo inoltre che una frase minima dotata di senso compiuto si compone del predicato e degli argomenti (zero, uno, due, tre) richiesti
13
necessariamente dal verbo (cfr. Lo Duca 1999: 126).8
Tabella 3 Esempi di diverso ruolo semantico interpretato dal soggetto grammaticale
STRUMENTO Es. La chiave aprirà la porta.ESPERIENTE Es. Maria ha sentito un rumore.BENEFATTIVO Es. Gianni ha una casa al mare.LOCATIVO Es. La piazza brulicava di giovani.TEMA Es. La pietra ruzzolò per la montagna.
Osservando la nozione di ‘soggetto grammaticale’ dal punto di vista della teoria dei ruoli semantici, ciò che comunemente e genericamente si definisce ‘soggetto’, sembra in realtà presentarsi sotto le sembianze di ruoli semantici molto diversi, come esemplificato nella Tabella 3, dove riporto alcuni esempi adattati da Brugè (2003: 40-41).Tra tutti i ruoli semantici che abbiamo individuato, uno in particolare si rivela di estrema utilità per aiutarci a comprendere e a spiegare i criteri di selezione dell’ausiliare nei tempi composti: il tema. Come abbiamo visto, il tema rappresenta l’entità interessata o mossa dall’azione o dallo stato espressi dal predicato (cfr. Tabella 2). Nell’esempio della Tabella 3 (‘La pietra ruzzolò per la montagna’) il tema coincide con il soggetto grammaticale della frase. Curiosamente va però notato che il ruolo
8 Si noti infine che in una frase del tipo di ‘La settimana scorsa, Gianni ha visto Laura’, solo Gianni e Laura costituiscono gli argomenti. ‘La settimana scorsa’ appartiene a una classe di elementi definiti ‘circostanziali’ (cfr. Graffi 1994). Va anche specificato che le operazioni di attribuzione della valenza sono compiute in base ad alcune caratteristiche intrinseche dei verbi. Queste caratteristiche si chiamano ‘tratti contestuali’, e indicano le varie classi di parole con cui i verbi possono combinarsi. C’è un altro genere di tratti contestuali, detti ‘tratti di selezione’, il cui ruolo è esemplificato nel seguente contrasto, tratto da Graffi (1994: 50): (i) Gianni teme la guerra. (ii) ? La guerra teme Gianni.Le proprietà dei tratti di selezione si collocano su un livello intermedio tra la semantica e la sintassi, le proprietà contestuali, come appunto quelle di valenza di cui ci stiamo occupando, riguardano invece unicamente il livello sintattico.
14
semantico di tema (come anche quello di paziente9) viene sempre assegnato all’oggetto diretto.
(3) Paolo ha dato il romanzo a Maria. AGENTE PREDICATO TEMA BENEFICIARIO
Ma si osservino i seguenti esempi (cfr. Haegeman 1994: 51-52):
(4) Paolo è a Londra. TEMA PREDICATO LOCATIVO
(5) Le storie d’amore piacciono a Paolo. TEMA PREDICATO ESPERIENTE
(6) La nave è affondata. TEMA PREDICATO
(7) Bastano pochi soldi. PREDICATO TEMA
(8) Succedono cose pazzesche. PREDICATO TEMA
Gli esempi da (4) a (8) mostrano chiaramente che non sono pochi i casi in cui il tema coincide con il soggetto grammaticale della frase e che la definizione classica indicante nel soggetto la persona o l’entità che determina o che compie l’azione espressa dal verbo, è inadeguata. Questa definizione comunica infatti l’idea di un soggetto attivo e dotato di volontà. Secondo la teoria dei ruoli semantici, all’opposto, il soggetto può coincidere con la persona o con l’entità che determina o compie l’azione espressa dal verbo solo quando è un agente. Mai quando è un tema.
9 Alcuni linguisti propongono infatti di incorporare il paziente e il tema in un unico ruolo semantico.
15
2.3 I verbi inaccusativiLa linguistica generativa propone che i verbi in cui la cui funzione di soggetto coincide con il tema sia una classe differenziata, detta dei ‘verbi inaccusativi’. La tradizione grammaticale classica ignora lo statuto di ‘verbo inaccusativo’ e ingloba indiscriminatamente questa categoria verbale nella classe degli intransitivi. Tuttavia sembra che gli inaccusativi costituiscano una classe sui generis, distinta da quella dei transitivi e degli intransitivi, a cominciare dal fatto che gli inaccusativi sono gli unici a selezionare l’ausiliare essere nei tempi composti. Il fatto che, inoltre, il loro soggetto grammaticale non corrisponda mai a un agente o a un esperiente, ma sia sempre un tema, fa sì che, per quanto il soggetto grammaticale di questi verbi sia caratterizzato dalle tipiche proprietà dei soggetti (caso nominativo, accordo soggetto verbo), dall’altra esso presenti proprietà sintattiche che sono tipiche dei complementi oggetti. Tali proprietà sintattiche vengono individuate attraverso le seguenti prove di inaccusatività (cfr. Graffi 1994 e Salvi 1988):
• Solo con i verbi inaccusativi il pronome clitico partitivo ne può essere usato per rappresentare il soggetto in posizione postverbale:
Sono partiti molti ragazzi. > Ne sono partiti molti.Sono bastati pochi euro. > Ne sono bastati pochi.
Lo stesso avviene con l’oggetto diretto dei verbi transitivi:
Carlo mangia molte caramelle. > Ne mangia molte.
Ma non può avvenire con il soggetto dei verbi intransitivi (inergativi):
Hanno lavorato molti ragazzi. > *Ne hanno lavorato molti.Nessun ragazzo ha telefonato. > *Non ne ha telefonato nessuno.
• Solo con i verbi inaccusativi il participio passato può essere usato come modificatore del nome soggetto, oppure può essere usato nelle costruzioni assolute:
16
Uno studente arrivato poco fa.Arrivato lo studente, abbiamo cominciato l’esame.
Lo stesso avviene con l’oggetto diretto dei verbi transitivi:
Una pizza mangiata di fretta.Mangiata la pizza, siamo partiti.
Ma non può avvenire con il soggetto dei verbi inergativi:
*Una ragazza telefonata poco fa.*Telefonata la ragazza, siamo partiti.
Una descrizione più ampia è offerta da Salvi (1988: 49) che classifica gli inaccusativi nei sottogruppi schematizzati nella Tabella 4:
Tabella 4 La classificazione dei verbi inaccusativi secondo Salvi (1988)
(A) ERGATIVI (O CAUSATIVI) Sono quegli intransitivi che hanno un corrispondente transitivo tale che il complemento oggetto del verbo transitivo corrisponde al soggetto dell’intransitivo.Es. Il nemico ha affondato la portaerei. > La portaerei è affondata.
(B) INERENTEMENTE RIFLESSIVI accorgersi, arrabbiarsi, arrampicarsi, congratularsi, fidarsi, pentirsi, ricordarsi, vergognarsi, ecc.
(C) VERBI TRADIZIONALMENTE DETTI INTRANSITIVI CHE
SELEZIONANO essereNEI TEMPI COMPOSTI
andare, bastare, bisognare, cadere, dipendere, entrare, nascere, piacere, restare, riuscire, scappare, sembrare, venire, ecc.
(D) METEREOLOGICI nevicare, piovere
(E) VERBI ALLA FORMA PASSIVA Es. Il vetro è stato rotto dai ragazzi.
(F) VERBI USATI CON IL SI PASSIVO Es. Si è mangiato bene.
La grammatica generativa, sulla base di costruzioni teoriche in cui non possiamo avventurarci – sia perché richiederebbero conoscenze specialistiche molto avanzate, sia perché esulerebbero dallo scopo puramente applicativo di questa presentazione – propone che l’unico argomento selezionato dai verbi inaccusativi corrisponde di fatto all’argomento associato alla funzione grammaticale di oggetto diretto il
17
quale viene però ‘promosso’ a soggetto grammaticale. Questa è l’operazione che spiegherebbe, sia la ragione per cui l’ausiliare selezionato nei tempi composti dai verbi inaccusativi è essere, sia il motivo per cui il participio passato di questi verbi concorda in genere e in numero con il soggetto grammaticale, esattamente come accade al soggetto grammaticale (ma oggetto logico) delle costruzioni passive (cfr. Brugè 2003: 48).
2.4 Riformulazione della regolaÈ evidente che la descrizione grammaticale sin qui fornita, non può essere proposta in questa forma nella didattica dell’italiano a stranieri. Queste spiegazioni, tuttavia, costituiscono un percorso obbligato se vogliamo giungere a formulare una regola teoricamente fondata. La nuova regola generale, inoltre, ci consentirà di spiegare più accuratamente e, a dispetto delle apparenze, in modo più semplice e funzionale per la didattica, il fenomeno grammaticale di cui ci stiamo occupando. Partendo dalle conoscenze desunte, riformuleremo la generalizzazione della Tabella 1 secondo lo schema della Tabella 5:
Tabella 5 Esempio di regolare generale
REGOLA GENERALE (2)REGOLA GENERALE (2)Il verbo ausiliare avere si usa: Il verbo ausiliare essere si usa:- Con i verbi TRANSITIVI.- Con i verbi INTRANSITIVI.
- Con i verbi INACCUSATIVI.
L’esperienza didattica accumulata con apprendenti giapponesi ha confermato che le nozioni tradizionali di ‘verbo transitivo’ e di ‘verbo intransitivo’ vengono chiaramente intese, perché comunemente usate per descrivere anche i verbi della L1. Il problema che ci si presenterà ora sarà quello di trovare un fondamento logico che permetta di far comprendere agli allievi, innanzi tutto, cosa si intende per ‘verbo inaccusativo’ e, in un secondo tempo, di individuare questo tipo di verbo autonomamente all’interno di un testo. Per ovvie ragioni, i verbi inaccusativi non si presenteranno ad apprendenti di italiano L2/LS attraverso le prove di inaccusatività esposte sopra, le quali rimangono fondamentalmente uno strumento ad uso del docente. Il criterio che quindi, a scopo glottodidattico, propongo per il riconoscimento dei verbi inaccusativi come classe verbale a sé, è un semplice test semantico fondato sulla constatazione che, in questi verbi,
18
il soggetto è sempre tema e che come tale presenta caratteristiche semantiche tipiche dell’oggetto diretto. Diremo quindi che al gruppo degli inaccusativi appartengono solo quei verbi (comunemente riconosciuti come ‘intransitivi’) che esprimono un cambio di stato del soggetto grammaticale. Per ‘cambio di stato’ intendo, in senso lato, un passaggio (es. uscire, andare), una sorta di mutazione (es. cambiare, diventare) un transitare da un punto a un altro (es. salire, scendere), una metamorfosi esistenziale (es. nascere, morire), o una ripercussione sul soggetto dell’azione o dello stato di cose espresse dal predicato al punto da influenzarlo (es. piacere, e i riflessivi), oppure limitarlo (es. restare, rimanere, e le costruzioni passive) fisicamente o psicologicamente.
3 Applicazione glottodidatticaDi seguito si vedrà come le nozioni astratte sin qui discusse, possono essere applicate a livello di didattica operativa. La proposta che schematizzo a partire dal § 3.1 si collega all’Unità 8 di Rete! Primo Approccio (Mezzadri & Balboni 2003).10 È articolata in otto passaggi che intarsiano, come in un mosaico, i primi esercizi del testo di riferimento. Il livello dell’Unità 8 di Rete! Primo Approccio contrasta con quello delle unità precedenti, introducendo un argomento grammaticale abbastanza complesso attraverso attività non certo semplici che fanno ampiamente leva sulla grammatica implicita, e che possono essere avvertite come troppo difficili – e di conseguenza, demotivanti – soprattutto da allievi nella cui L1 il tempo passato è realizzato con mezzi morfologici di gran lunga meno intricati di quelli dell’italiano (com’è ad
10 Questa proposta didattica è tratta dal supplemento in lingua giapponese (cfr. Ishikawa & Zamborlin i.c.s.) abbinato al testo di Mezzadri & Balboni (2003). Essendo stata estrapolata e adattata da un testo che, di fatto, è un manuale di grammatica, consta di una serie di esercizi tra i quali all’aspetto implicito e induttivo della scoperta della regola si intrecciano brevi spiegazioni di grammatica esplicita. Con i termini di ‘grammatica implicita’ e di ‘grammatica esplicita’ definiamo rispettivamente 1) una grammatica operatoria e intuitiva che viene appresa attraverso l’esposizione alla lingua e reimpiegata nell’uso della lingua, e 2) una grammatica formale e cosciente “che il soggetto ha appreso dallo studio dei meccanismi linguistici e che impiega sia per affinare l’uso della lingua sia per potenziare le sue modalità di pensiero” (Freddi 1999: 55; cfr. anche Freddi 1994). Purché rispettino principio di bimodalità-direzionalità, le due grammatiche sono da intendersi come complementari.
19
esempio il caso del giapponese).11
L’Unità in questione, si apre con un esercizio di ascolto globale in cui una ragazza parla con un intervistatore di un’esperienza avuta durante un fine settimana.12 Si passa quindi a un esercizio di ascolto mirato, costruito sulla seconda parte della registrazione, cui fanno seguito due esercizi grammaticali. Questi ultimi tre passaggi ([A] esercizio di ascolto mirato + [B] compilazione del testo usando i verbi del riquadro + [C] esercizio di ‘scoperta della lingua’) sono integralmente riportati di seguito.
Alla scoperta della lingua – [A] Ascolta nuovamente la seconda parte dell’intervista e [B] completa il testo. Usa i verbi del riquadro.
Dieci giorni fa ho ricevuto una lettera con un biglietto con scritto: “Complimenti! Lei (2) …………………………… un week-end di sport presso il Centro Natura e Salute” … Poi l’indirizzo e il numero di telefono. Così (3) …………………………… e mi (4) …………………………… tutto, ma non mi hanno voluto dire come mai hanno dato questo premio proprio a me. (5) ……………………………, curiosa di saperne di più e quando (6) …………………………… là, (7) …………………………… molte altre persone che come me avevano vinto un week-end presso quel centro. La cosa si è fatta subito misteriosa: mi hanno dato una stanza e la chiave … (8) …………………………… nella mia camera e curiosa come sempre, dietro la porta (9) …………………………… un cartello con i prezzi: per la pensione completa il prezzo era di 60 euro al giorno comprese le attività sportive. Invece il prezzo della pensione completa della seconda possibilità dal nome abbastanza chiaro “prezzo week-end si sport gratuito” era di 45 euro al giorno, ma gli sport naturalmente erano gratuiti. Ti puoi immaginare la mia rabbia e la velocità con cui me ne sono andata via … Ho ripreso i miei documenti e, urlando, (10) …………………………… . Gli altri “vincitori” probabilmente hanno fatto la stessa cosa.
ricevere, salire, ripartire, vincere, vedere, confermare, trovare,telefonare, arrivare, partire
11 Questo è anche il motivo che giustifica la creazione di testi supplementari in L1 abbinati all’opera.
12 L’esercizio di ascolto iniziale è anticipato da due brevi attività introduttive sull’argomento generale dell’unità che riguarda il tempo libero. Le due attività introduttive hanno lo scopo di preparare l’allievo ai successivi esercizi, facendo leva sulla motivazione e sulla modalità dell’emisfero cerebrale destro.
20
Alla scoperta della lingua – [C] Completa la tabella. Riesci a dedurre la regola del passato prossimo?
passato prossimopassato prossimo
essere + participio passato avere + participio passato
ho ricevuto
Le idee che hanno generato la mia proposta didattica sono scaturite dalla constatazione che, con i soli elementi che il testo di riferimento mette a disposizione, l’allievo ha ben poche chance di riuscire a “dedurre la regola del passato prossimo”, come la consegna [C] esigerebbe. Il suo punto focale è la regola generale schematizzata nella Tabella 5, da cui si arguisce che, mentre le nozioni di ‘verbo transitivo’ e ‘intransitivo’ risulteranno subito chiare, la nozione di verbo inaccusativo dovrà essere indotta.13 I destinatari sono apprendenti che non hanno ancora studiato il passato prossimo, o che pur avendo familiarizzato con le regole della sua formazione, non sono ancora in grado di comprendere i criteri che determinano la selezione dell’ausiliare. Un altro requisito è che si tratti di allievi adulti e motivati.
3.1 Riflessione sul significato dei verbiPer facilitare lo svolgimento della prima parte dell’esercizio riportato sopra, si invitano gli allievi a osservare un gruppo di verbi all’infinito tra i quali sono contenuti quelli del testo di Rete!. La consegna è di scrivere tra parentesi in L1 il significato di ciascun verbo, aiutandosi
13 Nel testo (Ishikawa & Zamborlin i.c.s.) abbiamo volutamente evitato di introdurre nuovi termini tecnici, classificando i verbi inaccusativi come jidooshi II (‘intransitivi II’).
21
eventualmente con un dizionario, e/o lavorando a coppie o in piccoli gruppi se l’esercizio è svolto in classe.
1) Consegna: Scrivi nelle parentesi il significato dei verbi nel riquadro.
ricevere ( ) salire ( ) partire ( ) ripartire ( ) vincere ( ) vedere ( ) confermare ( ) trovare ( ) telefonare ( )
arrivare ( ) bere ( ) lavorare ( ) entrare ( ) uscire ( ) mangiare ( ) ridere ( ) pulire ( )
piangere ( ) studiare ( ) comprare ( ) dormire ( )
2) Consegna: Inserisci ogni verbo del precedente riquadro nel gruppo corrispettivo.
TRANSITIVO INTRANSITIVO INACCUSATIVO
vedere
dormireentrare
TRANSITIVO: Un verbo che ha l’oggetto diretto. INTRANSITIVO: Un verbo senza l’oggetto diretto e che non esprime un cambiamento di stato del soggetto.INACCUSATIVO: Un verbo senza l’oggetto diretto e che allude a un passaggio di stato del soggetto o a una ripercussione sul soggetto dello stato di cose espresse dal verbo.
TRANSITIVO: Un verbo che ha l’oggetto diretto. INTRANSITIVO: Un verbo senza l’oggetto diretto e che non esprime un cambiamento di stato del soggetto.INACCUSATIVO: Un verbo senza l’oggetto diretto e che allude a un passaggio di stato del soggetto o a una ripercussione sul soggetto dello stato di cose espresse dal verbo.
TRANSITIVO: Un verbo che ha l’oggetto diretto. INTRANSITIVO: Un verbo senza l’oggetto diretto e che non esprime un cambiamento di stato del soggetto.INACCUSATIVO: Un verbo senza l’oggetto diretto e che allude a un passaggio di stato del soggetto o a una ripercussione sul soggetto dello stato di cose espresse dal verbo.
Il raggruppamento costituisce un momento di riflessione sulla lingua che fa leva sull’induzione. In questa fase, tuttavia, può esere opportuno inserire una serie di richiami all’attenzione tra un esercizio e l’altro, marcando in tal modo il passaggio dalla fase induttiva di scoperta, a quella deduttiva di riflessione esplicita guidata.14 Potrà pertanto essere fatto notare che il ‘passaggio di stato del soggetto’, implicito nel significato degli inaccusativi, è chiaramente espresso in verbi come arrivare, il quale indica un mutamento, un cambio di luogo avvenuto in
14 Ritengo che le esigenze metalinguistiche non vadano disattese e che, nel passaggio dalla fase di scoperta a quella di riflessione metalinguistica, spiegazioni esplicite possano essere fornite, soprattutto qualora siano richieste (cfr. Zamborlin 2000)
22
una certa direzione (se arrivo al punto B significa che prima ero in un punto A). Lo stesso vale per verbi come nascere, morire, accadere. Con questi verbi si può dire inoltre che che il soggetto subisca lo stato di cose espresso dal verbo. Può darsi che in queste fasi di riflessione metalinguistica emergano dubbi sulla classificazione di verbi quali camminare o correre. Si potrà quindi spiegare che camminare e correre indicano un movimento ma non necessariamente un passaggio di stato. Si può ad esempio dire che è addirittura possibile correre o camminare senza nemmeno spostarci (basta usare le macchine che ci sono nelle palestre!). Camminare e correre, come altri verbi intransitivi che indicano un’azione fisica o un’azione compiuta con sforzo (lavorare, ballare, nuotare), con volontà (telefonare, dormire) o che alludono a un fatto emozionale (piangere, ridere), ma senza implicare un passaggio di stato del soggetto nè che il soggetto subisca lo stato do cose che il contenuto semantico del verbo esprime, non possono essere confusi con gli inaccusativi. Il verbo correre, tuttavia, può diventare un inaccusativo, quando significa ‘andare di corsa’ (es. correre via, correre a casa, ecc.). In questa fase metalinguistica potrà essere anche fatto notare che al gruppo degli inaccusativi appartengono tutti i verbi riflessivi, dato che ogni azione o evento che si riflette sul soggetto implica un suo cambiamento.
3.3 Il participio passatoI successivi due passaggi da seguire per poter costruire il passato prossimo, riguardano la riflessione sulla nozione di participio passato, che non ha diretta attinenza con l’aspetto semantico-sintattico (l’inaccusatività o meno) del verbo. Seguendo i pricipi su cui si fonda la nozione di riflessione sulla lingua, si potrà dapprima invitare a individuare per ogni verbo all’infinito tra quelli del riquadro seguente – si tratta degli stessi verbi usati nel riquadro della consegna 1) – la corrispettiva forma del participio passato.
3) Consegna: Individua per ogni verbo il suo participio passato.
bere ( 5 ) ricevere ( ) salire ( ) partire ( ) ripartire ( ) vincere ( ) vedere ( ) confermare ( ) trovare ( )
telefonare ( ) dormire ( ) arrivare ( ) lavorare ( ) entrare ( ) uscire ( ) mangiare ( )
ridere ( ) piangere ( ) studiare ( ) comprare ( ) pulire ( )
23
1. comprato 2. ricevuto 3. pulito 4. studiato 5. bevuto 6. uscito 7. partito8. visto 9. vinto 10. ripartito 11. trovato 12. confermato 13. arrivato 14. lavorato 15. mangiato 16. telefonato 17. salito 18. riso 19. pianto
20. entrato 21. dormito
In seguito si cercherà di porre in evidenza il fatto che il participio passato esprime il contenuto semantico di un verbo al passato e che rappresenta uno dei due elementi indispensabili per la formazione del passato prossimo. Sempre induttivamente, l’attenzione verrà successivamente posta sulle regole di formazione del participio passato, conducendo gli apprendenti a notare che molti verbi (la maggior parte della coniugazione –ere) hanno il participio passato irregolare.
4) Consegna: Inserisci ogni participio passato nel gruppo a cui appartiene.
FORME REGOLARIFORME REGOLARIFORME REGOLARI FORME IRREGOLARI
-are > -ato -ere > -uto -ire > -ito
3.4 La nozione di ausiliareIl passaggio seguente rappresenta una fase cruciale, dato che riguarda il tema principale del presente lavoro, vale a dire, la riflessione sulla funzione e sull’uso del verbo ausiliare. Facendo leva sulla nozione di riflessione sulla lingua e sul suo movimento a spirale, in cui l’aspetto induttivo della scoperta della regola si bilancia con la fase metalinguistica di introspezione e ragionamento sul funzionamento della regola stessa, si inviteranno gli allievi a tornare a lavorare sul testo di partenza (attività [A] + [B] cfr. Figura 1) per osservare l’occorrenza dei due verbi (essere e avere) che precedono ogni forma di participio passato.Si passerà quindi a far notare che i verbi essere e avere in italiano sono molto utili perché, oltre al loro uso e significato tradizionale, vengono usati per formare i tempi composti, di cui il passato prossimo è appunto il primo caso studiato. Per questo sono detti ‘ausiliari’. Tornando testo riportato nella Figura 1, l’allievo potrà a questo punto dedurre da sé la generalizzazione schematizzata nella Tabella 5: i verbi transitivi e intransitivi costruiscono il passato prossimo con l’ausiliare avere; i verbi inaccusativi lo costruiscono con l’ausiliare essere.
24
5) Consegna: Torna al testo di Rete! a p. 69. Svolgi l’esercizio di ascolto mirato facendo attenzione all’occorrenza dei due verbi (essere e avere) che precedono
ogni participio passato.
avere essere
TRANSITIVO INTRANSITIVO INACCUSATIVO
ricevutotelefonato
arrivata
4.5 Messa a fuoco sulla concordanzaI succesivi passaggi riguardano aspetti morfo-sintattici secondari. Sulla base delle indicazioni fornite dagli schemi sottostanti, gli apprendenti possono a questo punto giungere, del tutto induttivamente, a stabilire che quando l’ausiliare è essere, il participio passato concorda in genere e numero con il soggetto sintattico del verbo.
6) Consegna: Forma il passato prossimo della prima persona singolare di tutti i verbi contenuti nel riquadro della consegna 1), immaginando che il soggetto (io)
sia un uomo.
avere essere
TRANSITIVO INTRANSITIVO INACCUSATIVO
Ho mangiatoHo dormito
Sono arrivato
7) Consegna: Forma il passato prossimo della prima persona singolare di tutti i verbi contenuti nel riquadro della consegna 1), immaginando che il soggetto (io)
sia una donna.
avere essere
TRANSITIVO INTRANSITIVO INACCUSATIVO
25
Ho mangiatoHo dormito
Sono arrivata
8) Consegna: Prova a completare la tabella in base alle indicazioni sul genere (e sul numero!).
m. f.
1. Due giorni fa (io) …………………….… una lettera.
ricevere
✓ 2. Yoko …………………….… subito. ripartire
3. (Tu) Se ancora non …………………….… il volo, devi telefonare subito alla compagnia aerea.
confermare
4. (Noi) …………………….… un week-end in un agriturismo della Toscana.
vincere
✓ 5. (Noi) arrivati a casa molto tardi ieri sera.
arrivare
✓ 6. Hiro …………………….… per Roma. partire✓ 7. Yuka e Yoko …………………….… di casa
molto presto questa mattina.uscire
8. (Voi) …………………….… ieri? lavorare✓ 9. Quando Anna …………………….… nella
stanza,…………………….… subito il cartello con i prezzi dietro la porta.
entrarevedere
✓ 10. Anche Hiro …………………….… nella stanza, ma non …………………….… il cartello.
entrarevedere
✓ 11. Io e mio marito non …………………….… mai sulla torre di Tokyo. salire
✓ 12. Io però …………………….… sulla torre Eiffel di Parigi.
salire
13. Ieri notte (io) non …………………….… bene.
dormire
✓ 14. Recentemente, i prezzi …………………….… .
aumentare
✓ 15. Le nostre vacanze …………………….… . finire
5 Informazioni supplementari e idee aggiuntive per la didatticaPremesso che la questione dei verbi inaccusativi non è così limpida
26
come potrebbe far ritenere la serie di riflessioni molto semplificate su cui ho impostato questa proposta didattica, e premesso che la categoria di questi verbi, pur essendo abbastanza omogenea, è ben lungi dall’essere compatta e chiusa a tenuta stagna, è possibile fornire una risposta a altri dubbi che di solito sorgono tra gli apprendenti di italiano LS/L2 alle prese con il problema dell’ausiliare nella formazione del passato prossimo. Tra questi, le questioni più prevedibili sono le seguenti: in che gruppo inserire il verbo essere? E verbi quali piacere, interessare, sembrare, bastare? E i verbi metereologici? Quanto al verbo essere, possiamo dire che il suo comportamento, nel significato esistenziale (es. ‘Non siamo mai stati in Australia’), nella costruzione presentativa (es. ‘C’è stato un lampo’) e nella sua funzione di copula (es. ‘Il concerto è stato grandioso’) è tipico dei verbi inaccusativi, a cominciare dal fatto che il soggetto grammaticale è identificabile in un tema.15
Anche verbi quali piacere, sembrare, interessare, bastare, sono classificabili come inaccusativi. Dal punto di vista semantico va notato che una peculiarità di questi verbi, come abbiamo detto, è che il soggetto ‘subisce’ l’azione o è comunque interessato dallo stato di cose espresso dal verbo. Per questo non si può dire che il soggetto di tali verbi sia un agente. Consideriamo due esempi con il verbo piacere:
(9) a. Tra le città italiane mi è piaciuta tanto Roma.
15 Come copula, tuttavia, va specificato che il verbo essere non viene considerato un inaccusativo vero e proprio (se con 'verbo inaccusativo' intendiamo un verbo a cui è associato un significato semantico pieno). Come mi ha spiegato Brugè (comunicazione personale), la copula, infatti, è solo un elemento la cui funzione è esclusivamente quella di fornire tratti grammaticali (persona e numero) per legittimare la realizzazione lessicale di un soggetto. Nelle costruzioni copulative il vero nucleo della predicazione è l’attributo stesso (aggettivo, nome, sintagma preposizionale), vale a dire, la parte segnalata in grassetto nelle seguenti frasi:(i) Gianni è intelligente.(ii) Gianni è medico.(iii) Gianni è di buon umore.Se aggettivi (i), nomi (ii) e sintagmi preposizionali (iii) possono selezionare un argomento, (il soggetto, in questi casi) non possono assegnare ad esso caso. Ecco, quindi, che nella struttura si inserisce la copula, la quale ha esclusivamente questa funzione. Ritornando a come viene descritta formalmente l'inaccusatività, va osservato che anche per la copula il soggetto grammaticale non corrisponde all'argomento esterno (es. l’agente) di questo verbo, esattamente come accade nei verbi inaccusativi (es. entrare, iniziare, ecc.).
27
b. Mi piacciono gli spaghetti alle vongole.
Osservando queste frasi (9a-b), appare chiaro che il soggetto non compie nessuna azione. Infatti in giapponese possiamo letteralmente tradurre una frase con piacere, es. la (9a), in questo modo:
(10) ... Roma wa watashi no konomi ni atta .... Roma WA-TEMA si è adattata al mio gusto
dove ‘konomi ni au koto’ (l’adattarsi, il conformarsi alle aspettavive del gusto dell’esperiente) non è un’azione ma uno stato che Roma ‘subisce’.Per quanto riguarda il problema con i verbi metereologici, esso riguarda il fatto che hanno una doppia costruzione possibile nei tempi composti: con ausiliare essere (‘È piovuto’) e con ausiliare avere (‘Ha tuonato’). I verbi meteorologici vengono normalmente definiti inaccusativi (cfr. Tabella 4) proprio perché selezionano l’ausiliare essere. Il fatto che non abbiano un argomento cui assegnare ruolo semantico probabilmente ha fatto sì che venisse accettato anche l’ausiliare avere (Laura Brugè, comunicazione personale). La questione tuttavia è aperta.Per quanto infine riguarda l’aspetto più propriamente applicativo della nozione di verbo inaccusativo nello studio del passato prossimo, molteplici sono le attività che possono essere elaborate partendo dalla proposta didattica sopra presentata. In una classe di studenti universitari in cui introducevo lo studio del passato prossimo ho ad esempio sfruttato la nozione di verbo inaccusativo lavorando quasi esclusivamente in senso implicito. Gli allievi avevano precedentemente appreso, su un manuale tradizionale, la regola generale schematizzata nella Tabella 1. Affermavano tuttavia di non essere in grado di stabilire quando effettivamente selezionare il verbo essere e quando il verbo avere con gli intransitivi. In questo gruppo di studenti la riflessione sulla lingua è stata impostata nel seguente modo. Dopo aver guardato i primi venti minuti del film Mediterraneo di Grabriele Salvatores, gli studenti sono stati invitati a leggere un breve testo in cui si descriveva al presente storico la trama di ciò che era stato appena visto (cfr. Figura 1).In un secondo tempo ho chiesto agli allievi di parlare dell’inizio del film
28
al passato prossimo, usando come traccia alcune frasi (cfr. Figura 2).16
Mediterraneo (1)Il periodo
(a) 1940 circa (b) 1950 circa (c) 1970 circaIl luogo
(a) l’Italia del Sud (b) l’Africa del Nord (c) la Grecia
La storiaUna nave di soldati italiani arriva a un’isola del Mediterraneo. Otto soldati scendono dalla nave per ispezionare l’isola, ma non trovano nessuno. Di notte ci sono bombardamenti in mare e la nave italiana affonda. Gli otto soldati sull’isola sono molto preoccupati. Per sbaglio, uno di loro spara e ferisce l’asina dell’alpino Strazzabosco. Lui, in collera, urla, piange, poi rompe la radio. Un altro soldato lavora notte e giorno per riparare la radio, ma niente da fare: è impossibile comunicare con l’esterno. Purtroppo, il giorno dopo, l’asina muore e tutti diventano tristi. Dopo alcuni giorni, finalmente, i soldati vedono gli abitanti dell’isola. […]
Figura 1 Esercizio (1) tratto da un’attività basata sull’uso del film Mediterraneo.
L’unica avvertenza esplicita che ho dato, è stata di fare attenzione al significato dei verbi, in quanto il nesso essere + participio passato che concorda in genere e numero con il soggetto grammaticale della frase,
16 La selezione delle frasi è avvenuta facendo attenzione di evitare i verbi che esprimevano un aspetto continuativo o una condizione, per i quali, al passato, deve essere usato l’imperfetto. Il contrasto perfetto vs. imperfetto va infatti introdotto in un secondo tempo, soprattutto quando si insegna ad apprendenti nella cui L1 tale distinzione aspettuale non è morfologicamente esprimibile come lo è in italiano. Con questo, ovviamente, non intendo suggerire l’opportunità di suddividere e presentare la grammatica per compartimenti stagni. Nella fase globale di contatto con il testo, è normale che gli allievi si trovino esposti a strutture con cui non hanno ancora familiarizzato. In fase di riflessione sulla lingua, tuttavia, appare opportuno rispettare la sequenza naturale dell’apprendimento ponendo dapprima l’attenzione su determinati aspetti prioritari e rimandando a una fase successiva la riflessione su aspetti che da questi conseguono (es. l’indicativo prima del congiuntivo; il presente prima del passato; l’aspetto perfettivo prima di quello imperfettivo, ecc.). Sulle sequenze di acquisizione dell’italiano come seconda lingua si veda ad esempio Pallotti (2000: 49-59).
29
interessa solo quelli che esprimono un ‘passaggio di stato’ del soggetto o una ripercussione sul soggetto dello stato di cose espresso dal verbo. Su undici allievi, dieci hanno capito la consegna e sono stati in grado di svolgere l’esercizio correttamente.17
Mediterraneo (2)Presente storico > Passato
1) Una nave di soldati italiani arriva a un’isola. >…………………………………………………………………………………2) Otto soldati scendono dalla nave per ispezionare l’isola.>…………………………………………………………………………………3) Non trovano nessuno.>…………………………………………………………………………………4) Quella notte, la nave affonda per i bombardamenti in mare.>…………………………………………………………………………………5) Per sbaglio, un soldato spara. Ferisce l’asina di Strazzabosco.>…………………………………………………………………………………6) Strazzabosco urla, piange e, in collera, rompe la radio.>…………………………………………………………………………………7) Un soldato lavora notte e giorno per riparare la radio, ma niente da fare.>…………………………………………………………………………………8) Il giorno dopo, purtroppo, l’asina muore e tutti diventano tristi.>…………………………………………………………………………………9) Dopo alcuni giorni, finalmente, i soldati vedono gli abitanti dell’isola.>………………………………………………………………………………… […]
Figura 2 Esercizio (2) tratto da un’attività basata sull’uso del film Mediterraneo.
Laddove esista l’interesse della classe a riflettere sulla lingua con concetti teorici, potrebbe essere utile introdurre anche le nozioni di ‘agente’, ‘tema’ verbo ‘inergativo’ vs. ‘inaccusativo’, e lavorare esplicitamente con la grammatica comparativa. È ad esempio interessante notare che esiste una corrispondenza tra verbi inaccusativi italiani e giapponesi e che anche in giapponese (che è appunto la L1 dei soli allievi con cui lavoro) esistono prove di inaccusatività usate per
17 Lo stesso approccio è da me ormai abitualmente seguito con profitto nelle cassi che insegno all’università, frequentate prevalentemente da ragazzi che riesco a motivare unicamente se propongo attività ‘piacevoli’ di problem solving.
30
individuarli. Sulla base di questa corrispondenza è pertanto possibile sviluppare esercizi di raggruppamento dei verbi che consentano all’allievo di riflettere non solo sulle proprietà sintattiche della LS ma anche su quelle della L1. Tsujimura (1997: 329), ad esempio, descrive i verbi inaccusativi giapponesi come verbi che presentano inerentemente una meta o un punto di arrivo come parte del loro significato. La descrizione non è poi così dissimile da quella che ho proposto nel principio generale su cui ho fondato la mia ‘prova di inaccusatività’ la quale, evidentemente, non costituisce solo un espediente glottodidattico di sintassi ingenua basato sulla semplice intuizione, ma è un fatto riconducibile a una regola profonda, teoricamente fondata, e condivisa dal sistema di funzionamento di lingue diverse.
RiconoscimentiRingrazio la Dottoressa Laura Brugè dell’Università Ca’ Foscari di Venezia per aver pazientemente, e a lungo, discusso con me alcuni punti della teoria dei ruoli semantici e per avermi spiegato parecchi aspetti del comportamento dei verbi inaccusativi. Mi assumo, naturalmente, la piena responsabilità di eventuali inesattezze contenute in questo contributo.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICIBALBONI, P., E. (1997). “Tecniche di didattica grammaticale”. In B.
Cambiagli (cur.)BALBONI, P., E. (1998). Tecniche didattiche per l’educazione
linguistica. Torino: UTET.BALBONI, P., E. (2000). “Per una didattica umanistico-affettiva
dell’italiano”. In R. Dolci, & P. Celentin (cur.) (2000): 13-19.BRUGÈ, L. (2000). “Teoria linguistica e insegnamento della
grammatica”. In R. Dolci &, P. Celentin (cur.) (2000): 42-61.BRUGÈ, L. (2003). “La linguistica nella glottodidattica”. Modulo
Master Itals. Laboratorio Itals. Università Ca’ Foscari di Venezia. http://www.itals.it
CAMBIAGHI, B. (cur.) (1997). La didattica della grammatica. Brescia: CLUC-La Scuola Editrice.
DANESI, M. (1988). Neurolinguistica e glottodidattica. Padova: Liviana.
DANESI, M. (1998). Il cervello in aula. Perugia: Guerra.DARDANO, M., & TRIFONE, P. (1985). La lingua italiana. Bologna:
Zanichelli.DOLCI, R., & CELENTIN, P. (cur.) (2000). L’insegnante di italiano
31
all’estero: Percorsi di formazione. Roma: Bonacci.FORNACIARI, R. (1881). Sintassi italiana dell’uso moderno. Firenze:
Sansoni. [Ristampa anastatica Firenze 1974).FREDDI, G. (1994). Glottoddattica. Fondamenti, metodi e tecniche.
Torino, UTET.FREDDI, G. (1999). Psicolinguistica, sociolinguistica e glottodidattica.
Torino, UTET.GRAFFI, G. (1994). Sintassi. Bologna: Il Mulino.HAEGEMAN, L. (1994). Introduction to Government & Binding.
Oxford: Blackwell.ISHIKAWA, M., & ZAMBORLIN, C. (i.c.s.). Supplemento in lingua
giapponese a Rete! [Primo approccio – parte A]. A cura di M. Mezzadri, & P. E. Balboni. Perugia: Guerra.
KATERINOV, K. (1992). La lingua italiana per stranieri. Perugia: Guerra
LEONE, A. L. (1970). “Una regola per gli ausiliari”. LN, XXXI: 24-30.LEPSCHY, L., & LEPSCHY, G. (1993) La lingua italiana. Milano:
Bompiani.LO DUCA, M. G. (1997). Esperimenti grammaticali. Riflessioni e
proposte sull’insegnamento della grammatica dell’italiano. Firenze: La Nuova Italia.
MEZZADRI, M., & BALBONI P. E. (2003). Rete! Corso multimediale per stranieri [Primo approccio –parte A]. Perugia: Guerra.
PALLOTTI, G. (2000). La seconda Lingua. Milano: Bompiani.RENZI, L. (cur.), (1988). Grande grammatica italiana di consultazione.
Vol. 1. Bologna: il Mulino.ROHLFS, G. (1969). Grammatica storica della lingua italiana e dei
suoi dialetti. Sintassi e formazione delle parole. Torino: EinaudiSALVI, G. (1988) “La frase semplice”. In L. Renzi (cur.), (1988).SERIANNI, L. (1991). Grammatica italiana. Italiano comune e lingua
letteraria. Torino: UTET.TSUJIMURA, N. (1997). An Intrroduction to Japanese Linguistics.
Oxford: Blackwell.ZAMBORLIN, C. (2000). “Italiano come LS per adulti: Coordinate
didattiche di riferimento”. In R. Dolci, & P. Celentin (cur.) (2000): 117-132.
ZAMBORLIN, C. (2002). “Tra frasi come molecole ed ergatività: Una classificazione dei verbi ‘fuori dagli schemi’”. In Biblioteca Master Itals. Laboratorio Itals. Università Ca’ Foscari di Venezia. http://www.itals.it