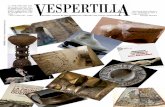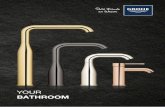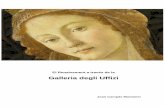Antonio Ruffo di Bagnara e la galleria d’arte di Messina nel secolo XVII
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of Antonio Ruffo di Bagnara e la galleria d’arte di Messina nel secolo XVII
Antonio Ruffo di Bagnara e la galleria d’arte di Messina nel secolo XVII
La Gran Casa dei Ruffo di Bagnara annovera personalità di spicco che si sono distinte in ambito
politico e religioso non solo nel Regno di Napoli ma anche in altre parti d’Italia. Tra questi
personaggi spicca indubbiamente don Antonio Ruffo che diede vita ad uno dei rami più floridi e
forti che il Casato di Bagnara abbia mai generato: i Ruffo della Scaletta e della Floresta.1.
Antonio Ruffo, ultimo figlio del duca Carlo di Bagnara, non era ancora nato alla morte del padre
e fu il figlio postumo previsto nel testamento. Nacque nel 1610 con molta probabilità nel castello di
Bagnara, o forse anche a Messina, dove si ritirò la duchessa Antonia Spatafora e Alliata, qualche
tempo dopo la morte del marito2.
La duchessa, che aveva origini messinesi, fece sposare l’ultimo figlio, Antonio, nel 1641 con una
sua pronipote Alfonsina Gotho figlia di Placido Gotho, barone della Floresta.
La vedova Ruffo finanziò la costruzione, essendosi presentata l’occasione propizia, di una
sontuosa dimora a Messina per il ramo cadetto dei Ruffo di Bagnara. Ella infatti si offerse di
completare i lavori, intrapresi dal Senato messinese, costruendo un palazzo a livello di quelli già
iniziati, per continuare decorosamente la strada Emmanuela3. La costruzione del nuovo palazzo fu
eseguita in breve tempo, grazie anche ai mezzi economici forniti da don Flavio Ruffo abate di San
Bartolomeo e di Sinopoli, figlio della duchessa, il quale, pur vivendo tra Roma e Napoli, non
trascurava certo gli affari in Sicilia, dove, oltre agli interessi di Messina, aveva la gabella delle
licenze d’armi della città di Augusta e delle terre di Monteforte, San Pietro e Scaletta. Nel 1646
nella regale dimora andarono a vivere, oltre alla duchessa, don Antonio e la moglie Alfonsina4.
Antonio Ruffo, appena sposatosi, “fu ammesso al patriziato della Mastra Nobile e nel 1645
venne eletto senatore nobile della città. Con il suo arrivo a Messina ebbe la gabella del biscotto,
già appartenuta a Federico Spatafora, ossia l’appalto della fornitura del biscotto, soprattutto per
le galee dell’ordine dei cavalieri di Malta, la gabella sui frumenti e le farine che entravano nel
Regio Campo delle vettovaglie, la fornitura del legname per la costruzione e riparazione delle navi
dell’Armata Reale e della flotta dell’ordine di Malta, la gestione dell’arsenale, la gabella della
1 D. GIOFFRÈ, La Gran Casa dei Ruffo di Bagnara, Reggio Calabria, 2010, p. 23.
2 V. RUFFO, La Galleria Ruffo nel secolo XVII a Messina, Bollettino d’arte, 1916, p. 21.
3 “La strada Emmanuela prende il nome dal principe Emmanuele Filiberto, gran priore di Castiglia e fratello del duca di Savoia Vittorio Amedeo I. Essendo Viceré in Sicilia, nella sua permanenza in Messina, prese a cuore la sistemazione della Marina, ossia del Teatro Marittimo. Per la costruzione della Palazzata della nuova strada, in suo onore fu denominata Emmanuela”. Ibidem, p. 22.
4 Ibidem, p. 23.
1
seta, i cui proventi, aggiunti a quelli ricavati dal traffico dei suoi bastimenti col commercio della
seta, del legname, lardo, carne salata e formaggi di Calabria, oltre alle rendite del suo patrimonio,
gli consentirono di fare acquisti di ogni genere” 5. Addirittura egli forniva al Senato il denaro per
acquistare il frumento per vettovagliare la città.
Le entrate di Antonio Ruffo, già vistose, continuarono a crescere: “assunse la gabella o appalto
della neve, che da lungo tempo veniva fornita dai Ruffo, che possedevano buona parte delle
montagne della bassa Calabria”6. Occupò ancora pubblici uffici, fu infatti senatore una seconda
volta nel 1648 e poi nel 1654, carica che non rifiutò nemmeno nel 1660-61, in momenti alquanto
turbolenti quando si trovò a sostenere, con altri senatori, i privilegi della città contro il viceré conte
di Ayala. Lo scontro fu aspro e il conte di Ayala tentò di incamerare i beni del Ruffo ma poi tutto si
risolse con il regio decreto del 5 ottobre 1662 di conferma dei privilegi della città. A questo punto
Antonio Ruffo decise di ritirarsi dagli incarichi pubblici e, quale gran signore e mecenate delle
maestranze e degli artisti, trasformò la sua dimora in un tempio di arte e di cultura7.
Antonio Ruffo, Principe della Scaletta (Collezione della
5 Ibidem, p. 24.
6 Ibidem, p. 27
7 Idem
2
Nobile Arciconfraternita degli Azzurri, Messina)8
Don Antonio Ruffo fu un grande collezionista di opere d’arte; per conto suo l’abate Flavio Ruffo,
vivendo a Roma, acquistava quadri e opere di inestimabile valore, per abbellire la galleria del suo
celebre palazzo. Altri acquisti furono effettuati tra Napoli e Malta dai nipoti del duca, ossia dal frate
domenicano Tommaso Ruffo e da Fabrizio Ruffo, balì9 della Gran Croce di Malta e priore di
Bagnara10. Altri quadri furono commissionati direttamente a pittori, magari all’estero, come quelli di
Rembrandt e di Iardaens d’Anversa, o acquistati per mezzo di intermediari in diverse città. Alcune
opere pervennero dall’eredità dell’abate don Flavio Ruffo, morto di peste nel 1656 nella sua villa
del Granatello a Portici, e da quella della duchessa di Bagnara, madre di don Antonio, nel 166011.
Infatti la duchessa di Bagnara, con atto del 28 agosto 1655, dichiarava che nella costruzione del
palazzo, aveva agito sempre per parte e nell’interesse del figlio abate don Flavio, che ne era il vero
proprietario. Tuttavia don Flavio abitava a Napoli in un grandioso palazzo di via Toledo. Quando
egli si ritirò nella sua villa del Granatello a Portici, dichiarò usufruttuaria del suo patrimonio la
madre ed erede universale il fratello don Antonio. La duchessa nel 1659 rinunciò all’usufrutto e
lasciò il suo patrimonio al figlio Antonio, insieme a diversi quadri del Vaccaro, che così entrarono
anch’essi nella dotazione artistica galleria. Ella venne sepolta a Messina nel monastero di San
Gregorio, luogo preferito dalle monache di casa Ruffo12.
Del cospicuo medagliere annoveriamo: “una medaglia grande da 100 zecchini in oro di Carlo V,
15 medaglie d’oro di imperatori e pontefici, 17 medaglie antiche di rame dei Ruffo e dei sigilli di
rame del conte di Catanzaro Pietro Ruffo di Calabria, del conte Guglielmo Ruffo, di Guglielmo
8 M. C. CALABRESE, Nobiltà, mecenatismo e collezionismo a Messina nel XVII secolo. L’inventario di Antonio Ruffo, principe della Scaletta, C.U.E.C.M., Catania, 2000, p. 34.
9 Balì: alto grado di alcuni ordini cavallereschi.
10 V. RUFFO, op. cit., p. 24
11 E. CAPIALBI – F. PITITTO, Lettere e quadri di Mattia Preti per la galleria Ruffo, in A. S. C., periodico bimestrale, Barbaro Editore, anno II, 1914, pp. 22-23.
12 “In S. Gregorio furono monache, tra le altre, suor Illuminata figlia di Francesco duca di Bagnara, Suor Maria Teresa figlia di Pietro visconte di Francavilla, ambedue nipoti di don Antonio, Imara, Antonia, Vittoria e Teresa sorelle del cardinale decano Tommaso, un’altra Imara sorella del cardinale Antonio, Andreana e Illuminata zie del famoso cardinale generale Fabrizio. Tutte abbellirono il monastero, ma suor Saveria Ruffo e Colonna figlia di don Antonio juniore, principe della Scaletta e della Floresta, nel 1743 fece fare la facciata della chiesa a sue spese e vi pose il suo stemma”. V. RUFFO, op. cit., p. 26. v. nota.
3
Ruffo conte di Sinopoli, di Nicolò Ruffo di Calabria conte di Catanzaro e marchese di Crotone, di
G. F. Marino Marzano Ruffo principe di Rossano, duca di Sessa e di Squillace, conte di Montalto
di Alife, figlio ed erede della celebre Cobella Ruffo”13.
Lo scalone di palazzo Ruffo, che portava alle stanze e alla galleria, era adorno di varie statue di
marmo, tra cui un busto di Pallade, comprato a Napoli nel 1671, quello di Scipione l’Africano, fatto
da Gaspare Serpotta in Palermo, un mezzo busto di Giulio Cesare con la corona di lauro in testa,
acquistato a Napoli il 20 Giugno 1673, e altre opere. Le sale erano state decorate da artisti di
notevole fama come il napoletano Nunzio Russo, Antonio Bova, Agostino Scilla14. Varcando
l’entrata del palazzo, un’imponente scalinata conduceva ad un’anticamera affrescata con le
raffigurazioni di divinità pagane: Nettuno e Minerva in un’apoteosi di mostri marini. Era l’
omaggio allo Stretto di Messina15.
La prima sala ospitava un quadro di Don Pietro Ruffo di Calabria, conte di Catanzaro, a cavallo.
Ai lati grandi medaglioni con le effigi di Giulio Cesare, Scipione e l’imperatore Tiberio: esaltazione
del mito dell’Antichità da cui discendeva l’origine della famiglia Ruffo. La seconda camera era
incentrata sul mito di “Giove e la favola di Danae”, in mezzo a numerose allegorie. Il Padre degli
Dei era circondato da sette quadri dei Ruffi antichi. In tal modo si esaltava il valore militare del
Casato, un valore legato alle grandi virtù dei Nobili Cavalieri medievali. Procedendo si accedeva
alla terza camera arredata con quadri che rievocavano l’opera principale collocata di fronte
all’ingresso: lo “Sposalizio del Merito e della Verità che scaccia l’invidia e l’avarizia”. Anche con
questa raffigurazione si elogiava il valore dell’ intelletto e il merito della Gran Casa, un’esistenza,
quella dei Ruffo, condotta senza invidia e senza avarizia, votata alla virtù umana. La quarta sala era
dedicata alle “Metamorfosi di Ovidio” e a “Giove e i Giganti” in mezzo a quadri di angeli e fiori:
apoteosi della Bellezza e della Dolcezza, come stile di vita e comunicazione16.
Il Palazzo Ruffo con la sua pinacoteca, il medagliere, le argenterie artistiche, i ricchi arazzi, gli
splendidi affreschi, divenne un luogo di incontro degli intellettuali del tempo. Artisti, letterati,
scienziati erano soliti soggiornare nel palazzo, ed anche dopo la morte del principe don Antonio, i
suoi figli, tra cui vi erano musicisti, pittori, poeti ed oratori, continuarono l’opera del padre
13 Ibidem, p. 25.
14 Ibidem, p. 26.
15 T. PUNTILLO, Il 1783 in Calabria in generale e a Bagnara in particolare. Il terremoto e i terremoti , parte seconda, (1783-1793). L’apocalisse e i terremoti, A. S. F. B., Bagnara Calabra, maggio, 2008, p. 25.
16 Idem
4
arricchendo la biblioteca e facendo del loro palazzo una vera e propria fucina di cultura17. Una
sensibilità verso l’arte e il bello che don Antonio trasmise soprattutto al figlio Antonino, musicista,
pittore e letterato, autore del celebre poemetto drammatico “Natale di Cristo”, dedicato al potente
zio, il cardinale Tommaso Ruffo, un’opera ispirata ai principi morali che costituivano il nucleo
spirituale fondante della Famiglia Ruffo18.
Incisione con veduta di Messina di Paolo Filocamo,
in Antonio Ruffo, Il Natale di Cristo. Poemetto
drammatico di Antonino Ruffo all’Eminentissimo
e ReverendissimoSignor Cardinale Ruffo,
Messina, presso D. Vittorio Maffei, 171719.
Ogni anno la galleria aumentava il patrimonio grazie a nuovi acquisti e la Casa di don Antonio se
ne avvantaggiava ottenendone maggiore fama. Il suo primogenito, Placido Ruffo, ottenne sulla
baronia a lui ceduta dalla madre Alfonsina, il titolo di principe della Floresta. Più tardi, nel 1672,
17 V. RUFFO, op. cit., p. 27.
18 PUNTILLO, Il 1783 in Calabria in generale e a Bagnara in particolare. Il terremoto e i terremoti, parte seconda, op. cit., p. 26.
19 CALABRESE, Nobiltà, mecenatismo e collezionismo a Messina nel XVII secolo. L’inventario di Antonio Ruffo, principe della Scaletta, op. cit., p. 36.
5
don Antonio comprò il principato e le terre della Scaletta ed ebbe anche l’investitura di principe di
Scaletta e Guidomandri, il 30 luglio del 1673.
Castello Ruffo – Scaletta (ME).
Nell’anno 1672-73 fu nominato governatore della nobile Arciconfraternita degli Azzurri,
sostituendo il nipote Vincenzo20.
20 Vincenzo Ruffo, uno dei figli di Francesco duca di Bagnara, si sposò in Messina con Lucrezia figlia di Placido Ventimiglia. Suo figlio Francesco fu duca di Mileto. V. RUFFO, op. cit., p. 28. v. nota.
6
Ritratto di Vincenzo Ruffo di Bagnara ( Collezione della
Nobile Arciconfraternita degli Azzurri, Messina)
La galleria aveva raggiunto il massimo fasto nel 1674 allorché scoppiò la rivoluzione di Messina
contro la Spagna; in tale occasione il principe della Scaletta aveva dovuto consegnare al Senato
messinese qualche pezzo delle sue argenterie artistiche, visto che in quella strenua lotta tra partiti
avversi - i Merli favorevoli alla Spagna e i Malvizzi favorevoli all’intervento francese -, era
guardato con sospetto e tre dei suoi figli erano stati trattenuti come ostaggi. Don Antonio Ruffo
trovò riparo a Palmi in Calabria, dove trasportò buona parte della sua galleria. Fece ritorno a
Messina solo nel marzo del 1678 quando, scacciati i Francesi, si insediò il governo spagnolo.
Gravemente malato di idropsia, morì il 16 giugno 1678 e venne sepolto nella cattedrale, nella
Cappella di Cristo risorto21.
La collezione di quadri del Ruffo comprendeva 364 opere di artisti di fama internazionale del
calibro di: Brughel, Durer, Novelli, Polidoro da Caravaggio, Poussin, Mattia Preti, Guido Reni,
Tiziano, Tintoretto, Annibale Carracci, Paolo Veronese, Pietro da Cortona, Dossi, Guercino, Palma
il Vecchio, Giovanni l’Olandese, Vincenzo Romano, Andrea Sacchi, Claudio Lorenese, Carlo
Maratti, Castiglione, Giacinto Brandi, Luca d’Olanda, Salvator Rosa, Van Dyck, Vouet, De Ribera
detto lo Spagnoletto, Artemisia Gentileschi ecc.
Antonio Ruffo era solito iniziare una lunga e florida corrispondenza epistolare con diversi artisti a
lui contemporanei. Dalla corrispondenza dei diversi pittori si evince quanta affabilità corresse tra
21 E. CAPIALBI – F. PITITTO, op. cit., p. 23.
7
essi e il principe, il quale per la sua generosità e la sua cordialità era carissimo agli artisti, anche
quando non lo conoscevano personalmente come la Gentileschi di cui riportiamo una lettera:
Ill.mo S.r Mio
Con questo mio avviso à V. S. Ill.ma haver ricevuto la sua delli 21 di febbraio tutta piena di quella
gratia, che sol fare V. S. Ill.ma la serva sua Artemisia, et insieme la inclusa polisa di cambio di cento
ducati, sento poi, quel che mi comanda circa l’opera che li devo fare, la quale spero dal S.re Iddio di
far tal cosa, che gli dara gran gusto, e di là vedrà V. S. Ill.ma quanto vaglia la cortesia in petto
virtuoso; mi dispiace bene, che la Calatea habbia patito per mare, che se mi fusse stato concesso di
havere conseguito li suoi comandi, non sarebbe intervenuto questo, mentre l’havesse comodato io
con le mie mani ma quest’altro non riuscirà così, già starà in mio arbitrio in eseguire i suoi
comandi; quanto prima manderò il mio ritratto insieme qualche operetta della mia s.ra figlia la
quale hoggi l’ho maritata con un Cavalier dell’Abito di San Giacomo, et mi ha scasato, e per tanto
prego V. S. Ill.ma che se vien qualche occasion d’opere in cotesto paese che Lei col suo solito favore
mi favorisca, et mi avisi per che ne ho grandissimo bisogno, che assicuro a V. S. Ill.ma che son
fallita, desidero anco che V. S. Ill.ma mi prometta che mentre io vivo tenga patrocinio sopra mia
persona, e faccia conto, che io sia nata sua schiavottella in casa sua, io non ho visto V. S. Ill.ma ma
però è tanto l’affetto, et il desiderio che tengo di servirlo, che è cosa che cede al imaginatione; non
starò più a fasti dirlo di queste chiacchiere femenili, ma l’opere saran quelle che parleranno e con
questo fo fine, e humilissima riverenza
Napoli hoggi li 13 di Marzo 1649
Di V. S. Ill.ma
humilissima serva
Artemisia Gentileschi22
Interessante risulta la corrispondenza del Ruffo con Mattia Preti23, incaricato di eseguire quadri
ma anche di acquistarne di artisti quali Tintoretto, Tiziano, Paolo Veronese e altri. Nella galleria
Ruffo si trovavano quattro quadri dell’artista calabrese: Sofonisba che si avvelena, Storia di
Rachele, Dionisio di Siracusa maestro di scuola, San Luca nudo sopra un bove che sta dipingendo
la Madonna24.
22 V. RUFFO, op. cit., pp. 48-49.
23 Mattia Preti, detto il Cavalier calabrese, poiché cavaliere gerosolimitano, nacque in Calabria, a Taverna nel 1613.
24 E. CAPIALBI – F. PITITTO, op. cit., pp. 23-24.
8
Riportiamo di seguito qualche missiva inviata da Mattia Preti a don Antonio Ruffo, attestante la
stima e la fiducia che intercorreva tra l’artista e il principe:
Ill. mo Sign. P. ron Cole. mo
Mi conosco tanto favorito dalla memoria che tiene di un suo servitore con la carissima lettera
ricevuta, alli 11 Giugno – che sarei fuori di me stesso quando non abbracciassi più che volentieri
ogni occasione che mi sarà commandata da S. S. Ill.ma stimando mio particolare signore, intorno
poi all’opera che mi significa della Chiesa Maggiore l’abbraccio volentieri prima per incontrare il
gusto di S. S. Ill.ma e poi per fare che anche in Sicilia ci siano opere mie a fresco mentre per tutta
l’Italia ne ho fatte in quanto alla fatica che incontrerò non mi ricordo bene della Grandezza ma
simili opere si costuma pagare tanto per figura cioè le intiere e tanto le meze non intendendosi le
lontane perché vanno per adornamento alle principali figure, al Domenichino li Signori del Tesoro
di Napoli li davano cento trenta ducati per figura al Lanfranchi le ne davano cento io poi lo rimetto
a S. S. Ill.ma come signore intelligentissimo di questa professione che se non fara cosa che sara di
mio danno né della Cita avertendola che armamento dei ponti e calcina e fabbricatori vanno a spese
di chi fa fare l’opera avverto anche S. S. Ill.ma e che effettuandosi la sudetta opera che io sia sicuro
del pagamento e che secondo si va facendo l’opera si vada pagando e nel mio arrivo mi sia data
caparra per spese che averò da fare per detta opera e la prego che se si risolvessero sia presto
perché mi ritrovo in tratao con li Patri di Monte Cassino benché non sia conclusa cosa nessuna e io
più volentieri verrei costì che andare in Montagna, benche non guadagnerei tanto; di quello che S.
S. Ill.ma mi dice di alcun quatro di gran pittore staro su l’aviso e se capitera ne sara avisato da me e
sevita la lettera che inviava era solo per salutarla mentre non poteva farlo di persona come al
presente fo con ricordarli la mia devota servetu e li bagio riverentemente le mani di Napoli li 12
Giugno 1660.
Di S. S. Ill.mo
Devotissimo servitore
Fra Mattia Preti25
Da questa lettera si scopre che don Antonio Ruffo e Mattia Preti si conoscevano già prima di
iniziare la loro corrispondenza, e che il Ruffo trattava con lui, che si trovava all’epoca a Napoli, per
fargli dipingere a fresco la Cattedrale di Messina, dato che non vi era alcun affresco in Sicilia del
Cavaliere calabrese, le cui tele invece erano sparse per tutta la penisola. Per ciò che concerne il
prezzo il Preti cita il Domenichino ed il Lanfranco26 che pure avevano lavorato a Napoli negli
25 Il Preti come tutti i Cavalieri di Malta soleva far precedere il nome dal “fra”. I “frà” Cavalieri di Malta erano dunque fratelli congregati nella Confraternita dell’Ordine. Ibidem, p. 26.
26 Il primo è Domenico Zampieri, il secondo è Giovanni Lanfranco, artisti operanti in Italia tra il XVI-XVII secolo.
9
affreschi della cappella del Tesoro. In questo contesto appare chiaro che il Preti trattasse per
dipingere nella badia di Monte Cassino, e che il Ruffo lo avesse incaricato dell’acquisto di qualche
quadro di grandi pittori27.
Un’altra interessante lettera è la seguente:
Ill.mo Sign. P.ron Col.mo
Dalla sua carissima da me ricevuta vedo la causa della tardanza che S. S. Ill.ma fece di non
rispondere alla mia lettera parendoli troppo ardua la mia dimanda io però la rimessi alla sua
attorità che à me con un suo devoto servitore ben che altre volte sono stati ciamato per fare opere
come fui in Modena ciamato dal duca bona memoria che mi dono due mila scuti e casa franca a
anche viagio pagato di andare a venire e di più mi regalo di una catena come potra S. S. Ill.ma
informarsi dall’Em.ssimo Sign. Cardinale d’Este. Ora per il desiderio che ho di servire S. S. di
persona e anche di essere onorato da questa nobilissima Cita di Messina in una opera publica per la
medesima Cita mi onori di una sua lettera per tale opera e io son prontissimo alli suoi commandi
con quella diligenza e fatica che le mie forse potranno e dal suo savio giuditio tali saranno
giudicati mentre per fine li bagio le mani di Napoli li 2 Ottobre 1661.
Di S. S. Ill.ma
Devoto servitore
Fra Mattia Preti28
A Messina era opinione generale che il Preti nel sostenere che il Domenichino era stato pagato a
130 ducati per ogni figura ed il Lanfranco a 100, volesse affermare che, pur se egli non si ritenesse
al pari del Domenichino, non credeva di valere meno del Lanfranco. Pertanto pretendeva essere
retribuito nella stessa misura. La pretesa apparve assurda a don Antonio Ruffo, che in quel periodo
era senatore della città per la terza volta e ritenne opportuno non rispondere all’artista. A lui
comunque si rimetteva il Cavaliere calabrese per giungere ad un accordo, facendogli però conoscere
come lo avesse remunerato il duca di Modena Francesco I d’Este, morto nel 1658, quando lo aveva
interpellato per la decorazione del palazzo ducale di Modena. Ad ogni modo l’artista per deferenza
al Ruffo e alla città di Messina avrebbe accettato un trattamento più modesto29.
27 E. CAPIALBI – F. PITITTO, op. cit., p. 26.
28 Ibidem, p. 27.
29 Ibidem, p. 28.
10
Con la morte di don Antonio Ruffo, la galleria rimase indivisa in possesso del primogenito don
Placido Ruffo. Tuttavia molto presto la collezione iniziò a disperdersi medianti doni, usurpazioni e
confische giudiziarie. Nonostante infatti la fedeltà dei Ruffo della Scaletta e della Floresta alla
Spagna negli anni della rivolta di Messina, Placido fu avversato nel periodo che va dal 1692 al 1696
dal viceré duca di Uzeda che lo imprigionò nella Cittadella con l’accusa di aver ordito una congiura
contro il re e di essere il responsabile dell’incendio del lazzaretto, avvenuto nel febbraio del 1691.
L’intervento del fratello Don Flavio, che si recò nel 1693 a Palermo per perorare la causa di Don
Placido presso il viceré, riuscì nell’intento di far promulgare una sentenza di assoluzione a cui seguì
la scarcerazione del principe il 4 dicembre 1693. In cambio della “generosità” del duca di Uzeda,
Don Flavio consigliò al fratello di inviare al viceré un quadro di Salvator Rosa e due vasi d’argento
cesellati da Innocenzo Mangani30. Le vessazioni del duca Uzeda non finirono e Placido si vide
costretto a rinunciare ad ulteriori quadri tra cui il Filosofo Archita Tarantino con la sua colomba del
Rosa, la Presentazione dei re magi di Vincenzo Romano, discepolo di Raffaello, la Madonna col
Puttino e San Giovanni del Franceschini, la Madonna col Bambino che tiene una rosa in mano del
Gennari, come indennizzo per la grazia concessa al principe31.
Alla morte di don Placido Ruffo il 6 Maggio 1710 la galleria era ridotta a 166 quadri. Alcune
opere andarono al primogenito Antonio Ruffo e La Rocca principe della Floresta che, con atto di
elezione del 1710, scelse i 100 quadri della primogenitura, altre furono divise tra i fratelli di don
Placido. In seguito don Antonio riuscì a recuperare i quadri ceduti agli zii don Federico nel 1718,
don Flavio nel 1725 e don Giovanni nel 1731, oltre ad altri quadri che costoro possedevano al di
fuori di quelli della galleria paterna32.
Dopo la morte del principe don Antonio juniore, per la disposizione da lui fatta in favore della
moglie Eleonora Ruffo e Colonna, sorsero gravi questioni tra costei e il figlio principe don
Calogero. Con la morte di quest’ultimo, insieme ai suoi fratelli, senza figli, nella peste del 1743, si
aprì la difficile questione della successione tra la sorella Antonia Ruffo e Colonna, moglie del duca
don Antonio Ruffo e Moncada, e lo zio don Giovanni Ruffo e La Rocca. Finalmente dopo varie
transazioni fatte tra il 1745 ed il 1750, il fedecommesso primogeniale agnatizio33, stabilito dal
30 M. C. CALABRESE, I Ruffo a Francavilla, la “corte” di Giacomo nel Seicento, Armando Siciliano Editore, Messina, 2001, p. 51.
31 Idem
32 V. RUFFO, op. cit., p. 377.
33 Agnatizio: che riguarda la parentela in linea maschile.
11
principe don Antonio seniore nella donazione propter nuptias del 1673 al figlio Placido, fu attribuito
a don Giovanni Ruffo e La Rocca, che diventò principe della Scaletta, e il resto alla duchessa
donna Antonia che divenne principessa della Floresta. La galleria Ruffo, dunque, dopo il lodo del
1750, restò nel palazzo al Regio Campo, il quale, facendo parte del fedecommesso, toccò a don
Giovanni Ruffo e La Rocca. Dopo quell’epoca, essendosi divisa la casa Ruffo nei rami di Scaletta e
Floresta, mancano negli archivi a noi disponibili, i documenti inerenti il nuovo ramo di Scaletta e
per conseguenza quelli della galleria34. Ad ogni modo il patrimonio subì nel corso degli anni
ulteriori danni: le continue liti giudiziarie tra parenti, il terribile sisma del 1783 che sconvolse
Sicilia e Calabria e lo spaventoso incendio che devastò il Palazzo nel 1848, ridurranno
ulteriormente l’intera collezione. I quadri e i diversi tesori, superstiti alle calamità appena
accennate, appartenuti alla galleria si trovano oggi, con ogni probabilità, sparsi in varie gallerie
italiane ed estere35.
34 Ibidem, pp. 377-379.
35 Ibidem, pp. 380-388.
12
Aristotele contempla il busto di Omero. Olio su tela di Rembrandt - Metropolitan Museum – New York36.
36 “Il dipinto, un olio su tela di cm 143,5 x 136,5 fu realizzato nel 1653 dal pittore Rembrandt Harmenszoon Van Rijn. Conservata al Metropolitan Museum of Art di New York l'opera, firmata e datata "REMBRANDT F. 1653", è la prima di un trittico che comprende Alessandro Magno e Omero, a celebrazione dei più grandi uomini della Grecia antica. Aristotele tiene una mano destra su un ritratto scultoreo di Omero, mentre la sinistra è posata sulla catena d'oro da cui pende un ritratto di Alessandro Magno, suo allievo. Nel quadro compaiono così anche le due opere successive, appena accennate.Fu eseguita per don Antonio Ruffo, che la pagò 500 fiorini, e gli fu inviata a Messina nel 1654. Il Ruffo, nel 1660, commissionò al Guercino una tela raffigurante una mezza figura che si potesse accordare con il dipinto del Rembrandt: a questo scopo gli inviò uno schizzo dell'opera che il Guercino interpretò come un Fisionomista che stesse studiando su una scultura i lineamenti di un volto, proponendo di dipingere in correlazione un Cosmografo intento a studiare un mappamondo. L'anno successivo, il Ruffo inviò a Mattia Preti gli schizzi dei dipinti del Rembrandt e del Guercino, richiedendo un altro dipinto che ad essi si accordasse e il Preti dipinse un Dionigi di Siracusa. Le opere del Guercino e del Preti sono tuttavia andate perdute. La famiglia Ruffo conservò il dipinto fino al 1760; pervenuto in Inghilterra, passò nel 1928 al collezionista americano Alfred Erickson e fu acquistato il 15 novembre 1961 dal Metropolitan Museum per 2.300.000 dollari, la più alta cifra mai spesa fino ad allora per un quadro”. http://it.wikipedia.org/
13