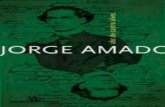Castro. Nuovi dati sulla frequentazione di età protostorica
-
Upload
unisalento -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Castro. Nuovi dati sulla frequentazione di età protostorica
LUIGI COLUCCIA
CASTRO. NUOVI DATI SULLA FREQUENTAZIONE DI ETÀ PROTOSTORlCA'
L'odierno abitato di Castro è ubicato a circa metà strada sul litorale che da Otranto procede verso il Capo di Santa Maria di Leuca. Rocca inespugnabUef per la sua posizione, andò evolvendosi nel corso dei secoli, mantenendo costantemente una vocazione peculiare di avamposto strategico, proteso verso oriente a controllo del Canale d'Otranto. Tale connotazione potrebbe essere alla base di una frequentazione del luogo già in età protostorica, come dimostra un numero sempre crescente di dati, in g ran parte inediti, che verranno di seguito presentati in via preliminare.
È opportuno ricordare come Castro sia stato oggetto di ricerca fin dal momento iniziale della Paletnologia in Italia, soprattutto in ragione della presenza nel suo territorio di numerose cavità carsiche, occupate già in epoca preistorica: particolare menzione meritano, infatti, le celebri grotte Romanelli e Zinzulusa '. Fu soprattutto la prima, tra fine '800 ed inizi '900, a rivestire un ruolo determinante nel processo di revisione dei precedenti approcci metodologici della Paletnologia italiana2
Le informazioni di cui disponiamo circa il popolamento protostorico del sito di Castro sono il fruito di alcune limitate ricerche operate in tempi diversi e da più autori3. Oltre a queste, esiste un discreto repertorio b ibliogra-
* Desidero rivolgere un sentito ringraziamento tll prof. Francesco D'Andria per l'opportu nità fornitami di redigere questa prima nota su ll e conoscenze acquisite per la tarda e tà del Bronzo a Castro. Colgo, inoltre, l'occasione per esprimere la mia riconoscenza nei confronti del dotto Marco Merico, amico fidato e prezioso consigliere, e dell'ingegnere Angelo Micello, esperto collaboratore nelle fasi di rilievo grafico.
) Entrambe le grotte si aprono tra i 7 e gli 8 m sul livello del mare, lungo la scogliera che da Castro, in direzione nord, porta a S. Cesarea Terme (fig. l , nn. 1, 2).
2 Per una storia degli studi su Grotta Romanelli e per una ricostruzione delle contrastanti tradizioni disciplinari nell'archeologia preistoric<l salentina, cfr. COPPOLA 2002, pp. 51-62; INCRAVALLO 2003, pp. 11-16 C OI~LANDO 2003, pp. 17-25; v., inoltre, TARANTIN! 2000, pp. 7-43. Per una storia degli stud i su Grotta Zinzulusa v. LAZZARl1947, pp. 5-63; CAVAllE" 1960, p. 9.
3 Si veda, ad esempio, il rccupero di due scuri ad "occhio" di bronzo da Grotta Zinzulusa (BLANC 1961, p. 332; BIBT! S~T!ERI1968, pp. 199-212). Va anche segnalato il recupero di cerami-
89
fico redatto da alcuni stud iosi locali tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del secolo successivo, dal qua le si può trarre qualche utile indicazione. L. Maggiulli, ad esempio, fa riferimento a diversi monumenti protostorici presenti nei territorio: "Om ill Castro e nelle sue vicinanze vi si osservanO Dolmen, Mellhirs o Pietre fitte, sepolcri incavernati nei 1110nti, ed altri monume/lti Pelasgici, i quali fan credere, che ivi quelle genU si fecer largo e stallziarono. { ... ] il superbo DO/Illell clIe esisteva iiI Castro stesso, su la via detta volgarlllwte delle Radde [. .. ] le celle mortwlrie ed i sepolcri scavati nel sasso COli sopra Wl coverclIio mono/ife, SO/W segni evidenti che i Pe/osgi LibuYlli IIC furo/IO gli autori, ed l'(.li vicilIo costrui-1'01'/.0 lo rocca di Castro"'. È evidente che la realtà descritta dallo studioso fa riferimento ad un contesto te rritoriale sostanzialmente intatto. Elnergono da questa esposizione alcuni elementi importanti, relativi soprattutto ai costu mi funerari che fanno riferimento alla presenza di abitati dell'età dei metalli. L'adozione di uno schema lTIonumentale ad alto contenuto simbolico viene a costituire il tramite attraverso cui si sancisce quel principio fondamentale dell'appartenenza e dell'autoidentificazione che è, insieme, esaltazione e legittimaz ione del ruolo di controllo e di possesso chc una comunità ha del suo territorio. Allo s tesso modo viene riproposto emblematicamente il modello verticistico tipico delle società di lignaggio dove a singole fig ure socialmente eminenti è affidato il compito, anche dopo la n1ortc, di rappresentare l'intera collettività, manifestandone l'esistenza nello spazio e nel tempo.
Oltre al dolmen Radde (fig. 1, n. 3), analoghi monumenti sono segnalati anche da M.A. Mica lella nel 19105, su indicazione di P.E. Stasi: si tratta di due strutture dolmeniche ubicate in località Bosco Sgarra, a poca distanza dal centro di Castro (fig. 1, n. 4). Anche P. Malagrinò nel suo MOl1ulllellti lIIe
galitici iII Puglia cita i due Dolmen, denominandoli Sgarra I e Sgarra II. TI primo di questi non fu più identificato dallo studioso, il quale lo ritenne irrimediabilmente perduto; per la sua descrizione Malagrinò si basò sulle precedenti comunicazioni di G. Palumbo, che in due occasioni (1930 e 1957) ebbe modo di osservarlo, fotografarlo e misurarlo6, constatando il forte degrado cui il monumento era andato incontro c01 passare del tcmpo.
ca d'impasto sulle pendici del promontorio di Castro da parte di G. Uggeri ( U CGERI 1972, p. 467; UCCERI 1983, p. 306); !o stesso A. rileneva che tale presenza fosse dovuta all'azione di dilnva mento dal sovrastan te piano ro di Castro alta, e proponeva una generica attribuzione cronologica dci materiali alla facies "Protovillanoviana" (Bronzo Finale).
" Il dolmen Raddc fu dh.trutto da contadini ignari del suo valore storico al fine di ottenere pietre per la rednzione di un podere, cfr. MAGGIULLI 1896, in particolare p. 17 e nota 1.
s MICALELLA 1910. ti PALUt-1BO 1956, pp. 84-108. La lastriJ di copertura di m 3,50 x 1,20, poggiava in parte su
grossi ortolili e in parte su roccia affiorante lasciando scoperto un tratto a est, coincidente con una probabile apertura.
90
• Evidenze archeologiche ",,,rt,,2~::;:"ii: (rinvenimento puntuale)
O Evidenze archeologiche nOIe
da fonti oral! cio bib1iOgrafiCh::'~,ç_1~6t~~;k\,l,(~rIf~~ Arca di frammenti ~ fittili
A N
,-O 100 I I
Fig. 1 - Stra1cio deJlé1 CTPN (Carta Tecnica Provinciale Numerica) sezione n. 527140 - Santa Cesarea Terme - scala 1:10.000 con ubicazionc delle evidenze archeologiche preistoriche e protostoriche accertate (rinvenimento puntuale; area di frr. fittili) e ipotetiche (note da fonti orali c/o bibliografiche).
91
200m I
Il dolmen Sgarra Il, invece, non venne più individuato già duran te il 50-
pralluogo del Palumbo nel 1930? La quasi totalità delle evidenze dolmeniche attestate nell'Italia continen
tale si concentrano in tre di versi distretti del territorio pugliese: l'area a nord di Taranto, la fascia costiera del Barese ed il Salento. Completamente isolato risu1ta, invece, il Dolmen di Torre Molinella, ubicato presso Vieste e distrutto nel 1981. Solo in rari casi tali dolmen sono stati oggetto di indagini archeologiche accurate e sistematiche: la scarna documentazione disponibile consente, tuttavia, non solo di ipotizzare una destinazione funeraria, ma anche di proporne un inquadramento cronologico a ll a prima metà del II millennio a.C., ossia in un periodo di transizione tra il Bronzo Antico e la successiva fase del Bronzo Medio8
Da un'indagine condotta da chi scrive presso gli Archivi della Soprintendenza Archeologica di Taranto sono emersi dati di considerevole rilievo circa la miste riosa scomparsa di uno dei due dolmen rin traccia ti nel bosco Sgarra. Con una lettera inviata al Soprintendente delle Antichità di Taranto in data 14 luglio 1971 dal prof. A. Lazzari, docente di Geologia presso l'Università Federico II di Napoli, veniva data comunicazione dell'avvenuta distruzione di un dolmen esistente nella medesima località in seguito a lavori effettua ti per la realizzazione di costruzioni a carattere residenziale9 Il sopralluogo da parte della Soprintendenza alle Antichi tà d i Taranto, avvenuto il giorno 29 dello stesso mese, in seguito al blocco dei lavori imposto nei confron ti del proprietario, diede l'avvio ad una serie interminabile di trattative p rotrattesi fino al 19 aprile 197510, per porre rimedio al grave danno perpetrato. I diversi tentativi di restauro e ripristino del monumento si sono rivelati impraticabili, soprattutto a causa della scarsissirna documentazione fotografica e grafica disponibile". Grazie ad alcuni documenti contenuti nel fascicolo citato, tra cui alcune foto scattate al momento del primo sopralluogo ed uno schizzo a penna realizzato su uno stralcio catastale con l'ubicazione del megalite, è stato possibile, a distanza di 35 anni da lla scomparsa dello stesso, localizzarne i resti (fig. 2).
7 Per questo monumento non si hanno indicazioni in merito alle dimensioni. 1:1 Si tralla di una datazione piuttosto tarda, se confro ntala con quella di monumenti
morfologicamenle affi ni ubicati in altri distretti; solo il Do lmen di Ttl Hlllnll//lf sulla costa settentrionale dell' isola di Malta è stato ri fe rito ad un medesimo arco tempora le. Sul fenomeno del megalitismo in Puglia, cfr. DE G10l~Gl 1912; GERVASIO 1913; PALUMBO 1956; WHITEHOUSE 1967, p p. 347-365; MALAGI~lNÒ 1978; WH1TEHOUSE 1981, pp. 42-63; ClPOLLON1-SAMr6 1987; MALAGIUNÒ 1997.
9 Archivio Soprintendenza Taranto - Deposito - BUSTA 6, Fase. 18, Castro Marina, ZOIW "Bosco Ssnrm" ex proprietà Bncile - Distruziolle Dolll1C11, 1971.
111 Dala ultima della corrispondenza epistolare durata per più d i quattro anni. 11 Del dolmen Sgarra I esistono solo due fotografie scattate da G. Palumbo, una nel 1930 e
l'a ltra ne l 1957.
92
Fig. 2 - Dolmen Sgarra T.
Importanti indizi si hanno, nondimeno, per ciò che riguarda le strutture ipogeiche. Da testimonianze orali è noto che nel 1960, a seguito di scavi edili in località Serra Catluddhri (fig. l , n. 5), subito a nord del centro storico del paese, vennero alla luce, all'interno di una "cavità" nel terreno, alcuni oggetr in metallo e in ceramica, in ottimo stato di conservazIone. Dalla descrizione è possibile risalire all'identificazione delle seguenti tipologie di manufatti: due asce in bronzo, di cui una a cannone e l'altra piatta, ed un probabile askòs in ceramica d'impasto12. Tale nucleo di reperti è plausibilmente interpretabile come il corredo funerario di una tomba a "grotticella": una sim ile ipotesi può essere avallata da una serie di dati emersi in seguito a ricognizioni sulle pendici occidentali dell'abitato di Castro, in corrispondenza della l.1ma che raccorda i bacini colluviali meteorici dell'entroterra con il mare. L'esplorazione delle scarpate ha permesso l'individuazione di alcune cavità scavate nel tenero banco roccioso (Formazione di Leuca), alcune delle quali
12 In tale associazione di materiali, desta qualche sospetto, in merito all'attribuzione cronologica, l 'a~da piatta che parrebbe di tradizione eneolitica. L'ascia a cannone e l'nskòs, invece, ~ i
possono ipoteticamente co!locare tra la fine de!l'età del Bronzo e l' inizio dcll'età del Ferro.
93
attualmente adibite a deposito d i s trumenti per attività agricole. Prive di riempimento archeologico, sono tuttavia riconoscibili dalle peculiarità architettoniche come monumenti protostorki a des tina zione funeraria (fig. 1, 11.
6)13
La ricognizione archeologica sta progressivamente ampli ando e integrando le conoscenze già disponibili, rivelandosi, quindi, uno strumento indispensabile per la comprensione delle dinamiche insediative che hanno interessato il centro antico. La p resenza di livelli archeologici attribuibili ad una fase di frequentazione protostorica è stata defini tivamen te acclarata nel marzo del 2003, grazie ad un'indagine d'emergenza mirata alla lettura stratigrafica di una sezione messa in luce da lavori per Jfjmpi anto della rete fognaria in località Palombara (fig . 1, n. 7).
T. DATT DA RICOGNIZIONE
La particolare orografia del territorio d i Castro, che ovviamente ha influito sulle scelte operate nella fase d' impianto del più antico abitato, merita un'attenta considerazione. Si tratta dell'estrem ità merid ionale di una serra, una struttura anticrinale a decorso nord-avest i sud-est, sviluppata a partire dall'entroterra otrantino e costituita da una formazione preneogenica nota come Calcare di Castro". Il promontorio su cui sorge il paese, noto col toponimo di Pizzo Mucurune, si erge per quasi 100 m s.l.m. e si protende in direzione dello scirocco per altri 400 m. Il versante orientale rappresenta il prolungamento naturale dello stesso tratto di costa che lo precede, a differenza del versante occidentale che ne spezza il profil o e ne interrompe la linearità. Si determina, in questo modo, un arretramento considerevole della linea di costa a vantaggio di una rada tra le più prote tte del Salento dai venti prevalenti dai quadranti settentrionali 15. La presenza d i numerosissime sorgenti d'acqua dolce all'interno della baia'6 facevano di questo luogo un buon punto di approdo nelle rotte marittime di piccolo cabotaggio, tra i d ue più im-
13 Al momento risulta prematuro qualsiasi intento espositivo dei dati per quest' area, essendo l'esp lorazione tuttora in corso.
14 Le s truttu re denominate serre sono dorsali non molto eleva te del Cretaceo intervallate da bassure occupate da cakareniti del Sa lento di formazione plio-pleis tocenica. Le più antiche ed alte, collocate nel settore sud-occidenta le della penisola, sono composte da Dolomie di Galatina e Calcari di Melissano che raggiungono un'altezza massima di 1.95 m s.l.m., cfr. BosSIU et n!ii 1987, pp. 127-146.
15 La stessa cosa non si può dire per i venti che soffiano dal II C m quadrante. 16 A titolo di esempio, sarà utile ricordare quanto P. Parenzan rilevava nel corso del suo
ventennale lavoro di ri cerca a proposito delle sorgenti d'acqua dolce di questo tratto di costa : .. Corrente di Castro», con portata media di 600 l/sec.; "Pozzo Capramontu», con portata media di 200 1/ sec.; "L'Ubissu», con portata media di 700 1/ sec.; «Fiumi dell'Acquaviva», con portata media di 500 l/sec. (PARENZAN 1983, pp. 52-53).
94
portanti scali di Otranto e Leuca. Il promontorio decresce di quota verso il mare ed è connotato dalla presenza di due grandi terrazzi naturali alla quota di 60 e 40 m circa s.l.m., disposti intorno alla sommità dello stesso.
Rispondendo alle peculiarità geomorfologiche del luogo e adattandosi ad esse, si è venuto a creare nel corso del tempo un articolato sistema di terrazzamenti, attualmente sfruttati prevalentemente per l'oHvicultura. Nel panorama litoraneo salentino questa insol1ta variante conferisce un aspetto singolare al paesaggio, per certi versi paragonabiJe solo ad alcuni limitati tratti in prossimità del Capo di Leuca. I terrazzamenti più p rossimi all' attuale centro storico (corrispondente all'abitato medievale) presentano generalmente dimensioni piuttosto ridotte e risultano costruiti O riadattati in epoca recente: l'apporto di terreno inlpiegato nella formazione di tali terrazze proviene, con ogni probabilità, dalla sommità del promontorio o dall'immediato entroterra. L'abbondante presenza di materiale ceramico (cronologicamente eterogeneo ed in giacitura secondaria) nell'ambito di questi campi consente di ipotizzare una lunga continuità di vita dell'antico abitato di Castro, la cui prima occupazione sembrerebbe risalire ad una fase più o lneno avanzata dell' età del Bronzo. Le evidenze finora indagate, tuttavia, permettono soltanto una sommaria e parziale ricostruzione sia dell'estensione che delle vicende evolutive di tale insediamento.
L'attenta analisi della distribuzione spaziale dei reperti ceramici individ uati nel corso delle prospezioni ha evidenziato la presenza di un' area caratterizzata da una elevata concentrazione di frammenti d'impasto dell'età del Bronzo (fig. 1, C)!'. L'area corrisponde al più alto dei terrazzi naturali descritti, il quale sovrasta nel suo limite nord-orientale la grotta marina della Palombara e prosegue fino alle rocce affioranti di Pizzo Mucurune in direzione sud. Trattandosi di una zona meno disturbata da attività antropiche moderne e contemporanee rispetto ai terrazzi alti, non è da escludere che i terreni in essa ubicati rappresentino il residuo dei più antichi livelli di occupazione. Il p ianoro trova un confine naturale ad occidente nel pendio che conduce alla cortina orientale delle mura cinquecentesche di Castro, grossomodo in coincidenza della sede stradale litoranea e in corrispondenza del luogo in cui si è avuta per la prima volta, la possibilità di indagare livelli archeologici chiaramente riferibili all'età del Bronzo.
Una seconda area caratterizzata da un'attestazione esclusiva di ceramica protostorica è ubicata al margine sud-orientale del promontorio e corrisponde al pianoro naturale più basso, che, a differenza del precedente, non ha subito, se non in maniera lieve, alcuna trasformazione recente da parte dell'uomo (fig. 1, B; fig. 3). Alla quota di circa 39 m s.l.m., dai campi semi-incolti e
17 Materiali della stessa classe si riscontrano su tutte le pendici del promontorio fino alla sommità dell 'abitato (fig. l , n. 8). Anche qui, in seguito a scavi per l'effettuazione di lavori pubblici, si è potuta costatare la presenza di ceramica d'impasto a di retto contatto coi livelli basali.
9S
Fig. 3 - Folo acre;) del promontorio di Castro visto d<l Nord~Est con l'indicazione dei pianori interessati dalle evidenze protostoriche; in primo p iano l'insenatura di Crotta Palom~ bara sovrastata da uno di questi alla quota di 60-65 m ca. s.l.m. (C); sullo sfondo è visibile quello più basso (39 m ca. s.l.m.) coincidente con Pizzo Mucurune (B) (foto R. De Santis).
ricoperti in larga misura da una bassa vegetazione a macchia, affiorano copiose quantità di frammenti d'impasto ed in figulina protostorica. Questi materiali sono contenuti all'interno di lin1itate sacche di terreno a dempimento delle irregolarità del suolo roccioso. Se si considera anche il buon grado di conservazione degli stessi, non pare improprio ipotizzare una reale concomitanza di luogo tra il dato messo in luce daJla ricognizione e il vero e proprio livello di frequentazione.
Un'ulteriore conferma a suffragio di queste prime impressioni si è avuta quando, sempre in fase di ricognizione, ci si è imbattuti nel livello di risulta prodotto dallo scavo di una breve trincea eseguita per il ripristino di un muro a secco. Tale terreno, situato in posizione centrale lungo il margine orientale dello stesso pianoro (fig. 1, n. 9), ha restituito alcuni frammenti di ceram ica d 'impasto (non flu itati) che offrivano la possibilità di risalire a forme vascolari ben determinabili (fig. 4, nn. 13_14)'8
18 Una patina d i concrezione realizzatasi in antico interessava le fratture d'unione dei fram~ mentì ricomposti, indiziando con buona probabilità un contesto primario di giacitura.
96
Una terza area interessata dalla sola presenza di ceramica protostorica insiste, infine, sul pendio occidentale del promontorio che mette in comunicazione le due terrazze appena descritte.
Si presentano di seguito i reperti (ceramici, metallici e lapidei) rinvenuti nel corso delle ricognizioni. Non si tratta di una rassegna esaustiva, bens) di una selezione dei materiali più rappresentativi e diagnostici sotto il profilo crono-tipologico. Occorre precisare che l'intera zona indagata è stata convenzionalmente distinta in tre settori (equivalenti alle tre aree a maggiore concentrazione di evidenze archeologiche), al fine di facilitare la gestione dei dati e di garantire una seppur approssimativa collocazione topografica dei singoli materiali analizzati :
Palombara (C), porzione centrale e nord-orientale del pianoro alla quota di 60-65 m ca. s.l.m. (fig. l, nn. 7, 9); Pizzo Mucurune (A), sul pendio a cavallo dei due pianori, tra i 60 e i 40 m ca. s.l.m. (fig. l, A); Pizzo Mucurune (B), che insiste sulla propaggine Sud-orientale del promontorio, alla quota di 36-39 m ca. s.l.m. (fig. l, B).
I criteri terminologici adottati nella descrizione del materiale archeologico si ispirano essenzialmente alle indicazioni proposte in un recente convegno in merito alla classificazione delle forme vascolari attestate nella tarda protostoria dell'Italia meridionale'9
Catalogo'
PALOMBARA (ZONA C)
Olle
1 (fig. 4) H. 5,3; largh. 7,9; spesso 1,2; diamo orlo 32. Fr. di orlo indistinto; labbro appiattito, appena inclinato all'interno; corpo sub-cilindrico con pareti leggermente convesse. Impasto grossolano, modellato a mano con superfici interna ed esterna steccate; colore rossastro. Bronzo Finale Cfr. Lo PORTO 1964, p. 192, fig. 12, n. 17 (livelli «tardo-appenninici)) di Satyriol1); GORGOGLIONE et alii 1993, tav. XXXI, n. 3 (capanna 7 di Torre Castelluccia); BUFFi\. 1994, p. 464, tav. 87, n. 5 (Broglio di Trebisacce); ORLANDO 1996, p. 291, fig. 15, n. 7 (livelli del Bronzo Finale di Otranto).
19 Cfr. BAlLO MODESTI et ahi 1999 (in particolare pp. 445-450) e bibliografia ivi citata. * I materiali sono attualmente in deposito temporaneo presso il Dipartimento di Beni Cul
turali dell'Università del Salento.
97
2. (fig. 4) H . 3,6; largh. 2,9; spesso 1; diamo orlo non ricostruibile. Fr. di orlo indistinto; labbro arrotondato; corpo presumibilmente sub-ci1indrico o troncoconico con pareti leggermente convesse. Impasto semi fine, modellato a mano con superfici interna cd esterna stecca te; colore rossastro. Bronzo Finale Cfr. BUFFA 1994, p. 459, lavo 83, n. 31 (Broglio di Trebisacce); ORLANDO 1996, p. 283, fig. lO, n . 9 c p. 291, fig. 15, n . 1 (livelli del Bronzo Finale di Otranto).
3. (fig. 4) H. 2,5; largh. 2,5; spesso "I; di amo orlo non ricostruibilc. Fr. d i orlo indistinto; labbro arrotondato; corpo presumibilmcnte sub-cilindrico o troncoconico con pareti leggermente convesse. Impasto semitine, modellato a mano con superfici interna ed esterna steccate; colore bruno-rossastro. Età del Bronzo Cfr. n. 2.
Ciotole carenate
4. (fig. 4) H . 2,7; largh. 3,8; spesso 0,8; diamo orlo non ricoslruibilc (diam. max. 19,6). Fr. d i carena a spigolo vivo; conserva l'attacco del collo e parte della bassa vasca troncoconica a profilo diritto . Impasto fine, modellato a mano con superfici interna ed esterna lisciate; colore nero. Bronzo Recente - Finale Cfr. ORLANDO 1990b, p. 22. n. 6 (Otranto); GORCOCLIOì'\E et alii 1993, tav. XXXVII, nn. 4-5 (capanna 7 di Torre Castelluccia); ORl.ANDO 1996, p . 268, fig. 3, n . 18 (livelli del Bronzo Finale di Otranto).
5. (fig. 4) H . 7,5; largh. 4; spesso l,l; diam o orlo non ricostruibile. Fr. di presa a contorno semicircolare a margine arrotondato; fa ccia inferiore convessa, superiore breve c appiattita. fmpasto grossolano, modellato a mano con superfici steccate e lisciate, in parte corrose; colore bruno-rossastro. Bronzo Finale Cfr. CREMONESI "1978, tav. "14, n . 10 (Leuca, fuori contesto stratigrafico); ORLANDO 1983, tav. 60, n. 4 (Otranto); GORGOGLIONE ct ahi 1993, ta\'. XXXII, n . 4 (capanna 7 di Torre Castelluccia).
6. (fig. 4) H . 3,5; largh. 5,2; spesso l,l. Fr. d i presa a contorno semicircolare a margine assottigliato; faccia inferiore convessa, superiore breve e appiattita. Impasto semi fine, modellato a mano con superfici lisciate; superficie esterna di colore rossastro, interna di colore bruno. Bronzo Finale Cfr. CREMONESI 1978, tav. 15, n. 3, 19 (Leuca); ORLANDO 1983, p. 86 (Otranto); GORGOGLIONE et alii 1993, tav. XXXJI, n . 1 (capanna 7 di Torre Castelluccia).
7. (fig. 4)
H . 4,1; largh. 1,5; spesso 1,5.
98
I I I- O ~-Q , , I
I
2 3
f (~ , ,
5
I 6
lO II 9
\ I \
13
I , ,
4
7 8
\
Fig. 4 - Palombaril (C): nn . 1-14 ceramica ad impasto dell'Età del Bronzo.
99
Fr. d i ansa a sezione circolare; presenza di brevi so1cature tra loro parallele, disposte ortogonalmente all'asse longitudinale dell'elemento da presa ed in frequenza costante di circa 0,5 cm. Impasto fine, modellato a mano con superfici lisciate, in parte corrose; colore rossastro. Bronzo Recente Cfr. Lo POlno 1963, p. 296, fig. 17, n. 7 (Porto Perone); Lo POKro 1964, pp. 191-194, fig. 13,2,9 (livelli «tardo-appen ninici>~ di Satyrioll); OI~LANDO 1983, pp. 85-105, tav. 56, n. 6 (Otranto); CAZZELLA, MOSCOI ONI 1987, p. 160, fig. 79, n. 20 (Coppa Nevigata); ORLANDO 1990b, p. 25, n. 22 (Otranto); CtNQUEPALMI, CARRTERr, MUNTONr 1998, p. 130, cat. n. 7.088 (Monopoli, centro storico).
8. (fig. 4) H. 3,7; largh . 1,5; spesso l,S. Fr. di ansa a sezione circolare; presenta evidenti costolature oblique a profilo arrotondato. Impasto fine, modellato a mano con superfici lisciate; colore bnmo-rossastro. Bronzo Finale Cfr. ORLANDO 1983, p. 86; ORLANDO 1990b (Otranto), p. 25-26, Il. 22; BUFFA 1994, p. 457, tav. 81, nn. 6, 18; p. 459, tav. 83, n. 12 (Broglio di Trebisacce); ORLANDO ]996, p. 273, fig. 5, n. 13 (livell i del Bronzo Finale d i Otranto).
9. (fig 4) H. 4,4; largh. 2,5; spesso l. Fr. di attacco d'ansa impostato obliquamente su parete rientrante e convessa. Impasto semifine, modellato a mano con superfici lisciate; superfici di colore bruno chiaro; nucleo ceramico di colore nerastro. Età del Bronzo
lO. (fig. 4) H. 2,1; largh . 2,9; spesso 2,5. Fr. d i maniglia a sezione ovale; profil o sernicircolare; presenza di evidenti costolatu re obliq ue. Impasto semifine, modellato a mano con superfici lisciate; colore bruno-nerastro. Bronzo Finale Cfr. CREMONESI 1978, tav. 16, n. 15 (Leuca); BUFFA 1994, p. 461, tav. 85, n . 5 (Broglio di Trebisacce); ORLANDO 1996, p . 281, fig. 9, nn. 3, 10 (livelli del Bronzo Finale di Otranto).
11. (fig. 4) H. 2,3; la rgh. 4,3; spesso 2,3. Fr. di maniglia a sezione quadrangolare; profilo semicjrcolare. Impasto semifine, modellato a mano con superfici lisciate, in parte corrose; colore bruno-rossastro. Bronzo Finale Cfr. ORLANDO 1983, tav. 56, n. 9; ORLANDO 1994, p. 218, fig. 8, n. 9; ORLANDO 1996, p. 281, fig. 9, nn. 5, 8, 14 (livelli del Bronzo Finale di Otranto).
12. (fig. 4) H. 3,2; largh. S,l; spesso 2,5. Fr. di maniglia a sezione quadrangolare; profilo sernicircolare. Impasto grossolano, modellato a mano con superfici lisciate; colore bruno-nerastro. Bronzo Finale Cfr. n. 11.
100
Dolii
13. (fig. 4) H. 18,3; largh. 15,3; spesso 1,2; diamo orlo 36,3. Fr. di orlo indistinto su parete rientrante; labbro taglia to obliquamente all' interno; corpo a profilo convesso; cordone plastico a rilievo, orizzontale, applicato a 3 cm dall'orlo e decorato a impress ioni digitali. lmpasto grossola no, modellato a mano con superfici interna cd esterna steccate e lisciate; colore bruno- nerastro. Bronzo Finale Cfr. Lo PORTO 1964, p. 193, fig . 13, nn. 21, 22 (livelli «ta rdo-appenninici» di Satyrioll); BERNABÒ Br~EA, CAVA IJER J980, tav. CCXXlI, n. 2 e tav. CCXXXVll, lUl. S, 8 (Lipari); Or~LANOO
1983, p. 86; GORGOGLIONE et alii 1993, tav. XXXI, n. 4 (capanna 7 di Torre Castelluccia).
14. (fig. 4) H. 8,6; largh. 14,2; spesso l, l; diamo orlo 47. Fr. di orlo indis tinto su parete rientrante; labbro tagliato obliquam ente all'interno; corpo a profilo convesso; cordone plastico a ril ievo, orizzontale, a sez ione trapezoidale, applica to a 4 cm dall'orlo. Impasto semifine, modella to a mano con superfici interna ed esterna steccate c lisciate; colore bruno-ncrast'ro. Bronzo Finale Cfr. n. pree.
Pizzo Mucurune (Zona A)
alle
15. (fig. 5) H. 4,7; largh. 5,5; spesso l,l; diamo orlo 24,5. Fr. di orlo indistinto su parete verticale; labbro appia ttito, arrotondato all'interno; corpo a profilo convesso; cordone plastico a rilievo, orizzontale, applicato a 3 cm dall'orlo e decorato a impressioni digitali. Impasto semifine, modellato a mano con superfici interna ed esterna lisciate; colore bruno-rossastro. Bronzo Finale Cfr. Lo PORTO 1964, p. 192, fi g. 12, n. 6 (livelli «tardo-appennin ici>} di Satyrioll).
16. (fig. 5) H. 4,1; largh. -I; spesso 1,2; diamo orlo non ricostruibile. Fr. di orlo indistinlo su parete verticale; labbro arrotondato appena ingrossato all'esterno; corpo a profilo presumibi lmente troncoconico. Impasto semifine, modella to a mano con superfici interna ed esterna lisciate; colore rossas tro. Bronzo Finale Cfr. OHLANOO 1996, p. 291, fi g. 15, n. 1 (livelli del Bronzo Finale di Otranto).
17. (fig 5) H. 3,6; largh. 4,4; spesso 1; diamo orlo non ricostruibilc. Fr. di presa a contorno sub-triangolare a margine arro tondato; faccia inferiore convessa, superiore breve e appena concava. Tmpasto grossolano, modellato a m,mo con superfici interna ed esterna lisciate, in gran parte corrose; colore bruno-rossastro. Bronzo Finale Cfr. CORCOCU ONE et alii 1993, hl\'. xxxn, n. 2 (capanna 7 d i Torre Castelluccia).
101
18. (fig. 5) H. 4; largh. 4,2; spesso l; diamo orlo non ricostruibile. Fr. di presa a contorno semi-circolare a margine appiattito, decorato a impressioni digitali; faccia inferiore concavo-convessa, superiore lievemente concava. Impasto semifine, modellato Cl mano con superfici interna ed esterna lisciate; colore bruno-rossastro. Bronzo Finale - Primo Ferro Cfr. Lo PORTO 1964, p. 206, fig . 22, Il. 5 (un fr. di presa simile proviene dai livelli dell'età dci Ferro di Satyrioll anche se associato ad una diversa forma ceramica).
19. (fig. 5) H. 6,6; largh. 4,7; spesso 1,5; diamo orlo non ricostruibile. Fr. di presa a contorno sub-triangolare a margine arrotondato; faccia inferiore lievcmente convessa, superiore breve e appiattita. Impasto semifine, modellato a mano con superfici interna ed esterna lisciate; colore bruno-rossastro. Bronzo Finale Cfr. GORGOGLIONE et alii 1993, tav. XXXII, n.1 (capanna 7 di Torre Castelluccia).
Scodelle
20. (fig . 5) H . 2A; largh. 3A; spesso 0,6; diamo orlo non ricostruibile. Fr. d i orlo indistinto; labbro appiattito cd ingrossato a tesa all'interno, dove realizza con la parete un gradino distinto da spigolo . Impasto semifine, modellato a mano con superfici interna ed esterna lisciate, in parte corrose; colore bruno-rossastro. Bronzo Recente Cfr. CREMONESI 1978, tav. 13, n. 7 (Leuca); ORLANDO 1983, tav. 54, n. 1 (Otranto); ORLANDO 1990b, p. 22. n. 4; analoghi esemplari provengono dai livelli sub-appenninici di Rocavecchia (Saggio IX, Amb. CI I LXXXVII, US 11349: si ringraziano per la segna~ lazione il prof. Riccardo Guglielmino e la dott.ssa Daria Palmisano); il hp,? di orlo compare già nella fase di transizione tra il protoappenninico finale e l'appenninico iniziale della Puglia centro-meridionale, spesso accompagnato da un motivo decorativo a zig-zag inciso sul labbro: V. a tal proposito ONQUEPALMI, CARRIERI, MUNTONI 1998, pp. 116~117, cat. lID. 7.028, 7.036 (Monopoli, centro storico); SCARANO 2006, pp. 133~ 145 (Rocavecchìa).
21. (fig. 5) H. 4; largh. 6,1; spesso 1,8; diamo orlo non ricostruibile. Fr. d i orlo indistinto; labbro appiattito ed ingrossato a tesa all'interno, dove realizza con la parete un gradino distinto da spigolo vivo. Impasto semifine, modellato a mano con superfici interna ed esterna mal rifinite ed in parte corrose. Bronzo Recente Cfr. n. prec.
22. (fig. 5) H. 2,2; largh. 4,1; spesso 0,7; diam o orlo 22. Fr. di orlo ind istinto; labbro appiattito ed ingrossato a tesa all'interno; labbro appiat-
102
I
~o , , I
17
20
23
15
18
I
~-e
"
I
26
24
I
21
,
'%'
~ , , ,
I
l-D
• ~ , ,
22
I
16
I
(J I
19
~-D-l9
I
27
25
o 3 cm =
Fig. 5 - Pizzo Mucurune (A): nn. 15-25 ceram ica ad impasto dell'Età del Bronzo; nn. 26-27 ceramica figulina.
i03
tito ed ingrossato a tesa all'interno, dove realizza con la parete un gradino distinto da spigolo vivo. Impasto fine, modellato a mano con superfici interna ed esterna li sciate; colore bruno chiaro. Bronzo Recente Cfr. nn . pree.
23. (fig. 5) H . 2,5; largh. 4.6; spesso 2,5. Fr. di maniglia a sezione circolare; contorno semicircolare. Impasto semifine, modellato a mano con superfici lisciate. Bronzo Finale Cfr. ORLANDO 1996, p. 281. fig. 9, nn. 1. 12.
24. (fig. 5) H . 2,4; largh. 2.6; spesso 2,5. Fr. di ansa a sezione da sub-triangolare (all'attacco) a circolare; presenta lateralmente i tratti sfuggenti della carena a spigolo sulla quale si impostava; medialmente, una terza nervatura interessa la faccia interna dell'ansa; nella porzione inferiore, sulla faccia esterna, si identificano due piccole cuppelle impresse (diam. cm 0,4), disposte una centralmente, l'altra lateralmente; ipolizzabile la presenza di una terza simmetrica a quest'ultima. Impasto fine, modellato a mano con superfici lisciate e lucidate; colore nero. Bronzo Finale Cfr. ORLANDO 1994, p . 218, fig. 8, n. 3; l'attacco inferiore dell'ansa a sezione sub-triangolare è attestato in un esemplare di tazza carenata proveniente dai livelli del Bronzo Finale in iziale di Rocavecchia: cfr. SCARANO es., cat. n. IV. 19.
25. (fig. 5) H . 3; largh. 4,3; spcss. 1,4. Fr. di ansa a sezione rettangolare, con margini appiattiti, leggermente assottigliati, d ivergenti verso l'a ttacco inferiore. Impasto semifine, modellato a mano con superfici lisciate; colore bruno chiaro. Bronzo Finale Cfr. ORLANDO 1990a, p. 9, n. 14 e pp. 23-24, n . 13 (Leuca).
Ceramica figulina
26. (fig. 5) H. 12,1; largh. 12,2; spesso 1,6; diamo orlo non ricostruibile. Fr. di parete di grande contenitore con corpo a profilo convesso; da riferire ad un rcstauro praticato in antico sono tre fori passanti (diam. circa cm 0,7) allineati lungo il margine di una frattura. Figulina compatta, probabilmente modellata al tornio, con supcrfici lisciate; colore rosa (vicino a M 7.5 YR 7/4). Bronzo Finale Cfr. GUGLIELMfNO 1999, pp. 475-486, in particolare p . 48"1, fig. 7; PAGLIARA, GUCLIELMI
NO 2005, p. 309, scheda d i catalogo II . 196 (a cura d i A. Ronca); gli esempi proposti si riferiscono a ceramiche interessate da fori di restauro eseguito in antico provenienti da Rocavecchia.
104
27. (fig. 5) H. 6; largh. 6,7; spesso 1,5; diam o orlo non ricostruibile. Fr. di parete di grande contenitore con corpo a profilo convesso; presenta un Illotivo dipinto a tre bande parallele obli que (presumibilmente parte di un motivo più complesso ad angoli inscrith , ben attestato nel repertorio dci Protogeometrico indigeno), Figulina compatta, probabilmente modellata al tornio, con su perficie esterna ingubbia ta e lisciata; pasta ceramica di colore bruno-chjaro (vicino a M lO YR 6 /6); ingubbio di colore bruno molto chiaro (vicino a M lO YR 6/6); vern ice di colore rosso (vicino a M 2.5 YR 5/6), opaca, parzialmente abrasa. Bronzo Finale Cfr. D'ANDRIA 1978, tav. 49, n. 6 e tav. 50, n. 6 (Leuca); ORLANDO 1990a, pp. 15-16, nn. 37, 38, 44 (Leuca); YNTEMA 1990, p. 22, fig . 6, n. 1 e p. 29, fig. 13; ORLANDO 1994, p. 220, fig. 9, n. 8; MUNTONI 1995, tav. XXIX, n. 14; ORLANDO] 995, tav. LXXXIII, n. 5; ORLANDO 1996, p. 294, fig. 17, n. 4 (livell i del Bronzo Finale di Otranto).
Pizzo Mucurune (Zona B)
Vasi a ,collo
28. (fig. 6) H . 1,8; largh . 5; spesso 1; diamo orlo 20. Fr. di orlo distinto da spigolo v ivo all'interno, svasato, a profilo teso (ad imbuto); labbro tagliato obliquamente all'esterno; collo presumibilmente cilindrico. Impasto semi fine, modellato a mano con superfici interna ed esterna li sciate; colore bruno-rossastro. Bronzo Finale Cfr. ORLANDO 1996, p. 290, fig . 14, nn. 1-2 (livelli del Bronzo Finale di Otranto).
29. (fig. 6) H. 2,5; largh. 6; spesso 1,4; diam o orlo 32,5. Fr. di orlo d istinto da spigolo v ivo all'interno, svasato, a profilo internamente convesso; labbro arrotondato; collo presumibilmente ci li ndrico. Impasto grossolano, modellato a mano con superfici interna ed esterna steccate e lisciate; colore bruno-rossastro. Bronzo Finale Cfr. ORLANDO 1990a, p. 11, IU1. 23, 25 (Leuca).
30. (fig. 6) H. 3,8; la rgh . 4,9; spesso 1,5; diamo orlo 23,5. Fr. di orlo presumibilmente indistinto su parete inclinata all'estel'l1o; profilo interno leggermente convesso; labbro assolt igliato e presenza di un accenno di spigolo al raccordo tra questo e la parete interna. Potrebbe trattarsi della parte terminale di una forma vascolare a profilo troncoconico non articolato (scodella, scodellone, ol1a). Impasto semifinc, modellato a mano con superfici interna ed esterna stecca te e lisciate; colore bruno-rossastro. Bronzo Finale Cfr. BUFFA 1994, p. 471, tav. 93, n. 22 (Broglio di Trebisacce); ORLANDO 1996, p. 288, fig. 13, n. 1 (livell i dcl Bronzo Finale di Otranto).
105
Scodelle
31. (fig. 6) H. 4,9; largh . 5,2; spesso 0,9; diam o orlo 15. Fr. di orlo indistinto con labbro appiattito ed ingrossato a tesa all'interno, dove realizza con la parete un leggero grad ino distinto da spigolo. Impasto semifine, modellato a mano con superfici in terna ed esterna stcccate e lisciate; colore bruno-rossasuo. Bronzo Finale Cfr. CREMONESl 1978, tav. l3, n. 7 (Leuca); ORLANDO lYt:!3, tav. 53; n. 7 e tav. 54, n. 2 (Otranto); ORLANDO 1995, tav. LXXXI, n. 6; ORLANDO 1996, p. 275, fig. 6, n . 2 (l ivelli del Bronzo Finale di Otranto) .
32. (fig 6) H.3; largh. 4,1; spcss. 0,7; diamo orlo 22. Fr. di orlo distinto, fortemente rientrante; labbro tagliato obliquamente all'interno; corpo a profilo troncoconico con pareti lievemente convesse; reca traccia dell'attacco di un elemento da presa (probabilmente una maniglia impostata obliquamente e sopraelevata). Impasto semifine, modellato a mano con superfici interna ed esterna lisciate; colore bruno-rossastro. Bronzo Finale Cfr. ORLANDO 1983, lavo 57, nn. 1, 2 (Otranto); ORLANDO 'I 990a, p. 7, n. '[ (Leuca); GORGOGLIONE et nlii 1993, tav. XL, n.1 (Torre Castelluccia); ORLANUO 1994, p. 222, Hg. lO, n. 2; ORLANDO 1996, pp. 276-277, fig. 7, n. 9 e fig. 8, n. 5 (livelli del Bronzo Finale di Otranto).
Tazze
33. (fig. 6) H. 4,5; largh. 3,5; spesso dcII a parete cm 1,2; diamo orlo 10,5. Fr. di orlo distinto, svasato; labbro arrotondato e assottigliato; parete sopra la carena a profi lo convesso; carena a spigolo vivo; vasca a profilo troncoconico con parete esternamente convessa. Impasto semifine, modellato a mano con superfici interna ed esterna lisciate e lucidate; colore nero. Bronzo Recente - Finale Cfr. ORLANDO 1990a, p. 8, n. 5 (Leuca); ORLANDO 1990b, p. 22. n. 6 (Otranto); GoRGOGLIONE et alii 1993, tav. XXXII, nn. 1-4 (Torre Castelluccia); ORLANDO 1996, p. 268, fig. 3, n. 19 (livelli del Bronzo Finale di Otranto) .
. '\4. (fie. 6) H. 3,1; largh. 2; spesso 1. Fr. di ansa a sezione da sub-rettangolare (all'attacco) a circolare. lmpasto fine, modellato a mano con superfici lisciate e lucidate; colore nero. Bronzo Finale Cfr. CREMONESI 1978, tav. 15, n. 6; ORLANDO 1990a, p. 9, nn. lO, 11, 12 (Leuca); ORLAN-
00 1990b, pp. 23-24, n. 12; ORLANDO 1994, p. 218, fig. 8, n. 2; ORLANDO 1996, p. 273, fig. 5, n. 8 (Otranto).
106
28
29 , , ,
30
'==fd ( ) 32
11 !l' 0-0-
33 34
NI 36
1 Br 37
gl 38
?
\D7 " , 31
I
@ CI ,O
35
~-Q-B 40
~-, -,
41
42 I t KJ , '
39 o 3= =
Fi g . 6 - Pizzo Mucurune (B): nn . 28-39 ceramica ad impasto dt:!ll'Età del Bronzo; n. 40 pestello; n. 41 1<101a in bronzo; n. 42 fuseruola.
107
35. (fig. 6) H. 2; largh . 5; spess. 2,4. Fr. d i m aniglia a sezione ovale; contorno semicircolare; presenta una serie di costolature oblique a profilo arrotondato. Impasto semifine, modellato a mano con superfici lisciate; superfici di colore rossastro all'esterno, nucleo ceramico di colore nero. Bronzo Finale Cfr. O'EMON ESI 1978, tav. 16, n. 19 (Leuca).
Olle
36. (fig. 6) H. 5; largh. 4; spess. 1,4; diam. orlo 19,7. Fr. d i orlo indistinto su parete rettilinea; labbro tagliato obliquamente all'interno ed appena ingrossato esternamente; corpo sub-cilindrico. Impasto sernifine, modellato a mano con superfici interna ed esterna lisciate; colore bruno-rossastro. Bronzo Finale Cfr. ORLANDO 1996, p. 291, fig. 15, n. 3 (livelli del Bronzo Finale di Otranto).
37. (fig. 6) H. 7; largh. 9,2; spess. 1,3; diam. orlo 24. FI. d i orlo indistinto; labbro tagliato obliquamente all'interno; corpo sub-cilindrico con pareti leggermente convesse; cordone p lastico a rilievo, orizzontale, applicato a 2 cm dall'orlo e decorato ad impress ioni dig itali ; sul cordone è impostata una presa a linguetta semicircolare (profilo inferiore concavo-convesso e superiore breve e appiattito) con margine arrotondato. Impasto semifine, modellato a mano con superfici interna ed esterna steccate e lisciate; colore bruno-rossaotro. Bronzo Recente - Finale Cfr. Lo PORTO 1963, p. 297, fig. 18 (livelli «tardo-appenninici» della capanna n di Porto Perone); Lo PORTO 1964, p. 192, fig . 12, n . 7 (una variante con margine della presa decorato da una impressione digitale mediana proviene dai livelli dardo-appenninici» di Satyrioll); ORLANDO 1983, tav. 56, n. 1; il tipo è attestato, inoltre, nei livelli del Bronzo Finale in iziale di Rocavecchia, SCARANO es., cat. n . IV. 38.
38. (fig. 6) H . 7; la rgh . IO; spess. 1,4; diam. orlo 26,5. Fr. d i orlo indistinto; labbro arrotondato, appena ingrossato all'esterno; corpo sub-cilindrico con pareti leggermente convesse; cordone plastico a rilievo, orizzontale, applicato a 4 cm dall'orlo. Impasto semifine, modellato a mano con superfici interna ed esterna steccate e lisciate; colore bruno-nerastro. Bronzo Finale Cfr. BUFFA 1994, p . 464, tav. 87, n . 8 (Broglio di Trebisacce); ORLANDO 1996, p. 291, fig . 15, n . 4 (livelli del Bronzo Finale di Otranto)
Doli
39. (fig. 6) H . 6, l; largh. 6,2; spess. 1; diam. orlo 51. Fr. di orlo indistinto; labbro tagliato obliquamente all'interno; corpo sub-cilindrico con pareti a profilo esterno leggermente convesso; cordone plastico a rilievo, oriz-
108
zontale, applicato a 2 cm dall'orlo e decorato ad impressioni digitali. Impasto semifine, modellato a mano con superfici interna ed esterna steccate e lisciate; colore bruno-rossastro. Bronzo Finale
Pestello
40. (fig. 6) H. 5,3; largh. 4; spesso 3. Fr. di forma più O meno sferoidale; presenza di facce piane prodotte da usura interessano ampie porzioni della superficie. Pietra dura (arenaria); colore bruno-rossastro.
Lama di coltello in bronzo
4 1. (fig. 6) H. 0,9; largh . 4; spesso 0,2. Fr. di lama a sezione sub-triangolare; è riconoscibile un dorso a profilo convesso e un filo (margine tagliente); privo del codolo, conserva la punta. Bronzo (lega di rame); patina: superficiale; colore verdastro. Bronzo Recente Cfr. BiANCO PERONI 1976, tav. 2, nn . 17, 21 e tav. 8, n. 73 (l'esemplare è da attribuire, probabilmente, ai coltelli a codolo tipo Scoglio del Tormo, cronologicamente riferibi li al Bronzo Recente).
Fuseruola
42. (fig. 6) H. 2,3; largh. 2,8. Fr. di fuseruola a sezione biconica con margini arrotondati; presenta un foro passante longitudinale (diam. cm 0,5). Impasto semifine, modellato a mano con superfici lisciate; colore bruno-chiaro. Bronzo Finale Cfr. Lo PORTO 1963, p. 303, fig. 25, n . 20 (Porto Perone); ORLANDO 1990b, p. 24. n. 16 (Otranto); GORGOGLIONE et a/ii 1993, tav. XLIl, n. 7 (Torre Castelluccia); RECOfIA 1995, tav. X, n. 8 (Grotta M anaccora) .
H . PALOMBARA: LETTURA STRATICI,AFICA DELLE SEZIONI
Il 3 marzo 2003, nel corso delle operazioni di impianto della rete fognaria in località Palombara (sulla Litoranea per S. Cesarea Terme20t sono stati intercettati livelli archeologici riferibili ad età protostorica ed ellenistica (fig. 1, n . 7; fig . 7)2'. Tali livelli, messi in luce dalla trincea praticata dal mez-
l() Ex Strada Statale 173 "delle Terme Salenti ne" alla progressiva krn 21 +237 m. 21 Segnalazione avvenuta ad opera di chi scrive.
109
zo meccanico, sono stati oggetto di indagine da parte del Centro Operativo per l'Archeologia del Salento della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, lnediante 1'esecuzjone di un rilievo grafico e fotografico . Le attività di documentazione hanno consentito il recupero del materiale archeologico individuat022 .
La sezione occidentale (W - figg. 7-9), lunga m 2,80 circa, mostra, sulla formazione naturale di base (costituita da roccia intervallata da depositi di terra sterile d'origine eolica), un livello di frequentazione antropica che, ne1-l'interfaccia superiore, è a diretto contatto col piano di preparazione a nlas-
I
"
Il I , -,---" , -
+
SOm
Fig. 7 - Palombara. Ubicazione del saggio (Ex Strada Statale 173 "delle Terme Salenti ne").
Fig. 8 - Palombara. Sezione Ovest (W).
22 Tali operazioni sono sia il" condotte dallo scrivente sotto la direzione scientifica del dotto L. Tondo, responsabile del Centro Operativo, che ringrazio per la cordiale disponibilità.
110
+
,
--------------------,
&z",,",o,e" IW) (A _ BI
-------,
• •
•
Fig. 9 - Palombari). Sezioni Ovest (W) cd Est (E),
-.., ASFALTO MI\SSICC IATA STRADALE US2Il~·o'o do""""o"",,c.')
• US3 · LJS611 • ..,e""""",,,",oo,e) _l)S'{l"""'O",.'Obon"""""""l)S'>1 _ US5R".'od'elil<l'e<>'''''.) • US 7(T."o""~".""""",o,,,o ;US8)
?'ETRE CE<W.lICA(R, Iv.. 1.l )''lC''''" "'«~"'."""' )
· l ARGUA CONcorrA OSS'\ ANiMAl i f<OCClA{C""""~ d' C"tra) l!l. 'IfE DI SCAVO
sicciata della sede stradale moderna23 . Lo strato archeologico (US 2, di colore bruno, piuttosto compatto, con spessore che varia dai 20 ai 10 cm) è interessato dalla presenza di diversi fran1menti di ceramica figulina foggiata a mano di colore rosa arancio che, in alcuni casi, presenta tracce residue di decorazione in rosso, purtroppo in gran parte abrasa. Lo stesso strato ha restituito piccole pietre grigie o arrossate dall' azione del fuoco, grumi di argilla con cotta, rari e frammentari reperti faunistici e qualche residuo vegetale carbonizzato. L'omogeneità delle ceramiche, frammentate iII situ e distinte in due nuclei all'interno dello strato, suggeriva la pertinenza dei pezzi ad esemplari vascolari distinti, parziahnente ricostruibili e ne indiziava già in fase di recupero uno stato di deposizione in giacitura primaria (RA 1-2). Si tratta di ceramica Protogcometrica enotrio-iapigia, una classe che nel corso del Bronzo Finale soppianta nell'artigianato indigeno di molte regioni dell'Italia meridionale le precedenti produzioni figuline di più evidente affinità egea (dolii cordonati, ceramica grigia ed italo-micenea), ereditandone alcune caratteristiche tecnologiche ed elaborando un repertorio decorativo di matri-
23 [] fondo naturale, composto da Calcare di Castro e da terreno comunemente denominato /1010, è stato raggiunto dallo scavo a soli 40/45 cm di profondità dal piano stradale, situato a sua volta a 65,70 m circa s.l.m. (US 3) (v. fjgg. 8-9).
111
•
ce tipicamente locale24 Uno degli esemplari (RA l, figg . 10-11, n. 43), attribuibile ad una forma chiusa di grandi dimensioni (urna), è interessato da una decorazione dipinta organizzata su due fasce, campi te da un motivo angolare multiplo e disposte l'una tra spalla e attacco del collo, l'altra tra questo e l' orlo. Ulteriori tracce si identificano in corrispondenza di un probabile attacco d'ansa sopraelevata impostata tra orlo e collo. La parte interna dell'orlo è decorata con tratti obliqui25.
Un secondo esemplare (RA 2) è più lacunoso del precedente e conserva, ol tre al fondo completo, alcuni frammenti ornati da una banda orizzontale subito sotto l'orlo. Su tali frammenti si notano, inoltre, una serie di fori riconducibili plausibilmente ad un restauro eseguito in antico. È assai probabile che anche questo reperto sia da rifer ire alla medesima classe vascolare del precedente, pur presentando dimensioni ridotte.
In seguito ad una rettifica della sezione operata per il recupero dei reperti, è s tato individuato il taglio di una fossa (US 8), larga 30 cm e profonda circa 40 cm, rastremata verso il basso. L'escavazione, inoltre, sfrutta nel suo margine meridionale la spalla naturale offerta dal banco d i roccia affiorante (fig. 9, B). Il deposito di riempimento della fossa, di colore bruno, si presenta compatto, ricco di piccole pietre e d i qualche minuto frammento di ceramica d' impasto (US 7).
Anche ne lla sezione est (E - figg. 7-9) i livelli di preparazione del manto stradale coprono una sequenza stratigrafica estesa per 2,90 m circa. Un primo strato (US 4, di spessore variabile tra gli 8 e i 4 cm circa, di colore rossastro, molto compatto) risulta composto da alcune pietre di piccole dimensioni e qualche minuto frammento ceramico d'epoca storica; esso oblitera un secondo livello (US 5, spesso dai 25 ai 30 cm, di colore bruno grigiastro, compatto), ricco d i p ietre di piccole e medie d imensioni e di frammenti ceramici molto fluitati. La presenza di tegole frammentarie, di ceramica acroma e a vernice nera c di un frarrunento pertinente all'orlo di un'anfora da trasporto greco-italica consente di proporre un'attribuzione di ta le strato alla fase messapica. L'ultimo deposito visibile, quello basale, è lo stesso che ritroviamo nella sezione opposta (US 6 = US 3). In guesta sequenza, a differenza
24 Per un quadro d'insieme sulle attestazioni del Protogeometrlco enot-rio-iap igio (particolarmente numerose in Puglia, Basi licata e Calabria settentrionale), cfr. YNTEMA 1990.
25 Il motivo compreso tra le bande è costituito da una coppia di elementi angolari inscritti, che delimitano una fila di grossi punti. Si tratta di un repertorio ornamentale ampiamente attestato nella sintassi stili stica del Protogeometrico cnotrio-iapigio (cfr. YNTEMA 1990, p. 22, fig. 6, n. 2 e p. 28, fig . 9 - Termitito e Salapia; ORLANDO 1996, p. 302, fig. 19, n. 1 - Otranto, Cantiere 3), al pari della decorazione su ll'orlo (cfr. VNTEMA 1990, p . 22, fig . 6, n. 16). (n pa rticolare, l'esemplare di Castro trova un confronto estremamente puntuale sotto il profilo formale, dimensionale e decora tivo con un orcio dal villaggio di Punta Meliso a Santa Maria di Leuca (ORLANDO
1990a, p. 14, n. 35).
112
di quella occidentale dalla quale dista poco meno di 1,50 m, i livelli protostorici sono completamente assentj a causa di pesanti interventi (probabilmente agricoli), che in età ellenistica avevano intaccato persino la roccia la quale, in diversi punti, appare scheggiata e frantumata. L'unico possibile relitto del contesto archeologico originario è rappresentato da diversi frammenti di ceramica d'impasto sparsi a varia quota lungo la sezione.
Come già accennato, i dati derivanti dall' osservazione e dall'interpretazione della strati grafia appena descritta permettono di integrare ed amp liare quelli derivanti dalla ricognizione di superficie e dalle ricerche archeologiche pregresse. Sembra sostenibile, pertanto, che l'area cormessa all'abitato d'età storica avesse un'estensione ben più ampia rispetto a quella tradizionalmente ipotizzata . A supporto di questa constatazione ci viene la notizia riportata da L. Maggiulli, circa un ipotetico circuito difensivo ad un chilometro dal paese, visibile in località Palombella26
Ceramica figulina
43. (figg. 10-11) H . ric. 60 ca.; spesso lA-l,l; diam o orlo ric. 32,6; diam o max ric. 51,7; diamo fondo 15 . Urna frammentaria di produzione indigena in argilla depurata non tornita. Orlo d istinto da spigolo vivo all'interno, svasato, a profilo teso (ad imbuto); labbro arrotondato all'esterno, collo appena distinto, a profilo troncoconico con pareti sub-rettilinee; possibile attacco di ansa sopraelevata impostata tra orlo e collo; spalla a profilo arrotondato con parete piuttosto ispessita; ventre troncoconico a parete assottigliata e sub-rettilinea; fondo appena distinto a profilo esterno concavo. Figulina compatta, modellata a mano, con superfici lisciate; si conservano tracce d i ingubbiatura esterna, in particolare in corrispondenza delle parte alta del vaso interessata dalla presenza di decorazione dipinta. Tl repertorio ornamentale si articola in due fasce, campite da un motivo angolare multiplo e disposte l'una tra spalla e attacco del collo, l'altra tra questo e l'orlo; la parte interna dell'orlo è decorata con tratti obliqui . Pasta ceramica di colore bruno-chiaro (vicino a M 7.5YR 6/6); ingubbio di colore bruno molto chiaro (vicino a M lOYR 8/3); vernice di colore rosso (vicino a M 2.5YR 5/8), opaca, parzialmente abrasa. Bronzo Finale
26 MAGGIULU 1896, p. 36. Non è da escludere che tale toponimo sia da identificare con quello attuale di Palombara: tale ipotesi è suffragata, oltre che da !l'assonanza etimologica tra i due termini, anche dal rinvenimento, nel limite nord-orientale del pianoro, d i un insieme di blocchi, fo rtemente corrosi e realizzati in calcarenite di formazione Plio-Pleistocenica (calcareniti del Salento); si tratta di un tipo di roccia estranea alle caratteristiche btologiche dell'area, connotata, invece, dalla presenza di altre formazioni dette calcari di Castro. I b locchi, disposti su due filari alla base di un muro a secco, risultano analoghi, per dimensioni e materia prima impiegata, a quelli delle fortificazioni messapiche già note (v. supra D'ANDRIA, pp. 19-24; illfra DE MITRI, pp. 121-177).
]]3
o 5cm ......... Fig. lO - Palombara: Il. 43 ceramica figul ina (urna) US 2, RA 1 (dis. D. De Giosa, L. Coluccia).
114
TT1. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La presentazione preliminare dei dati relativi a recenti interventi di ricognizione nel territorio di Castro contribuisce all'ampliamento delle conoscenze sul Salento durante l'età del Bronzo. All o stato attuale, infatti, il centro protostorico di Castro va ad arricchire la fitta rete di insediamenti costieri presenti lungo il litorale salentino nel corso della seconda metà del II millennio a.C (Otranto, Leuca e Rocavecchia, per citarne alcuni tra i meglio indagati27). Si tratta d i una fase storica in cui l'Italia meridionale, e la sua estrema propaggine sud-orientale in particolare, rivestono un ruolo di nevralgica importanza nell'ambito di un vasto ed articolato panorama di traffici commerciali ed interscambi culturali con le civiltà dell'area egea e più in generale del Mediterraneo centro-orientale. Non a caso lo sviluppo dei centri indigeni del Salento, particolarmente florido a partire dal Bronzo Medio, avviene in un clima di interazione culturale tra processi autoctoni ed influenze esterne sotto il profilo sia tecnologico che ideologic02".
L'indagine su Castro durante la tarda protostoria, data la più volte rimarcata lacunoSltà e fram mentarietà della documentazione disponibile, non può che limitarsi in questa sede ad un primo tentativo di definizione dell'ambi to cronologico e territoriale cui ta le sito può essere riferito. L'analisi dei dati spaziali e crono-tipologici forniti dalle prospezioni topografiche e da limitati interventi di scavo suggeriscono l'esistenza di un insediamento piuttosto esteso ed attivo almeno a partire dal Bronzo Recente (seconda metà del XIV - XIII sec. a.C), come indiziato dalla presenza di tipi ceramici e metallici pecul iari dell'orizzonte sub-appenninico (si pensi alla scodella troncoconica d'impasto con labbro appiattito n. 20, oppure al frammento di lama di coltello in bronzo n. 41). Altre forme, come le tazze carenate ad impasto con carena a spigolo vivo Il. 33, sono attestate sia in contesti del Bronzo Recente che del Bronzo Finale iniziale (XI! sec. a.C). Altri indicatori ceramici, come gli elementi da presa decorati a costolature (nn. 8, lO, 34-35) oppure i frammenti di ceramica fi gulina p rotogeometrica (v. in particolare i due esemplari rinvenuti in località Palombara, n. 43), trovano attestazioni nei siti dell'Italia meridionale durante tutto l'arco del Bronzo Finale (XI!- XI sec. a.C).
Un d iscorso a parte meritano le forme d i lunga durata come le alle o doli d'impasto a profilo indistinto (presumibilmente destinati alla cottura e / o alla conservazione di derrate alimentarO, che meno si prestano ad essere inquadrate dal punto di vista cronologico, essendo caratterizzati da una scarsa
27 Per Otranto, cfr. ORLANDO 1983, ORLANDO 1990b, ORLANDO 1994, ORLANDO 1996; per Roca, cfr. PAGLIARA 2001, GUCLIELMINO 2005, PAGLIARA 2005, PACUAHA, GUGLIELMINa 2005; per Leuca, cfr. CREMONESI 1978, ORLANDO 1990a.
28 Cfr., ad esempio, BI ETTI SEST!ERI 1996; PERON! 1996.
116
variabilità morfo-metrica nei secoli a cavallo tra TI e T millennio a.C. (nn. 13, 14, 36-39). Sebbene queste forme vascolari si rivelino poco diagnostiche dal punto di vista dell'inquadramento temporale, Uloro rinvenimento in associazione con altri grandi contenitori in argiJla depurata e / o tornita, rappresenta una prova del regime stabile delJ'insediamento.
Un'ultima considerazione emerge dalla lettura topografica della dispersione spaziale dei materiali. Un computo metrico delle aree interessate dalla presenza esclusiva di ceramica d'impasto o da giaciture in posto databili all'età del Bronzo ci offre, infatti, una stima approssimativa delt'estensione originaria dell'abitato: una superficie di poco più di due ettari per ciò che concerne il pianoro superiore, un ettaro e mezzo all'incirca per quello inferiore, cui si può aggiungere l'area corrispondente alJ'attuale centro storico (circa due ettari), dalla quale provengono ulteriori sporadici indizi di frequentazione protostorica . Si tratta evidentemente di un dato da considerare con estrema cautela: solo il completamento delle ricerche in corso ed un auspicabile ampliamento delle stesse potrà, infatti, fornire informazioni più coerenti e sistematiche su questa e sulle altre problematiche poste dall'analisi sulla presenza antropica a Castro nclle fasi che precedono l'impianto del centro messa pico.
Il?
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE*
Arcllcologia Mcssapi, D'ANDRIA E (ed.), Archeologia dei Messapi, Catalogo della Mostra, Bari 1990.
AttiTaranto, ANi del COl/vegno llltenzaziOlwle di Studi sulla A1agna Grecia, Napoli-Taranto 1962-.
BAlLO MODESTI G. et ahi 1999, Strutture 1I100/afogiche e fUllziollali delle classi vascolari del Bronzo Finale e della prima età del Ferro iII Italia meridionale, in COCCHI GENICK D. (ed.), Criteri di /lOmenclatura e di termiHologia inerente alla defillizione delle farnie vasco/ari del Neolitico/El/colitico e del Brollzo/Ferro, Atti del Congresso, Lido di Camaiore 1998, voI. Il, Firenze, pp. 441-467.
BERNABÒ BREA L., CAVALIER M . 1980, Meligllllls Lipdra. L'acropoli di Lipari nella Preistoria, voI. JV, Palermo.
BIANCO PERONI V. 1976, I coltelli ucll'ltalia cOlltinc!ltalc, in PBF, Vll, 2, Miinchen . BIETII SESTI EI~ J A.M. 1968, Due scuri ad occhio di bro/lzo dalla Grotta Zil/zulusa (Terra d'O
tranto), in Quaternaria, X, pp. 199-212. Bl.E1TI SEST1ERI A.M. 1996, Protostoria. lèoria e pratica, Roma . BLANC A.C. 1961, Re/aziol/c sulle osscrvazio/li e ricerche stratigraficl,e eseguite /Iella grotta
Zil/Zlllllsa (Castro Marina, Lecce) e sull'esito di alcLllli sopraluoghi nel Sa/CHto, 22 dicell1-bre 1958 - 5 gell/wio 1959, in Quatemaria, V, pp. 330-334.
BOSSIO A. et alii 1988, Studi sul Neogene e Quaternario della Pcnisola Sa/cl/tina. V - Note geologicllC sulla zona di Castro, in Atti del Convegno sulle conoscenze geologiche del terri torio salentino, Lecce 1987, Quaderni di ricerche del CCI/tra Studi Ceotecl/ici e d'Ingegneria - Lecce, 11, pp. 127-146.
BTCGl, N ENCI G., VALLET G. (edd .), BiblIOgrafia topograflCt1 deffa colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniclle, Pisa-Roma-Napoli 1977-.
BurrA V 1994, l materiali del Bronzo finale e della prima età del ferro , in PE1{0Nl R, TRUCCO F. (edd .), Enotri e Micenei nella Sibaritide, Magna Grecia, 8, val. I, Taranto, pp. 455-574.
CAVALIER M. 1960, Le grotte de la Zirlzu[uza et [a stratigraphie de Lipari, in ME FRA, LXXII, pp. 7-34.
CAZZELLA A., MOSCOLONI M. 1987, Coppa Nevigata e il 5110 territorio . Testimoniallze archeologiche dal VII al II millennio a.c., Roma.
ONQUEPALMI A " CARR!ERI M ., MUNTONI L 1998, Monopoli centro storico, in CiNQUEI'A LMI A., RADINA E (edd.), Documenti dell'ef.'ì del Bronzo. Ricerche lw/go il versanfe adriatico pugliese, Catalogo della Mostra, Fasano, pp. 101-131.
CWOLLONI SAMl'Ù M. 1987, Manijestazio/li f~lIIerarie e strutture sociali, in ScAnt, 1, pp. 55-119.
COPPOL;\ D . 2002, Le grotte carsiche d'in/"eressc palclnologico ill Puglia: storia delle ricerche e prospettive di illdagilli, in Atti del III Convegno di Speleologia Pugliese, Castellana Grotte 2002, Grotte e dintonzi, Anno 2, 4, pp. 51-62.
CREMONESI G. 1978, il villaggio dcll'età del BrollZO del Salltuario di S. M. di Leuca, in Leuca, pp. 27-43.
* Le abbreviazioni delle riviste scguono il si5tcma dc]]' Arclliiologische Bibliogmphie.
118
D'ANDRIA F. 1978, Appendice H . 2 - Punta Meliso, in LeuGI, pp. 88-90. DE GIoReI C. 1912, Censimento dei dolmen iII Terra d'Otranto, in Apulia, 111 . GERVASIO M. 1913, 1 dolmen e la civiltà del bronzo l/elle Puglie, Bari. GORGOGLIONE M. et alii ·!993, La capall/w 7 di Torre Castellllccia (Pulsano-Taranto) dal
Bronzo filiale alla prima età delferro, in Taras, XIII, 1-2, pp. 25-114. GUGLlELMfNO R. 1999, l dolii cordonati di Rom Vecchia (LE) c il problema della loro deriva
zione egea, in LA ROSA v., PALERMO D., VAGNETrJ L. (cdd.) Efll nONrON nAAZOMENOI. Simposio italiano di Studi Egei dedim/D a Luigi Bemabò Brca e Giovanni Pugliese Carrate/Ii, Roma, pp. 475-486.
GUGLIELMINO R. 2005, Rocavecchil1: Iluove testinwllianze di relazioni CO/1 l'Egeo e il Mediterraneo orientale Ilell 'età del Bronzo, in LAFFINEUR R., GRECO E. (edd.), EMPORIA. Aegealls iii fhe Ccntra! alld Eastem Mediterrallea/l, Proceedings of the 10th lnternationa! Aegean Conference, Athens 2004, Liége-Austin, pp. 637-652.
INGRAVALLO E. 2003, La Scoperta di Groffa Rornallelli l1el panorama illtcflettuale salentillo, in FABBRI P.F., INGRAVAL LO E., MANGIA A. (edd.), Grolla ROlllanelli ileI cen/fllario della sua scoperta (1900-2000), Atti del Convegno, Castro, 6-7 ottobre 2000, Galatina, pp. 11-16.
LAZZA}{[ A. 1947, La Grotta Zinzulusa presso Castro, provo di Lecce - Osservazioni geoIIlOJfologiche COli IlOtizie storico-bibliografiche e due appelldici, in Anllali dell'Istituto Superiore di Sciel1ze e Lettere - S. Chiara, VIII, pp. 5-63.
Leuca, AA.VV., Leuca, Galatina 1978. Lo PORTO F.G. .! 963, Leporallu (Taranto) . La staziolle protostorica di Porto Faone, in NSc,
XVII, pp. 280-380. Lo PORTO EG. 1964, Sa/yrioll (Tarallto) . Scavi e ricerche Ild lU0f{0 del più alllico insedia-
mento laconico in Puglia, in NSc, XVIII, pp. 177-279. MAGGTUlLI L 1896, Monografia di Castro, Galatina. MALAGR1NÒ p. 1978, Dolmen e mCl/hir di Puglia, Fasano. MALAGRlNÒ p. 1997, i\101nlll1ellli megalilici iII Puglia, Fasano. MICALELLA M.A.1910, 1 dolmell di Vaste, in Apulia, L MONTICELLl T. 1837, Descrizione della grotta "Zinzulusa", Napoli . Mosso A. 1910, Le origùli della civiltà mediterranea, in NSc, pp. 193-220. MUNTON! T. 1995, L'insediamento dell'età del Bronzo di MadOJ1I1a del Petto, in Taras, XV, 2,
pp. 175-198. ORLANDO M.A. 1983, L'età del Brollzo recente e finale ad Otranto, in StAnt, 4, pp. 67-1.18. ORLANDO M.A. 1990a, Salita Maria di Leuca - Punta Meliso, in Archeologia Messapi, pp.
5-16. ORLANDO M.A. 1990b, Otral/to. Età del BroIIZO, in Arclwolo:;ia Messapi, pp. 21-28. ORLANDO M.A. 1994, Otranto. [livelli dell'eM del bronzo finale del cantiere Mitello, in
StAI/t, 7, pp. 209-234. ORLANDO M.A. 1995, Plll/ta Meliso e il Basso Salel/fo nel quadro dell'età del Bronzo Recen
te e Finale, in Taras, XV, 2, pp. 501-512. ORLANDO M.A. 1996, l livelli alla base della serie stratigrafica del cantiere 3 di Otranto ilei
quadro del Brollzo finale dell'ltalia meridionale, in Origini, XX, pp. 233-327. ORLANDO M.A. 2003, Grotta Romanelli e il Museo Civico di Pa!cont%gia e Pa/etn%gia di
Maglic, in FABBRI P.F., INCRAVALLO E., MANGIA A. (edd.), GroUa Romanelli lIel cen/enario della sua scoperta (1900-2000), Atti del Convegno, Castro, 6-7 ottobre 2000, Galatina, pp. 17-25.
119
PAGLIARA C. 2001, S.v. Roca, in BTCG1, XVI, pp. 197~229.
PAGLIARA C. 2005, Rocavecchia (Lecce): il sito le fortificaziolli e l'abitafD dell'età del Bronzo, in L AFFII'\IEU1{ R., GI{ECO E. (edd .), EMPORTA. Aegeans in file Centrai alld Eastern Mediterranean, Proceed ings of the 10th International Aegean Conference, Athens 2004, Liége~Austin, pp. 629~636.
PAGLIARA C, GUGLIELMINO R. 2005, Roca: dalle curiosità antiquarie allo scavo stratigrnfico, in SEITIS S., PARRA M.C. (edd.), Magna Gmecia . Archeologia di II/I sapere, Catalogo della Mostra, Milano, pp. 298~321.
PALUMBO G. 1956, Invclztario dei dolmen di Terra d'Otrallto, in Riv5cPr, XI, pp. 84-108. PARENZAN P. 1983, Puglia Marittima. Aspetti geologici e hiologin marina (20 {limi di ricer
che nafuralistiche Ilei mari pugliesO, Gala ti na. PERONI R. 1996, L'Italia alle soglie della storia, H.oma. RECCHIA C. 1995, Grotta Manaccora : Rilettura del saggio Bawngéirtel "TG 1933 ", in Taras,
Xv, 2, pp. 55~86. SCARANO T. 2006, La ceramica decorata di tipo appellllùùcO dei livelli del Bronzo Medio di
Roca (Lecce): con/ribulo per una rilettura di alculli aspetti archeologici e crol/ologici della facies appeunillica Ilella Puglia cen/ro-meridiorwle, in AA.VV, Studi di Protostoria iII oliare di Renato PerolIi, Firenze, pp. 133-145.
SCAlZANO T. c.s., Analisi tip%gica preliminare del/a ceramica il/digella ad impasto, in PAGLIARA C. et alii, La sequel/za crollostratigrafica delle fasi di occupaziolle dell'abitato protostorico di Roca (Melendugno, Lecce). Relazione prelimi/1{1fe delle campagl/a di SCf1VO
2005 - Saggio X, in RivScPr, LVII, in corso dì stampa. TARANTINI M. 2000, Tradizioni e tellsiolli disciplillari nell'archeologia preistorica italialla tra
Ottocellto e Novecento, in Origini, XXII, pp. 25-35. UGGERI G. 1972, Castro, in RivScPr, XXVII, 2, p . 467. Uex.;ERI G. 1983, La viabiliM rOIl1flllflllel Sale/lto, Fasano. WHITEHOUSE R. 1967, The megalithic 1l1OIlwnents of sOl/th etlst ltaly, in Man, Il, pp. 347-
365. WHITEHOUSE R. 1981, Megaliths of lhe celltral Mediterral/call, in R ENFREW C. (ed .), Thc
Mcgalithic Monuments ofWestern Europe, Oxford, pp. 42-63. YNTEMA D. 1990, The Matt-paillted Pottery of SOflthem ltaly, Galatina .
120