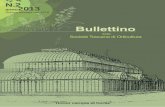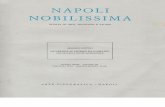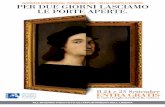(2013) I grossi d'argento e la monetazione di Genova tra Due e Trecento: nuovi dati ed osservazioni...
-
Upload
valdarnomusei -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of (2013) I grossi d'argento e la monetazione di Genova tra Due e Trecento: nuovi dati ed osservazioni...
QUADERNI TICINESI 2013
XLII
2013
Numismaticae Antichità Classiche
Num
ism
atic
aeA
ntic
hità
Cla
ssic
he
275NAC 42, 2013, 275-299
Questo contributo sulla monetazione della zecca medievale di Genova tra Duecento e Tre-cento ed in particolare sui grossi in argento ivi coniati ravviva in quest’ambito la discussio-ne a proposito di cronologia e lettura storica delle emissioni genovesi di quel tempo. Gli stu-diosi propongono una nuova crono-tipologia, evinta da un riesame delle evidenze archivi-stiche, archeologiche e numismatiche ma anche da analisi archeometriche effettuate sui mate-riali. La nascita della moneta grossa a Genova si situa a cavallo dei primi due decenni delDuecento. L’inizio della coniazione di una valuta in buon argento è dovuta a fattori econo-mico-strutturali, i quali incoraggiano poi le modifiche della stessa – soprattutto concernentiil fino ed il peso – durante la prima metà del secolo. Nel terzo e ultimo quarto del Duecentoavvengono gli ultimi cambiamenti nella tipologia che sembrano in parte strettamente legaticon la politica interna ed esterna di Genova. Questa nuova ricostruzione ben si inserisce nelcontesto storico-economico del XIII secolo e dei primi decenni del secolo successivo.
Monica Baldassarri – Daniele Ricci
I grossi d’argento e la monetazione
di Genova tra Due e Trecento:
nuovi dati ed osservazioni
per vecchi problemi
La monetazione della zecca medievale di Genova fino al primo periodo del doga-to ha visto di recente fiorire una nuova stagione di studi, che hanno riavviato la discussionesulla cronologia e sulla lettura storica di alcune serie di monete piccole (denari, medaglie, quar-tari e petachine)1, aprendo la strada ad ulteriori riflessioni sui coevi nominali maggiori. Paral-lelamente si sono avuti contributi aggiornati sulle monete grosse di Venezia, di Pisa e di altrezecche dell’Italia centro-settentrionale, oltre a nuovi input sull’eventuale relazione tra queste ei miliaresi citati dalle fonti scritte nel pieno Duecento2.
A tutto ciò si sono aggiunti nuovi, per quanto rari, ritrovamenti di monete grossein argento e talvolta di pezzi in oro che hanno consentito di aggiungere alcuni tasselli circa lapossibile cronologia di emissione e l’area di uso di certe monete rispetto al contesto peninsu-
14 baldassari ricci:Layout 1 15.11.2013 7:49 Pagina 275
276 I GROSSI D’ARGENTO E LA MONETAZIONE DI GENOVA TRA DUE E TRECENTO
lare e mediterraneo3. Infine la recente collaborazione con il CNR di Pisa4 ha permesso di ef-fettuare una campagna di analisi archeometriche non distruttive (XRF) su diverse serie mone-tali di produzione genovese che, pur essendo preparatorie ad ulteriori verifiche con metodichedi maggiore approfondimento, hanno fornito interessanti risultati preliminari.
In questo contributo si affronterà quindi il problema della coniazione della mo-neta grossa in argento a Genova e delle sue mutazioni tra XIII e prima parte del XIV secolo,facendo riferimento solo sullo sfondo alle serie in oro e in mistura, che per alcuni aspetti van-no alle prime correlate. (M.B., D.R.)
Gli studi precedenti: il dibattito sulle origini e sulla crono-tipologia
Le monete grosse di Genova, così come le altre principali serie numismatiche cit-tadine, vantano una lunga tradizione di studio, rinnovata solo in tempi recenti. Tuttavia, perquanto riguarda la possibile datazione delle diverse tipologie di grossi in argento che la zeccagenovese avrebbe coniato nei primi due secoli della propria attività, le posizioni assunte daglistudiosi sono essenzialmente due.
Da un lato i cultori di numismatica genovese, che hanno ritenute valide le propo-ste formulate da Gandolfi e Desimoni: essi datavano al 1172 le prime emissioni di grossi «leg-geri» a legenda IANVA, al 1217 gli analoghi grossi di peso maggiore e al 1252 quelli con l’iscri-zione CIVITAS IANVA, collocando all’ultimo quarto del Duecento il gruppo IANVA QVAMDEVS PROTEGAT5.
Dall’altro Lopez e altri ricercatori di storia e di numismatica medievale, che in se-guito hanno accolto in buona parte le sue ipotesi: questi hanno collocato la coniazione dei pri-mi grossi IANVA a inizi Duecento, rivedendo il periodo di produzione delle serie successive(al 1280/1290 circa la serie CIVITAS IANVA e genericamente tra fine XIII e primi decenni delXIV secolo il tipo IQDP)6.
A questi si è poi aggiunto un lavoro di Astengo, che riportava la prima coniazio-ne dei grossi agli inizi del Duecento7, e l’indicazione di Felloni, che sulla base di alcuni riferi-menti documentari, ha considerato possibile la battitura dei primi grossi prima nel 1193 equindi nel 1194, quando i Genovesi supportarono Enrico VI nell’organizzazione della spedi-zione navale in Sicilia, senza però entrare nel merito circa le caratteristiche di queste monete,né a riguardo delle emissioni successive8.
Nessuno fino ad oggi sembra aver invece messo in discussione la successione del-le tre tipologie di grosso caratterizzate dalle diverse iscrizioni e il fatto che tra i tipi a legendaIANVA fossero stati prima coniati i pezzi detti «da 4 denari», del peso teorico di 1,45 g circa,e quindi quelli definiti «da 6 denari», accresciuti a 1,75 g circa. Altro tema di confronto tra glistudiosi, invece, è stato quello relativo alle motivazioni dell’introduzione di questa specie mo-netale e al sistema di conto e ponderale da essa preso a riferimento, che si correlano ai proble-mi di cronologia assoluta e relativa ricordate sopra9.
14 baldassari ricci:Layout 1 15.11.2013 7:49 Pagina 276
Tali discrepanze sulle origini della monetazione grossa d’argento della RepubblicaMarinara e sulla successiva crono-tipologia traggono motivo da vari fattori. Come già illustra-to in precedenza per i nominali inferiori10, anche questa è infatti caratterizzata dalla staticitàdei tipi, che non contengono informazioni immediatamente utili alla datazione del periodo diemissione, da una difficile scansione cronologica delle varianti interne e dalla relativa scarsez-za dei riferimenti nella documentazione scritta. Oltre a questo, si aggiunge un altro elemento,più specifico per questo genere di nominale: la relativa esiguità dei ritrovamenti, tanto in ri-postiglio, che come singolo reperto sporadico o da scavo.
In base alla rilettura dei documenti anche già noti nella letteratura precedente, masoprattutto grazie a nuovi studi numismatici e recenti rinvenimenti, sembra ora possibile ri-prendere la questione e presentare una ricostruzione storica che in parte presenta elementi dinovità, in parte riprende e approfondisce alcune delle argomentazioni degli stessi Desimoni eLopez.
2.1 La coniazione dei primi grossi di Genova: una nuova proposta crono-tipologica
Per poter sciogliere i nodi presenti nelle precedenti ricostruzioni storiche relativealla coniazione dei primi grossi genovesi, è necessario riprendere le evidenze archivistiche, ar-cheologiche e numismatiche oggi note. Gli elementi di maggior rilievo da ridefinire sono quel-lo cronologico e quello relativo agli aspetti intrinseci (peso e argento fino in lega) di queste pri-me coniazioni.
Guardando alla documentazione scritta, è evidente come per i primi grossi la da-tazione alta, al 1172, non sia giustificabile, a partire dai motivi indicati da Lopez. L’unico fon-damento per tale attribuzione sarebbero dei ragguagli indicati da Desimoni tra il valore del-l’argento e quello della libbra genovese di conto, dei quali peraltro l’autore non forniva le ci-tazioni documentarie di dettaglio, errandone la presunta data di riferimento (riportata da Lo-pez al 1164)11, o altri elementi certi.
Lo spoglio dei cartulari notarili dell’Archivio di Stato di Genova databili tra metàXII e inizio XIII secolo, ormai in buona parte editi, oltre che delle fonti pubbliche e cronisti-che del tempo, conferma inoltre che in quel periodo non si ritrova alcuna menzione esplicitadi questa moneta; né se ne è trovata traccia nelle serie archivistiche pisane o di altre città dellapenisola centro-settentrionale, anche se per queste ultime non è stato effettuato un lavoro dischedatura sistematico.
Infine gli studi più recenti sulla monetazione grossa di altre città italiane hannofatto risalire a Venezia il primato di questa innovazione, probabilmente già dal 1194 (ma conattestazioni documentarie tra 1202 e 1212), forse seguita da Trento tra 1195 e 1205, quindi daPisa e Lucca nel 1210-1215 circa12, mentre gli altri veri e propri grossi in argento di altre zec-che dell’Italia centro-settentrionale dovrebbero essere ancora successivi. Poiché questo generedi fenomeno sembra avere una certa concentrazione nel tempo, con una diffusione «a catena»
277MONICA BALDASSARRI – DANIELE RICCI
14 baldassari ricci:Layout 1 15.11.2013 7:49 Pagina 277
278 I GROSSI D’ARGENTO E LA MONETAZIONE DI GENOVA TRA DUE E TRECENTO
tra le diverse realtà che producevano moneta, una datazione verso gli inizi del Duecento perGenova pare dunque assai più probabile.
Del resto i primi documenti che menzionano l’adozione di questo nuovo nomi-nale ligure sono riferibili a un arco cronologico compreso tra 1216 e 122213, similmente aquanto registrato per Pisa.
Il documento più antico che lo cita potrebbe essere un atto rogato a Genova a fi-ne settembre 1216 in cui Gugliemo, canonico di Ivrea, dichiara di aver ricevuto da Ansimocappellano di S. Andrea di Porta libras .iiii. januinorum mutuo gratis, abrenuntians exceptioni etce-tera. Quas vel valens in denariis crossis Janue tibi vel tuo certo misso per me vel meum missum in civita-te Antiochie dare et reddere promitto ad mensem unum postquam ibi fuerimus, o al più tardi al rientroa Genova14. L’atto del 1222 è ancora più esplicito: quattro mercanti romani, che a nome delpontefice Onorio III ricevono le somme depositate presso i canonici di S. Lorenzo dal legatoapostolico di ritorno dalla Sardegna, ottengono la cifra in varie monete tra cui triginta duobussolidis ianuensium grossorum in numero ac duodecim libris et octo unciis minus quartam ianuensiumgrossorum in pondere15.
Si tratta comunque di evidenze che attestano una situazione al tempo di fatto esi-stente e nel 1220 già presa come riferimento nella vicina Piacenza16, i cui operatori economicistavano in quel periodo entrando con forza nel mercato della città ligure. Altra conferma in-diretta, ricordata già da Grierson, è costituita dall’inizio della produzione del grosso nella vici-na Marsiglia nel 121817: non a caso esso corrispondeva nel peso (1,8 g teorici) alla serie di gros-si genovesi «da 6 denari» e anche ai primi denari «pesanti» piacentini, e se su una faccia adot-tava il tipo del profilo del sovrano aragonese, dall’altra mostrava l’immagine della città turrita,come avveniva da tempo anche sulle monete genovesi18.
Stanti questi elementi, il momento di avvio della produzione dei grossi a Genovapotrebbe essere stato forse tra 1193 e 1194, come proposto da Felloni, ma altri fattori spingonoa pensare che il fenomeno sia avvenuto diversi anni più tardi. Difatti i documenti a supportodell’ipotesi dello storico genovese raccontano che in quegli anni vi fu l’emissione di denari«buoni», ovvero migliori per peso o fino dei precedenti, e che Enrico VI fece coniare il proprioargento a Genova per finanziare la spedizione contro il regno meridionale, tacendo sul tipo dinominale ottenuto da quel metallo19. I precedenti studi da parte di chi scrive sembrano sugge-rire che in quel frangente si fossero semmai coniati i denari genovesi del tipo CVNRAD1REXsenza interpunzioni e una piccola spina nel primo quarto della croce al rovescio, di peso pocomaggiore rispetto quelli battuti in precedenza, che si trovano abbastanza diffusi nelle stratifica-zioni e nei ripostigli delle isole tirreniche maggiori databili a inizi XIII secolo (tav. I, n. 1)20.
Un contributo alla datazione e all’individuazione di questi grossi giunge dai ritro-vamenti e dall’analisi numismatica. Se guardiamo ai primi e ne incrociamo le informazionicon i dati della documentazione scritta, ci si rende conto di un aspetto importante, finora tra-scurato: i grossi d’argento di Genova più antichi non sarebbero quelli leggeri, detti «da 4 de-nari», bensì quelli «da 6 denari», dal peso teorico di 1,8 g e caratterizzati da un fino abbastan-
14 baldassari ricci:Layout 1 15.11.2013 7:49 Pagina 278
za elevato, non dissimile da quello usato in Venezia, come rivelato anche dal documento pia-centino sopra richiamato. Questi grossi più pesanti si trovano infatti solo in ripostigli databilientro la prima metà del XIII secolo, talvolta con addensamenti dei pezzi emessi tra 1210 e1240 circa21, mentre i grossi più leggeri di vario tipo sono occultati in depositi posteriori, dal-la metà del Duecento ai primi decenni del Trecento. L’unico rinvenimento in contesto strati-grafico di un pezzo «da 6», avvenuto a Finalborgo (SV), rimanda anch’esso alla prima metà delsecolo, e lo vede in associazione con monete minute genovesi battute tra la fine del 1100 ed il1240 e un denaro astigiano probabilmente emesso poco dopo22.
Anche l’analisi numismatica sembra concordare con questa nuova proposta, vistoche i grossi «da 6» mostrano caratteristiche tipiche di denari che si possono ora datare tra il 1210e il 1230 circa (tav. I, n. 2): il castello/imago civitatis ha dei piccoli prolungamenti obliqui in bas-so; la crocetta ad inizio legenda è di forma latina e attaccata al cerchio; la lettera A ha un cap-pello arricciato in alto e la X è iscritta in un quadrato regolare; la legenda al rovescio presentauna sola interpunzione finale (tav. I, n. 3). La presenza di un taglietto nella E e nella R potreb-be essere stato un sistema per indicare l’inizio della nuova serie, o il particolare intrinseco (tav.I, n. 4, tipo I.III.1; tav. II). Questo, verificato su alcuni esemplari delle collezioni pubbliche eprivate genovesi per quanto con metodica XRF, sembra peraltro attestarsi sui 930-940‰ di me-dia, come indicato da certe fonti scritte e da alcune delle equivalenze citate da Desimoni23. Diquesto tipo di moneta si conoscono molti conii, ma con poche varianti principali, elemento chepotrebbe dimostrarne la stabilità e la durata di produzione non prolungata nel tempo.
Allo stato attuale sembra dunque possibile ipotizzare che Genova abbia iniziato abattere moneta grossa in argento tra primo e secondo decennio del Duecento (ante 1216): unamoneta di peso teorico di 1,8 g e in lega di buon argento, appena inferiore allo standard delgrosso veneziano, del valore di 6 denari genovesi o 6 mezzani lombardi, ma al contempo in-tercambiabile anche con altre valute mediterranee in base ad una facile relazione di conto conil bisante di miliaresi24.
In quello stesso periodo buona parte dell’area lombarda avrebbe adottato analoghistandard, seguita verso il 1230 dalle zecche toscane. Non meraviglia dunque che i rinvenimentinoti, per quanto quantitativamente assai limitati, di questo tipo di grossi genovesi siano localiz-zati nella Liguria di Levante, in Lombardia e in Germania meridionale (tav. IV). Tale indizio po-trebbe essere utile anche per riflettere sulle motivazioni che furono alla base dell’introduzione diquesta novità monetaria: riprenderemo la discussione di questi aspetti nelle conclusioni finali.
2.2. Le serie dei grossi IANVA fino alla metà circa del Duecento
Nel passaggio tra primo e secondo quarto del Duecento la crescente svalutazionedei denari deve aver portato a un aggiustamento nel fino e nel peso dei grossi, che da quel mo-mento fino al terzo quarto del XIII secolo circa furono battuti secondo nuovi standard, dellamisura teorica di 1,45/50 g.
279MONICA BALDASSARRI – DANIELE RICCI
14 baldassari ricci:Layout 1 15.11.2013 7:49 Pagina 279
280 I GROSSI D’ARGENTO E LA MONETAZIONE DI GENOVA TRA DUE E TRECENTO
Le nuove serie dovrebbero coincidere con i pezzi che mostrano il castello/imagocivitatis con la base allungata e doppia interpunzione al rovescio (CVNRAD1•REX•, tipoI.III.2). In essi la crocetta a inizio legenda è attaccata al cerchio, ma con braccia equilatere emaggiormente potenziate, la A ha un cappello diritto, mentre la X appare un poco schiaccia-ta; tranne che in rare eccezioni in pezzi da considerare di transizione, la E e la R perdono il ta-glietto (tav. II). Sono note numerose varianti al tipo principale, che possono mostrare un pun-to o globetto sotto il castello/imago civitatis, oppure avere diverse interpunzioni nella parte fi-nale e/o iniziale delle legende (tav. I, nn. 5-6).
In un altro gruppo è leggermente mutata anche l’impronta del dritto, e le primedue lettere dell’iscrizione IANVA sono intervallate da un regolare bisante o da cuneo (tav. I,nn. 7-8, tipo I.III.3). Questa ultima soluzione potrebbe essere stata impiegata in un periodonon troppo distante dall’analogo cambiamento su alcune serie di denari genovesi25; e poichéalcuni esemplari sono stati trovati ribattuti su denari astigiani, forse in connessione con la mi-sura del Comune che nel 1255 ne vietava la circolazione nel territorio della Repubblica26, si po-trebbe ipotizzare che pure i grossi che mostrano questa variazione siano databili poco dopo lametà del Duecento27.
A tale mutamento potrebbe riferirsi anche l’atto che nel 1253 menziona i «vecchigrossi genovesi», aventi titolo paragonabile ai vecchi grossi veneziani28. Difatti le analisi XRFeffettuate di recente hanno rilevato ancora un titolo medio del 960‰ per i grossi leggeri coninterpunzione «tradizionale» al dritto, mentre gli esemplari di analogo peso, ma con il bisantetra I ed A hanno restituito valori di fino in superficie del 940-945‰ di media. Questo leggeroribasso potrebbe essere legato all’aggiustamento delle serie monetarie in lega d’argento seguitoall’introduzione del nuovo nominale aureo nel 125229.
La datazione proposta per questi due gruppi di grossi leggeri pare confermata dal-l’analogia con le coeve serie di denari, con quanto registrato per le vicine zecche lombarde edai ritrovamenti di complessi monetali, come quello di Cisano30. Di particolare rilievo a pro-posito del periodo di emissione del secondo raggruppamento è il ripostiglio probabilmenteproveniente da Tripoli nell’attuale Libano, dove i grossi delle tipologia I.III.3 nelle diverse va-rianti sono stati rinvenuti con quelli delle serie successive I.III.4 (tav. I, n. 9); poiché i geno-vesi furono attori di diverse tensioni con i Conti di Tripoli dal 1277 e dovettero abbandona-re la città nel 1289 in seguito alla conquista dei Mamelucchi31, la deposizione potrebbe esse-re avvenuta entro tali date, associando monete battute a partire dalla metà del secolo. Anchealtri tesori, come Oschiri, nati da accumulazioni realizzate tra seconda metà del Duecento eprimo decennio del Trecento, vedono la presenza di grossi di questi due tipi32. Tale cronolo-gia d’uso è infine testimoniata anche dai pochi rinvenimenti in scavo ben databili, come quel-lo di Geridu (SS)33.
L’area di circolazione di queste serie di grossi testimoniata dai rinvenimenti sembraessere più ampia e, soprattutto, allargata al Mediterraneo centro-occidentale e medio-orientale(tav. IV). Per orizzonte cronologico, elementi ponderali e diffusione potrebbero essere questi i
14 baldassari ricci:Layout 1 15.11.2013 7:49 Pagina 280
grossi che una parte della letteratura identifica con i miliaresi delle fonti scritte relativamente al-l’ambiente genovese (come moneta reale, e non come bisante di miliaresi di conto)34.
Il titolo restituito dall’analisi XRF per questi pezzi rivela un fino abbastanza ele-vato, nonostante gli aggiustamenti al ribasso di metà secolo. Per tale motivo si potrebbe rite-nere che essi corrispondano a 4 imperiali del tempo, e più probabilmente al valore legale di 6dei coevi denari di Genova, ora leggermente sviliti rispetto all’inizio del Duecento35. Anche te-nuto conto dell’arricchimento superficiale in argento, che potrebbe aver innalzato leggermen-te i dati acquisti con metodica XRF sugli esemplari disponibili, pare possibile il ragguaglio coni coevi grossi toscani da 12 denari espresso da talune fonti del tempo, visto che questi ultimiavevano un intrinseco inferiore (850-860‰ di media, con 900‰ di massima, da analisi per at-tivazione neutronica)36.
2.2 Tra terzo e ultimo quarto del Duecento: dai nuovi grossi del tipo IANVA ai CIVITAS IANVA
Non molto tempo dopo la metà del secolo, il grosso a legenda IANVA verificòl’ultimo rilevante mutamento, legato ai cambiamenti avvenuti nella monetazione minuta e al-l’evoluzione del mercato dei metalli, nel quale a partire dagli anni Sessanta del Duecento co-minciò a farsi sentire il peso delle nuove valute auree introdotte dalle città dell’Italia centro-settentrionale. Dovrebbe risalire infatti ad un momento tra terzo e quarto finale del Duecentol’ultimo tipo di grossi contrassegnati ancora dalle iscrizioni precedenti, e conosciuto con dueprincipali tipi di conii.
Il primo mostra una particolare forma del castello/imago civitatis nella quale si evi-denziano gli attacchi degli archi centrali con piccoli triangoli, la crocetta a inizio legenda di ti-po greco e staccata dal cerchio, la R di forma nuova e caratteristica, ma la E con taglietto (tav.II); anche la disposizione delle iscrizioni sembra rimandare ai primi grossi, con + •IA•NV•A•al dritto e un’unica interpunzione alla fine della legenda del rovescio, rappresentata da due otre punti in verticale (tav. II, n. 9, tipo I.III.4; tav. III, n. 1). Il peso medio degli esemplari no-ti si attesta su 1,25/30 g, ma sono conosciuti diversi pezzi da 1,45 g37.
Il secondo tipo, fino ad ora riscontrato in un unico esemplare (1,44 g), appare co-me una sorta di evoluzione nelle caratteristiche del conio, che mostra aspetti transizionali ri-spetto alle successive serie CIVITAS IANVA. L’imago civitatis è di forma simile, ma qui mostraun taglietto centrale e inoltre ha un crescente sotto; la crocetta è ancora equilatera e staccatadal cerchio, così come rimane invariata la distribuzione delle interpunzioni al dritto, che peròadesso sono rappresentate da piccoli trifogli. Un trifoglio appare anche nella prima interpun-zione al rovescio, mentre i due punti in verticale ne segnano la fine; la forma delle lettere so-prattutto sul lato della croce ha assunto caratteristiche che preludono al gotico, con la E chiu-sa e il gambetto della R sagomato (tav. III, n. 3, tipo I.III.5).
Non è stato possibile verificare l’intrinseco del secondo e unico pezzo, mentre leanalisi XRF sul primo gruppo hanno dato valori piuttosto oscillanti, ma con una media intor-
281MONICA BALDASSARRI – DANIELE RICCI
14 baldassari ricci:Layout 1 15.11.2013 7:49 Pagina 281
282 I GROSSI D’ARGENTO E LA MONETAZIONE DI GENOVA TRA DUE E TRECENTO
no a 945-950‰. Potrebbe dunque riferirsi a queste emissioni, se non alle precedenti I.III.2 vi-sta la posizione nell’elenco, quanto registrato nella lista di monete «Columbia», datata al 1280circa: Genovini grossi a onc. 11 e ½; Pisani vecchi sonno a onc. 11 e ¼; Lucchesi vecchi sonno a onc. 11e ¼; Sterlini sonno a onc. 11 e ¼; Reali di Marsiglia sonno a onc. 11 e 1/338. Sempre queste potreb-bero essere le monete citate nelle Rationes decimarum della diocesi di Luni del 1296-1297, dovetra le specie reali pervenute si menzionano: grossi aquilini di Pisa, quorum quilibet valet d.XXXIII pisanorum; bolognini grossi, quorum quilibet valet d. XV pisanorum; grossi genovesi e ter-zi di tornese, quorum quilibet valet d. XVI pisanorum39.
Rimane difficile al momento trovare una conferma a questa ipotesi cronologicasulla base delle altre fonti, anche se grossi di questo nuovo primo tipo si trovano nel già citatotesoro da Tripoli del Libano chiuso al più tardi nel 1289, e nel ripostiglio di Oschiri (SS). Inquest’ultimo sono associati anche ad altre monete genovesi e pisane in larga parte prodotte trail 1260 e il primo decennio del Trecento, e in particolare a due grossi genovesi «leggeri» dei ti-pi I.III.3 e, appunto, a dei terzi di tornese40.
Il secondo, oltre alla presenza di trifogli, mostra alcune caratteristiche epigrafichedi una serie parallela di denari e di mezzaglie, per motivi tipologici battuti probabilmente en-tro fine Duecento. Altro elemento di interesse è che le medesime caratteristiche ricorrono inun gruppo di grossi a legenda + •CIVITAS❣IANVA• / •CVNRADVS❣REX•, che al momentodella prima introduzione potrebbe aver fatto «serie» con questi nominali inferiori e col grosso«minore» suddetto. Difatti è noto in diversi esemplari e conii un grosso di tipo CI, con ta-glietto o punti nell’imago civitatis, crocetta equilatera staccata dal cerchio, crescente nel secon-do quarto e interpunzioni in forma di trifogli; il peso teorico in questo caso è di 2,80 g: all’in-circa il doppio dei grossi IANVA prodotti fino a allora (tav. III, nn. 2-4, tipo CI.I.1).
Se questa ricostruzione fosse giusta, e dato che un simile grosso non pare citatonella lista del 1280, i grossi genovesi potrebbero essersi rinnovati posteriormente a quella data,forse durante l’ultimo periodo della diarchia Spinola-Doria, come supposto in passato, o an-cora qualche anno più avanti, dopo la vittoria sui Pisani nel 1284, ma di certo non oltre gli ini-zi degli anni Novanta del Duecento, per il rincaro dell’argento che si ebbe in quel periodo.Questa ipotesi è compatibile anche con uno dei conteggi di Desimoni tra lira genovese in ar-gento e pezzi effettivi che parrebbe attestare la presenza di grossi da un soldo già nel 128841. Ilrinnovamento tipologico sarebbe dunque avvenuto a partire dal nuovo grosso doppio o da unsoldo (12 d.), per poi vedere successivamente la coniazione anche di un nuovo tipo di grossominore (6 d.), a legenda + •CIVITAS❣IANVA• e contrassegnato da un triangolo nel secondoquarto sul lato della croce, come il parallelo grosso maggiore (tav. III, nn. 5-6). Un esemplaredi grosso minore di questo conio viene ora da contesti di pieno Trecento negli scavi di Geridu(SS), tra le ultime emissioni liguri che raggiungono il sito prima della sostituzione con il cir-colante aragonese di produzione isolana. Alle analisi XRF questi due primi grossi maggiori e iltipo minore CI hanno restituito uno spettro corrispondente ad un fino medio di 965‰, quin-di ancora abbastanza elevato.
14 baldassari ricci:Layout 1 15.11.2013 7:49 Pagina 282
Posteriori, per aspetti estrinseci e per parallelismo con i coevi denari, dovrebberoessere gli altri tipi di grosso CI, per quanto alcuni di essi siano molto rari e noti soltanto dapubblicazioni e non sia stato possibile per ciò né valutarne l’autenticità, né avere i necessari da-ti metrologici (con spina che nasce da punto nel secondo quarto, con anelletto o con crescen-te finale in legenda: tav. III, nn. 7-8). Rispetto alla genuinità del tipo con anelletto o crescentefinale (tipo CI.I.2) siamo assai più possibilisti, non solo per quanto si evince dalle riproduzio-ni note, ma per l’esistenza di genovini aurei con cerchio polilobato, che presentano gli stessisegni in analoga posizione42. Da questo momento sembra cessare invece la produzione di gros-si «da 6 denari», o comunque del peso di un grammo e mezzo circa.
Di collocazione cronologica altrettanto difficile sono gli ultimi grossi a legen-da + •CIVITAS•IANVA•, ora caratterizzati dalla presenza di un contorno polilobato su en-trambe le facce, per i quali si ha il parallelo «genovino» aureo. Dal punto di vista tipologi-co questo gruppo presenta nell’epigrafia (E chiusa semplice, R con gambetto a triangolo ro-vesciato, crocetta di inizio legenda di nuovo attaccata al cerchio) e nello stile dell’imago,priva di taglietti o punti interni, strette affinità con le serie senza segni nei quarti, ma allafine della legenda, illustrata sopra. La loro battitura dovrebbe essere per questo collegata esuccessiva (tav. III, n. 9, tipo CI.1.3).
L’impiego del contorno polilobato era stato sperimentato dalle zecche d’Oltre-mare (grosso di Tripoli per Boemondo VI e VII) e francesi (écu d’oro di Luigi IX) tra1266/70 e 1287, e quindi dalla Messina aragonese (1282-1285, pierreale per Pietro e Co-stanza). Vista la somiglianza e le relazioni strette con queste aree, Genova potrebbe averneseguito l’esempio negli anni Novanta del Duecento43. In questo periodo a causa dei rincaridell’argento e della forte concorrenza del fiorino che cominciava ad imporsi pesantementesui mercati internazionali, Genova interviene di nuovo sul suo sistema monetario forse so-spendendo la coniazione di denari, riaggiustando il fino dell’unico grosso da 12 denari, cheadesso dovrebbe essere intorno a 960-965‰, e peso ed intrinseco della propria monetad’oro maggiore, che invece, in base alle ultime analisi condotte, riduce leggermente il nu-mero di carati.
Un’ipotesi simile è congruente con le osservazioni epigrafiche già del Promis,ma soprattutto con i conteggi sul genovino d’oro basati sulla documentazione del 1292 fat-ti da Lopez44 e con i dati riportati sulle pratiche di mercatura e le liste di monete tra 1290 e1314 circa. Da queste, infatti, il grosso risulterebbe avere ancora un contenuto in argentodi 11 once e mezzo o poco più (o. 11 e d. 14)45, mentre il genovino nuovo ricordato nel1302, nel 1305 e poco dopo ha un fino inferiore ai tipi detti vecchi46. Da notare infine chequeste due serie di monete mostrano nelle iscrizioni la N rovesciata che diventerà tipicadelle emissioni genovesi successive, ma che si ritrova in alcune coniazioni milanesi databi-li tra 1298 e 1310 e quindi al nome di Enrico VII. Visto che nel suo editto del gennaio 1312registrato in domo domini Barnabosii de Auria extra portam Ianue in contrata Sancti Thome l’Im-peratore nomina come zecchieri per la battitura della sua moneta al tipo milanese Phlippo
283MONICA BALDASSARRI – DANIELE RICCI
14 baldassari ricci:Layout 1 15.11.2013 7:49 Pagina 283
284 I GROSSI D’ARGENTO E LA MONETAZIONE DI GENOVA TRA DUE E TRECENTO
de Nigro civis Ianue e Georgii Alyon civis Astensis per fare la sua moneta in ogni luogo d’Ita-lia47, viene da chiedersi se queste serie genovesi possano giungere all’incirca fino a quel pe-riodo, per subire nuovi mutamenti dopo la morte precoce del grande Arrigo. (M.B.)
2.4. Per una revisione della cronologia dei grossi IQDP
Per meglio inquadrare il problema della discussa datazione dei grossi IANVAQVAM DEVS PROTEGAT è utile anzitutto capire i motivi di tale attribuzione. Gandolfisembra essere stato il primo ad assegnare ad un periodo molto ampio la serie IQDP, inse-rendovi però anche i grossi di Valerando di Lucemburgo e di Teodoro II di Monferrato, sul-la base di un raggruppamento che tiene conto della dicitura in legenda48. In seguito Desi-moni cita solo ragguagli sul prezzo dell’argento49, senza menzionare il grosso in questione,e Lopez affronta il problema della nascita della moneta grossa a Genova, proponendo unaseriazione cronologica dei grossi IANVA e CIVITAS IANVA soltanto50. Pesce si attiene al-la cronologia del CNI per la serie monetale IQDP51 anche se per i mezzi grossi e denari mi-nuti riprende i dubbi già espressi da Astengo ed altri (per i minuti)52.
Da quello che si evince, l’elemento che ha portato all’attribuzione delle emis-sioni IQDP sul finire del XIII secolo e prima dei dogi a vita è la presunta cronologia dei ti-pi CIVITAS IANVA e la vicinanza con legende delle serie del primo periodo dogale.
Alla luce delle nuove datazioni proposte per le emissioni di grossi precedenti53,e dell’analisi stilistica ed epigrafica delle monete attribuite a questo difficile periodo com-preso tra la scorcio del Duecento e la metà circa del secolo successivo54, il concetto di unaserie di monete IQDP, necessariamente coeve, sembra aver perso valore. Infatti già la co-niazione dei soldini o mezzi grossi IQDP è stata spostata alla fine del XIV secolo, così co-me i denari minuti IQDP sono di recente stati datati tra il 1344 ed il 139455.
Ragionando sulle evidenze al momento disponibili, appare plausibile collocarel’emissione dei grossi IQDP alternativamente in due finestre temporali. Il periodo appenaprima della «rivoluzione dogale» (tra 1320 e prima del 1339 circa), cosa che si conciliereb-be con le rare emissioni auree che portano i segni distintivi guelfi e ghibellini (tav. V, nn. 5-6), anche se è evidente una maggiore vicinanza stilistico-epigrafica con i genovini con le let-tere A e C in legenda al dritto56. Altrimenti nell’arco cronologico della prima dedizione al-la Signoria Viscontea, durante la quale a Genova si hanno due governatori: dal 1353 al1355 Guglielmo Pallavicino (per Giovanni Visconti, signore e arcivescovo di Milano) e dal1355 al 1356 Gaspare Visconti (per Matteo, Bernabò e Galeazzo Visconti).
Se si prende in considerazione l’ipotesi della prima finestra temporale pre-dogale,potrebbe essere plausibile che il grosso IQDP preceda il grosso PRIMVS, anche se il numeralemal si concilia con una prima emissione di una carica appena nata e con le implicazioni cheporta con sé. In effetti va tenuto conto delle strette affinità stilistiche ed epigrafiche del grossoIQDP con il raro DVX IANVENSIVM PRIMVS, e in particolare con la serie rappresentata
14 baldassari ricci:Layout 1 15.11.2013 7:49 Pagina 284
dall’esemplare conservato nella collezione civica di Palazzo Bianco di Genova (tav. V, n. 2). Diquesto tipo di grosso CNI e Desimoni menzionano un unico esemplare57, che potrebbe esse-re lo stesso presente nel medagliere del Comune di Genova. È oltremodo interessante perchérispetto alle emissioni con legenda abbreviata in PRIMV’ (tav. V, n. 3), probabilmente succes-sive, non ha lettera sotto l’imago civitatis; inoltre la disposizione del cerchio polilobato e la de-corazione floreale alle punte sono in pratica le medesime dei pezzi IQDP noti.
Tuttavia ciò non esclude affatto che la serie PRIMVS, seguita dalla variante PRIMV’,sia stata battuta durante il secondo dogato di Simon Boccanegra (1356-1363), immediatamentesuccessivo alla Signoria dei Visconti: vista l’estrema rarità del grosso con legenda DVX IAN-VENSIVM e del mezzo grosso DVX IANVE (a differenza dei denari dogali decisamente menorari), in sette anni di magistratura Boccanegra potrebbe aver ritirato dalla circolazione e rifuso laquasi totalità delle emissioni del suo primo ufficio dogale per poi emettere in occasione del nuo-vo incarico nel 1356 nominali con la legenda che sottolineasse il suo primato58. D’altronde è no-to un altro caso di apposizione a posteriori: Antoniotto Adorno fece coniare sia grossi che geno-vini con il numerale SEPTIM’ non certo durante le poche ore del 13 giugno 1378 in cui ricoprìla carica come settimo doge, ma più verosimilmente durante una delle tre successive nomine.
Un altro dato a supporto di una probabile emissione negli anni della Signoria Vi-scontea è che la legenda IANVA QVAM DEVS PROTEGAT è stata usata in frangenti analo-ghi, ovvero sotto il dominio di Carlo VI, Re di Francia, tra il XIV e XV secolo, quando sia igrossi che i mezzi grossi attribuiti a Valerando di Lucemburgo ed i grossi di Teodoro di Mon-ferrato hanno questa legenda, anche se abbreviata in modi diversi. Ma un ulteriore ed impor-tante indizio lo forniscono le lettere A e C poste ad inizio e fine legenda sul rovescio, proba-bilmente le iniziali dello zecchiere responsabile di quella emissione, poichè dalle ricerche di ar-chivio sulle fonti scritte59, sappiamo che proprio nel 1358 erano soprintendenti della zecca An-tonius de Corvaria e Quilicus de Andrea.
Come accennato in precedenza anche su una serie di genovini IQDP troviamo lelettere A-C ma al dritto60. L’associazione di queste emissioni auree ai grossi non è dovuta soloalla stessa abbreviazione della legenda, ma anche dal confronto dei punzoni delle lettere e del-l’imago civitatis.
In conclusione: nulla vieta di prendere in considerazione entrambe le finestretemporali qui proposte (1320-1339; 1353-1356) come effettivi momenti in cui la zecca ge-novese emise queste pezzature d’argento IQDP, per quanto le evidenze parrebbero indica-re una maggiore probabilità per il secondo periodo, ovvero durante la Signoria Viscontea.Vista la consuetudine nel Trecento di battere nominali diversi con legende differenti, ancheattinte dal repertorio già usato in precedenza (vedi il caso della petachina CIVITAS IANVEe dei minuti IQDP)61, non ci sarebbe nulla di cui stupirsi. Pensare invece ad altri archi tem-porali, molto anteriori o molto più tardi, non pare possibile in virtù dell’analisi sui punzo-ni delle legende e della forma della stessa imago civitatis, le cui peculiarità sono condivisecon altre monete genovesi databili al pieno Trecento. (D.R.)
285MONICA BALDASSARRI – DANIELE RICCI
14 baldassari ricci:Layout 1 15.11.2013 7:49 Pagina 285
286 I GROSSI D’ARGENTO E LA MONETAZIONE DI GENOVA TRA DUE E TRECENTO
3. Alcune considerazioni in conclusione
Se queste ipotesi parranno accettabili, o se, pur non sembrando persuasive, indurranno qual-cuno a riprendere in esame le date arbitrariamente suggerite dal Desimoni, questa postilla avrà attenutoil suo scopo62.
Concludeva così un contributo dedicato alla moneta grossa genovese Roberto Sa-batino Lopez, che a distanza di tanti anni in più sedi, delle quali questa è l’ultima, ha matura-to il suo fine. Ancora oggi «qualcuno» ha ripreso in esame la questione con spirito critico, cer-cando di applicarsi alla ricerca con verifiche rigorose delle fonti. Con tutti i limiti del caso, macon nuovi strumenti a disposizione, si è cercato di verificare le ipotesi enunciate per poi pro-porre un contributo che tenesse conto delle evidenze archeologiche, delle fonti scritte e dellostudio delle monete sia nell’aspetto metrico-ponderale che stilistico-epigrafico.
Il lavoro è stato svolto nella consapevolezza delle peculiarità della documentazio-ne scritta consultata e delle problematiche della fonte archeologica stessa, in particolare per lestratificazioni del periodo medievale, e delle difficoltà ed insidie che le analisi archeometrichepresentano, se non affrontate con le dovute cautele e consapevolezze delle caratteristiche del-la metodica adottata.
Tuttavia il quadro risultante (cfr. anche tabella di sintesi, tab. 1) ci pare convin-cente, accordandosi in misura maggiore con il contesto storico-economico del XIII e dei pri-mi decenni del XIV secolo rispetto a molte ricostruzioni passate.
La nascita della moneta grossa a Genova (1,75/80 g) si attesta dunque intorno aduna data prossima a quella documentata per altre città del centro-nord Italia, a cavallo dei pri-mi due decenni del Duecento nei quali una serie di fattori economico-strutturali portano allaconiazione di una valuta in buon argento utile al mercato della penisola nord-occidentale e perlo scambio con l’Europa centrale (come si vede dall’aggancio al sistema dei denari locali e daipochi ritrovamenti noti), forse prima che con il Mediterraneo.
Intorno al 1230 ci fu un primo aggiustamento di peso (1,45 g), causato dalla sva-lutazione della libbra di denari, dei quali si seguirono anche i cambi tipologici (forma imago ci-vitatis, interpunzioni), mantenendo comunque alto il fino.
Un ulteriore, rilevante cambiamento si registrò negli anni 1252-1254 a seguito del-l’introduzione della moneta aurea e dei mutamenti avvenuti nel mercato mediterraneo dei me-talli preziosi. In questo caso, oltre al rinnovamento estrinseco dei conii (interpunzioni), sem-bra notarsi una leggera diminuzione del fino e del peso mediano, pur conservando inalteratoil teorico a 1,45 g. Sono questi, e quelli prodotti nel periodo immediatamente successivo, igrossi di Genova maggiormente diffusi nei ripostigli mediterranei, cosa che confermerebbe dauna parte le ipotesi formulate da Travaini e Spufford sul periodo di attestazione (1240-1270 cir-ca) e sulle motivazioni che possono aver indotto alla produzione di miliaresi di imitazione (ca-lo del fino in lega), dall’altra la possibile sovrapposizione lessicale del termine per indicare igrossi coevi in alcune fonti, come invece riaffermato di recente da Saccocci63.
14 baldassari ricci:Layout 1 15.11.2013 7:49 Pagina 286
L’ultimo cambiamento dei grossi IANVA si ha tra terzo e ultimo quarto del Due-cento (1260-1270/80 circa) con l’emissione di due tipologie, delle quali la seconda è transito-ria ed introduttiva ai grossi del tipo CIVITAS IANVA. Questi ultimi sembrano legati a una ri-forma del sistema monetario genovese che ebbe luogo nell’ultimo ventennio del XIII secolofino al primo decennio del successivo, tra affermazioni di tipo proto-signorile interne e alter-ne vicende nella politica estera (la vittoria su Pisa nel 1284, la perdita di Tripoli nel 1289, ilcomplesso rapporto con Enrico VII), ma soprattutto di fronte ai movimenti nella ratio tra oroe argento, che nel 1290 vide il primo rincaro del metallo bianco sull’altro.
Per quanto riguarda i grossi IQDP la questione rimane ancora aperta a ulteriori ri-cerche negli archivi e a future considerazioni, magari sulla scorta di nuovi ritrovamenti, ma inquesta sede si è cercato di aggiungere alcuni tasselli utili ad inquadrare più propriamente laquestione. Ben si comprende, ad ogni modo, come anche la monetazione di Genova nel Tre-cento, durante l’affermazione del Secondo Popolo, il passaggio al governo dogale e la speri-mentazione di prime signorie straniere, abbia necessità di revisione. Sperando per questa dinon dover attendere altri sessanta anni, come è invece toccato in sorte al bell’affresco del Due-cento dipinto da Lopez. (M.B., D.R.)
287MONICA BALDASSARRI – DANIELE RICCI
Tab. 1. Sintesi delle proposte crono-tipologiche per i grossi in argento di Genova.
14 baldassari ricci:Layout 1 22.11.2013 16:36 Pagina 287
288 I GROSSI D’ARGENTO E LA MONETAZIONE DI GENOVA TRA DUE E TRECENTO
1 2
3 4
5 6
7 8
9
Tav. I. nn. 1-2: denari di Genova, fine XII-inizi XIII secolo, coll. privata; nn. 3-4: grossi «da 6» di Genova, tipo I.III.1,1210/15-1230, coll. privata e di Banca Carige; nn. 5-6, grossi «da 6» di peso leggero, tipo I.III.2var., 1230-1252, coll. private; nn. 7-8, grossi «nuovi», tipo I.III.3, 1252-1260/70; n. 9, grosso «da 6» tardo, tipo I.III.4, 1270-1280,coll. di Banca Carige.
14 baldassari ricci:Layout 1 15.11.2013 7:49 Pagina 288
289MONICA BALDASSARRI – DANIELE RICCI
Tav. II. Tavola riassuntiva dei segni in legenda e delle lettere caratteristiche nei diversi tipi di grossi genovesi.
Grosso IANVA da 6
(1,8 g):
I.III.1 (1210/15-1230)
Grosso IANVA da 6
(1,45 g):
I.III.2 (1230-1252)
Grosso IANVA da 6
(1,45 g):
I.III.3 (1252-1260/70)
Grosso IANVA da 6
(1,45 g):
I.III.4 (1270-1280/85)
Grosso IANVA: I.III.5. e
CIVITAS I. da 12 e da 6:
CI.I.1-2 (1285-1310/15)
14 baldassari ricci:Layout 1 15.11.2013 7:49 Pagina 289
290 I GROSSI D’ARGENTO E LA MONETAZIONE DI GENOVA TRA DUE E TRECENTO
1 2
3 4
5 6
7 8
9
Tav. III. n. 1, grosso «da 6» tardo, tipo I.III.4 var., 1270 -1280, coll. privata; nn. 2, 4, grossi «da 12», tipo CI.I.1, post1280/1285-1290, coll. privata; n. 3, grosso «da 6» tardo, tipo I.III.5 (inedito), 1280-1285, coll. privata; nn. 5-6, grosso «da 6» e «da 12», tipo CI.I.1 var.,1285-1290 circa, coll. privata e di Banca Carige; nn. 7-8, grossi «da 12», tipo CI.I.2-3, 1290 -1311/15, coll. Ruggero e di Banca Carige; n. 9, genovino d’oro, tipo CI.2.2, post 1290-1311/15, coll. di Banca Carige.
14 baldassari ricci:Layout 1 15.11.2013 7:49 Pagina 290
291MONICA BALDASSARRI – DANIELE RICCI
Tav. IV. Carta con la distribuzione dei diversi ritrovamenti di monete grosse in argento o di nominali in oro battuti da Genova traXIII e metà XIV secolo circa.
Legenda
● ritrovamento singolo o sporadico di monete d’argento
✤ ritrovamento singolo o sporadico di monete d’oro
■ ripostiglio di monete d’argento
★ ripostiglio di monete d’oro
500 km
300 mi
© Daniel Dalet / d-maps.com
14 baldassari ricci:Layout 1 15.11.2013 7:49 Pagina 291
292 I GROSSI D’ARGENTO E LA MONETAZIONE DI GENOVA TRA DUE E TRECENTO
1 2
3 4
5 6
7 (scala 1:1,5)
8 9 10
Tav. V. n. 1, grosso IQDP, tipo IQDP.I.1, 1320-1339 e/o1353-1356, coll. privata; n. 2, grosso DVX IANVENSIVM PRIMVS, coll. Comune di Genova; n. 3, grosso DVX IANVENSIVM PRIMV', coll. privata; n. 4, genovino d’oro IQDP, coll. privata; nn. 5-6, genovini d’oro «guelfo» e «ghibellino»,coll. di Banca Carige; n. 7, quartaro, tipo Q.IV. 1, secondo-terzo quartoXIV secolo, coll. privata; nn. 8-10, particolari di: legenda rovescio del grosso al n. 1; legenda rovescio del grosso al n. 2; legenda diritto del genovino al n. 4.
14 baldassari ricci:Layout 1 15.11.2013 7:49 Pagina 292
293MONICA BALDASSARRI – DANIELE RICCI
APPENDICE
I ritrovamenti di grossi in argento, quartarole e genovini aurei (XIII-prima metà ca. XIV secolo)
RITROVAMENTI SINGOLI IN SCAVO E SPORADICI
1) Finalborgo, (Savona), scavi archeologici urbani, Piazza del Tribunale, XIII secoloIn occasione degli scavi archeologici per recenti lavori nel centro abitato sono state rinvenute diverse monete ge-novesi. Interessanti sono i reperti di Piazza del Tribunale dai contesti di XIII secolo.US 4107: grosso di Genova «da 6 denari», con legenda CNRAD1REX• (CNI III, nn. 101-103), 1,57 g, in associazionecon una mezzaglia di Genova tipo CNRAD1REX (fine XII secolo), un denaro di Genova tipo CVNRAD1REX• (1210-1240 circa), ed un denaro di Asti (metà XIII secolo circa).Inedito, con prime notizie in MURIALDO 2003, p. 28 e approfondimenti con comunicazione personale da parte di Gio-vanni Murialdo, che qui si ringrazia.
2) Geridu, Sorso (Sassari), scavo archeologico, villaggio, fine XIII-XIV secoloMonete rinvenute come sporadici nella stratificazione relativa alle frequentazioni e al primo abbandono di un villag-gio rurale poco a nord di Sassari, tra il tardo Duecento ed il pieno Trecento. Tra le monete dello scavo si nota un ad-densamento cronologico dei reperti emessi tra la metà del XIII secolo e la metà circa del successivo; le monete diPisa e di Genova presenti sembrano risalire quasi tutte al periodo anteriore al 1330, quando gli Aragonesi vietaro-no la circolazione di moneta straniera sull’isola.US 3543, strato di uso dell’edificio 4, primo quarto del XIV secolo circa: 1 grosso «da 4 denari» di Genova,CVNRAD1•REX•, con punto sotto imago e R con gambetta dritta. Altri materiali in associazione: Maiolica Arcaica pi-sana e savonese di prima metà del Trecento; strato sigillato da crolli con monete aragonesi di Bonaria (1324-1327).US 3527, strato di abbandono, databile al pieno Trecento: 1 grosso «da 6 denari» di Genova, •CIVITAS❣IANVA• /•CVNRADVSREX• e nel secondo quarto �. Inedito, con prime notizie in BALDASSARRI 1996; catalogazione analitica in corso di stampa.
3) Scarlino (Grosseto), scavo archeologico, castello, XII-XV secolo Scavo delle stratificazioni relative alle frequentazioni del castello di Scarlino; dopo una distruzione avvenuta nel Due-cento, nel secolo successivo il castello fu rifortificato dal Comune di Pisa.Contesti datati genericamente al XII-XIII secolo: 1 denaro di Lucca, H/LVCA intorno a punto, seconda metà XII se-colo; 1 denaro di Pisa, F/PISA intorno a punto, seconda metà XII secolo; 1 grosso «da 4 denari» di Genova,CVNRAD1•REX:, datato al 1200-1250 ca.; 1 denaro del ducato di Atene, 1280-1308.ROVELLI 1996.
4) S. Cornelia, Formello (Roma), scavo archeologico domusculta e monastero benedettino, VIII-XIII secoloTra le monete recuperate dal sito, delle quali, però, è stato perduto il riferimento stratigrafico:1 grosso di Genova + •IA•NV•A•, 1,32 g, datato tra la fine del XII e la prima metà XIII secolo.TRAVAINI – CHRISTIE 1994, pp. 322-324, n. 3.
5) Perti (Savona), ritrovamento occasionaleRitrovamento occasionale da parte del parroco, durante lo svuotamento del deposito-ossario della cripta di S. Eu-sebio di Perti, di una quartarola d’oro: 0,86 g, CNI III, n. 111.MURIALDO 2003, p. 28.
* A questo elenco si aggiungono notizie di ritrovamenti sporadici e casuali di grossi in argento nei tipi «da 4» con punto sot-to l’imago e di quartarole tipo CNI III, pp. 18-19, nn. 1-12; p. 24, n. 68 in Corsica; la moneta pubblicata in ISTRIA 2005,fig. XVIII, dalla fotografia non parrebbe invece un grosso, ma un denaro, forse di tipo imitativo delle prime emissioni.
RIPOSTIGLI
A) Fontanile, Acqui Terme (Alessandria), chiesa parrocchiale, ritrovamento casuale, ante 1339?Durante lavori effettuati nella chiesa parrocchiale furono rinvenute alcune monete d’oro di Genova, non meglio spe-cificate quanto a cronologia, ma presumibilmente del periodo pre-dogale.Unità Cattolica, Firenze, 8 gennaio 1901.
B) Lurate Abbate (Como), casa colonica, ritrovamento casuale, dep. 1320 circaRitrovamento durante i lavori di restauro di una casa colonica di 1237 monete d’oro e d’argento di zecche italianee grossi tornesi per Filippo IV e Carlo II Angiò; disperso. Composizione: 50 grossi veneziani, dal doge Pietro Ziani a Giovanni Dandolo, con 317 pezzi per Pietro Gradenigo;6 zecchini di Pietro Dandolo ed uno per Marin Zorzi; 188 monete di Merano: 25 erano grossi aquilini attribuiti al con-te Alberto, e 163 grossi tirolini di Mainardo II; 7 grossi repubblicani d’Ivrea, e 2 di Acqui del vescovo Oddone Bel-lingeri; 3 grossi del secolo XIII della zecca di Trento; 181 grossi tornesi ed un mezzo tornese di Filippo IV il Bello diFrancia, e 18 grossi tornesi di Carlo II d’Angiò, come conte di Provenza; 84 monete di Milano: 4 denari di Lodovico
14 baldassari ricci:Layout 1 15.11.2013 7:49 Pagina 293
I il Pio; 49 soldi della prima Repubblica; 25 grossi da soldi due, e 6 esemplari del soldo dell’imperatore Enrico VII;un denaro di Lodovico V il Bavaro.Altre monete di zecche italiane: Tortona, Pavia, Brescia, rispettivamente da 2, 3 e 1 soldi della Repubblica; Cremona 2grossi con Sant’Imerio; Piacenza da 26 grossi repubblicani; Parma grossetto battuto fra il 1269 e il 1299; Reggio da unbolognino del vescovo Nicolò Maltraversi; Modena da 4 grossi col nome di Federico; Bologna da 26 bolognini repubbli-cani; imitazioni del grosso tirolino, del matapan, del grosso tornese. Tra gli esemplari di zecche toscane: 13 popolini e14 fiorini di Firenze, fine XIII-inizio XIV secolo; 15 grossi minori di Arezzo, seconda metà XIII secolo; 5 grossi minori di Pi-sa, fine XIII-inizio XIV secolo; 4 grossi di Siena, prima metà del XIII secolo. Seguono 35 monete per Enrico VI di BrindisiHENRICVS REX SEMPER AVGVSTVS; 8 tari di Pietro I di Aragona e Costanza, 3 di Giacomo, e 13 di Federico di Messina.Per la zecca di Genova: 8 genovini d’oro «di epoca anteriore alla istituzione del Dogato».AMBROSOLI 1888.
C) Garlasco (Pavia), ritrovamento casuale, dep. 1420 circaRipostiglio ritrovato casualmente a Garlasco nel 1910; al momento del recupero constava di 131 esemplari, deiquali se ne conservano 102. Composizione: monete grosse in argento di Milano, Tortona, Parma Arezzo, Firenze e Pisa, oltre a grossi di Venezia,Verona e Merano, pierreali di Messina, tornesi e frazioni di tornesi francesi, tutti databili tra la metà del XIII e la me-tà circa del XIV secolo. Vi sono inoltre 2 denari di Asti, 8 di Milano, 1 di Mantova, 5 di Parma ed 1 di Ravenna; 2mezzi denari di Ivrea, 13 mezzanini di Cremona, 2 mezzani di Piacenza e 11 di Pavia, inquadrabili tra fine XII e XIVsecolo. La moneta più recente è un mezzo grosso di Cremona per Cabrino Fondulo, datato 1406-1420, mentre lapiù antica è un miliaresion per Niceforo II Foca, che costituisce l’unico pezzo in argento anteriore al Duecento.Per la zecca di Genova: 13 denari databili tra primi decenni del XIII ed inizi XIV secolo; 2 genovini d’oro +•I•A•N•V•A• P•.CHIARAVALLE 1988.
D) Foresta di Finges, Valois (Sierre, Svizzera), area rurale, ritrovamento casuale, dep. 1420-1430 circaRipostiglio ritrovato casualmente durante gli scavi per la realizzazione di un canale non lontano da Sierre nel 1908.A queste vanno aggiunte alcune altre monete analoghe probabilmente provenienti dallo stesso ripostiglio e acqui-state dal rivenditore Clerici a Milano.Composizione: 3 mezzi grossi per Amedeo di Savoia (1391-1415); 1 sesino per Pietro conte di Ginevra (1374-1391); 2denari per Amedeo VI o VII di Saint-Maurice (Valais, 1343-1391); della zecca di Milano: 1 soldo per Enrico VII, 16 soldiLudovico V il Bavaro; soldi e grossi per i Visconti dal 1329 al 1402; 48 pegioni per Galezzo II Visconti della zecca di Pa-via (1359-1378); della zecca di Venezia: grossi da Ranieri Zeno (1253-1268) a Michele Zeno (1400-1413); 2 grossi diModena del XIII secolo; 2 grossi e 2 bolognini d’oro per Bologna (1230-1300); 4 fiorini d’oro di Firenze dal 1336 al XIVsecolo; monete feudali e reali francesi dal 1226-1270 al 1422; monete di varie zecche tedesche dal 1353 al 1382; 1goldengulden attribuito a Alberto II d’Austria (1339-1358); monete di zecche dei paesi bassi emesse dal 1292 al 1393.Per la zecca di Genova: 2 genovini IQDP (DESIMONI, nn. 168 e 180), 13 genovini Simon Boccanegra doge I (1339-1344), 3 genovini Simon Boccanegra doge IV (1356-1363), 3 genovini Gabriele Adorno doge V, 2 genovini NicolaGuarco doge VIII, 1 genovino per Leonardo Montaldo doge X ed uno per Carlo VI re di Francia (1396-1409). DEMOLE 1908.
————————-
a) S. Martino Siccomario (Pavia), vicino al Ticino, ritrovamento casuale, dep. prima metà/metà XIII secoloRipostiglio rinvenuto presso San Martino di Siccomario di Pavia, dentro un vaso di terracotta grezza, sepolto alla pro-fondità circa di 1 metro sulla costa nei pressi del Ticino, nel 1881.Composizione: 10.000 monete tra cui circa 2.000 tra denari, mezzi denari e grossi di Pavia, datati tra 1220 e 1250;600-700 pezzi delle zecche di Brescia e di Mantova, della fine del XII-metà circa XIII secolo; all’incirca 500 denariper Enrico e Federico Hohenstaufen della zecca di Milano; 1 denaro di Parma al nome di Ottone IV datato al 1209;alcuni denari di Cremona e di Asti datati tra la seconda metà del XII e gli inizi del XIII secolo; denari tornesi coniatinel primo quarto del Duecento.Per la zecca di Genova: alcune decine di denari e mezzi denari, apparentemente del tipo CVNRAD1REX, con pesi cor-rispondenti ad esemplari della seconda parte del XII-inizi XIII secolo; 1 grosso di I tipo + •IA•NV•A• «da 6 denari».BRAMBILLA 1887; STAHL 2001, p. 327.
b) Oos, Baden Baden (Germania), ritrovamento casuale, dep. 1238-1248 circaRitrovamento casuale dentro una pentola sotterrata nel 1836. Tesoro composto da oltre 5000 pezzi monetali oc-cultati insieme a «Klumpen geschmolzenen Silbers»; in gran parte disperso ad eccezione di alcuni esemplari pre-senti al gabinetto numismatico di Karlsruhe.Composizione: una moneta per Engelberto I (1216-1225) e altre 560 per Enrico I (1225-1238) di Köln; alcune de-cine monete di Metz, datate tra il 1170 e il 1238; almeno 26 pezzi per Dietrich II, Trier (1212-1242); un pezzo perFerri II di Lothringen (1205-1213) di Nancy; 7 o 8 sterline per Enrico II e/o III del tipo «short cross», soprattutto neitipi datati tra 1220 e 1247; denari delle zecche di Epinal, Saarburg, Neufchäteau e Toul o area limitrofa della primametà del XIII secolo. Monete italiane: 7 grossi veneziani (4+3) attributi rispettivamente a Pietro Ziani (1205-1229)e a Jacopo Tiepolo (1229-1249).
294 I GROSSI D’ARGENTO E LA MONETAZIONE DI GENOVA TRA DUE E TRECENTO
14 baldassari ricci:Layout 1 15.11.2013 7:49 Pagina 294
295MONICA BALDASSARRI – DANIELE RICCI
Per la zecca di Genova: pochi (3?) grossi del tipo + •IA•NV•A• / CVNRAD1REX• «da 6», tav. III, n. 75 (cfr. CNI III, n.103).WIELANDT 1950/51, pp. 98 -118, tavv. VII-VIII; STAHL 2001, p. 327.
c) Chiaravalle, Cisano (Bergamo), area agricola, ritrovamento casuale, dep. 1253-1268 circa (più in gen. terzoquarto XIII secolo)Ripostiglio rinvenuto casualmente durante lavori agricoli nella frazione di Chiaravalle di Cisano, dentro un «ciottolo d’are-naria, scavato a scodella e ricoperto d’argilla», nel 1992. Consegnato al medagliere milanese del castello sforzesco.Composizione: 260 pezzi in argento e mistura di zecche italiane, emessi tra XII e XIII secolo. Nel dettaglio: Venezia,con 4 grossi di Jacopo Tiepolo (1229-1249), 3 grossi di Marino Morosini (1249-1253) e 22 grossi assai poco cir-colati di Ranieri Zeno (1253-1268); Bergamo, 48 denari scodellati e 44 denari piani; Milano, 3 denari ed una mez-zaglia per Enrico III, IV, e V, 16 denari per Federico I (1152-1190), 7 denari per Federico II (1220-1250), 62 grossi IaRepubblica (1250-1310); Brescia, 10 grossi; Piacenza, 6 denari e 3 grossi, ipotizzati anteriori al concordato del1253; Pavia, 1 grosso da 6 denari, e 7 denari per Federico II (1220-post 1250); Cremona, 5 mezzaglie post con-cordato 1254; Tortona, 4 grossi post 1254; Como, 1 denaro per Federico I, fine XII secolo; Ivrea, 1 denaro imperia-le, metà XIII secolo; Coira, 1 denaro, fine XII secolo? Per la zecca di Genova: 11 grossi «da 4» del tipo + •I•A•NV•A• / CVNRAD1•REX• (CNI III, p. 12, n. 81).VICENZI 1922.
d) Tripoli (Libano), ritrovamento casuale, dep. 1287-1289 circaRitrovamento casuale, probabilmente nella zona di Tripoli di Siria, anteriormente al 1996.Composizione: 120 grossi genovesi dal peso «leggero», di cui almeno 21 del tipo + I•A•NV•A / CVNRAD1•REX•(uno con tre punti in verticale finali, ed uno con cuneo tra crocetta ed I) del peso medio di 1,32 g; almeno 15 del ti-po + I•A•NV•A / CVNRAD1•REX•, con globetto sotto la porta turrita del dritto, talvolta con piccola unghia tra cer-chio e croce, del peso medio di 1,36 g; almeno 25 del tipo + IA•NV•A /CVNRAD1REX⁞ con piccola unghia attacca-ta al cerchio dopo la croce o tra E ed X, e talvolta con taglietto nella E, dal peso medio di 1,32 g; insieme con 6 de-nari di Genova, 1 solo dei quali CVNRAD1REX•, e altri + I•A•NV•A / CVNRAD1•REX•, con varianti.BALDASSARRI 2009.
e) Anela (Sassari), ritrovamento casuale, dep. 1302-1330 circaRinvenimento casuale, nel febbraio del 1492 (fonte documentaria).Composizione: 911 tornesi o grossetti d’argento di Iglesias, 131 tarì d’argento di Messina per la Corona di Arago-na, 1176 ? tra cui sicuramente grossi di Pisa, carlini, grossi e denari di Genova.PERANTONI SATTA 1957, pp. 115-117.
f) Latte Dolce (Sassari), «Villa Bosone», ritrovamento casuale, dep. ante 1330 Ritrovamento avvenuta nella «Villa Bosone» nel 1864.Composizione: 3000 monete di Genova del XII e XIII secolo, presumibilmente grossi, denari minuti e medaglie diGenova.DESSÌ 1898, pp. 21 e 25; PERANTONI SATTA 1957, p. 125.
g) Oschiri (Sassari), ritrovamento casuale, dep. 1316 circaModalità del rinvenimento non note, acquistato nel 1926.Composizione: 840 pezzi di cui 9 grossoni di Lucca (1300 ca.-1316); 226 grossi minori di Pisa (1270-1316); 153aquilini minuti di Pisa (post 1256-1316); 39 carlini di Napoli (1279-1302); 1 pierrale di Messina (1291-1296); 111terzi di grosso tornese di Francia (1295, 1308-1311).Per la zecca di Genova: 4 grossi di Genova cui 3 leggeri del tipo + I•A•NV•A / CVNRAD1•REX•, con globetto sottola porta turrita del dritto ed uno «da 6», tipo tardo (I.III.4); 297 denari minuti di Genova (3 di XII secolo,CVNRAD1REX; 158 di prima metà XIII secolo, CNRAD1REX• e CVNRAD1•REX•, restanti metà XIII-primo decennioXIV secolo).TRAVAINI 1983, pp. 27-70.
h) Noceto-Gragnana (Carrara), vicino a viabilità di crinale, ritrovamento casuale, dep. 1424-1450 circaLe monete furono rinvenute durante lavori per la realizzazione dell’acquedotto di Gragnana-Noceto (Carrara) nel1913. Il ripostiglio è costituito da 88 pezzi tutti in argento. Composizione: 39 grossi da 3 soldi di Lucca, post 1387; un grosso aquilino di Enrico II Conte di Gorizia (1319-1323)per la zecca di Treviso; un grosso aquilino emesso da Bailardino Nogarola Podestà di Cangrande Della Scala (1320-1329); 3 grossi del Comune di Modena (1242-1293); 2 bolognini di Mantova del Duca Francesco I Gonzaga (1382-1407); 4 marchesini grossi di Ferrara per Nicolò II (1361-1388) e Nicolò III (1393-1441); 5 grossi da 5 soldi e 6 de-nari di Firenze (1405). Per quanto riguarda la zecca di Bologna sono presenti: 8 bolognini del primo periodo dellaRepubblica (1230-1337), un altro delle emissioni viscontee (1402-1403), 7 del periodo di Autonomia dell’ultimoquarto del Trecento e 6 delle emissioni Anonime Pontificie (fine XIV-inizio XV secolo).Per la zecca di Genova: un grosso IQDP, insieme con una petachina (seconda metà XIV secolo), alcuni grossi di Si-mon Boccanegra Doge I (1339-1344?) e Doge IV (1356-1363), Nicola Guarco Doge VIII (1378-1383) e due soldinidi Tommaso di Campofregoso Doge XIX (1414-1421).BALDASSARRI – CATALLI – CAVICCHI 2010.
14 baldassari ricci:Layout 1 15.11.2013 7:49 Pagina 295
296 I GROSSI D’ARGENTO E LA MONETAZIONE DI GENOVA TRA DUE E TRECENTO
BIBLIOGRAFIA
AMBROSOLI 1888 = S. AMBROSOLI, Il ripostiglio di Lurate Ab-bate, «RItNum», 1888, I, pp. 15-24.
ASTENGO 1957-58 = C. ASTENGO, Genova nella Numismatica,«Italia Numismatica» 11-12, 1957-58, pp. 11-12.
ASTENGO 1961 = ID., La coniazione dell’oro a Genova ed unapubblicazione del Prof. R.S. Lopez della Yale University, «RIt-Num» IX, 1961, pp. 13-57.
BALDASSARRI 1996 = M. BALDASSARRI, I reperti numismatici, inIl villaggio medievale di Geridu (Sorso, SS), M. Milanese(cur.), Firenze 1996, pp. 529-530.
BALDASSARRI 2009 = EAD., I denari della zecca di Genova e iloro frazionari tra il XII e il XIV secolo: alcune osservazioni sudatazioni, seriazioni ed ambiti di circolazione, «NAC» XXVIII,2009, pp. 331-376.
BALDASSARRI 2010 = EAD., Zecca e monete del Comune di Pi-sa, dalle origini alla Seconda Repubblica. XII secolo – 1406,I, Pisa 2010.
BALDASSARRI 2011 = EAD., Genova (Liguria), in Le zecche ita-liane fino all’Unità, L. Travaini (cur.), Roma 2011, pp. 722-741.
BALDASSARRI c.d.s. = EAD., “Identità” urbana, sigilli e monetenel Mediterraneo occidentale medievale: alcuni casi a con-fronto, in Polis, urbs, civitas: moneta e identità, Atti delconvegno di studio del Lexicon Iconographicum Numisma-ticae, Milano 25 ottobre 2012, L. Travaini – G. Arrigoni(curr.), Roma, c.d.s.
BALDASSARRI – CATALLI – CAVICCHI 2010 = M. BALDASSARRI – F.CATALLI – A. CAVICCHI, Ripostiglio di Noceto-Gragnana (Carra-ra 1913). XIII-XV secolo, Gubbio 2010.
BIANCO 1938 = P. BIANCO, Diversa attribuzione cronologicadel minuto IANVA QDP, «Numismatica e scienze affini –Santamaria», anno IV/2, 1938, pp. 35-36.
BRAMBILLA 1887 = C. BRAMBILLA, Due ripostigli di monete, bat-tute dal cadere del secolo XII ai primi del XIV, «Bollettino dinumismatica e sfragistica» III, 1887, pp. 93-103.
CASARETTO 1928 = P.F. CASARETTO, La moneta genovese inconfronto con le altre valute mediterranee nei secoli XII eXIII, «Atti della Società Ligure di Storia Patria» LV, 1924, pp.1-224.
CHIARAVALLE 1988 = M. CHIARAVALLE, Garlasco (PV), 1910, inRipostigli monetali in Italia, schede anagrafiche, CivicheRaccolte Numismatiche di Milano, Milano 1988.
CNI III = Corpus Nummorum Italicorum, III, Liguria, Roma1912.
DAY 2005 = W.R. DAY JR., The Petty Coinage of Genoa Underthe Early Doges, 1339-1396, in XIII Congreso internacionalde numismática. Actas-Proceedings-Actes, Madrid 15-19September 2003, C. Alfaro – C. Marcos – P. Otero (curr.),Madrid 2005, pp. 1295-1304.
DEMOLE 1908 = E. DEMOLE, Le trésor de la forêt de Finges(Valois), «SchwNumRu» XV, 1908, pp. 212-219.
DESIMONI 1888 = C. DESIMONI, Le prime monete d’argento del-la zecca di Genova ed il loro valore (1139-1493), «Atti dellaSocietà Ligure di Storia Patria» XIX, 1888, pp. 179-223.
DESIMONI 1890 = C. DESIMONI, Introduzione alle tavole de-scrittive della zecca di Genova, Tavole descrittive della zec-ca di Genova, e Sigle impresse nelle monete e nomi di so-prastanti della zecca di Genova, «Atti della Società Ligure diStoria Patria» XXII, 1890, pp. VII-LXXII, 2-265, 268-292.
DESSÌ 1907 = V. DESSÌ, Ripostiglio di monete medioevali rin-venuto a Pattada e valore delle monete effettive e di corsoin Sardegna nel Medioevo fino ai primi anni della domina-zione aragonese, «Archivio Storico Sardo» III, 1907, pp. 3-54; ora anche in ID., Gli scritti di numismatica, Sassari1970, pp. 166-224.
FALCONI – PEVERI 1984-88 = E. FALCONI – R. PEVERI (curr.), Il Re-gistrum Magnum del Comune di Piacenza, Milano 1984-88.
FELLONI 1999 = G. FELLONI, Genova organizza la sua zecca ele sue monete cominciano a correre per il mondo, «La Ca-sana» XL, 1998, pp. 2-9; ora anche in ID., Scritti di storiaeconomica, I, «Atti Società Ligure Storia Patria» n.s.XXXVIII, 1999, pp. 691-698.
FELLONI 2010 = ID., Monete, economia e finanza: il caso ge-novese, in Il patrimonio artistico di Banca Carige. Monete,pesi e bilance monetali, L. Travaini (cur.), Genova 2010, pp.26-33.
FERRETTO 1906, Magistri Salmonis = A. FERRETTO, Liber Magi-stri Salmonis, sacri palatii notari (1222-1226), «Atti dellaSocietà Ligure di Storia Patria» XXXVI, 1906.
FERRO 2008 = D. FERRO, Nuovi spunti di numismatica geno-vese: le monete di Giovanni da Murta e di Giano II Fregoso,«CercNum» XIV, 2008, pp. 317-335.
GANDOLFI 1841-42 = C. GANDOLFI, Della moneta antica di Ge-nova libri quattro, I-II, Genova 1841-42.
GRIERSON 1971-72 = PH. GRIERSON, The Origins of Grossoand of the Gold Coinage in Italy, «Numismatický sborník»XII, 1971-72, pp. 33-44.
KRUEGER – REYNOLDS 1952, Lanfranco = H.C. KRUEGER – R.L.REYNOLDS (curr.), Lanfranco (1202-1226), in Notai Liguri delsecolo XII e del XIII, VI 2, Genova 1952.
ISTRIA 2005 = D. ISTRIA, Pouvoirs et fortifications dans lenord de la Corse – XIe-XIVe siècle, Ajaccio 2005.
LOPEZ 1955 = R.S. LOPEZ, Settecento anni fa: il ritorno al-l’oro nell’Occidente Duecentesco, «Rivista Storica Italiana»LXV, 1955, pp. 5-78.
LOPEZ 1956 = ID., La prima crisi della banca di Genova(1250-1259), Milano 1956.
LOPEZ 1967 = ID., Prima del ritorno all’oro nell’OccidenteDuecentesco: i primi denari “grossi” d’argento, «Rivista Sto-rica Italiana» LXXIX, 1967, pp. 174 -181.
14 baldassari ricci:Layout 1 15.11.2013 7:49 Pagina 296
LUNARDI 1975 = G. LUNARDI, Le monete della Repubblica diGenova, Genova 1975.
MATZKE 2000 = M. MATZKE, Beginn und Frühzeit der Grosso-Prägung im Königreich Italien (Ende 12.-Mitte 13 Jh.), inProceedings of the XIIth International Numismatic Congress,II, Berlin 8-12 September 1997, B. Kluge – B. Weisser(curr.), Berlin 2000, pp. 1045-1053.
MADDEN 2006 = T.F. MADDEN, The New Concise History of theCrusades, London 2006.
MURIALDO 2003 = G. MURIALDO, Circolazione monetaria me-dievale nel Finale (Savona), in Atti del III Congresso Nazio-nale di Archeologia Medievale, Salerno 2-5 ottobre 2003,R. Fiorillo – P. Peduto (curr.), Firenze 2003, pp. 27-31.
PERANTONI SATTA 1957 = G. PERANTONI SATTA, Rinvenimenti inSardegna di monete medievali e moderne, «Annali dell’Isti-tuto Italiano di Numismatica» IV, 1957, pp. 113-163.
PESCE 1967 = G. PESCE, Le varianti al grosso di primo tipoper la zecca di Genova (dal 1172 a prima del 1252), «RIt-Num» LXIX, 1967, pp. 131-138; ora anche in ID., Scritti diargomento numismatico, 1941-1991, Genova 2005, pp.65-69.
PESCE 1978 = ID., Come classificare il grosso multiplo “IAN-VA” della zecca di Genova, «Rassegna Numismatica» 1/I,1978, pp. 13-16; ora anche in ID., Scritti di argomento nu-mismatico, 1941-1991, Genova 2005, pp. 236-241.
PESCE – FELLONI 1975 = G. PESCE – G. FELLONI, Le monete ge-novesi, Genova 1975.
PIGOZZO 2013 = Il contributo della documentazione trenti-na al dibattito sulla nascita della moneta grossa in Italia,«Studi Tridentini di Scienze Storiche Storia», n. 92/1,2013, pp. 13-30.
PISTARINO 1961 = G. PISTARINO, Le Pievi della Diocesi di Luni,La Spezia-Bordighera 1961.
PUNCUCH 1996, Libri Iurium = D. PUNCUCH (cur.), I “Libri Iu-rium” della Repubblica di Genova, I 2, Genova 1996.
ROVELLI 1996 = A. ROVELLI, Le monete del castello di Scarli-no. Materiali per lo studio della circolazione monetaria nel-la Toscana meridionale, «Annali dell’Istituto Italiano di Nu-mismatica» XLIII, 1996, pp. 225-245.
RUNCIMAN 1993 = S. RUNCIMAN, Storia delle Crociate, Torino1993.
SACCOCCI 1994 = A. SACCOCCI, Tra Bisanzio, Venezia e Frie-sach: alcune ipotesi sull’origine della moneta grossa in Ita-lia, «NAC» XXIII, 1994, pp. 313 -341.
SACCOCCI 2010 = ID., L’introduzione dei grossi agli inizi del XIIIsecolo e la massiccia esportazione di argento dall’EuropaOrientale ai territori islamici: una semplice coincidenza?, inThe Second Simone Assemani Symposium on Islamic Coins,B. Callagher – A. d’Ottone (curr.), Trieste 2010, pp. 127-164.
SPUFFORD 1998 = P. SPUFFORD, Money and Its Use in MedievalEurope, Cambridge 1998.
STAHL 2000a = A.M. STAHL, Zecca: The Mint of Venice in theMiddle Ages, New York 2000.
STAHL 2000b = ID., The Orte Hoard of Tuscan Grossi, in Pro-ceedings of the XIIth International Numismatic Congress, II,Berlin 8-12 September 1997, B. Kluge – B. Weisser (curr.),Berlin 2000, pp. 1085-1090.
STAHL 2001 = ID., Genova e Venezia, la moneta dal XII al XIVsecolo, in Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV, I, At-ti del convegno, Genova-Venezia 10-14 marzo 2000, «Attidella Società Ligure di Storia Patria» n.s. XLI (CXV), 2001,pp. 319-334.
TRAVAINI 1983 = L. TRAVAINI, Il ripostiglio di Oschiri (SS),«BNumRoma» I, 1983, pp. 27-216.
TRAVAINI 1992 = EAD., Miliarenses e grossi argentei: unaidentificazione errata?, «Bullettino dell’Istituto Storico Ita-liano» 98, 1992, pp. 383-394.
TRAVAINI 2003 = EAD., Monete, mercanti e matematica, Ro-ma 2003.
TRAVAINI 2010 = EAD., La collezione numismatica di BancaCarige: arte e storia, economia e segreti, simboli e politica insette secoli di monetazione, in Il patrimonio artistico di Ban-ca Carige. Monete, pesi e bilance monetali, L. Travaini (cur.),Genova 2010, pp. 12-23.
TRAVAINI – CHRISTIE 1994 = L. TRAVAINI – N. CHRISTIE, FurtherCoins from Santa Cornelia, Rome, «BSR» LXIII, n. ser. XLIX,1994, pp. 321-324.
VICENZI 1922 = C. VICENZI, Note su un ripostiglio di monetemedioevali (XII-XIII secolo) rinvenuto a Cisano (Bergamo),«RItNum» XXV, 1922, pp. 157-170.
WIELANDT 1950-51 = F. WIELANDT, Beiträge zur oberrheini-schen Münz- und Geldgeschichte: Die Münzfunde von Ro-tenfels, Oos und Illingen, «JNG» II, 1951-51, pp. 68 -125.
297MONICA BALDASSARRI – DANIELE RICCI
14 baldassari ricci:Layout 1 15.11.2013 7:49 Pagina 297
NOTE
1 DAY 2006; BALDASSARRI 2009,2010.
2 STAHL 2000a; TRAVAINI 2006; BAL-DASSARRI 2010; SACCOCCI 2010.
3 Cfr. ritrovamenti e relativa biblio-grafia citati in Appendice.
4 Prof. Vincenzo Palleschi del CNRdi Pisa, che qui si ringrazia, insie-me alla Fondazione Banca Carige,al Comune di Genova, alla direzio-ne dei Musei di Strada Nuova – Pa-lazzo Tursi – di Genova e ai privatiche hanno messo a disposizione leproprie collezioni per le analisi.
5 GANDOLFI 1841-42; DESIMONI 1888,1890; PESCE 1967; PESCE – FELLONI
1975; LUNARDI 1975. A questi si èaggiunto poi Matzke in un suo contri-buto di sintesi sui primi grossi italia-ni: MATZKE 2000.
6 LOPEZ 1955, 1967; TRAVAINI 1983;STAHL 2001; BALDASSARRI 2010,2011.
7 ASTENGO 1961.
8 FELLONI 1999, 2010.
9 MATZKE 2000; TRAVAINI 1996, 2006;SACCOCCI 1999, 2010.
10 BALDASSARRI 2009.
11 DESIMONI 1888, p. 180 ss.; LO-PEZ 1967, p. 178. Nel contributosuccessivo Desimoni non argomen-ta neanche il dato riassumendo co-sì le cose: Presto a Genova compar-ve il grosso di buon argento e delvalore di 4 denari […]; e ciò a difet-to di documenti, si può per buoneragioni supporre non più tardi del1172 (DESIMONI 1890, p. xxxv).
12 Per Venezia: STAHL 2000a; suTrento: PIGOZZO 2013; su Pisa e Luc-ca: BALDASSARRI 2010.
13 L’accenno in un documento del1193 conservato alla Biblioteca Be-rio di Genova (Mss. Rari, Perg.I, n.12/1) a denariorum bonorum perpe-rorum Ianuenisum sembrerebbe inrealtà basato su un errore di trascri-zione del manoscritto, nel quale iltermine perperorum era stato in ef-fetti depennato dallo scriba: cfr.STAHL 2000, p. 328, nota 42.
14 KRUEGER – REYNOLDS 1952, Lan-franco, pp. 116-117, n. 1189. Aquesto potrebbe seguire l’atto del1217 citato da Desimoni in riferi-mento ai nuovi grossi, che peròsembra parlare piuttosto di nuovidenari genovini, probabilmente dacorrelare ai primi: cfr. LOPEZ 1967,p. 179.
15 FERRETTO 1906, Magistri Salmonis,pp. 200.202, nn. DXII-DXIII.
16 Cfr. atto del 1220 in cui si fasaggio dei grossi piacentini: Et eaminvenimus bonam et legalem de pen-so et lega, scilicet X solid. et dimi-dium pro Marcha ad pensum. et delega, ad eo bonam et eciam melio-rem ut illa janue et venecie (FALCONI
– PEVERI 1984-88, II, p. 129, n.351, r. 6).
17 GRIERSON 1971-72.
18 Sulla rinnovata ipotesi che sullemonete medievali di Genova noncompaia il castello vescovile, né unadelle porte urbiche, ma un’immaginedi sintesi della città stessa si vedaBALDASSARRI c.d.s.
19 FELLONI 2010, p. 27; TRAVAINI
2010, p. 14. Per l’argento fatto co-niare da Enrico VI nel 1194: […]cum autem ad expedicionem no-stram pro regno Siciliae et Apulie ob-tinendo, multis indigeamus sumpti-bus, de bona voluntate ipsorum ia-nuensium ordinavimus, ut in civitateeorum de argento nostro moneta cu-datur in forma ianuensium (PUNCUCH,Libri iurium, p. 19, n. 1194).
20 BALDASSARRI 2009.
21 Appendice, a-b: S. Martino diSiccomario (Pavia) e Oos (BadenBaden).
22 Appendice, 1.
23 DESIMONI 1888.
24 Dai cambi citati nei documenti difine XII e inizi XIII secolo risulta uncorso oscillante tra poco più di 4 e5 bisanti di miliaresi per libbra geno-vese, che calcolato l’eventuale au-mento del cambio e riportato a 4 bi-santi per lira, e data l’eventualeequivalenza di 10 dirham o miliaresiper bisante darebbe l’equivalenzacon circa 6 denari di Genova del pe-riodo: su questo cfr. già STAHL 2001,p. 324, nota 29.
25 Cfr. CNI III, nn. 29 e 54.
26 Cfr. documenti in appendice a LO-PEZ 1956, pp. 158-160, n. 106.
27 Simile soluzione nella variantecon il cuneo è adottata anche nel«grosso multiplo», un pezzo di dub-bia attribuzione conosciuto in diversiesemplari da conii diversi: cfr. PESCE
1978. L’unico visionato direttamen-te, conservato nella collezione numi-smatica dei Musei di Strada Nuovadi Genova, è stato anche analizzatomostrando una lega in argento com-patibile con le altre serie di grossigenovesi del tempo, a differenza dialtri falsi moderni.
28 DESIMONI 1888, pp. 19-20; il do-cumento è pubblicato in LOPEZ 1959,pp. 156 -157, n. 103.
29 Sulle emissioni auree in quelladata LOPEZ 1955.
30 Appendice, c.
31 RUNCIMAN 1993; MADDEN 2006.
32 Appendice, d. g.
33 Appendice, 2.
34 Per queste citazioni su GenovaDESIMONI 1888, pp. 17-19, CASARETTO
1928 e LOPEZ 1955. Il dibattito sul-l’interpretazione di queste menzioninelle fonti scritte europee del temposi trova in TRAVAINI 1992, SPUFFORD
1998, pp. 171-176, SACCOCCI 1994 e2010.
35 Sul fatto che nel 1253 i grossi diGenova valessero mezzo soldo, ovve-ro 6 d, DESIMONI 1888, pp. 19-20.
36 STAHL 2000b.
37 Si segnala l’esistenza di falsifica-zioni del grosso di questo tipo, pro-babilmente ad opera del Cigoi, facil-mente riconoscibili per il peso leg-germente più eccessivo del normale;all’analisi XRF uno di questi esem-plari ha rivelato un tenore argenteomedio di 800-820‰, che ne confer-ma l’origine moderna. Si ringrazianoi privati che ne hanno consentitol’esame.
38 TRAVAINI 2003, p. 96: i grossi to-scani ai quali qui ci si riferisce sonole serie da 12 denari della primametà del Duecento, mentre gli aqui-lini maggiori e minori della seconda
298 I GROSSI D’ARGENTO E LA MONETAZIONE DI GENOVA TRA DUE E TRECENTO
14 baldassari ricci:Layout 1 15.11.2013 7:49 Pagina 298
299MONICA BALDASSARRI – DANIELE RICCI
metà sono elencati successivamen-te e risultano di titolo inferiore (Ibi-dem, p. 97).
39 PISTARINO 1961, pp. 87-88.
40 Appendice, g.
41 DESIMONI 1888, p. 10 e 1890, p.xxxv.
42 CNI III, p. 26, nn. 7-8.
43 È suggestivo e interessante il fat-to che l’adozione del cerchio polilo-bato sui nominali maggiori genovesipossa essere avvenuto all’indomanidella perdita delle posizioni dei ligurinella Contea di Tripoli, conquistatadefinitivamente dai Mamelucchi nel1289, dopo i tentativi di prenderne ilpotere di Guido II Embriaco (1277-82) ed i successivi complotti soste-nuti anche da Benedetto Zaccaria(1287-89).
44 LOPEZ 1955, pp. 38-39.
45 TRAVAINI 2003, pp. 106, 117,127, 133; anche se in molti casipotrebbe essere la trascrizione delvecchio valore da liste precedenti,pare interessante che non vi sianoindicazioni di rinnovamento colle-gati al calo del fino comunementenoti.
46 TRAVAINI 2003, pp. 105, 113,138, con le identiche riflessioni dicui alla nota precedente.
47 SCHWALM, Consitutiones, pp. 716-721, nn. 727-729.
48 GANDOLFI 1841-42, pp. 166-167.
49 DESIMONI 1890, p. xxxi.
50 LOPEZ 1967.
51 PESCE – FELLONI 1975.
52 ASTENGO 1957-58; già prima BIAN-CO 1938.
53 BALDASSARRI, supra.
54 BALDASSARRI 2009 e DAY 2005 pernominali piccoli.
55 BALDASSARRI 2009, p. 347; DAY
2005, pp. 1299-1300.
56 Tutti i grossi IQDP in Desimoni eCNI hanno la dicitura abbreviata IAN-VA QVA DEVS PTEGAT come i genovi-
ni con le lettere A-C (tav. V, n. 4),mentre i genovini guelfi e ghibellinihanno la versione estesa (tav. V, nn.5-6).
57 DESIMONI 1890.
58 Ipotesi di lavoro già presentateed argomentate in FERRO 2008, pp.317-335.
59 DESIMONI 1890, riviste di recenteda BALDASSARRI 2011.
60 DESIMONI 1890, p. 22, nn. 165-167; CNI III, p. 32, nn. 19-21.
61 DAY 2005.
62 LOPEZ 1967, p. 181.
63 A tale proposito si veda la biblio-grafia citata a nota 34.
14 baldassari ricci:Layout 1 15.11.2013 7:49 Pagina 299