Nuovi dati su alcune necropoli rinaldoniane. Revisione di vecchi scavi, nuove datazioni e recenti...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Nuovi dati su alcune necropoli rinaldoniane. Revisione di vecchi scavi, nuove datazioni e recenti...
ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA
RIVISTA DI SCIENZEPREISTORICHE
fondata da Paolo Graziosi
LXIV - 2014 - Firenze
RIV
ISTA D
I SCIE
NZ
E PR
EIST
OR
ICH
EL
XIV
- 2014 - Firenze
RIVISTA DI SCIENZE PREISTORICHEdell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria
redazione e amministrazioneVia S. Egidio 21 - 50122 Firenze
Tel. 055 2340765; fax: 055 5354821; e-mail: [email protected]
Direttore responsabileRaffaele C. de Marinis
Comitato di letturaClarissa Belardelli, Maria Bernabò Brea, Daniela Cocchi Genick, Isabella Damiani, Raffaele C. de Marinis, Giovanni Leonardi, Franco Marzatico, Monica Miari, Lucia Sarti
Prezzo per l’Italia e per l’estero € 95,00Per i volumi precedenti prezzi vari a seconda della disponibilità
(sul sito www.iipp.it)
ISSN 0035-6514
Jean Vaquer, Les pratiques funéraires au Néolithique moyen dans le Midi de la France .........
Maria Maffi, Il Neolitico Recente Emiliano (NRE): proposta di definizione ..........................
Günther Kaufmann, L’ascia dell’Uomo venuto dal ghiaccio .................................................
Nuccia Negroni Catacchio, Elsa Pacciani, Erika Albertini, Matteo Aspesi, Jacopo Moggi-Cecchi, Nuovi dati su alcune necropoli rinaldoniane. Revisione di vecchi scavi, nuove datazioni e recenti analisi dei resti scheletrici ..............................................................................
Anita Crispino, S. Ippolito, Caltagirone: nuovi dati sull’abitato dagli scavi Orsi ....................
Maria Clara Martinelli, Francesca Cannizzaro, Milena Gusmano, Considerazioni sulla facies di Malpasso nella cuspide orientale della Sicilia e nelle isole Eolie .........................
Davide Tanasi, Rappresentazioni naturalistiche nella ceramica del Bronzo Antico Siciliano: il caso di Grotte di Marineo (Licodia Eubea, Catania) ...................................................................
Carlo Veca, Contenitori “per i vivi” e contenitori “per i morti” a Thapsos (Siracusa): un approccio tecnologico a un problema interpretativo ....................................................................
Biancamaria Aranguren, Maria Rosaria Cinquegrana, Alberto De Bonis, Vincenza Guarino, Vincenzo Morra, Marco Pacciarelli, Le strutture e lo scarico di olle del Puntone Nuovo di Scarlino (GR) e i siti costieri specializzati della protostoria mediotirrenica ........................
Gianni Santuari, Umberto Tecchiati, Due ganci di cintura in bronzo di cui uno traforato tipo Castaneda (età antico La Tène) da Collalbo-Bolzano
ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA. Attività degli anni 2013 e 2014
Norme per gli autori ...............................................................................................................
5
25
57
83
115
151
193
203
227
259
281
297
Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria
Rivista di ScienzePreistoriche
fondata da Paolo Graziosi
LXIV - 2014 - Firenze
SUMMARY - New data on some rinaldonian necropoleis. Revision of previous excavations, new dates and recent analyses of the skeletal remains – In July 2011, the Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria partially funded the research project entitled “The Rinaldone facies: new dates”. The project, whose results are presented here, was coordinated by Nuccia Negroni Catacchio on behalf of the Centro Studi di Pre-istoria e Archeologia of Milan, while Elsa Pacciani was responsible for the dating itself. During the project, it soon emerged that Rittatore’s previous excavations of the very same necropoleis that were being dated were in need of revision, both from an archaeological perspective and from an anthropological one. The outcomes of all these different strands merge organically in the present work, complementing each other. The main topics discussed are listed below. Revision of the old excavations. The dating carried out on skeletal remains from the necropoleis of Chiusa d’Ermini and of La Porcareccia, which are presented here, fits well within wider scholarly trends that in rela-tively recent years have led to a renewed interest in the Eneolithic period and the Rinaldone culture. For ex-ample, the necropoleis of Ponte San Pietro and of Garavicchio, among others, have been recently dated (Dolfini et alii, 2012; Manfredini 2012). For the latter two necropoleis new analyses of materials and skeletal remains have been carried out, and they are presented here.In order to provide a framework for the dating and the analysis of the skeletal remains, here we briefly analyze, from an archaeological point of view, the four necropoleis excavated in the fifties and sixties by F. Rittatore Vonwiller. Renewed scholarly interest towards these necropoleis is partly due to the rediscovery of the diaries of F. Rittatore himself and L. Cardini, which are now kept at the Istituto Italiano di Paleontologia Umana.The new data. The twelve samples selected for dating within the research project “The Rinaldone facies: new dates” were taken from human skeletal remains from burial tombs in the necropoleis of Chiusa d’Ermini and La Porcareccia, presently housed in the Anthropology and Ethnology section of the University of Florence Natural History Museum, and from remains found at the necropolis of Poggialti Vallelunga and currently kept at the Laboratorio di Archeoantropologia of the Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.In detail, the samples selected are: four from Chiusa d’Ermini (Tomb I, individual 1; Tomb I, individual 4; Tomb IIIF.1; Tomb IIIM.A); three from La Porcareccia (Tomb IV, individual 1; Tomb IV, individual 3; Tomb IV, individual 4); five from Poggialti Vallelunga (Tomb 3, Tomb 4, Individual A, Tomb 4, Individual B, Tomb 5, Tomb 8).The samples were subjected to radiocarbon dating, using the technique of high-resolution mass spectrometry (AMS), at the Centro di Datazione e Diagnostica (CEDAD) of the University of Salento. All the samples from Chiusa d’Ermini and two of the samples from La Porcareccia yielded viable results. Here these results are discussed in the light of archaeological knowledge and the problems inherent in the methodology. The remain-
Nuovi dati su alcune necropoli rinaldoniane.Revisione di vecchi scavi, nuove datazioni e recenti analisi dei
resti scheletrici
Nuccia Negroni Catacchio (1), Elsa Pacciani (2), Erika Albertini (3), Matteo Aspesi (4), Jacopo Moggi-Cecchi (5)
Rivista di Scienze Preistoriche - LXIV - 2014, 83-113
(1) Università degli Studi di Milano e Centro Studi di Preisto-ria e Archeologia; Viale Lazio 26, 20135 Milano, tel. 02.22477212; [email protected] (2) Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, La-boratorio di Archeoantropologia, via dei Rossi 26A, 50018 Scandicci, Firenze; tel. 055 253273; e-mail [email protected](3) Università di Firenze, Dipartimento di Storia, Archeolo-
gia, Geografia, Arte e Spettacolo, via San Gallo 10, 50129 Firenze; tel. 3349283094; [email protected](4) Centro Studi di Preistoria e Archeologia Viale Lazio 26, 20135 Milano; tel. 02.22477212 [email protected](5) Università di Firenze, Dipartimento di Biologia, Laborato-ri di Antropologia, via del Proconsolo 12, 50121 Firenze; tel. 0552757746; [email protected]
84 Nuccia Negroni Catacchio, Elsa Pacciani, Erika Albertini, Matteo Aspesi, Jacopo Moggi-Cecchi
ing six samples, including all those from Poggialti Vallelunga and one from La Porcareccia, failed to yield a sufficient amount of collagen and did not therefore produce any result, because of the diagenetic degradation of bone tissues.The new analyses of the skeletal remains. After more than forty years since the publication of the anthropologi-cal analyses by Raffaello Parenti (1970) on the skeletal remains from the Rinaldonian necropoleis of Ponte San Pietro, La Porcareccia, Chiusa d’Ermini and Garavicchio, it was deemed appropriate to review the data and to carry out an additional study of the human skeletal remains from these sites, also following recent studies published in the field of archeology and the new absolute dates acquired (Dolfini 2004, 2006, 2010; Negroni Catacchio et alii, 2005; Conti et alii, 2006; de Marinis, 2006; Petitti et alii, 2006; Sarti 2006; Cocchi Genick, 2008; Manfredini et alii, 2009; Aspesi 2012). These studies have highlighted the complexity of the Rinaldone culture, proposing new systems of interpretation for reconstructing the relations between the different commu-nities and their social structure, with a degree of freedom from the original classification criteria. Similarly, in recent decades, in the field of anthropology, new areas of research have emerged, mainly aimed at outlining a broad paleobiological profile for human groups, one that takes into account economic, socio-cultural and envi-ronmental aspects; and it is precisely in light of this innovative approach (rather than following any traditional typological analysis) that a review of the skeletal remains has been undertaken. Working on these remains has also provided the opportunity to carry out their restoration, that it has become necessary due to the elapsed time; to update the inventory of the remains and, where necessary, to correct any inaccuracy or mistake found in previous publications.
Parole chiave: età del rame, Rinaldone, datazioni radiocarboniche, analisi antropologica Keywords: Copper age, Rinaldone, radiocarbon dates, anthropological analysis.
Il Progetto “La facies di Rinaldone e le nuove datazioni” (Nuccia Negroni Catacchio)
Nel luglio del 2011 l’Istituto Italiano di Prei-storia e Protostoria ha parzialmente finanziato il Progetto di ricerca dal titolo “La facies di Rinal-done: nuove datazioni”1. Il progetto, i cui risultati si presentano ora in questa sede, è stato coordi-nato dalla scrivente per conto del Centro Studi di Preistoria e Archeologia di Milano e da Elsa Pac-ciani per la parte relativa alle datazioni.
Nello stesso periodo è nata l’esigenza della revisione dei vecchi scavi Rittatore legati alle ne-cropoli di cui si stavano facendo le datazioni, sia dal punto di vista archeologico (a cura di Matteo Aspesi) sia antropologico (a cura di Jacopo Mog-gi-Cecchi e Erika Albertini)2.
1 Ringrazio l’Istituto italiano di Preistoria e Protostoria per il contributo assegnato al Centro Studi da me presieduto; a causa del momento di generale crisi finanziaria, lo stesso contributo ha dovuto essere ridotto in corso d’opera, tuttavia i risultati delle datazioni ottenute sono importanti e sufficien-ti ad aumentare le nostre conoscenze in questo campo.2 Un particolare ringraziamento va anche all’amico e colle-ga Fabio Martini, relatore della tesi di Erika Albertini. In particolare gli studi dei resti ossei rientrano nell’ambito delle collaborazioni in atto tra il Dipartimento di Storia, Ar-
Tutti i risultati sono ora confluiti in questo la-voro, che presenta quindi gli esiti di studi diversi, ma confluenti in un quadro organico e completo.
Le datazione effettuate sui resti ossei delle ne-cropoli di Chiusa d’Ermini e di La Porcareccia, che vengono qui presentate, si inseriscono nel filone di studi che in anni relativamente recenti hanno portato ad un rinnovato interesse per il pe-riodo eneolitico e la “cultura”3 di Rinaldone. Re-centemente infatti sono state datate, tra le altre, le necropoli di Ponte San Pietro e quella di Gara-vicchio (Dolfini et alii 2012; Manfredini 2012), per le quali sono state effettuate anche le nuove
cheologia, Geografia, Arte e Spettacolo SAGAS dell’Uni-versità di Firenze, il Dipartimento di Biologia, Laboratori di Antropologia della medesima Università, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e il Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria in merito alla valorizzazione di sto-riche collezioni paletnologiche e antropologiche soprattutto dell’età dei metalli. Si ringrazia inoltre il Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, Sezione di Antropologia e Etnologia e in particolare la dottoressa Monica Zavattaro per la disponibilità e lo spirito di collaborazione con cui ha seguito i nostri lavori.3 In questa sede il termine “cultura” è usato nell’accezione più volte indicata di un insieme sistemico di elementi tra loro interdipendenti (cfr. Negroni Catacchio 2006. Il concetto è ripreso in Negroni Catacchio 2011).
85Nuovi dati su alcune necropoli rinaldoniane. Revisione di vecchi scavi, nuove datazioni
analisi dei materiali o dei resti ossei, che qui si presentano.
In questa sede, si riprendono in esame breve-mente dal punto di vista archeologico le tombe del-le necropoli di Ponte San Pietro, Chiusa d’Ermini, La Porcareccia e Garavicchio oggetto delle nuove datazioni o della revisione degli studi antropolo-gici, per meglio inquadrarne i risultati. Per quanto riguarda l’analisi territoriale, le prime tre necropoli rientrano in quella che ho definito ”area nucleare”, che ha il suo centro ideale proprio a Ponte San Pie-tro (Negroni Catacchio 2000); quella di Garavic-chio è posta proprio al limite di quest’area, sposta-ta verso il mare, non lontano dall’Argentario.
Come è noto si tratta di necropoli scavate tra gli anni ’50 e ’60 da F. Rittatore, ristudiate in anni più o meno recenti, e le cui analisi dei resti ossei furono a suo tempo effettuate da Raffaello Parenti. Alcuni nuovi dati e qualche precisazio-ne provengono anche dal recupero dei diari di F. Rittatore e L. Cardini, conservati presso l’Istituto Italiano di Paleontologia Umana4.
La revisione dei vecchi scavi (Matteo Aspesi)
Ponte San PietroLa necropoli di Ponte San Pietro (Ischia di ca-
stro, VT) venne scoperta nel 1940 durante la co-struzione della strada che da Farnese (VT) porta a Manciano (GR). È situata sul versante orientale del poggio di Pianizza in prossimità del ponte sul Fiora da cui il sepolcreto prende il nome5.
Le ricerche vennero svolte a partire dal 1946, per un arco di quasi vent’anni fino all’ultima del 1959 da Ferrante Rittatore e da Luigi Cardini, e portarono alla luce ben 25 sepolture e un’ingente quantità di materiale, che fanno di Ponte San Pie-tro uno dei contesti archeologici più importanti dell’Italia protostorica.
4 Si ringrazia sentitamente anche l’Istituto Italiano di Pale-ontologia Umana per aver permesso e agevolato la consulta-zione dei diari da parte di Matteo Aspesi e di Erika Albertini.5 Questa breve presentazione delle necropoli oggetto delle recenti datazioni si basa sulle riedizioni degli scavi via via citate, su una rilettura dei diari di Cardini conservati presso l’Istituto Italiano di Paleontologia Umana e sulle pubblica-zioni di R. Parenti. La revisione dei risultati delle analisi di R. Parenti costituisce la seconda parte di questa ricerca ed è più avanti riportata.
Nonostante la grande rilevanza di questo con-testo, vennero forniti sia da F. Rittatore sia da L. Cardini solo dati parziali tramite la pubblicazione di alcuni resoconti6, che ponevano l’attenzione maggiormente sulle tombe ritenute più rilevanti, come la celeberrima “tomba della vedova” (Rit-tatore 1942, 1948-49, 1951; Cardini 1946,1955; Cardini e Rittatore 1948, 1951). Soltanto nel 1993 vennero pubblicati i dati dell’intero scavo ad opera di M. Miari (Miari 1993), che per la pri-ma volta analizzò tutte le tombe nella loro inte-rezza. In seguito a questi studi Monica Miari ha potuto giungere a nuove conclusioni riguardanti l’organizzazione spaziale in rapporto con l’orga-nizzazione sociale (Miari 1995), argomento lar-gamente dibattuto agli inizi degli anni ‘90 (Caz-zella e Moscoloni 1995).
La necropoli si sviluppa lungo il pendio orien-tale dello sperone tufaceo di Pianizza (Ischia di Castro, VT) ed era composta da venticinque se-polture organizzate in due gruppi distinti, distanti tra loro circa 20 m: uno sud-occidentale composto da tredici sepolture e uno nord-orientale di dodici. In più, ogni gruppo, secondo Miari 1995, sarebbe suddiviso ulteriormente in sottogruppi che richia-merebbero l’organizzazione sociale della comu-nità rinaldoniana.
Le tombe risultavano avere la classica forma a grotticella artificiale con la camera a pianta sub-circolare o sub-ellissoidale, generalmente mancanti del vestibolo, fatta eccezione per la tomba 16 che aveva un vestibolo di accesso circolare profondo 1,40 m. Un altro dato che si desume dalle notizie di F. Rittatore e L. Cardini è che le prime otto tombe trovate avevano un corridoio di accesso alla camera, dato che oggi risulta di difficile interpretazione per due motivi principali: il primo è che negli unici scavi condotti in maniera scientifica7 su contesti di questo orizzonte cronologico, laddove le tombe presentano un corridoio, elemento peraltro raro, le sepolture son dotate di un vestibolo, come alla
6 I resti ossei vennero analizzati da Raffaello Parenti che nel 1970 pubblicò i dati sulla rivista “Archivio per l’Antro-pologia e l’Etnologia” (Parenti 1970).7 Le uniche due necropoli nell’area nucleare indagate in epoca moderna applicando un metodo di scavo stratigrafico sono quella della Selvicciola (Petitti et alii 2006, 2012) e quella di Poggialti Vallelunga (Negroni Catacchio e Aspesi c.s.).
86 Nuccia Negroni Catacchio, Elsa Pacciani, Erika Albertini, Matteo Aspesi, Jacopo Moggi-Cecchi
Selvicciola (Conti et alii 1997 ), mentre dove il vestibolo non c’è, come a Poggialti Vallelunga (Negroni Catacchio e Aspesi c.s.), le tombe non presentano il corridoio8.
I corredi rinvenuti nelle varie tombe della ne-cropoli evidenziano un repertorio che, fatte salve alcune costanti, come il vaso a fiasco seppur in differenti tipologie, appare vario e con elemen-ti che trovano confronti in aree diverse, come il vaso a brocca della tomba 24 che ha un confronto diretto nelle necropoli del Gaudo.
La grande abbondanza di materiale, il cospi-cuo numero di sepolture e la varietà dei reperti che presentano sia tipologie tipiche della cultura di Rinaldone, sia elementi particolari che colle-gano questo sepolcreto al resto delle culture ene-olitiche della Penisola, permettono di indicare la necropoli di Ponte San Pietro come la più rappre-sentativa dell’intero aspetto culturale9.
Tra le venticinque sepolture indagate, ad oggi risultano molto interessanti, nel quadro degli studi che negli ultimi anni stanno portando ad
8 Si ricorda che all’epoca degli scavi di F. Rittatore l’in-teresse per i vestiboli era scarso e in molti casi può essere che gli scavatori non si siano interessati all’area antistante le camere perché più interessati al recupero dei materiali di cor-redo, di cui molte volte, escluse alcune eccezioni, i vestiboli sono privi.9 Visto il numero complessivo delle tombe e la grande quantità di materiali, anche in questo caso si è preferito pren-dere in esame solo le poche tombe recentemente oggetto di datazioni; per quanto riguarda le parti qui non analizzate in dettaglio si rimanda alle pubblicazioni di M. Miari (Miari 1993 e 1995).
una migliore definizione cronologica dell’età del rame in Italia, le tombe 7, 19, 21, 23, 25, che negli ultimi anni sono state datate con il metodo del radiocarbonio (Dolfini et alii 2012; Manfredini et alii 2009; Manfredini 2012)10. In questa sede si riprenderanno in esame solo queste, allo scopo di permettere il confronto tra le datazioni, le nuove analisi antropologiche e i corredi.
La tomba 7 (fig. 1) venne scoperta e scavata nel 1955; la volta risultava crollata obliterando gli strati inferiori, al cui interno vennero tro-vati alcuni resti ossei (Parenti 1970) e alcuni elementi di corredo. La tomba doveva avere la tipica forma a grotticella artificiale con la ca-mera a pianta sub-ellissoidale o sub-circolare con accesso semplice. La camera era chiusa da una porta in travertino che venne ritrovata in posto al momento della scoperta. Il corredo era composto da un vaso a fiasco a corpo ellissoi-dale schiacciato con 4 nervature verticali sulla parte superiore del corpo (fig. 1, 1) e una ascia a martello a tallone indistinto (fig. 1, 2). Per
10 Le datazioni sono state eseguite presso l’Oxford Radio-carbon Accelerator Unit. La principale differenza tra le due serie di datazioni sta nel fatto che mentre A. Dolfini prende in considerazione le date calibrate a due sigma, A. Manfre-dini, nel tentativo di fornire un quadro cronologico dell’E-neolitico del Tirreno centrale, utilizza le datazioni di molti contesti pubblicate in vari articoli, quindi per rendere pos-sibili i parallelismi considera le datazioni ad un solo sigma. La differente calibrazione fornisce date leggermente discre-panti, e quindi si è ritenuto opportuno, per completezza di informazione, riportare entrambe le serie di datazioni.
Fig. 1 - Necropoli di Ponte San Pietro (Ischia di Castro – VT). Corredo della tomba 7 (da Miari 1993) (1-2 scala 1:3).
Ponte San Pietro Necropolis (Ischia di Castro – VT). Grave-goods from tomb 7 (after Miari 1993) (1-2 scale 1:3).
87Nuovi dati su alcune necropoli rinaldoniane. Revisione di vecchi scavi, nuove datazioni
questa sepoltura è stata fornita una data: 3648 – 3520 BC cal 2σ (Dolfini et alii 2012), ricavata da una tibia dell’individuo femminile articolato PSP VIII. 1 (Parenti 1970).
La tomba 19 (fig. 2 ) venne scoperta e scavata nel 1954; si trattava anche in questo caso di una tomba a grotticella artificiale con accesso sempli-ce, con la camera di forma sub-ellittica. La tomba venne trovata sigillata da una porta in scisto e la volta era ancora intatta. Al suo interno vennero ritrovati resti di 3 individui: un uomo, una donna e un bambino in perfetta connessione anatomica; sembra plausibile che il bambino fosse collocato vicino alla porta. Furono inoltre rinvenuti due vasi a fiasco11: uno di dimensioni maggiori con corpo biconico schiacciato collocato vicino all’ingresso accanto al bambino (fig. 2, 1), mentre il secon-do, di dimensioni ridotte, era collocato tra i due crani degli adulti (fig. 2, 2). Si tratta di un vaso a fiasco con corpo ellissoidale, collo cilindrico a colletto; nei diari di L. Cardini si parla anche di una punta di freccia che però risulta dispersa. Per questa tomba è stata fornita una datazione 3500 – 3430 BC cal 1σ (Manfredini 2012)12, eseguita su un osso umano non meglio specificato.
11 È uno dei rari casi in cui il vaso a fiasco ricorre in più di un esemplare (Miari 2006).12 Questa datazione è stata eseguita presso il laboratorio del CEDAD di Lecce.
La tomba 21 (fig. 3) venne ritrovata nel 1954 ed era sovrapposta alla sottostante tomba 22, da cui era separata solo da un diaframma roccioso talmente sottile che il fondo risultava crollato in quella inferiore. La tomba presentava una volta a cupola intatta ed era chiusa da una porta in traver-tino con pietre di rincalzo.
Al momento dell’apertura della tomba 2213 nello strato di crollo vennero ritrovati i resti di due individui (Parenti 1963) e alcuni elementi di corredo: 2 pugnali a lama triangolare e base tra-pezoidale del tipo Guardistallo con tre fori per i ribattini (fig. 3, 1-2); un’ascia di rame a margini concavi, taglio convesso e leggermente espanso; una fusaiola a corpo lenticolare (fig. 3, 7); una te-sta di mazza piriforme (fig. 3, 4); un pugnale in selce a codolo triangolare (fig. 3, 3); due punte di freccia a peduncolo e spalle (fig. 3, 5-6); inoltre vennero trovati alcuni elementi di ornamento: un pendaglio litico cilindrico in arenaria (fig. 3, 8), un vago in antimonio di forma biconica (fig. 3, 10) e alcuni vaghi cilindrici sempre in antimonio (fig. 3, 9). Per questa sepoltura vengono fornite due datazioni: 3750 – 3537 BC cal 2σ e 3635 –
13 Si tratta della famosa “tomba dell’intruso” (Cardini e Rittatore 1958) i cui resti ossei e di parte del corredo ap-partenevano probabilmente alla soprastante tomba 21. Per questo le datazioni effettuate sugli individui “caduti” nella tomba 22, ma appartenenti in origine alla tomba 21, ven-gono attribuite nella letteratura, ora all’una, ora all’altra tomba.
Fig. 2 - Necropoli di Ponte San Pietro (Ischia di Castro – VT). Corredo della tomba 19 (da Miari 1993) (1-2 scala 1:3).
Ponte San Pietro Necropolis (Ischia di Castro – VT). Grave-goods from tomb 19 (after Miari 1993) (1-2 scale 1:3).
88 Nuccia Negroni Catacchio, Elsa Pacciani, Erika Albertini, Matteo Aspesi, Jacopo Moggi-Cecchi
Fig. 3 - Necropoli di Ponte San Pietro (Ischia di Castro – VT). Corredo della tomba 21 (da Miari 1993) (1-2, 4, scala 1:3; 3-6, 8, 10 scala 1:2; 9 scala 1:1).
Ponte San Pietro Necropolis (Ischia di Castro – VT). Grave-goods from tomb 21 (after Miari 1993) (1-2, 4, scale 1:3; 3-6, 8, 10 scale 1:2; 9 scale 1:1).
3376 BC cal 2σ (Dolfini et alii 2012)14: la prima è stata fornita dalla fibula dell’individuo maschile
14 A. Manfredini fornisce delle date leggermente differen-ti, ma che si discostano solo di qualche anno da quelle qui esposte, collocando questa tomba all’incirca a metà del IV millennio (Manfredini 2012).
articolato PSP IV. 1bis (Parenti 1970), mentre la seconda proviene dal radio dell’individuo femmi-nile articolato PSP IV. 1 (Parenti 1970).
La tomba 23 (fig. 4) fu scavata nel 1954 e al momento della scoperta venne indicata come tomba U o T.17. Si presentava con la volta crol-lata e le ossa inglobate in uno strato di carbonato
89Nuovi dati su alcune necropoli rinaldoniane. Revisione di vecchi scavi, nuove datazioni
di calcio; si tratterebbe dei resti di almeno due individui, di cui uno in connessione anatomica (Parenti 1970). Anche in questo caso si hanno po-chissimi dati sulla struttura che dovrebbe essere comunque paragonabile a quelle già descritte. Il corredo era composto da un vaso a fiasco a corpo ellissoidale con collo cilindrico medio e due anse canaliculate verticali (fig. 4, 1), quattro punte di freccia in selce (fig. 4, 2-3-5-6) e da una lami-na di rame frammentaria fortemente erosa (fig. 4, 4). Anche per questa sepoltura si hanno due datazioni assai simili: 3640 – 3383 BC cal 2σ e 3639 – 3383 BC cal 2σ (Dolfini et alii 2012)15: la prima è stata fornita dal femore dell’individuo disarticolato forse di sesso femminile PSP XII. 2 (Parenti 1970), mentre la seconda proviene dal-
15 Anche in questo caso A. Manfredini fornisce una data leggermente differente ( 3640 – 3550 BC cal 1σ), ma che è del tutto paragonabile a quelle qui esposte (Manfredini 2012).
la tibia dell’individuo articolato forse femminile PSP XII. 1 (Parenti 1970).
La tomba 25 (fig. 5) è una delle ultime scoper-te e indagate, infatti venne trovata nel 1958 e F. Rittatore la scavò nel 1959. La tomba a grotticella aveva una cella a pianta sub-ellittica ed era ad ac-cesso semplice, chiusa da una lastra di travertino con pietre di rincalzo. La volta era crollata sigil-lando le ossa racchiuse in uno strato di carbonato di calcio. Al suo interno vennero trovati i resti di almeno tre individui: uno in connessione, ma pri-vo di cranio e due ammucchiati lungo la parete di fondo. Il corredo era composto da un vaso a fiasco ellissoidale schiacciato con collo tronco-conico medio e quattro nervature verticali sulla parte superiore del corpo (fig. 5, 1), un vasetto cilindrico con anse canaliculate verticali (fig. 5, 2) e una punta di freccia in selce a peduncolo e spalle (fig. 5, 3). Per questa tomba viene fornita
Fig. 4 - Necropoli di Ponte San Pietro (Ischia di Castro – VT). Corredo della tomba 23 (da Miari 1993) (1 scala 1:3; 2-6 scala 1:2).
Ponte San Pietro Necropolis (Ischia di Castro – VT). Grave-goods from tomb 23 (after Miari 1993) (1 scale 1:3; 2-6 scale 1:2).
90 Nuccia Negroni Catacchio, Elsa Pacciani, Erika Albertini, Matteo Aspesi, Jacopo Moggi-Cecchi
una data16: 3484 – 3104 BC cal 2σ (Dolfini et alii 2012), proveniente dalla fibula dell’individuo ar-ticolato femminile PSP XI.1 (Parenti 1970).
GaravicchioLa necropoli di Garavicchio si trova nel
comune di Capalbio (GR) e venne scoperta nel 1955 su segnalazione a F. Rittatore e L. Cardini da parte del marchese Litta Modignani, proprietario del terreno dove era stata aperta una cava per raccogliere la terra per la costruzione di strade. In seguito al rinvenimento delle prime tombe nel 1955, vennero eseguite altre due campagne di scavo: una l’anno successivo e un’altra nel 1959.
Nonostante la rilevanza del sito archeologico, i due studiosi non pubblicarono mai in maniera esaustiva il contesto, ma si limitarono a darne brevi notizie preliminari (Cardini e Rittatore 1955, 1956, 1659; Cardini et alii 1958-61). Qualche notizia è stata fornita anche da F. Falchetti (Falchetti 1977) che ne tratta brevemente, ma che segnala il numero delle tombe scoperte nel 1955, cioè sette17.
L’edizione completa della necropoli avvenne solo nel 1988 ad opera di B. Aranguren, P.
16 A. Manfredini fornisce una datazione ancora una volta leggermente differente ovvero 3370 – 3320 BC cal 1σ (Man-fredini 2012).17 Questo dato è in disaccordo con quanto riportato nella pubblicazione della necropoli del 1987/88 (Aranguren et alii 1987/88) in cui si afferma che le tombe sarebbero cinque scoperte nel 1955 e in totale sette considerando la campagna del 1959.
Pallecchi, P. Perazzi e A. Revedin (Aranguren et alii 1987/88), che per la prima volta analizzarono i dati di scavo inviati da F. Rittatore e L. Cardini alla Soprintendenza e studiarono i materiali conservati al Museo Fiorentino di Preistoria e al Museo Archeologico Nazionale di Firenze.
Oltre all’organizzazione sistematica dei dati e alla pubblicazione esaustiva del contesto, in questo lavoro viene fornita anche la collocazione precisa del sepolcreto che si sa essere localizzato nella proprietà Caracciolo, su una collina a sud-ovest di Pescia Fiorentina, sulla desta della strada che unisce il paese alla via Aurelia (Foglio IGM F. 136 III NO lat. 42° 25’ 29’’; long. 10° 59’ 2’’).
Ad oggi però è possibile approfondire ulteriormente quanto esposto nella pubblicazione appena citata, grazie al recupero dei diari di L. Cardini conservati presso l’Istituto Italiano di Paleontologia Umana; è quindi possibile notare alcune discrepanze rispetto a quanto finora noto.
Secondo questi diari la necropoli sarebbe composta da un totale di dieci sepolture: le prime due scavate nel 1955, come viene evidenziato anche nella pubblicazione dell’88, ma nella campagna di scavo del 1956 sarebbero venute in luce altre cinque tombe e non tre18; inoltre nei diari si parla del rinvenimento nel 1959 di tre altre sepolture e non di due19.
18 Nella pubblicazione si fa menzione della possibilità che ci fosse anche una tomba 6.19 Questi nuovi dati tratti dai diari di Cardini sono stati
Fig. 5 - Necropoli di Ponte San Pietro (Ischia di Castro – VT). Corredo della tomba 25 (da Miari 1993) (1-2 scala 1:3; 3 scala 1:2).
Ponte San Pietro Necropolis (Ischia di Castro – VT). Grave-goods from tomb 25 (after Miari 1993) (1-2 scale 1:3; 3 scale 1:2).
91Nuovi dati su alcune necropoli rinaldoniane. Revisione di vecchi scavi, nuove datazioni
Le prime sette sepolture, indagate tra il 1955 e il 1956, sono state numerate progressivamente da 1 a 7, mentre quelle scavate nel 1959 sono indicate con le lettere A, B e C. La loro disposizione in pianta lungo il pendio non è molto chiara e soprattutto non è facile capire il rapporto tra le tombe trovate durante le prime campagne di scavo e quelle del 1959.
Questo dato, che è difficile evincere anche dai diari di L. Cardini stesso, ma che si spera di poter chiare con nuove acquisizioni, non permette di individuare un’organizzazione spaziale della necropoli, anche se sembra che la collocazione fosse subordinata all’andamento del pendio.
Le sepolture presentano tutte la classica forma a grotticella artificiale con la camera a pianta sub-ellittica o sub-circolare, come sembra desumibile dalle piante delle tombe disegnate da L. Cardini, ed erano tutte prive del vestibolo, spesso sigillate da portelli in pietra. Un dato interessante è l’in-dicazione della presenza di “muretti a secco” per la chiusura dei sepolcri, elemento di cui non si conoscono confronti, anche se a Ponte San Pietro si sa dell’utilizzo di pietre di rincalzo a sostegno delle porte.
Per Garavicchio, come per le altre necropoli, si prendono in considerazione solo le sepolture
esposti in maniera esaustiva e dettagliata al XII Incontro di Studi Preistoria e Protostoria e Protostoria in Etruria, che si è tenuto nel settembre del 2014 (Aspesi c.s.).
per cui sono state fornite datazioni assolute20: ov-vero le tombe 2 e 321.
La tomba 2 (fig. 6) è stata scoperta e scavata nel 1955; si tratta di una tomba a grotticella artificiale con la cella a pianta sub-circolare ad accesso semplice e ingresso chiuso da una lastra in pietra, orientato verso sud. La volta era crollata obliterando la deposizione di un inumato in connessione anatomica al centro della cella e un secondo ammucchiato disordinatamente lungo la parete di fondo (Parenti 1970). Il corredo era composto secondo i diari di Cardini da un vaso a fiasco a corpo biconico schiacciato con collo cilindrico medio distinto dal corpo e carena smussata con due nervature verticale (fig. 6, 1), da una cuspide di freccia a peduncolo e alette (fig. 6, 4), da uno spillone o lesina di rame (fig. 6, 2) e da un pendaglio in scisto (fig. 6, 3) oltre che da alcuni frammenti di parete. Secondo quanto riportato nella pubblicazione dell’87/88 sarebbe stata portata alla luce anche un’ascia di rame che poi sarebbe andata dispersa, ma niente di tutto ciò è stato riportato da L. Cardini.
Per questa sepoltura vengono fornite tre date: una per l’individuo articolato maschile GAR II.1 (Parenti 1970) e due per l’individuo femminile disarticolato GAR II.2 (Parenti 1970): la prima eseguita su una fibula è 3632 – 3373 BC cal 2σ, mentre le altre due
20 Cfr. nota 14.21 Anche per la tomba 1 è stato fatto un tentativo di datazione che però è fallito.
Fig. 6 - Necropoli di Garavicchio (Capalbio – GR). Corredo della tomba 2 (da Aranguren et alii 1987/88) (1 scala 1:4; 2-4 scala 1:3).
Garavicchio Necropolis (Capalbio – GR). Grave-goods from tomb 2 (after Aranguren et alii 1987/88) (1 scale 1:4; 2-4 scale 1:3).
92 Nuccia Negroni Catacchio, Elsa Pacciani, Erika Albertini, Matteo Aspesi, Jacopo Moggi-Cecchi
sono: 3632 – 3374 BC cal 2σ e 3641 – 3384 BC cal 2σ, entrambe fornite dalla stessa fibula dello stesso individuo (Dolfini et alii 2012)22.
La tomba 3 (fig. 7), indagata nel 1956, era stata intaccata dai lavori di cava che avevano asportato quasi metà sepoltura, lasciando però praticamente intatta la deposizione di un inumato in connessione anatomica al centro della cella. Il corredo era costituito da un vaso a fiasco a corpo ellissoidale con collo troncoconico medio fortemente distinto dal corpo con due anse canaliculate nella parte alta del corpo (fig. 7, 1), una ciotola troncoconica con una bugna al di sotto del bordo (fig. 7, 2), una probabile lesina di rame (fig. 7, 6), un pugnale a lama triangolare con base arrotondata e con due fori per i ribattini, ricoperto probabilmente da cinabro (fig. 7, 5), un’armilla al polso dell’inumato e sei cuspidi di freccia (fig. 7, 3-4-7-8-9).
Una di queste non è stata ritrovata e non si ha neanche il disegno, mentre le altre presentano un peduncolo e alette di varie dimensioni; una sembra non avere un ritocco bifacciale coprente, cosa assai rara nella cultura di Rinaldone.
Il corredo di questa sepoltura risulta anomalo: il vaso a fiasco ha una forma particolare che con difficoltà può essere avvicinata ad altri esemplari, soprattutto per la singolarità delle anse; il pugnale al momento della scoperta sembrava ricoperto di cinabro o ocra; infine si ha notizia di un’armilla al polso del defunto, mai ritrovata, elemento che risulta essere un unicum.
Per questa sepoltura viene fornita una sola data proveniente da un campione prelevato dall’indivi-duo forse femminile trovato in connessione GAR III.1 (Parenti 1970): la datazione è 2909 – 2704 BC cal 2 σ23 (Dolfini 2012).
Chiusa d’ErminiLa necropoli di Chiusa d’Ermini, come tutte
quelle qui esaminate, si inquadra nell’Eneolitico dell’Italia centrale e in particolare nella “cultura” di Rinaldone; si trova nel comune di Ischia di
22 A. Manfredini dà una datazione differente per questi re-sti: sia per i resti articolati sia per quelli disarticolati fornisce una datazioni 3440 – 3370 BC cal 1σ (Manfredini 2012). 23 Anche per questa tomba A. Manfredini riferisce una data-zione leggermente differente: 2910 – 2870 BC cal 1σ (Man-fredini 2012).
Castro (VT) e venne scoperta e scavata da F. Rittatore nel 1950, quando, in seguito ad una segnalazione, con un intervento di emergenza portò alla luce due tombe (tomba 1 e 2) pubblicate dallo stesso Rittatore nel 1951 (Rittatore 1951).
A seguito di questa prima campagna ne venne condotta una seconda, ad opera di F. Rittatore e L. Cardini nel 1954, dopo un sopralluogo, in cui si era potuto notare che altre sepolture erano state violate da scavi clandestini24.
Un ultimo intervento in questa necropoli venne eseguito da F. Falchetti ed altri collaboratori di F. Rittatore V. nel 1975, quando vennero individuate altre undici tombe, per un totale di quattordici sepolture, quasi tutte violate dai clandestini: a parte le prime due indagate nel 1950, soltanto la tomba 12 della ricognizione Falchetti25 risultava avere un buono stato di conservazione.
Dopo gli scavi e le ricognizioni sopra citate, questo contesto non è stato più pubblicato e studiato in maniera definitiva fino al 2012 (Aspesi 2012), anche se è stato analizzato parzialmente da F. Falchetti nella sua tesi di laurea presso l’Università degli Studi di Milano (Falchetti 1971-72) e nel contributo del 1977 (Falchetti 1977) riguardante il periodo eneolitico, all’interno di una pubblicazione di più ampio respiro, che aveva come oggetto non le singole necropoli, quanto piuttosto la preistoria e la protostoria della valle del fiume Fiora.
Ad oggi l’esatta collocazione di questa necropoli rimane ancora incerta: come spesso accade per i siti scavati in quegli anni, la mancanza di documenta-
24 Rispetto alla pubblicazione edita dallo scrivente (Aspe-si 2012), grazie al recupero dei manoscritti di L. Cardini, è possibile ora sottolineare che nel 1954 venne scavata una tomba, che sebbene crollata, conservava molti resti ossei: è la tomba che nella pubblicazione di R. Parenti (Parenti 1970) viene denominata C.E. III; in più vennero indagate altre due sepolture fortemente intaccate da scavi clandestini.25 F. Falchetti non pubblicò mai i risultati di questa ricogni-zione, che ci è nota solo per alcuni brevi appunti scritti sul diario di scavo di F. Rittatore. Egli rinumerò tutte le sepol-ture della necropoli, ma nei documenti da noi analizzati e in particolare negli appunti da lui scritti nel diario Rittatore, non si trova menzione della corrispondenza tra le prime tre tombe indagate e quelle analizzate da lui vent’anni dopo; l’unica indicazione riguarda la collocazione della tomba 1 che dovrebbe essere la più ad ovest. Purtroppo questo dato è contenuto nella tesi di F. Falchetti che è del 1971-72, quindi scritta tre anni prima dell’indagine del 1975 e della sua nuo-va numerazione. Sembra pertanto impossibile indicare con certezza la corrispondenza tra le due numerazioni.
93Nuovi dati su alcune necropoli rinaldoniane. Revisione di vecchi scavi, nuove datazioni
zione accurata non ha permesso di ritrovare il sito. La descrizione, i disegni e gli appunti sembrano in-dicare una collocazione a sud del Ponte di San Pie-tro, in un area boschiva al di sopra di un fosso e al di sotto di un casale non meglio identificato, a sud est di Poggio Conte; ma nonostante questi dati, non è ancora stata trovata traccia del sepolcreto, che pur-troppo potrebbe essere stato distrutto in seguito ai lavori agricoli che hanno modificato sensibilmente i territori su cui insistono questo e gli altri siti qui presi in esame.
La necropoli, come sopra si è e detto, è compo-sta da 14 tombe, ma solo di tre si ha una descrizio-
ne accurata26. Le tre sepolture note, tutte rivolte a meridione, presentano la tipica forma a forno nella sua tipologia più semplice: senza vestibolo e con l’ingresso chiuso da una lastra di travertino.
La tomba 1 (fig. 8) doveva essere la più a ovest; venne individuata e scavata nell’estate del
26 Per le notizie riguardanti la necropoli, si rimanda alle pubblicazioni citate e in particolare alla sua edizione critica (Aspesi 2012). Qui per brevità si prenderanno in esame in maniera approfondita solo le sepolture oggetto di datazione radiometrica.
Fig. 7 - Necropoli di Garavicchio (Capalbio – GR). Corredo della tomba 3 (da Aranguren et alii 1987/88) (1-2 scala 1:4; 3-9 scala 1:3).
Garavicchio Necropolis (Capalbio – GR). Grave-goods from tomba 3 (after Aranguren et alii 1987/88) (1-2 scale 1:4; 3-9 scale 1:3).
94 Nuccia Negroni Catacchio, Elsa Pacciani, Erika Albertini, Matteo Aspesi, Jacopo Moggi-Cecchi
1950. La volta della camera era crollata all’inter-no, ricoprendo di detriti gli strati di deposizione. Sotto lo strato di crollo vennero trovati i resti di cinque individui ed alcuni oggetti di corredo: un vaso a fiasco con corpo ellissoidale (fig. 8, 1), una ciotola carenata (fig. 8, 2), un’accetta in rame sub rettangolare con i margini lievemente rialzati e il margine espanso (fig. 8, 4) e un pugnale tipo Guardistallo con due particolari solcature centrali (fig. 8, 3)27 (Rittatore 1951).
Il sepolcro risultava essere privo del vestibolo, con la camera a forno scavata nel tufo, chiusa con una lastra di travertino che misurava 90 cm d’altezza e 65 cm di larghezza.
La sepoltura conteneva frammenti di ossa umane che erano state accumulate disordinata-mente presso la parete della tomba (Parenti 1970). Al momento del rinvenimento tali resti erano stati attribuiti a tre individui, ma dopo la liberazione dalla ganga, sono stati riferiti a cinque individui, fra cui un bambino.
Ad oggi questa tomba è una delle pochissime conosciute che abbia restituito un corredo completo: (vaso a fiasco, ciotola, accettina e pugnale), associato a sole ossa disarticolate; in particolare è rara l’associazione di materiale metallico con resti che hanno subito manipolazioni post-mortem, mentre generalmente questi oggetti di prestigio sono collegati ad individui intenzionalmente lasciati in connessione anatomica.
Di questa tomba sono state fatte le datazioni finanziate dall’IIPP e riportate più avanti da Elsa Pacciani.
La tomba 2 è come la precedente una grotti-cella artificiale con orientamento nord-sud. La camera è a pianta sub-ellittica e risulta priva del vestibolo.
Al suo interno erano presenti i resti di quattro individui (Parenti 1970): uno al centro in posizione rannicchiata, mentre i resti degli altri tre erano ammucchiati lungo il fondo. L’unico elemento di corredo rinvenuto è un vaso a fiasco con corpo biconico. Di questa tomba si era deciso
27 I reperti metallici sono andati perduti e quindi per le descrizioni ci si è avvalsi della pubblicazione di Rittatore (1951), della tesi di F. Falchetti (Falchetti 1971-72) e, per quanto riguarda il pugnale, delle indicazioni date da V. Bianco Peroni (Bianco Peroni 1994).
di prelevare i campioni per la datazione, ma, visto il loro pessimo stato di conservazione, si è preferito sostituirli con alcuni campioni della tomba 3.
La tomba 3 è l’unica scavata scientificamente nel 1954, anche se parzialmente interessata da interventi clandestini. Di questo sepolcro si hanno pochissimi dati di scavo, quasi nulli: si sa unicamente che la tomba aveva la tipica forma a forno, senza vestibolo, e con la volta crollata (Aspesi 2012).
Non sono stati trovati elementi di corredo; tuttavia sono stati recuperati i resti ossei, che solo in pochissimi casi si sono potuti restaurare e hanno fornito elementi anatomici completi (Parenti 1970).
I frammenti sono stati attribuiti dal Parenti (Parenti 1970) a cinque/sei persone, nello specifico a due uomini, due/tre donne, un bambino. Persino la distribuzione dei singoli reperti tra gli individui dello stesso sesso risultava molto difficile.
I risultati delle datazioni sono più avanti riportati da Elsa Pacciani.
La PorcarecciaLa necropoli di La Porcareccia si trova nel
comune di Pitigliano (GR); venne scoperta da Ferrante Rittatore Vonwiller nel 1966, quando fu informato da alcuni scavatori clandestini della presenza di alcune tombe a forno. Dopo la prima campagna di scavi effettuata con la collaborazione di Leone Fasani e Adriana Soffredi, in cui vennero alla luce sette sepolture, l’anno successivo F. Rittatore dovette constatare altri interventi clandestini che avevano portato alla scoperta di ulteriori quattro tombe28.
La necropoli venne parzialmente pubblicata su Sibrium da L. Fasani (Fasani et alii 1964/66) e sulla Rivista di Scienze Preistoriche da F. Ritta-tore (Rittatore Vonwiller 1964/66).
Dopo queste pubblicazioni sommarie il sito è stato riconsiderato e studiato da Nuccia Negroni Catacchio nel 1992 (Negroni Catacchio 1992),
28 In una relazione di Rittatore del 1968 si fa cenno alla pos-sibilità che le sepolture fossero circa 15 o 16, ma di queste tombe non è rimasta alcuna documentazione, ad eccezione della tomba 12 pubblicata da N. Negroni Catacchio (Negroni Catacchio 1992, pag. 209).
95Nuovi dati su alcune necropoli rinaldoniane. Revisione di vecchi scavi, nuove datazioni
che riconsiderando i dati di scavo e le relazioni inviate da F. Rittatore alla Soprintendenza Arche-ologica della Toscana, ha portato ad una pubbli-cazione definitiva del contesto.
La collocazione è nota: la necropoli si trova nel territorio di Pitigliano (Foglio IGM 136 IV SE Ponte San Pietro. lat. 42°34’12’’ N – long. 10°50’05’’ E) e prende il nome dalla località su cui insiste il sito: un pendio della collina di Grotta Nuova, in un terreno, che al momento dello scavo, era di proprietà del Sig. Jonio della Morte.
Le sepolture erano allineate in maniera mol-to irregolare lungo il lato sud-ovest del pendio, e purtroppo il numero esatto delle tombe non è chiaro: secondo F. Falchetti erano 13 (Falchetti 1977), mentre F. Rittatore nella sua pubblicazione (Rittatore 1964/66) parla di 12 tombe, ma, come già riportato in nota, potrebbero essere 15 o 16 secondo una relazione inviata da F. Rittatore alla Soprintendenza.
La tomba 4 (fig. 9), i cui resti ossei sono stati ora datati, è l’unica scavata interamente in manie-ra scientifica; si tratta di una tipica tomba a grot-ticella artificiale con camera a pianta sub-ellittica e con accesso semplice; presentava la volta com-
pletamente crollata, ma i livelli di deposizioni erano intatti.
All’interno erano conservate quattro sepoltu-re: due in connessione anatomica al centro della cella (numeri 3 e 4) e altre due corrispondevano ai resti di due individui (numeri 1 e 2) manipolati e raggruppati disordinatamente lungo la parete di fondo.
Il corredo comprendeva: un vaso a fiasco con corpo globulare, collo cilindrico medio e fondo piatto, decorato a stralucido con un motivo me-topale (fig. 9, 1), un’olla ovoide con quattro pre-se (fig. 9, 2), un pugnale in rame a base semplice e lama piatta con tre fori per i ribattini (fig. 9, 4), un frammento di ciotola troncoconica (fig. 9, 5), un frammento di ciotola carenata, un frammento di vasetto biconico e due frammenti di vaso a fiasco, più precisamente una parete decorata con bugna (fig. 9, 6) e un orlo a colletto con bugna (fig. 9, 3).
Nel 1967, come già detto, venne constatata la presenza di almeno altre cinque tombe di cui rimangono sommarie descrizioni e rilievi poco accurati. Un dato da sottolineare è la distanza notevole tra i due gruppi (tra la tomba 1, ulti-
Fig. 8 - Necropoli di Chiusa d’Ermini. Corredo della tomba 1 (Ischia di Castro – VT) (da Aspesi 2012) (1-2 scala 1:3; 2-3 scala 1:2).
Chiusa d’Ermini Necropolis. Grave-goods from tomb 1 (Ischia di Castro – VT) (after Aspesi 2012) (1-2 scale 1:3; 2-3 scale 1:2).
96 Nuccia Negroni Catacchio, Elsa Pacciani, Erika Albertini, Matteo Aspesi, Jacopo Moggi-Cecchi
ma del primo gruppo e la tomba 8, prima del secondo gruppo, la distanza è di almeno 35 m); inoltre il secondo gruppo presenta un orienta-mento leggermente divergente rispetto al primo: le tombe sono orientate più marcatamente verso sud (Negroni Catacchio 1992, fig. 1). I risultati delle datazioni sono più avanti riportati da Elsa Pacciani.
Le nuove datazioni (Elsa Pacciani)
Nell’ambito del progetto “La facies di Rinal-done: nuove datazioni” sono stati selezionati 12 campioni, di cui 4 da Chiusa d’Ermini, 3 da La Porcareccia e 5 da Poggialti Vallelunga, che ven-gono descritti nella Tabella 1.
Le sigle identificative degli individui sono quelle riportate sulle ossa a seguito della revisio-ne dei materiali, e corrispondono quindi al cata-logo ufficiale del Museo, aggiornato in occasione della revisione stessa.
Il prelievo dei campioni è stato eseguito dall’osso compatto delle diafisi delle grandi ossa lunghe. Sono state prescelte quelle incomplete e le aree prive di punti metrici o morfologici di valenza antropologica, così da ridurre al mini-mo la distruttività dell’operazione e non com-promettere la possibilità di altri studi. Ad ogni buon conto sono stati fotografati tutti i campioni prima e dopo il prelievo. La figura 10 ne riporta due esempi.
Per quanto riguarda Chiusa d’Ermini e La Porcareccia, le diafisi erano piuttosto consistenti
Fig. 9 - Necropoli di La Porcareccia (Pitigliano – GR). Corredo della tomba 4 (da Negroni Catacchio 1992) (1-3, 5-6 scala 1:3; 4 scala 1:2).
La Porcareccia Necropolis (Pitigliano – GR). Grave-goods from tomb 4 (after Negroni Catacchio 1992) (1-3, 5-6 scale 1:3; 4 scale 1:2).
97Nuovi dati su alcune necropoli rinaldoniane. Revisione di vecchi scavi, nuove datazioni
e talvolta il canale midollare era riempito di un sedimento calcareo. Si è asportato comunque sen-za difficoltà un segmento di 2-4 cm dall’estremità diafisaria fratturata, mediante taglio con un se-ghetto manuale (fig. 10 b).
Per quanto riguarda Poggialti Vallelunga, dove le ossa erano per lo più frammentarie, sono state selezionate quelle più complete, da cui sono stati prelevati gruppi di frammenti già distaccati (fig. 10 a).
I campioni sono stati inviati al CEDAD (Cen-tro di Datazione e Diagnostica dell’Università del Salento), per la datazione col metodo del radio-carbonio mediante la tecnica della spettrometria di massa ad alta risoluzione (AMS). Le tecniche di pretrattamento e di datazione sono descritte da D’Elia et alii (2004), Quarta et alii (2004) e Cal-cagnile et alii (2005).
La datazione è stata calibrata in età di calendario, utilizzando la curva INTCAL 13 ed il software OxCal Ver. 4.2.
I risultati sono presentati nella Tabella 2, sia come datazione non calibrata, con l’errore assoluto della misura, sia come datazione calibrata (livello di confidenza 2σ).
Non è stato possibile datare il campione dell’individuo 4 (POR.IV,4) di La Porcareccia e nessuno dei campioni di Poggialti Vallelunga, poiché questi non hanno restituito collagene.
Vengono riportati anche i grafici delle curve di distribuzione delle probabilità, con livelli di confidenza 1σ e 2σ (fig. 11), per dare la possibi-lità di analizzare in modo più dettagliato i picchi di probabilità all’interno dell’intervallo com-plessivo.
Le recenti datazioni: conclusioni
1. La cronologia di Rinaldone (Nuccia Negroni Catacchio)
Le datazioni di questi ultimi anni hanno per-messo un inquadramento abbastanza convincente della cronologia di Rinaldone; in particolare, il prezioso lavoro di riepilogo delle diverse recenti datazioni di Alessandra Manfredini (2012) mette chiaramente in luce che l’arco di tempo è molto ampio, compreso allo stato attuale degli studi tra il secondo quarto del IV millennio e l’inizio del II, e che è possibile suddividere il periodo in al-meno tre momenti:
Una fase antica compresa tra il secondo quarto e la metà del IV millennio. In particolare la data più antica (3710 - 3630 BC cal 1σ) pro-viene dall’individuo 1 della tomba 29 della ne-cropoli di Osteria del Curato, via Cinquefrondi. A questa stessa fase si possono collegare le date più alte di altre necropoli come Ponte San Pietro e Selvicciola, in particolate le tombe 7 (3590-3530 BC cal 1σ), 21 (3670-3635 BC cal 1σ) e 23 (3640-3550 BC cal 1σ) di Ponte San Pietro e la tomba 23 della Selvicciola (3640-3560 BC cal 1σ). In questo periodo rientra anche la tomba 2 di Garavicchio, sia con la data dell’individuo articolato maschile, (3632-3374 cal 2σ) sia con quelle dell’individuo femminile disarticolato (3632 – 3374 BC cal 2σ e 3641 – 3384 BC cal 2σ), entrambe fornite dalla stessa fibula dello stesso individuo.
Una fase media compresa tra la metà e la fine del IV millennio. Nella seconda fase si inse-riscono numerose datazioni ottenute dalle tombe 5, 6, 8, 14 di Selvicciola e dalle tombe 19 e 25
Fig. 10 a (sopra) e b (sotto) - Due esempi di campioni prelevati.
Two examples of extracted samples.
a
b
98 Nuccia Negroni Catacchio, Elsa Pacciani, Erika Albertini, Matteo Aspesi, Jacopo Moggi-Cecchi
Sito Tomba Individuo (sigla) N. Inventario
Parte anatomica e modalità di prelievo Peso (gr)
Chiusa d’Ermini
I 1 (C.E. I,1) 6442 Tibia destra, parte inferiore della diafisi* 10I 4 ( C.E. I,4) 6445 Tibia sinistra, parte inferiore della
diafisi**9
III M (C.E. III, M.F.1) 6453 Femore destro, parte inferiore della diafisi*
23
III F (C.E. III, F.F.1) 6454 Femore destro, parte superiore della diafisi*
17
La Porcareccia IV 1 (POR.IV,1) 6433 Perone sinistro, parte inferiore della diafisi*
4
IV 3 (POR.IV,3) 6435 Tibia destra, parte inferiore della diafisi*
10
IV 4 ( POR.IV,4) 6436 Tibia sinistra, circa a metà diafisi* 10Poggialti Vallelunga
3 (P.G.V. T3) - Femore destro, parte superiore della diafisi***
40
4 A ( P.G.V. T4, Ind.A)
- Femore destro, parte superiore della diafisi***
9
4 B ( P.G.V. T4, Ind.B)
- Femore destro, parte inferiore della diafisi***
10
5 ( P.G.V. T5) - Frammenti di diafisi 198 ( P.G.V. T8) - Frammenti di diafisi 20
Tab. I - Elenco dei 12 campioni prelevati.
List of the 12 taken samples.
* Prelievo eseguito mediante sezione anulare della diafisi, con seghetto
** Distacco con acqua di un frammento in precedenza incollato
*** Distacco manuale di frammenti
1 2 3 4 5 6 7 8Sito Tb. Individuo N. Inv. Codice
Lab.Datazionenon cal.(BP)
δ 13C (‰) Datazione cal. BC 2σ (95.4% probabilità)
Chiusa d’Ermini
I 1 (C.E. I,1) 6442 LTL12526 4550 ± 45 -15.9±0.5 3490BC - 3471BC ( 2.6%)3373BC - 3097BC (92.8%)
I 4 (C.E. I,4) 6445 LTL12527 4424 ± 45 -19.0±0.2 3331BC - 3214BC (24.0%)3186BC - 3156BC (4.3%)3128BC - 2918BC (67.1%)
III M(C.E.III,M.F.1) 6453 LTL12529 3964 ± 45 -24.5±0.2 2580BC - 2336BC (93.8%)2324BC – 2307BC (1.6%)
III F(C.E.III, F.F.1) 6454 LTL12528 4609 ± 45 -21.5±0.5 3620BC - 3320BC (0.4%)3521BC – 3323BC (82.5%)3233BC - 3172BC (6.9%)3163BC – 3117BC (5.6%)
La Porcareccia
IV 1 (POR.IV,1) 6433 LTL12530 3635 ± 45 -24.5±0.5 2136BC - 1894BC (95.4%)IV 3 (POR.IV,3) 6435 LTL12531 4323 ± 45 -21.1±0.5 3086BC - 3061BC (4.5%)
3030BC - 2881BC (90.9%)
Tab. II - Datazioni AMS, non calibrate, in anni BP, con l’errore assoluto della misura (colonna 6), e calibrate, con livello di confidenza 2σ (colonna 8).
AMS dates, uncal. BP and cal. BC 2 σ.
99Nuovi dati su alcune necropoli rinaldoniane. Revisione di vecchi scavi, nuove datazioni
Fig. 11 - Grafici relativi alle curve di distribuzione delle probabilità con livelli di confidenza 1 σ e 2σ.
Graphs showing likelihood distribution curves, with a confidence interval of 1 σ and 2 σ.
di Ponte San Pietro. Proprio da Selvicciola e in particolare dalla tomba 8 provengono la data più alta (3520-3360 BC cal 1σ) e quella più bassa (3020-2870 BC cal 1σ). A questo momento sono riferibili le datazioni delle tombe 1 e 3 di Chiusa d’Ermini.
Una fase tarda corrispondente all’intero III millennio. L’ultima fase si sviluppa lungo l’ar-co del III millennio: la data più antica è fornita, ancora una volta, dalla necropoli di Selvicciola,
tomba 1 (2920-2870 BC cal 1σ). Molte datazioni dell’area a sud del Tevere appartengono a questo arco cronologico. In particolare la data più bassa è stata riscontrata nella tomba 38 della necropoli di Romanina (2040-1930 BC cal 1σ). Appare evi-dente la lunga durata di questa realtà archeologi-ca che, come testimonia la tomba 2 di Fontanile di Raim, arriva a sovrapporsi alla facies del Vaso Campaniforme (tomba 2 di Fontanile di Raim: 2290-2190 BC cal 1σ). Le datazioni della necro-
100 Nuccia Negroni Catacchio, Elsa Pacciani, Erika Albertini, Matteo Aspesi, Jacopo Moggi-Cecchi
poli della Porcareccia e quella dell’individuo ma-schile della tomba 3 di Chiusa d’Ermini sono da inserire in questa fase.
Naturalmente questo è un discorso di carattere generale per il quale si è tenuto conto di tutte le datazioni finora note, anche se esse non sono del tutto omogenee e confrontabili, perché risalenti ad epoche diverse, effettuate in laboratori diversi e, per quelle più vecchie, con una tecnologia meno aggiornata di quella odierna; così il confronto tra datazioni calibrate a1 σ e quelle calibrate a 2σ con-tiene certamente un margine di errore: tuttavia ci permette di ricostruire un quadro forse non del tutto preciso, ma generale, da cui la ricerca futura potrà partire per nuove precisazioni e approfondimenti.
Queste datazioni, alle quali si aggiungono quelle nuove qui riportate, inducono ad alcune considerazioni:1. Allo stato attuale delle datazioni, Rinaldone
è di poco posteriore al Gruppo marchigiano. Il Gruppo Roma - Colli Albani è invece del tutto coevo all’area nucleare rinaldoniana, che si sviluppa nel medio corso del fiume Fiora. Sebbene i due gruppi siano intervallati da una zona compresa, grosso modo, tra Tarquinia e Roma in cui i rinvenimenti sono più rari, le date di inizio e di fine delle corrispondenti necropoli sono del tutto analoghe.
2. Considerando il Gruppo marchigiano come un polo della cultura rinaldoniana, si può osservare che i tre gruppi coesistono solo nel momento più antico, durante il IV millennio, mentre il gruppo eponimo e quello laziale appaiono tra loro sostanzialmente contemporanei e della medesima durata.
3. Nel momento finale Rinaldone è contemporaneo al Vaso Campaniforme, con cui sembra convivere, almeno nella tomba 2 di Fontanile di Raim (2290-2190 BC cal 1σ) ( Manfredini 2012, Negroni Catacchio e Miari 2001; Petitti et alii 2002).
5. Appare caratteristica del Rinaldone tirrenico la lunga durata (circa 1500 anni) non solo della facies culturale in sé, ma anche delle singole necropoli e persino di alcune singole tombe (Negroni e Aspesi cds2).
2. I nuovi dati (Nuccia Negroni Catacchio, Matteo Aspesi)
Prendendo in esame questi nuovi dati e met-tendoli a confronto con quanto sopra esposto circa la cronologia della cultura di Rinaldone, si
possono trarre alcune interessanti conclusioni, che vengono a rafforzare quanto in precedenza si era già intuito.
La necropoli di Ponte San Pietro risulta attual-mente la più antica, con inizio nel primo quarto del IV millennio, confermando l’impressione, per ora solo una ipotesi affascinante, che sia stata la prima ad essere costruita e che la tomba detta “della Vedova”, contenga i resti, mai più disturba-ti, degli “antenati” fondatori.
Anche la datazione della necropoli di Garavicchio è alta e sembra indicare un precoce interesse delle genti di Rinaldone per uno sbocco sul Mar Tirreno
Tra le datazioni effettuate con il contributo dell’IIPP, la data più alta proviene da uno scheletro femminile della tomba 3 di Chiusa d’Ermini (C.E. III F 3521 – 3323 BC cal 2σ) e inserisce questa necropoli nel momento finale della fase antica o iniziale della fase media di Rinaldone.
La stessa tomba sembra durare almeno un migliaio di anni (C.E. III M 2580 - 2336BC cal 2σ) e quindi viene usata fino al periodo tardo.
La tomba 1 è un ossuario con corredo anche metallico, dato questo abbastanza raro: si pone nella fase media (C.E. I, 1 3373 - 3097 BC cal 2σ e C.E. I, 4 3128 - 2918 BC cal 2σ).
La necropoli di La Porcareccia sembra collocarsi, in base alle datazioni della tomba 4, nella parte tarda e finale di Rinaldone (POR. IV, 3 3030 - 2881 BC cal 2σ e POR. IV, 1 2136- 1894 BC cal 2σ).
Anche in questo caso l’uso della tomba è durato circa 1000 anni ed è possibile osservare che le ossa più antiche sono quelle soggette a manipolazione post-mortem, mentre quelle più recenti sono in connessione anatomica al centro della camera.
Da questa tomba proviene uno dei più bei vasi a fiasco di tutto il Rinaldone, con decorazione a stralucido a scansione metopale: appare quindi probabile che lo stralucido compaia all’inizio del-la facies (è presente già nella tomba detta “della vedova” di Ponte San Pietro) e sia presente anche nella sua parte finale.
Le nuove analisi dei resti scheletrici (Erika Albertini, Jacopo Moggi-Cecchi, Elsa Pacciani)
1. IntroduzioneIl lavoro consiste in una revisione e uno
101Nuovi dati su alcune necropoli rinaldoniane. Revisione di vecchi scavi, nuove datazioni
studio integrativo dei reperti scheletrici umani delle necropoli rinaldoniane di Ponte San Pietro, La Porcareccia, Chiusa d’Ermini e Garavicchio, scavate da Cardini e Rittatore Vonwiller dagli anni ’40 agli anni ’60 (Cardini 1946, 1955; Cardini e Rittatore 1948, 1950, 1955; Rittatore 1942, 1959, 1964-66).
Tutti i reperti sono stati studiati e pubblicati da Parenti (1963, 1965, 1967, 1970); i resti di due tombe di Ponte San Pietro erano già stati oggetto di analisi da parte di Graziosi (1948); una descrizione paleopatologica di due elementi ossei fu pubblicata da Milanesi (1963); la determinazione dei gruppi sanguigni del campione di Ponte San Pietro fu eseguita da Borgognini et alii (1967); infine uno studio paleopatologico di quest’ultimo fu condotto da Formicola e Garulli (1988).
L’impulso a riprendere in mano questo materiale deriva da un concorso di evenienze:- la recente edizione di lavori di rielaborazione
archeologica comprendenti alcune di queste necropoli (Negroni Catacchio et alii 2005; Conti et alii 2006; De Marinis 2006; Sarti 2006; Cocchi Genick 2009; Manfredini et alii 2009; Dolfini et alii 2011; Aspesi 2012), che hanno proposto nuovi sistemi interpretativi e nuovi criteri per la ricostruzione della struttura sociale delle comunità eneolitiche rinaldoniane;
- le datazioni assolute eseguite di recente da Manfredini et alii (2009) e da Dolfini et alii (2011) e quelle nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “La facies di Rinaldone: nuove datazioni” i cui risultati vengono qui presentati;
- l’opportunità di effettuare una verifica della consistenza e dello stato di conservazione attuale dei campioni ed eventuali trattamenti di restauro resisi necessari col passare del tempo;
- la possibilità di integrare gli studi di Parenti, a distanza di più di quarant’anni dalla loro pubblicazione, alla luce dei nuovi campi di indagine antropologica rivolti principalmente a delineare un profilo paleobiologico dei gruppi umani includente gli aspetti economici, socio-ambientali e culturali.
- il progetto in corso, di cui è responsabile Jacopo Moggi-Cecchi, di revisione di tutti i materiali antropologici di epoca preistorica conservati
presso la sezione di Antropologia e Etnologia del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze.
2. Materiali e metodiIl materiale osteologico revisionato è conservato
nel Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, sezione di Antropologia ed Etnologia ed è catalogato nei Volumi XI e XII dell’Inventario della Collezione Antropologica del Museo.
Per quanto riguarda lo stato di conservazione dei resti scheletrici, la buona consistenza delle ossa recuperate dal sito di Ponte San Pietro sembra dovuta ad un lento e graduale processo di calcificazione per scambio diagenetico con lo strato calcareo sedimentatosi sul fondo delle tombe a forno (De Angeli; in Rittatore 1942).
Il materiale scheletrico recuperato nella necro-poli di Chiusa d’Ermini, distante poco più di 3 km da Ponte San Pietro, mostra invece condizioni di conservazione molto diverse: i resti si presentano non solo molto frammentari, ma anche profonda-mente alterati sulla superficie e nella struttura. Il primo fattore responsabile del degrado deve essere stata l’acidità dei tufi vulcanici del suolo di deposi-zione, insieme all’azione delle radici penetrate nel-la cella a seguito del crollo della volta della tomba. Sebbene anche in questo caso al di sotto degli strati di crollo fosse presente un compatto deposito di cal-care pulverulento che inglobava i resti ossei (Car-dini 1950), probabilmente la sedimentazione degli strati calcarei è stata talmente lenta da essere pre-ceduta dall’azione disgregante dell’acidità. Questo stato di conservazione dei resti ha anche impedito, come riferisce lo stesso Cardini, un loro completo recupero tanto che, in numerosi casi, è stato possi-bile estrarre solamente il cranio che, quantomeno, ha permesso una parziale stima del Numero Mini-mo di Individui (NMI) deposti nelle tombe.
Le ossa provenienti dalla vicina necropoli di La Porcareccia devono aver subìto lo stesso decorso diagenetico dal momento che anche in questo caso le tombe sono ricavate da un piano-ro tufaceo. I resti scheletrici, recuperati solo par-zialmente, sono rappresentati principalmente dai distretti cranici, peraltro tutti frammentari, e le poche ossa lunghe presenti sono frammentarie e prive delle regioni epifisarie.
Anche i resti umani della necropoli di Garavicchio sono stati estratti solo parzialmente e sono molto frammentari; inoltre vi si riconoscono
102 Nuccia Negroni Catacchio, Elsa Pacciani, Erika Albertini, Matteo Aspesi, Jacopo Moggi-Cecchi
incrostazioni di natura calcarea e, soprattutto, solchi, erosioni e macchie di colore scuro sulla superficie provocati dalle radici delle piante infiltratisi nelle cavità tombali. Anche in questo caso gli elementi pertinenti allo scheletro post-craniale sono rappresentati principalmente dalle ossa lunghe degli arti, tutte incomplete nei distretti epifisari.
Nel corso della revisione si è reso necessario un lavoro di restauro che, oltre a migliorare lo stato di conservazione e la stabilità dei resti, ha permesso in vari casi nuove associazioni e attribuzioni di elementi ossei a determinati individui e quantomeno di giungere ad un corretto numero minimo degli individui presenti (NMI); infine si è talvolta proceduto ad una nuova pulitura con rimozione meccanica della matrice calcarea, mettendo meglio in luce caratteri anatomici o patologici. La ricomposizione dei frammenti è stata effettuata utilizzando come collante una resina acrilica termoplastica con un buon grado di reversibilità, diluita in acetone.
La revisione è stata impostata procedendo ad un primo confronto tra i dati presentati nei lavori di Parenti e l’inventario del Museo. Inoltre si è fatto ricorso anche alla consultazione dei diari di scavo Cardini, al fine di tentare una ricostruzione tafonomica e di verificare la corrispondenza con i dati di Parenti. Nonostante le preziose informa-zioni giaciturali non è stato possibile ottenere in-formazioni tafonomiche precise dal momento che non si dispone né della documentazione grafica in scala né di quella fotografica.
Le analisi antropologiche condotte da Parenti riguardano l’identificazione degli individui o la determinazione del numero minimo di individui, la diagnosi dell’età e del sesso, le misure antro-pometriche e i caratteri morfologici individuali, la definizione delle caratteristiche tipologiche e le relative elaborazioni statistiche. Nelle pubbli-cazioni sono inserite anche alcune tavole icono-grafiche dei crani. Alle pubblicazioni dell’Autore si rimanda per quanto riguarda gli aspetti antro-pometrici, mentre vengono qui riportati i nuovi dati riguardanti recenti campi di indagine antropologica, quali lo stile di vita e lo stato di salute degli individui, e alcune discordanze riguardanti il NMI, la diagnosi dell’età e del sesso. A seguito della revisione si è aggiornato il catalogo e la siglatura delle ossa.
La diagnosi del sesso è stata effettuata
utilizzando i metodi di Açsádi e Nemeskéri (1970), Pearson (1917), Olivier (1960). Data l’incompletezza degli individui e delle ossa, la diagnosi, è stata espressa secondo tre gradi di probabilità: 1 altamente probabile; 2 probabile; 3 verosimile.
L’età alla morte degli individui di età infantile e giovanile è stata valutata attraverso il grado di sviluppo ed eruzione dentaria (Brown 1985), le lunghezze massime diafisarie delle principali ossa lunghe (Stloukal e Hanakova 1978) e lo stadio di saldatura tra epifisi e diafisi (France e Horn 1988).
Per gli individui adulti sono stati utilizzati vari criteri: variazioni morfologiche della sinfisi pubica (Suchey et alii 1986), della superficie auricolare dell’ileo (Lovejoy et alii 1985) e dell’estremità sternale delle coste (Iscan et alii 1984), stadio di obliterazione delle suture ectocraniche (Meindl e Lovejoy 1985), usura dentaria (Brothwell 1981). Gli individui sono stati suddivisi secondo sei classi di età: Infante I (0-6 anni); Infante II (7-12 anni); Giovane (13-19 anni); Adulto giovane; Maturo; Anziano.
Tra gli aspetti indicativi dello stile di vita e delle condizioni socio-ambientali sono stati considerati: il grado di dimorfismo sessuale (Hall 1982), il grado di lateralizzazione degli arti (Schultz 1937) come indicatore di un maggiore impegno muscolare a carico di un arto rispetto all’altro, gli indicatori muscolo-scheletrici di stress occupazionale (Mariotti et alii 2004, 2007).e gli aspetti paleopatologici29.
3. La revisioneDi seguito si riporta per ciascuno dei quattro
siti un elenco analitico delle tombe che hanno re-stituito resti scheletrici, presentando alcuni nuovi dati relativi al NMI, al sesso e all’età alla morte e sottolineando eventuali punti di divergenza rispetto al lavoro di Parenti. L’ordine seguito per le tombe di Ponte San Pietro fa fede alla numerazione de-finitiva del 1955-59 su cui si è basato il lavoro di riordino eseguito da Monica Miari (1993), mentre di fianco al numero definitivo si riporta anche il nu-mero dato da Parenti così da facilitare la compren-
29 In merito a questo tipo di indagine un sentito ringrazia-mento va al paleopatologo Dottor Filiberto Chilleri per i pre-ziosi consigli e il fondamentale aiuto nella revisione degli aspetti patologici rilevati
103Nuovi dati su alcune necropoli rinaldoniane. Revisione di vecchi scavi, nuove datazioni
sione dei nomi assegnati agli individui. A conclu-sione dell’elenco presentato i dati saranno sintetiz-zati per ciascun sito in tabelle comparative. Per le informazioni archeologiche e giaciturali si riman-da ai lavori di sintesi editi per ciascun sito (Miari 1993; Negroni Catacchio 1992; Aspesi 2012, Id. cds; Aranguren et alii 1987-1988).
Ponte San PietroTomba 1- Tomba X (Parenti 1963, 1970). La
revisione del materiale scheletrico conferma quanto stimato da Parenti (1970), secondo cui i resti sono pertinenti ad un soggetto maschile di età matura (X,1) ed uno femminile adulto giova-ne (X,2). Tuttavia sono necessarie alcune pun-tualizzazioni: per prima cosa si è riscontrata una certa confusione nella siglatura dei resti, alcuni dei quali presentavano i numeri di inventario di entrambi gli individui, per cui l’attribuzione del-le ossa all’uno o all’altro è stata effettuata solo sfruttando le differenze dimensionali e per alcu-ni elementi estremamente frammentari non può considerarsi certa. Lo stato di incompletezza del materiale osteologico ha permesso infine solo una diagnosi di grado 2 riguardo al sesso degli individui, mentre quella dell’età alla morte è stata possibile grazie alla presenza della superficie au-ricolare dell’ileo per l’individuo 1 e dei denti per l’individuo 2.
Tomba 7- Tomba VIII (Parenti, 1963, 1970). Il lavoro di revisione concorda con l’analisi di Pa-renti (1963, 1970) che aveva riferito i resti a cin-que individui, di cui quattro adulti e un bambino.
Tomba 10- Tomba I (Graziosi 1948;Parenti 1963). Tomba 11- Tomba II (Graziosi 1948; Pa-renti 1963). Il materiale osteologico recuperato venne studiato da Graziosi (1948) purtroppo sen-za distinguere la pertinenza dei resti a ciascuna delle tombe. L’Autore si limitò all’analisi accura-ta dei crani meglio conservati (IA, IIA) dei qua-li non venne specificata la provenienza tombale, anche se dalle pubblicazioni di Graziosi prima e Parenti poi (1963) sembra possibile che siano da attribuire l’uno alla tomba 10 e l’altro alla tomba 11. Oltre a questi Graziosi riferiva della presenza di altre due calotte (IIIA, IVA) in pessimo stato di conservazione e di cui di nuovo non venne indi-cata la tomba di appartenenza, ma stando ai reso-conti editi è possibile che provenissero entrambi dalla tomba 10. Inoltre nel corso della revisione si è riscontrata la presenza di quattro mandibole non associabili alle calotte craniche che insieme ai crani hanno condotto ad una stima del NMI di quattro o al massimo cinque individui adulti. Anche i resti post-craniali, riferiti da Graziosi ad almeno tre soggetti maschili e tre femminili, fu-rono descritti brevemente e non ne venne indicata la tomba di provenienza. Il NMI risultante è di
Ponte San PietroParenti (1963, 1970) Revisione del materiale
Tombe n. inumati Adulti Sudadulti n. inumati Adulti Subadulti
1 2 2 / 2 2 /
7 5 4 1 5 4 1
tt. 10-11 NS (6?) 6 (?) / Almeno 8 5 o 6 2 (?)
14 4 4 / 3 3 /
15 2 2 / 2(+1) 2(+1) /
16 1 1 / 1 1 /
19 6 5 1 10 6 4
21 2 2 / 2 2 /
22 5 5 / 5 5 /
23 2 2 / 3 1 2
25 1 1 / 1 1 /
Totale 36 34 2 43 34 9
Tab. III - Ponte San Pietro. NMI calcolato da Parenti (1963, 1970) e nel corso della presente revisione.
Ponte San Pietro. NMI after Parenti (1963, 1970) and after this revision.
104 Nuccia Negroni Catacchio, Elsa Pacciani, Erika Albertini, Matteo Aspesi, Jacopo Moggi-Cecchi
cinque o sei individui adulti e due soggetti suba-dulti di cui uno, rappresentato dalla sola scapola destra, di circa un anno di età e l’altro, di cui si conserva l’omero destro, di 5-6 anni.
Tomba 14- Tomba IX (Parenti 1970). La tom-ba, secondo quanto risulta dalla documentazione Cardini, conteneva i resti di due inumati scarsa-mente rappresentati e non in buone condizioni di conservazione. Nell’analisi sui resti scheletrici, Parenti riferisce dell’impossibilità di giungere ad una ricostruzione individuale, per cui l’Autore ha preferito distribuire i frammenti raccolti in due complessi, riunendo nel primo gli elementi con caratteristiche maschili e nel secondo quelli dotati di caratteristiche femminili. Nel corso della revi-sione del materiale è stata tentata, per alcuni degli elementi riconosciuti come femminili, una rico-struzione individuale e ciò è stato possibile grazie alla giovane età di uno dei due soggetti che pre-sentava, su alcune ossa lunghe, la linea epifisaria ben visibile, indicante un’età alla morte tra i 18 e i 21 anni. A riguardo, nonostante Cardini abbia riferito della presenza di un mascellare di aspetto giovanile, l’elemento deve essere andato perduto presumibilmente prima dell’analisi di Parenti, vi-sto che l’Autore non ne fa alcun cenno.
In merito ai resti identificati da Parenti come pertinenti a soggetti maschili, rispetto all’elenco da lui fornito è assente un femore destro per cui il MNI risultante è minore: tre individui, a fronte dei quattro riconosciuti da Parenti.
Tomba 15- Tomba III (Parenti 1963). Il NMI concorda con quanto osservato da Parenti e cioè che le ossa fossero pertinenti a due individui: uno di sesso maschile (III,1), maggiormente rappre-sentato, e il secondo di sesso femminile (III,2) di cui si conserva la sola tibia sinistra. In merito a quest’ultimo individuo non si ritiene ci siano ab-bastanza elementi per una stima attendibile del sesso in ragione non solo della presenza di un uni-co osso, ma anche della giovane età del soggetto che risulta, per la permanenza della linea epifisa-ria, di poco superiore ai 18 anni. Infine sono state rinvenute due tibie, due fibule e alcune ossa dei piedi, in un sacchetto in cui non era specificata la provenienza tombale ma che sulla base del car-tellino risultavano recuperati durante gli scavi del 1948. Queste ossa potrebbero appartenere proprio alla tomba 15 se si considera che nel corso dello
scavo vennero indagate solamente due tombe, la 15 e la 17, la seconda delle quali non venne sca-vata per non compromettere il possibile recupero dei reperti inglobati nella massa calcarea (Rittato-re 1951). Se così fosse andrebbe riconsiderato il NMI totale della tomba. Questi resti, a cui Parenti non fa riferimento, sono presumibilmente perti-nenti ad uno stesso individuo maschile.
Tomba 16- Tomba VI (Parenti,1963, 1970). L’analisi concorda con quella condotta da Parenti (1963) secondo cui il cranio recuperato è perti-nente ad un adulto di sesso maschile. Le ossa del-le mani, a cui fa riferimento la documentazione pubblicata per la tomba, risultavano assenti già all’epoca dello studio dell’Autore.
Tomba 19-Tomba V (Parenti,1963, 1970). Sul-la base della documentazione Cardini la tomba conteneva resti umani appartenenti a tre individui ancora in connessione anatomica (uno maschile, uno femminile e un subadulto di 6-7 anni) e ossa disarticolate comprendenti tre crani di adulti e uno di un bambino di meno di un anno. Anche Miari (1993), grazie ad una notizia riportata da Falchetti (1971-72), aveva riferito della presenza, tra le ossa disarticolate, dei resti pertinenti ad un neonato, spe-cificando che la presenza di tali ossa non era stata riportata da Parenti (1963) e presupponendo di con-seguenza che la loro fragilità non ne avesse permes-so il recupero. Tuttavia durante l’attuale revisione del materiale sono state rinvenute, col numero di inventario 6420 Bis, numerose ossa che dopo un’a-nalisi accurata sono risultate appartenenti ad un ne-onato di circa 9 mesi di età con il cranio incompleto e lo scheletro postcraniale ben rappresentato.
Un’altra osservazione riguarda un individuo recuperato tra quelli frammisti, per il quale già fu riscontrata una certa confusione nell’attribu-zione di alcuni elementi anatomici (Borgognini 1967). Sebbene Parenti (1963) riporti la docu-mentazione fotografica del cranio in articolazio-ne con la mandibola nelle quattro norme (tavola XIII), si è constatata un’ associazione probabilmente errata della mandibola con il cranio per cui i due elementi dovrebbero essere considerati separatamente, e ciò aumenterebbe il NMI. In ogni caso il NMI indicato da Parenti deve essere corretto a causa del rinvenimento, tra le ossa frammiste, di quattro ossa coxali in buone condizioni di conservazione le cui caratteristiche anatomiche permettono di escludere una loro
105Nuovi dati su alcune necropoli rinaldoniane. Revisione di vecchi scavi, nuove datazioni
associazione agli individui già identificati e di riferirli piuttosto a due ulteriori soggetti di età di poco superiore ai 18 anni e ad un terzo, adulto giovane. La presenza di questi elementi fa salire perciò a dieci il NMI.
Tomba 21 o dell’Intruso Superiore-Tomba IV (Parenti,1963, 1970). Non si riscontrano punti di divergenza con quanto osservato da Parenti (1963) secondo cui i resti scheletrici sono pertinenti a due individui, uno maschile e l’altro femminile, entrambi anziani.
Tomba 22 o dell’Intruso Inferiore-Tomba IV (Parenti,1963, 1970). Si conferma il NMI indicato da Parenti, ma il nuovo restauro effettuato tenendo conto dei frammenti presenti tra il materiale non attribuito ha permesso una stima più precisa del sesso e dell’età alla morte. Dei cinque individui identificati ne risultano tre di sesso femminile di cui uno maturo (IV,3) e due adulti giovani (IV,4x-IV,4y) e due maschili, uno di età anziana (IV,2) e l’altro adulto giovane.
Tomba 23-Tomba XII (Parenti 1970). Si è riscontrato un NMI differente da quello di Parenti; inoltre si è potuta riconoscere un’errata attribuzione di alcuni elementi anatomici e si è stimata una diversa età alla morte per entrambi gli inumati, che Parenti aveva riferito ad una donna adulta giovane (XII,1) e una di età matura (XII,2). In primo luogo quelli che erano stati identificati come due crani incompleti sono risultati, al termine di un lavoro di restauro, un cranio unico (XII,2). Inoltre lo scheletro 1 è risultato un subadulto di 14-15 anni sulla base di un’accurata analisi dei denti sparsi presenti e del grado di saldatura epifisaria di alcune ossa lunghe, tra l’altro in parte erroneamente attribuite dall’Autore all’individuo 2. Anche per il soggetto femminile XII, 2 è stato possibile risalire ad una diversa età alla morte sulla base della linea di saldatura epifisaria visibile su omero e femore e dell’usura dentaria, da cui si è desunta un’età adulta giovane. Si è osservato infine che tra i denti sparsi attribuiti all’individuo 2 era presente un ca-nino deciduo mascellare sinistro ascrivibile ad un bambino deceduto intorno ai 7 anni. Tale evidenza potrebbe indicare una precedente deposizione. Il nuovo NMI stimato è quindi di tre individui due dei quali subadulti. Sulla base delle nuove attribu-zioni i tre campioni che erano stati prelevati per
effettuare le analisi radiometriche (Dolfini et alii 2011 ), ritenuti da Parenti relativi ad entrambi gli inumati, sono invece risultati appartenenti ad un unico individuo (XII,2).
Tomba 25-Tomba XI (Parenti 1970). Si con-ferma la presenza del solo individuo segnalato da Parenti, rinvenuto in connessione anatomica ma mancante del cranio. L’Autore non fa alcun riferi-mento alla presenza di ossa di precedenti inuma-zioni, a cui invece fa cenno lo studio riportato da Miari. Nel corso della revisione non è stato rinve-nuto alcun elemento osteologico in eccesso, tale da suggerire la presenza di altri individui.
La Porcareccia (Parenti 1970)Tomba III. I frammenti di cranio e delle ossa
post-craniali recuperati furono identificati da Pa-renti come pertinenti ad un soggetto maschile di età compresa tra i 35 e i 40 anni. Tuttavia il re-stauro nel corso del lavoro di revisione ha per-messo di identificare almeno due crani di cui uno effettivamente riferibile ad un soggetto maschile mentre l’altro, a causa dell’incompletezza, non meglio determinabile. Relativamente allo schele-tro post-craniale il nuovo restauro ha permesso la ricostruzione di porzioni diafisarie relative a due femori, una tibia, un omero e una fibula da riferire presumibilmente ad un unico individuo.
Tomba IV. Parenti descrive i resti di due indi-vidui in connessione anatomica (IV 1; IV,2) ed elementi disarticolati riferibili ad altri due indivi-dui (IV,3; IV,4).
La revisione concorda con Parenti in merito agli individui IV,1 e IV,2 i cui resti sono stati ri-feriti ad un uomo adulto e una donna adulta gio-vane. In più, un consistente lavoro di restauro ha
Tab. IV - La Porcareccia. NMI calcolato da Parenti (1970) e nel corso della presente revisione.
La Porcareccia. NMI after Parenti (1970) and after this revision.
La PorcarecciaParenti (1970) Revisione
Tombe n. inumati adulti
III 1 2
IV 4 4
VIII 4 o 5 3 o 4
Totale 9 o 10 9 o 10
106 Nuccia Negroni Catacchio, Elsa Pacciani, Erika Albertini, Matteo Aspesi, Jacopo Moggi-Cecchi
permesso di recuperare numerosi frammenti dal cumulo dei resti frammisti, ricongiungerli e rico-struire così le diafisi di alcune ossa lunghe, che in tal modo è stato possibile attribuire all’individuo IV,1. Per quanto riguarda i due individui rinvenuti sconnessi, nel cumulo dei resti frammisti si sono rinvenuti tre denti appartenenti all’individuo IV,3 che ne hanno permesso una stima più accurata dell’età alla morte.
Tomba VIII. L’analisi di Parenti ha trovato par-ziale riscontro durante la revisione: per gli indivi-dui VIII,1 e VIII,2, scarsamente rappresentati, le osservazioni concordano, ma per quanto riguarda il gruppo eterogeneo di ossa, riferibile secondo Parenti a due o tre individui, anche a fronte del nuovo restauro che ha portato alla ricongiunzione di segmenti, è stata riscontrata la presenza di uno o al massimo di due individui. Inoltre è da sot-tolineare che la presenza del secondo individuo sarebbe indicata solamente dal diverso stato di conservazione di un femore sinistro.
Chiusa D’Ermini (Parenti 1970)Tomba I. La tomba conteneva resti scheletrici
attribuiti da Parenti a cinque individui, tra cui un bambino. Non si riscontrano differenze con quan-to osservato dall’Autore, a parte la nostra perples-sità sulla possibilità di diagnosi del sesso su resti che sono altamente frammentari, scarsi e per di più ricoperti di sedimento calcareo. In compenso è stato possibile determinare l’età alla morte del bambino, non indicata da Parenti, sulla base dello sviluppo del dente deciduo presente, che corri-sponde a circa 6 anni.
Tomba II. La tomba ospitava quattro indivi-dui, di cui uno in connessione anatomica (II,4),
gli altri frammisti. Parenti riferisce la presenza dei soli crani di quattro individui, senza men-zionare le altre ossa, che si presentano molto frammentarie e per la maggior parte ricoperte di concrezioni calcaree. La revisione del mate-riale ha permesso di riconoscere tra questi resti postcraniali almeno tre individui adulti, di cui due femminili e uno maschile, e un bambino di 10-11 anni. Il NMI attestato da Parenti resta dunque invariato, considerato che tre dei quattro crani sono rappresentati dalla sola calva per cui è lecito supporre che una di queste possa appar-tenere al bambino.
Tomba III. La tomba conteneva ossa sparse riferibili, stando a quanto riportato da Cardini, a sette-otto individui. Secondo l’analisi di Parenti i resti scheletrici erano da riferire a cinque-sei in-dividui, dei quali due uomini, due-tre donne e un bambino di circa 3 anni. Durante la revisione si sono potute riscontrare numerose divergenze con quanto osservato dall’Autore, mentre il NMI è andato a concordare con il numero riportato da Cardini e Rittatore in sede di scavo.
Parenti, data la difficoltà di distribuire i sin-goli elementi a specifici individui, ha ritenuto più prudente raggruppare insieme i resti di tipo maschile e i resti di tipo femminile. Tuttavia nel corso della revisione si è osservato come la diagnosi del sesso non possa considerarsi pienamente attendibile in questo caso a causa della frammentarietà dei resti e del loro stato di alterazione diagenetica; di conseguenza si è tenuto solo parzialmente conto della suddi-visione proposta dall’Autore e in seguito alla ricomposizione effettuata in laboratorio e all’a-nalisi degli elementi diafisari risultanti è stato possibile giungere ad un diverso NMI. Ne è
Tab. V - Chiusa d’Ermini. NMI calcolato da Parenti (1970) e nel corso della presente revisione.
Garavicchio (Parenti 1970).
Chiusa d’Ermini. NMI after Parenti (1970) and after this revision.
Chiusa d'ErminiParenti (1970) Revisione del materiale
Tombe n. inumati Adulti Subadulti n. inumati Adulti Subadulti
I 5 4 1 5 4 1
II 4 4 / 4 3 1
III 5 o 6 4 o 5 1 7 o 8 5 o 6 2Totale 15 13 2 17 13 4
107Nuovi dati su alcune necropoli rinaldoniane. Revisione di vecchi scavi, nuove datazioni
così risultata la presenza, tra gli individui se-gnalati come maschili, di tre soggetti anziché due, tra gli individui segnalati come femminili, di tre soggetti, dei quali due adulti e un bambi-no di circa 5-7 anni, rappresentato da una tibia sinistra. Per quanto riguarda il bambino di 3 anni descritto da Parenti, questo è risultato in realtà di 8-9 anni. Per quanto riguarda il sesso degli individui adulti, le dimensioni delle ossa presenti hanno suggerito con buona probabilità l’identificazione di almeno un soggetto maschi-le e uno femminile. Il NMI risultante è quindi sette o al massimo otto individui, di cui cinque-sei adulti e due bambini.
Complesso Tombale III-V. Il materiale è quello raccolto da ignoti in tombe esplorate irregolarmen-te tra il 1950 e il 1954. Anche in questo caso ad eccezione di una calva di donna adulta, Parenti ne ha suddiviso i resti in ossa riferibili ad individui maschili e ad individui femminili, senza specifica-re l’NMI risultante. Durante la revisione sono stati identificati quattro individui, di cui due maschili, uno femminile e un subadulto di età di poco infe-riore ai 18 anni. C’è da rilevare che, trattandosi di materiale sporadico recuperato in varie tombe non specificate e considerata la grande frammentarietà e incompletezza dei resti pertinenti alle tre tombe sopracitate, la maggior parte dei quali privi delle ossa post-craniali, l’NMI risultante potrebbe non costituire evidenza di altri individui oltre a quelli già stimati per le tre tombe.
Garavicchio (Parenti 1970).Tomba I. L’analisi concorda con quanto
riportato da Parenti, secondo cui la tomba conteneva i resti di due individui maschili, il secondo dei quali rappresentato dal solo femore destro. Malgrado ciò è da sottolineare che l’estrema frammentarietà dei resti e il loro stato di conservazione ha permesso solo una stima del sesso di grado 2.
Tomba II. La tomba conteneva secondo Parenti resti pertinenti ad un uomo e ad una donna adulta. I dati ottenuti dalla revisione non divergono circa il NMI e il sesso dei soggetti; tuttavia viene proposta una diversa attribuzione di alcuni elementi diafisari, non solo in base al diverso stato di conservazione dei due individui, ma anche e soprattutto in seguito al nuovo restauro effettuato. Inoltre sono stati rinvenuti quattro denti sparsi, a
cui Parenti non fa alcun riferimento, che sono stati attribuiti all’individuo 1 e che ne hanno permesso una determinazione più accurata dell’età alla morte.
Tomba III. Nella tomba furono ritrovati i resti di un individuo. Sono state riscontrate diverse incongruenze con l’analisi effettuata da Parenti. Per prima cosa non c’è corrispondenza tra i denti sparsi descritti dall’Autore e quelli inventariati col numero assegnato all’individuo; di conseguenza si è giunti ad una diversa stima dell’età alla morte del soggetto. Tra i denti sparsi inoltre sono stati identificati, durante la revisione, due denti presumibilmente appartenenti, sulla base del diverso stato di usura e delle condizioni di conservazione, ad un altro soggetto. Di contro i quattro denti a cui fa riferimento l’Autore come pertinenti ad un secondo individuo (III,2) non sono stati rinvenuti né risultano nell’Inventario della Collezione Antropologica. Infine non si rinviene il semicalco terroso della faccia di un bambino indicato da Parenti come III,3, anche questo non citato nel catalogo.
Tomba IV. All’interno della tomba furono individuati resti scheletrici pertinenti a quattro individui i cui uno di un uomo (IV,4) e tre identificati da Parenti come pertinenti a un uomo, a una donna e a un bambino di età di poco inferiore ai due anni. Anche in questo caso sono state riscontrate varie differenze rispetto all’analisi di Parenti sia in relazione al NMI che in riferimento all’età degli individui. Ciò è stato possibile in seguito all’accurata analisi dei quaranta denti sparsi recuperati, di cui Parenti cita la sola presenza. Si è proceduto all’identificazione dei denti e alla loro attribuzione tenendo conto solo parzialmente della loro suddivisione in sacchetti. Di questi, ventidue sono risultati molto probabilmente pertinenti all’individuo IV,1 mentre un’altra parte è stata assegnata all’individuo IV,2, ritenuto da Parenti un soggetto femminile adulto e risultato invece un subadulto di 11-12 anni. La giovane età dell’inumato era già stata ipotizzata sulla base delle dimensioni e dell’aspetto delle ossa lunghe presenti; il ritrovamento dei denti ne ha dunque permesso la determinazione più precisa.
Inoltre è stato possibile identificare la presen-za di un ulteriore bambino di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, riconosciuto grazie a due diafisi fe-
108 Nuccia Negroni Catacchio, Elsa Pacciani, Erika Albertini, Matteo Aspesi, Jacopo Moggi-Cecchi
morali rinvenute tra i frammenti non associati ad alcun individuo e a un dente presente tra quelli sparsi già citati, e denominato individuo (IV,5). In sintesi il lavoro di revisione ha permesso di iden-tificare almeno cinque individui, dei quali due adulti e tre subadulti.
Tomba VI. I risultati della revisione effettuata
concordano con quanto riferito da Parenti circa la presenza di un solo individuo di sesso maschile, di cui tuttavia è stato possibile determinare con più accuratezza l’età alla morte da considerarsi giovane, data la minima usura sul secondo molare mascellare sinistro rinvenuto sparso.
4. Sintesi e discussioneCome risulta dall’elenco sopra riportato e dal-
le tabelle comparative, numerosi nuovi dati sono emersi nel corso della revisione del materiale, ri-guardanti principalmente il NMI, il sesso e l’e-tà alla morte di alcuni soggetti. Il nuovo NMI è sensibilmente più alto rispetto a quello di Parenti, risultando di 81-84 individui, anziché 72-73. In riferimento all’età alla morte l’informazione si-curamente più importante, anche in termini di in-terpretazione del contesto archeologico, riguarda la percentuale di soggetti subadulti che, ad ecce-zione della necropoli di La Porcareccia, è molto più alta rispetto di quella risultante dai lavori di Parenti. Infatti a Ponte San Pietro risultano su-badulti il 20,9% dei soggetti contro al 5% calco-lato dall’Autore, a Garavicchio la percentuale è più del doppio, 30,7% rispetto al 15,3%, infine a Chiusa d’Ermini sono stati identificati tre bambi-ni contro un unico soggetto riportato da Parenti. Questi dati permettono di ritenere più improbabi-le l’ipotesi proposta da Miari (1995) circa l’esi-
stenza di un rituale funerario differenziato per la maggior parte degli individui di età prepuberale. Sicuramente lo scarso numero di bambini attesta-to non può essere letto neppure come il riflesso di una bassa mortalità infantile, ma probabilmente la ragione principale risiede nella fragilità dei re-sti stessi che mal si conservano rispetto a quel-li degli adulti e nelle condizioni di giacitura del materiale per cui spesso si trovavano inglobati in una massa calcarea compatta che ne ha impedito il completo recupero.
Passando adesso ai nuovi aspetti antropolo-gici indagati, sono state tratte interessanti infor-mazioni relative allo stato di salute e allo stile di vita degli individui, in particolare per Ponte San Pietro, che hanno integrato e ampliato le analisi specifiche già presentate per il sito da Formicola e Garulli (1988). Le analisi paleopatologiche, af-fiancate dalla rilevazione di altri indicatori come ad esempio quelli di stress occupazionale o nu-trizionale, costituiscono strumenti essenziali per ricostruire il profilo biologico della popolazione in studio, interpretando le osservazioni secondo il contesto archeologico di riferimento.
Nel campione di Ponte San Pietro, quello più consistente e meglio conservato, tra gli individui adulti la percentuale di soggetti interessati da evidenze di natura artropatica è piuttosto alta e raggiunge il 62,5% degli individui, sia di sesso femminile che maschile. Le lesioni interessano principalmente la colonna vertebrale, l’area in cui si scaricano maggiormente le forze di tipo mecca-nico, e colpiscono il 69,2% degli individui adulti che conservano gli elementi vertebrali. Sono stati osservati, in particolare nel tratto toraco-lombare, esiti degenerativi del disco intervertebrale, bordi osteofitici ai margini del piatto vertebrale ed evi-
Tab. VI - Garavicchio. NMI calcolato da Parenti (1970) e nel corso della presente revisione.
Garavicchio. NMI after Parenti (1970) and after this revision.
GaravicchioParenti (1970) Revisione del materiale
Tombe n. inumati Adulti Subadulti n. inumati Adulti Subadulti
I 2 2 / 2 2 /
II 2 2 / 2 2 /
III 3 2 1 3 2 1*
IV 4 3 1 5 2 3
VI 1 1 / 1 / 1
Totale 12 10 2 13 8 5
109Nuovi dati su alcune necropoli rinaldoniane. Revisione di vecchi scavi, nuove datazioni
denze di eburneazione, insieme a numerosi casi di ossificazione dei legamenti gialli.
Nell’individuo maschile di età anziana IV,1 Bis (t.21) l’estrema alterazione patologica riscontra-ta a livello vertebrale e la presenza di specifiche evidenze ha condotto a diagnosticare un probabile caso di polientesopatia iperostosante dismetabo-lica (DISH), nota anche come sindrome di Fore-stier (fig.12). Si tratta di una patologia sistemica a carico delle entesi, di eziologia ancora in parte sconosciuta, che colpisce principalmente i sog-getti maschili non più giovani. L’ossificazione del legamento longitudinale anteriore ha provocato la fusione vertebrale del tratto toracico medio-finale e in particolare dall’ottava vertebra toracica all’un-dicesima, anche se già a partire dalla sesta e pro-gredendo fino alle lombari il ponte osseo che si è formato è tale che le vertebre sono quasi bloccate per tutta la regione toracica e lombare. Sul resto dello scheletro postcraniale quasi tutte le ossa sono colpite da evidenti alterazioni entesopatiche che confermano il quadro patologico.
In riferimento agli eventi di natura traumatica si segnala in particolare il caso di un individuo politraumatizzato (V,3, t.21), di cui è stata eviden-ziata una frattura delle ultime due vertebre tora-ciche, con anchilosi vertebrale sia a livello delle faccette articolari che a livello del corpo verte-brale, collasso a cuneo del corpo dell’undicesima vertebra e conseguente aspetto cifotico (fig. 13); un’ulteriore frattura è stata osservata sul terzo di-stale della diafisi dell’ulna sinistra, guarita con spostamento del moncone inferiore e formazio-ne di un callo osseo (Milanesi, 1963; Formicola e Garulli, 1988). Entrambe le fratture potrebbero essere ricollegate ad un unico evento traumatico da caduta. Formicola e Garulli (1988) ricollegano sempre ad un esito traumatico la neoformazione ossea osservata sulla superficie distale posteriore del femore sinistro del soggetto IV,2, più preci-samente nell’area chiamata iato adduttorio che costituisce la regione tra le due inserzioni del mu-scolo grande adduttore. La lesione è probabilmen-te la conseguenza di un ematoma subperiostale provocato dal trauma. Un caso particolare, degno di nota, riguarda l’omero destro del soggetto ma-schile IV,4 che, per il suo aspetto “patologico e deforme”, era stato considerato da Milanesi come probabile espressione del morbo di Paget, un’o-steopatia dismetabolica piuttosto rara. L’Autore in primo luogo riferisce che l’elemento era diviso
in due frammenti che “riuniti dimostrano tutta-via normale connessione anatomica fra di loro tranne la perdita di un piccolo frammento della faccia antero-laterale”. Nel corso della revisione però è stato riscontrato un probabile errato restau-ro dell’osso, ricomposto da Milanesi all’altezza della tuberosità deltoidea e facendo ricorso ad un’integrazione per la parte mancante. La figura 14a mostra chiaramente l’integrazione che corre lungo la linea di frattura, che è ancora più visibi-le sulla radiografia (fig. 14b). Rimosso il collante
Fig. 12 - Ponte San Pietro, tomba 21 (individuo IV, 1 Bis). Manifestazione patologica sulla colonna vertebrale: ossi-ficazione del legamento longitudinale anteriore.
Ponte San Pietro, tomb 21 (individual IV,1 Bis). Spine pathology: ossification of the longitudinal anterior ligament.
110 Nuccia Negroni Catacchio, Elsa Pacciani, Erika Albertini, Matteo Aspesi, Jacopo Moggi-Cecchi
e l’integrazione (fig. 14c), appare quasi sicura la mancanza di un frammento diafisario, che ha in-dotto l’errore nel restauro e di conseguenza nella diagnosi paleopatologica, basata appunto sulla “abnorme brevità” riferita dall’Autore.
Quadri ricollegabili invece a forme di ipero-stosi porotica, dovute a condizioni anemiche cro-niche, sono piuttosto rari; ne sono stati osservati quattro casi (IA; V,1; V,2; VI,1), e tutti in forma leggera e in via di riassorbimento.
In riferimento alle patologie dentarie, nel campione di Ponte San Pietro sono stati riscon-trati solo quattro casi di tartaro (IA; 6732.a; V, 4A; VI,1) quasi sempre caratterizzato da piccole concrezioni con deposito di grado 1, e una bassa frequenza di carie (17,8%), osservabile solo su cinque soggetti (6732 a.1; IV,4 y; V, 4C; VIII,4; XII,2) dei 43 identificati. Sono invece presenti vari casi di ipoplasia dello smalto, espressione di possibili stati di malnutrizione in età infantile.
Nel campione di Garavicchio non sono sta-te riscontrate carie, mentre è piuttosto diffusa la presenza di tartaro, anche con deposito invadente (I,1). Infine sono presenti due individui con ipo-plasia dello smalto (IV,1; IV,2). Sia a Garavicchio che a La Porcareccia e a Chiusa d’Ermini sono numerosi i casi di caduta di denti ante-mortem as-sociata a stati di forte usura dentaria.
La bassa prevalenza della carie, piuttosto comu-ne in contesti pre/protostorici, è stata messa in re-lazione al tipo di alimentazione che probabilmente caratterizzava queste comunità rinaldoniane (For-micola e Garulli, 1988; Chilleri e Pacciani, 2002), ad esempio il consumo di prodotti caseari, conte-nenti grassi con funzione protettiva contro la carie.
Sempre in riferimento all’analisi dei denti si segnala in particolare un carattere morfologico interessante, rilevato sia in quattro individui dal-la necropoli di Ponte San Pietro (IA; IV,4; IV,4x; VIII,3), che in due dal sito di Garavicchio (IV,2; IV,4). Si tratta di un solco che interessa la corona degli incisivi centrali e laterali mascellari, localiz-zato sulla faccia linguale, in prossimità del colletto, ad orientamento mesio-distale (fig. 15). La natura del solco, che non sembra essere collegata ad attivi-tà funzionale, è tuttora in corso di studio. Esso è sta-
Fig. 13 - Ponte San Pietro, tomba 19 (individuo V, 3). Frattura delle ultime due vertebre toraciche, con collasso a cuneo e anchilosi vertebrale.
Ponte San Pietro, tomb19 (individual V, 3). Fracture of the two lowermost thoracic vertebrae, with wedge-shaped collapse and vertebral ankylosis.
Fig. 14 a, b, c: Ponte San Pietro, tomba 22 (individuo IV,4). L’omero destro in seguito ad un errato restauro aveva assunto un aspetto patologico, inducendo un’erra-ta diagnosi di morbo di Paget. a) l’integrazione utilizzata per congiungere linee di frattura non complementari. b) radiografia che mette in evidenza l’area di integrazione. c) omero dopo la rimozione dell’integrazione.
Ponte San Pietro, tomb 22 (individual IV, 4). After a misguided attempt at restoration, the right humerus had taken a pathological appearance, which caused it to be mistakenly diagnosed as manifesting Paget’s disease. a) the restoration attempted to refit fracture lines that were not, in fact, complementary. b) X-ray showing the “restored” area. c) the humerus after the effects of the restoration were removed.
a
b
c
111Nuovi dati su alcune necropoli rinaldoniane. Revisione di vecchi scavi, nuove datazioni
to rilevato per la prima volta in individui di una ne-cropoli italiana riferibile al Bronzo Antico - Arano di Cellore (VR) (Dori e Moggi-Cecchi, submitted).
La possibilità di ricostruzione dello stile di vita attraverso la rilevazione dei markers muscolo-sche-letrici di stress ricollegabili ad una specifica attività lavorativa è limitata dall’esiguità del campione e dall’incompletezza dei resti. Ciononostante sono possibili alcune considerazioni, sia in riferimento alle specifiche aree muscolari coinvolte in movi-menti ripetuti tali da provocare stati infiammatori delle entesi, sia in relazione a differenze di espres-sione tra i due sessi collegabili presumibilmente ad una netta differenziazione delle attività tra uomini e donne all’interno della comunità.
Sono stati quindi interpretati i dati risultanti dagli indici antropometrici, dalla valutazione del-le alterazioni entesopatiche, dalle evidenze artro-patiche secondarie a stress meccanici, dall’indice di dimorfismo sessuale e dall’indice di lateraliz-zazione degli arti.
Tra le entesopatie del cingolo scapolare e dell’arto superiore sono particolarmente frequenti e marcate, soprattutto nei soggetti maschili, quelle del legamento costoclavicolare, correlate al trasporto di carichi pesanti con le braccia e le spalle piegate in avanti (Capasso et alii 1999), e quelle dei muscoli bicipite e supinatore sull’avambraccio, attivi nei movimenti di prono-supinazione.
A livello degli arti inferiori le lesioni più importanti sono state registrate a carico del muscolo tibiale anteriore e del soleo sulla tibia, che sono coinvolti e particolarmente sollecitati durante il cammino sotto sforzo in terreni acci-dentati (Palastanga et alii 2007). Interessante è il dato sulla distribuzione tra i due sessi di queste entesopatie degli arti inferiori: poiché risulta una quasi esclusiva presenza in soggetti maschili, si può ipotizzare che solo gli uomini svolgessero la-vori implicanti la deambulazione con trasporto di carichi pesanti. Ciononostante gli indici antropo-metrici ottenuti suggeriscono comunque un buon grado di sviluppo muscolare degli arti inferiori anche per le donne.
Gli indici di lateralizzazione non denotano una forte asimmetria bilaterale tra gli arti, né per quel-li superiori né per quelli inferiori, negando quindi un impegno differenziale tra il lato destro e quello sinistro, e ciò vale sia per gli uomini che per le don-ne. Fa eccezione l’alto grado di lateralizzazione a
carico dell’ulna nei soggetti femminili, relativa alle misure di circonferenza. Tale valore potrebbe indi-care un forte stress di tipo meccanico derivato da una particolare attività occupazionale sotto sforzo a carico dell’avambraccio di un solo lato.
I dati sul dimorfismo sessuale sembrano indi-care un basso grado di differenziazione nei due sessi sia in riferimento agli arti superiori che in-feriori, dal momento che i valori risultanti sono piuttosto ridotti, ad eccezione di quelli relativi al femore. Considerato che valori elevati potrebbero indicare attività lavorative sesso-specifiche dob-biamo concludere che questo dato non concorde-rebbe del tutto con quello fornito dalle entesopa-tie degli arti inferiori.
Riguardo alle artropatie da stress si è eviden-ziato soprattutto un elevato numero di individui, anche di giovane età, colpiti da artrosi vertebrale accentuata, probabile conseguenza di attività la-vorative pesanti.
Riferimenti Bibliografici
Aranguren B., Pallecchi P., Perazzi P., Revedin A.1987/88, La necropoli di Garavicchio (Capalbio, Grosseto), RSP XLI, pp. 199-237.
Aspesi M. 2012, Le necropoli rinaldoniane del Palombaro e di Chiusa d’Ermini: Revisione degli scavi di F. Rittatore Vonwiller, PPE Atti X, pp. 223-246.
Aspesi M. c.s, Una rivisitazione degli scavi della necropoli rinaldoniana di Garavicchio alla luce dei diari Rittato-re-Cardini, PPE Atti XII.
Fig. 15: Ponte San Pietro, tomba 22 (individuo IV,4). Sol-co evidente che interessa la corona dei denti incisivi cen-trali e laterali mascellari, localizzato sulla faccia linguale nei pressi del colletto.
Ponte San Pietro, tomb 22 (individual IV, 4). Pronounced groove on the crowns of both central and lateral maxil-lary incisors, located on the lingual face, near the neck of the teeth.
112 Nuccia Negroni Catacchio, Elsa Pacciani, Erika Albertini, Matteo Aspesi, Jacopo Moggi-Cecchi
Açsádi G., Nemeskéri J. 1970, History of Human Life, Span and Mortality, Akadèmiiai Kiadò, Budapest.
Bianco Peroni V. 1994, I pugnali nell’Italia continentale, PBF VI, 10, Stuttgart.
Borgognini S., Bartoloni C. S. Omer 1967, Determina-zione di gruppi sanguigni ABO in un gruppo di scheletri eneolitici provenienti dalla necropoli di Ponte San Pie-tro, in Archivio per l’Antropologia e la Etnologia 97, pp. 35-46.
Brothwell D. R. 1981, Digging up Bones, Oxford Univer-sity Press, Oxford.
Brown W.A.B. 1985, Identification of Human Teeth, Bul-lettin 21/22 of the Institute of Archaeology, London, pp. 1-29.
Calcagnile L., Quarta G., D’Elia M. 2005, High-reso-lution accelerator-based mass spectrometry: precision, accuracy and background, Applied Radiation and Isoto-pes 62(4), pp. 623–629.
Capasso L., Kennedy A. R., Wilczack C.A. 1999, Atlas of Occupational markers on Human Remains, Edigrafital, Teramo.
Cardini L. 1946, Ponte San Pietro presso Ischia di Castro (Viterbo), RSP I, 1-2, p. 96.
Cardini L. 1955, Ponte San Pietro (Ischia di Castro), RSP X, p. 157.
Cardini L., Litta Modignani G.F., Rittatore F. 1958-61, Nuove scoperte nella necropoli di Garavicchio presso Capalbio (Grosseto), Quaternaria V, p. 336.
Cardini L., Rittatore F. 1948, Nuovi scavi in giacimenti preistorici della Toscana e del Lazio, RSP III, 1-2, pp. 149-151.
Cardini L., Rittatore F. 1950, Necropoli eneolitica della “Chiusa d’Ermini”(Viterbo), RSP 5, pp. 122-23.
Cardini L., Rittatore F. 1951, Necropoli eneolitica di Ponte San Pietro(Ischia di Castro, Viterbo), Notiziario RSP VI, 3-4, pp. 201-202.
Cardini L., Rittatore F. 1955, Garavicchio (Grosseto), Notiziario RSP X, 1-4, p. 156.
Cardini L., Rittatore F. 1956, Garavicchio (Grosseto), Notiziario RSP XI, 1-4, p. 249.
Cardini L., Rittatore F. 1958, Notizie preliminari sulle re-centi scoperte nel sepolcreto eneolitico presso Ponte S. Pietro (Ischia di Castro, Viterbo), Istituto Lombardo di Scienze e lettere, Rendiconti 92, pp. 381-385.
Cardini L., Rittatore F. 1959, Garavicchio (Capalbio - Grosseto), Notiziario RSP XIV, 1-4, p. 317.
Cazzella A., Moscoloni M. 1995, Modelli di organizza-zione spaziale in alcune necropoli eneolitiche e dell’e-tà del Bronzo della penisola italiana, PPE Atti II, pp. 35-44.
Chilleri F., Pacciani E. 2002, Note Antropologiche sui re-sti umani dalla necropoli eneolitica di Poggialti Valle-lunga (Pitigliano, GR), PPE Atti V, pp. 513-520.
Cocchi Genick D. 1996, Manuale di preistoria III. L’età del rame, Firenze.
Cocchi Genick D. 2009, Preistoria, QuiEdit, Verona.Conti A.M., Persiani C., Petitti P. 1997, I riti della mor-
te nella necropoli eneolitica della Selvicciola (Ischia di Castro – Viterbo), Origini XXI, pp. 169-185.
Conti A.M., Persiani C., Petitti P. 2006, Analisi dei ri-tuali: depositi archeologici e “mito degli antenati”, PPE Atti VII, pp. 455-59.
D’Elia M., Calcagnile L., Quarta G., Sanapo C., Lau-disa M., Toma U., Rizzo A. 2004, Sample preparation
and blank values at the AMS radiocarbon facility of the University of Lecce, in Nuclear Instruments and Me-thods in Physics Research B 223-224, pp. 278-83.
de Marinis R.C. 2006, Aspetti della metallurgia dell’età del Rame e dell’antica età del Bronzo in Toscana, RSP LVI, pp. 211-272.
Dolfini A. 2004, La necropoli di Rinaldone (Montefiasco-ne, VT): rituale funerario e dinamiche sociali di una co-munità in Italia centrale, BPI, 95, pp. 127-278.
Dolfini A. 2006, La necropoli di Rinaldone e il problema delle sepolture primarie in Italia centrale tra il IV e il III millennio,PPE Atti VII, pp. 77-96
Dolfini A. 2010, The origins of metallurgy in central Italy: new radiometric evidence, Antiquity 84, pp. 707-723.
Dolfini A., Aranguren B., Silvestrini M. 2011, La pri-ma metallurgia in Italia centrale alla luce di nuove date radiometriche, Atti IIPP XLIII, pp. 171-179.
Falchetti F. 1971/1972, L’Eneolitico nella valle del Fiora, Tesi di laurea discussa presso l’Università degli Studi di Milano, relatore prof. F. Rittatore Vonwiller.
Falchetti F. 1977, Periodo eneolitico, in F. Rittatore Vonwiller, F. Falchetti, N. Negroni Catacchio, Preistoria e Protostoria della valle del fiume Fiora, in La civiltà arcaica di Vulci e la sua espansione, Atti del X Convegno di Studi Etruschi e Italici, Firenze, pp. 114-130.
Fasani L., Rittatore Vonwiller F., Soffredi A. 1964/66, Necropoli dell’età eneolitica e del Bronzo nella vallata del fiume Fiora (Viterbo), Sibrium VIII, pp. 87-91.
Formicola V., Garulli A. 1988, Il campione eneolitico di Ponte S. Pietro: indicatori di stress e condizioni di vita, Rivista di Antropologia, 66, pp. 77-88.
France D. L., Horne A.D. 1988, Lab Manual and Workbo-ok for Physical Anthropology, West Publishing Com-pany, New York-Los Angeles-San Francisco.
Graziosi P. 1948, I resti scheletrici umani della necropoli preistorica di Ischia di Castro, RSP 3, pp. 113-27.
Hall R.L. 1982, Sexual Dimorphism in Homo sapiens. A Question of Size, Praeger, New York.
Iscan M. Y., Loth S. R., Wright R. K. 1984, Age estima-tion from the rib by phase analysis: White males. Journal of Forensic Sciences, 29, pp. 1094-1104.
Lovejoy C. O., Meindl R. S., Pryzbeck T. R., Mensforth R. 1985, Chronological metamorphosis of the auricular surface of the ilium: a new method for determination of adult skeletal age at death, American Journal of Physical Anthropology, 68, pp. 15-28.
Maat G.J.R., Van Der Velde E.A. 1987, The caries attri-tion competition, International Journal of Anthropology, II, pp. 281-292.
Manfredini A. 2012, La cronologia dell’eneolitico del ter-ritorio tirrenico centrale alla luce delle recenti datazioni radiometriche, Atti PPE X, pp. 275-283.
Manfredini A., Fugazzola Delpino M. A., Sarti L., Sil-vestrini M., Martini F., Conati Barbaro C., Mun-toni I. M., Pizziolo G., Volante N. 2009, Adriatico e Tirreno a confronto: analisi dell’occupazione territoriale tra il Neolitico finale e l’età del Rame in alcune aree cam-pione dell’Italia centrale, RSP LIX, pp. 115-80.
Mariotti V, Facchini F, Belcastro M.G. 2004, Entheso-pathies: proposal of a standardised scoring method and ap-plications, Collegium Antropologicum, 28/1, pp. 145-159.
Mariotti V, Facchini F, Belcastro M.G. 2007, The Study of Entheses: Proposal of a Standardised Scoring Method
113Nuovi dati su alcune necropoli rinaldoniane. Revisione di vecchi scavi, nuove datazioni
for Twenty-three Entheses of the Postcranial Skeleton, Collegium Antropologicum 31/1, pp. 291-313.
Meindl R.S., Lovejoy C.O. 1985, Ectocranial Suture Clo-sure: A Revised Method for the Determination of Age at Death Based on the Lateral-Anterior Sutures, American Journal of Physical Anthropology, 68, pp. 57-66.
Miari M. 1993, La necropoli eneolitica di Ponte San Pietro (Ischia di Castro – Viterbo), RSP XLV, fasc.1, pp. 101-166.
Miari M. 1995, Topografia e organizzazione spaziale della necropoli eneolitica di Ponte S. Pietro (Ischia di Castro, VT), AttiPPE II, pp. 55-66.
Miari M. 2006, I materiali del corredo: funzioni e simboli, AttiPPE VII, pp. 47-62
Milanesi Q. 1963, Su due ossa patologiche del Sepolcreto eneolitico di Ponte S. Pietro, Archivio per l’Antropolo-gia e l’Etnologia 92, pp. 215-33.
Negroni Catacchio N. 1992, La necropoli della Porcarec-cia (Pitigliano - Grosseto), Origini XVI, pp. 195-219.
Negroni Catacchio N. 2006, Il paradigma sistemico: una rivisitazione, AttiPPE VII, pp. 368-376
Negroni Catacchio N. 2000, La facies di Rinaldone e i suoi rapporti con le comunità eneolitiche dell’Italia cen-trale, in M. Silvestrini (a cura di), Recenti acquisizio-ni, problemi e prospettive della ricerca sull’Eneolitico dell’Italia Centrale, Atti del Convegno, Arcevia 14-15 maggio 1999, Ancona, pp. 131-147.
Negroni Catacchio N. 2011, Rituali funerari e aspetti simbo-lici della “cultura” di Rinaldone, in L’età del rame in Italia, Atti IIPP XLIII, Bologna 2008, Firenze 2011, pp. 289-296.
Negroni Catacchio N., Aspesi M. cds, La necropoli eneo-litica di Poggialti Vallelunga (Pitigliano – GR) nel qua-dro della cultura di Rinaldone.
Negroni Catacchio N., Aspesi M. cds2, Rinaldone e Gau-do. Rituali a confronto, in Studi in Memoria di Gianni Bailo Modesti
Negroni Catacchio N., Miari M. 2001, La necropoli di Fontanile di Raim, (Ischia di Castro-VT), in Bell Beakers today, Atti del Colloquio, Riva del Garda 11-16 maggio 1998, Trento, pp. 671-673.
Negroni Catacchio N., Miari M. 2001, La necropoli ri-naldoniana di Fontanile di Raim (Ischia di Castro- VT), Atti PPE III, pp. 391-400.
Negroni Catacchio N., Miari M. Dolfini A. 2005, Rap-porti tra area tirrenica ed adriatica durante l’Eneolitico alla luce della cultura di Rinaldone, Atti IIPP XXXVIII, pp. 399-420.
Olivier G. 1960, Pratique Anthropologique, Vigot Frères, Paris.
Palastanga N., Field D., Soames R. 2007, Anatomia del movimento umano. Struttura e funzione, Elsevier (ed.).
Parenti R. 1963, Studio antropologico d’un gruppo di sche-letri eneolitici, riferibili alla civiltà di Rinaldone, Archi-vio per l’Antropologia e la Etnologia 92, pp. 5-39.
Parenti R. 1965, Studio antropologico d’un gruppo di scheletri eneolitici, riferibili alla civiltà di Rinaldone. II. Tipologia gruppale, Archivio per l’Antropologia e la Etnologia 95, pp. 5-27.
Parenti R. 1967, Gli scheletri umani di Ponte S. Pietro (cul-tura Rinaldone) nel contesto antropologico della Provin-cia Tirennica, all’epoca dei primi metalli, Archivio per l’Antropologia e la Etnologia 97, pp. 17-34.
Parenti R. 1970, Resti scheletrici umani raccolti in tombe a forno della bassa valle della Fiora, Archivio per l’antro-pologia e l’etnologia, Firenze, pp. 147-189.
Pearson K. 1917, A study of the long bones of the English skeleton, University of London Press, London.
Petitti P., Negroni Catacchio N., Conti A.M., Lemo-rini C., Persiani C. 2002, La necropoli eneolitica del Fontanile di Raim. Nuovi dati dalla campagna di scavo, AttiPPE V, pp. 545-568.
Petitti P., Conti A.M., Persiani C. 2006, I rituali di depo-sizione nella cultura di Rinaldone alla luce della necro-poli di Selvicciola, Atti PPE VII, pp. 63-75.
Petitti P., Conti A.M., Persiani C. 2012, La necropoli di Selvicciola. Le fasi finali dell’esplorazione, Atti PPE X, pp. 217-221.
Quarta G., Calcagnile L., D’Elia M., Rizzo A., Ingra-vallo E. 2004, AMS radiocarbon dating of “Grotta Cap-puccini” in Southern Italy, in Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 223-224, pp. 705-708.
Rittatore F. 1942, Necropoli eneolitica presso Ponte San Pietro nel Viterbese, SE XVI, pp. 557-563.
Rittatore F. 1948/49, Recenti scoperte del periodo eneoli-tico e dell’età del bronzo nella valle del fiume Fiora, SE XX, pp. 267-270.
Rittatore F. 1951, Scoperte di età eneolitica e del Bronzo nella Maremma Tosco-Laziale, RSP VI, 1-2, pp. 3-33.
Rittatore F. 1959, Ischia di Casto (Viterbo), RSP XIV, p. 319.
Rittatore Vonwiller F. 1964/66, La necropoli eneolitica della Porcareccia, Sibrium VIII, pp. 93-94.
Sarti L. 2006, Sepolture e rituali funerari nell’Eneolitico in Italia, in Fabio Martini (a cura di) La cultura del mo-rire nelle società preistoriche e protostoriche italiane, Origines, pp.128-160 (in collaborazione con V. Leonini).
Schultz A.H. 1937, Proportions, Variability and Asymmetri-es of the Long Bones of the Limbs and Clavicles in Man and Apes, Human Biology, 9, pp. 281-328.
Stloukal M., Hanakova H. 1978, Die länge der Längskno-chen altslawischer Bevölkerungen - Unter besonderer Berücksichtigung von Wachstumsfragen, Homo, 29, pp. 53-69.
Suchey, J.M., Wiseley, D.V., Katz, D. 1986, Evaluation of the Todd and Mc Kern-Stewart methods for aging the male os pubis, in K.J. Reichs (ed.), Forensic Osteology, C. C. Thomas, pp. 33-67.
Jean Vaquer, Les pratiques funéraires au Néolithique moyen dans le Midi de la France .........
Maria Maffi, Il Neolitico Recente Emiliano (NRE): proposta di definizione ..........................
Günther Kaufmann, L’ascia dell’Uomo venuto dal ghiaccio .................................................
Nuccia Negroni Catacchio, Elsa Pacciani, Erika Albertini, Matteo Aspesi, Jacopo Moggi-Cecchi, Nuovi dati su alcune necropoli rinaldoniane. Revisione di vecchi scavi, nuove datazioni e recenti analisi dei resti scheletrici ..............................................................................
Anita Crispino, S. Ippolito, Caltagirone: nuovi dati sull’abitato dagli scavi Orsi ....................
Maria Clara Martinelli, Francesca Cannizzaro, Milena Gusmano, Considerazioni sulla facies di Malpasso nella cuspide orientale della Sicilia e nelle isole Eolie .........................
Davide Tanasi, Rappresentazioni naturalistiche nella ceramica del Bronzo Antico Siciliano: il caso di Grotte di Marineo (Licodia Eubea, Catania) ...................................................................
Carlo Veca, Contenitori “per i vivi” e contenitori “per i morti” a Thapsos (Siracusa): un approccio tecnologico a un problema interpretativo ....................................................................
Biancamaria Aranguren, Maria Rosaria Cinquegrana, Alberto De Bonis, Vincenza Guarino, Vincenzo Morra, Marco Pacciarelli, Le strutture e lo scarico di olle del Puntone Nuovo di Scarlino (GR) e i siti costieri specializzati della protostoria mediotirrenica ........................
Gianni Santuari, Umberto Tecchiati, Due ganci di cintura in bronzo di cui uno traforato tipo Castaneda (età antico La Tène) da Collalbo-Bolzano
ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA. Attività degli anni 2013 e 2014
NORME PER GLI AUTORI .......................................................................................................
RIVISTA DI SCIENZE PREISTORICHEVol. LXIV - 2014
INDICE
5
25
57
83
115
151
193
203
227
259
281
297









































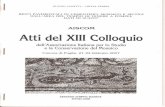





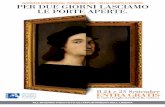

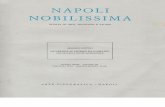



![I resti faunistici [Il villaggio medievale di Geridu (Sorso, SS)]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6321608b0c12e1161503c46b/i-resti-faunistici-il-villaggio-medievale-di-geridu-sorso-ss.jpg)







