Trasformazioni simboliche, dal cadavere alla reliquia: corpi manipolati e resti umani isolati nel...
Transcript of Trasformazioni simboliche, dal cadavere alla reliquia: corpi manipolati e resti umani isolati nel...
FORMA VRBIS – Ottobre 2014
1
Trasformazioni simboliche, dal cadavere alla reliquia: corpi manipolati e resti umani isolati nel Mesolitico europeo
Stefano Cucchiarini – PhD in Scienze dell’Antichità e Archeologia, Università degli Studi di Firenze
Abstract
A partire dall’ultima fase del Paleolitico superiore europeo, molti resti umani rivelano tracce deliberate di manipolazioni antropiche. Ovunque alcune ossa, specialmente crani, sono state separate dai rispettivi scheletri per essere conservate in contesti non sepolcrali e integrate simbolicamente nella quotidianità dei viventi. Possibili reliquie, culti ancestrali o trofei, al momento nessuna ipotesi può essere esclusa con certezza. Nelle prossime pagine verranno evidenziati alcuni casi studio di crani isolati in contesti particolari e sepolture incomplete provenienti dal Mesolitico dell’Europa centrale, settentrionale e dell’area dei Balcani.
Introduzione
Per molto tempo ci siamo abituati a immaginare che le pratiche funerarie durante la preistoria europea convogliassero unicamente in sepolture canoniche, con corpi interi o parziali, all’interno di fosse e strutture litiche. La tendenza era quella di interpretare l’elevata incidenza di ossa umane disarticolate, individuate in tutte le fasi preistoriche, come ciò che rimaneva di sepolture perturbate da eventi antropici o dall’azione di processi tafonomici e diagenetici. L’analisi della documentazione antropologica disponibile per il Mesolitico europeo rivela però almeno due tipi di azioni attorno al corpo dei defunti: quella della sepoltura, primaria e secondaria con deposizione di scheletro intero o parziale, e quella della conservazione deliberata di resti isolati quale possibile “reliquia”. A partire dalle ultime fasi del Paleolitico superiore, per poi svilupparsi con maggior impeto nel Mesolitico e Neolitico, conosciamo, infatti, molteplici resti umani trattenuti fuori dal contesto sepolcrale (CUCCHIARINI Cds; ORSCHIEDT 2013). Si evince l’esistenza di due diversi approcci sul cadavere, uno statico e l’altro dinamico. L’inumazione primaria mira all’integrità del corpo, ogni contatto col mondo dei vivi è precluso, e se vogliamo concederci un paragone, può risultare verosimile alla nostra cultura moderna del morto che “riposa in pace”. Manipolare il corpo, riaprire una sepoltura, selezionare determinate ossa è invece qualcosa di estremamente dinamico (fig. 1). Molti resti umani circolano nella società mesolitica alla stregua di altri oggetti di uso comune, oppure vengono deposti in contesti particolari (CAUWE 2005). Ossa così trattate, che generalmente definisco come possibili “reliquie” mentre nel mondo anglosassone come “curated human bones”, attraverso un’azione di selezione, circolazione e conservazione, esulano da un piano strettamente funerario per assumere nuova dimensione simbolica nella quotidianità dei viventi (fig. 2). Si tratta di resti umani, manipolati e non, conservati in contesti abitativi, strutture funzionali e talvolta in aree rituali/funerarie. Occorre inoltre ricordare la forte valenza simbolica che presentano le ossa sparse in contesti non necropolici, luoghi non primariamente destinati alla loro deposizione. Testimonianze dell’esistenza di tali pratiche sono osservabili non solo nel ritrovamento di resti umani laddove non ci aspetteremo di trovarli, ma anche dall’evidenza di atti deliberati di prelievo
FORMA VRBIS – Ottobre 2014
2
secondario di ossa selezionate, specialmente crani, da alcune sepolture primarie (CUCCHIARINI Cds). Alcuni di questi resti rivelano tracce di manipolazione intenzionale, per la maggior parte segni di taglio e raschiatura. A parte questo, si osserva la forte dominanza di elementi cranio-dentali, dato che può essere spiegato solo con una selezione deliberata.
Deposizioni di crani in Europa centrale : scarnificazioni, trofei e reliquie
La pratica della selezione e conservazione di crani umani si riscontra abbastanza regolarmente a partire dall’ultima fase del Paleolitico superiore, il Maddaleniano, per poi svilupparsi nel corso del Mesolitico europeo (X-VII Millennio). Tutte le culture europee del Paleolitico superiore, infatti, hanno restituito resti umani isolati e talvolta manipolati, specialmente tra 20.000 e 10.000 a.C. (Badegouliano e Maddaleniano europeo). In alcuni casi, inoltre, i crani hanno ricevuto una particolare protezione tangibile: una sorta di circolo di pietre per Rond-du-Barry (Haute-Loire, Francia) e forse per Abri Pataud (Dordogne, Francia), mentre il cranio di Rochereil (Dordogne, Francia) sembrerebbe posato su due piccole lastre calcaree, così come quello di Mas D’Azil (Ariége, Francia) in una nicchia. Interi o frammentari, preservati o gettati via alla stregua di altri rifiuti, manipolati o meno, ovunque alcuni crani sono stati separati dai rispettivi scheletri per essere integrati nella vita quotidiana di tutti i giorni. Occorre però mettere in relazione questi elementi con i contesti di ritrovamento, quasi mai prettamente funerari, e rivalutare la “funzione” e il ruolo dei resti umani isolati nella società. Si potrebbe trattare di resti pertinenti a familiari o persone relativamente importanti nel gruppo, per poi essere conservati come ricordo e fatti circolare da un posto all’altro. In altri casi, abbiamo evidenze di deposizioni in luoghi speciali, all’interno di abitazioni o in aree fortemente ritualizzate. Per quanto concerne il Mesolitico antico, IX millennio a.C, le evidenze non sono molto numerose ma comunque significative. Tra queste, ricordiamo il sito di Sauveterre (Sauveterre La Lemance, Francia) con il rinvenimento di un cranio di individuo adulto, femminile, posizionato sopra una roccia in una cavità con contesto di frequentazione/abitazione (FAREMBACH 1974). La mandibola era assente e in associazione col cranio si menzionano strumenti microlitici e alcune ossa faunistiche. Un’altra calotta isolata, in questo caso di maschio adulto di circa 25-30 anni di età, proviene dalla grotta di Blatterhohle (Westfalen, Germania) presso una grossa pietra in contesto abitativo (ORSCHIEDT 2012). Ciò che colpisce maggiormente è la presenza di tre crani di cinghiale attorno alla calotta umana in un’area di 1,5 m di superficie (figg. 3-4). Sia la calotta che i crani sono datati al Mesolitico antico: circa 9390 ± 35 a.C., 8677 ± 43 cal. a.C per la calotta umana e 9000/9300 a.C. e 8500/8200 cal. a.C. per il resto. L’analisi del contesto ci suggerisce che tutti questi elementi siano stati situati nel medesimo posto intenzionalmente, resta difficile capire se in un unico atto o in tempi diversi. Attestazioni più evidenti, sia nel numero che nella tipologia di deposizione, le ritroviamo in un’area circoscritta dell’Europa centrale durante il Mesolitico tardo/finale e nella successiva fase del Neolitico. Questo numero importante di resti cranici porta inevitabilmente ad alcuni interrogativi: perché un comportamento speciale riservato al cranio? Erano utilizzati come trofei? Elementi rituali? Certo, non tutte queste evidenze sono frutto di azioni antropiche intenzionali, restano da valutare anche i fattori post-deposizionali e i processi tafonomici. Vista però la netta sovrabbondanza di resti craniali rispetto a quelli post-craniali, è lecito poter parlare, se non di atti rituali, almeno di un interesse particolare verso la testa del defunto per tutte le classi di età e sesso. Forse il cranio rappresentava le fattezze del defunto, inoltre, si adoperava bene per una questione pratica come il prelievo e il trasporto da un posto all’altro. Rimane valida anche l’ipotesi che fossero teste appartenute a nemici e conservate forse come ricordo o monito per società rivali. Molti crani, infatti, presentano segni di taglio sul tavolato esterno e presso le prime vertebre cervicali, tutte tracce compatibili con pratiche di decapitazione, peri o post-mortem, e di scarnificazione intenzionale. Tra questi si ricordano i depositi di crani del tardo Mesolitico provenienti dalla Germania meridionale (fig. 5), grotta di
FORMA VRBIS – Ottobre 2014
3
Ofnet (Holheim, Baviera), Hohlenstein-Stadel (Asselfingen, Bade-Wurtemberg), Kaufertsberg (Lierheim, Baviera) e dalla Francia orientale col sito di abri du Mannlefelsen (Oberlag, Haut-Rhin).
Kaufertsberg
Nel 1913, all’interno di una fossa scavata intenzionalmente, si rinvenne un cranio isolato di un soggetto maschile di circa 20-25 anni di età (KAULICH, 1983). In connessione col cranio si trovavano la mandibola e le prime due vertebre cervicali, che rispetto alle altre evidenze a Ofnet, Hohlenstein e Mannlefelsen, non presentano tracce di decapitazione o alterazioni di origine antropica (SCHROTER 1983; ORSCHIEDT 1999). Nessun oggetto di corredo si trovava in corrispondenza dei resti umani ad eccezione di tracce di ocra rossa. La fossa, nonostante sia sicuramente intenzionale, si presenta oggettivamente meno complessa rispetto a quelle rinvenute a Ofnet o Hohlenstein. La datazione del contesto ricade intorno al VII millennio a.C., durante le ultime fasi del Mesolitico.
Hohlenstein-Stadel
Il sito, non distante dal precedente Kaufertsberg, ha restituito un deposito costituito da tre crani umani durante gli scavi del 1937. Si tratta di una fossa, impiantata sotto una struttura pavimentale di pietra, di 45 cm di diametro e 70 di profondità (fig. 6). Il riempimento della fossa, dal basso verso l’alto, si compone da un primo livello di ghiaia, un secondo di blocchi di medie dimensioni e da un terzo di ghiaia (JEUNESSE 2012). I tre crani giacevano presso il secondo livello, a circa 30 cm dall’inizio della fossa e guardavano nella medesima direzione, sud-est ovvero verso l’interno della grotta (figg. 7-8). I tre individui sono un uomo, una donna e un bambino disposti in modo da ricordare una sorta di triangolo, col maschio al vertice (WAHL 2007). Il sedimento su cui poggiano i resti cranici risulta impregnato di ocra, inoltre, presso il cranio femminile si rinvengono numerosi denti di carpa non forati e alcune selci nel riempimento della fossa. Tutti i crani sono associati alla rispettiva mandibola e alle prime vertebre cervicali. I due individui adulti, di circa 20-30 anni di età, presentano tracce inequivocabili di decapitazione e altre alterazioni a livello della superficie craniale mentre nell’infante, al contrario, non vi sarebbero segni visibili di violenza. Datazioni al radiocarbonio indirizzerebbero il contesto nella prima metà del VII° millennio a.C, tra i 6900 e 6600 a.C.
Ofnet La grotta ha restituito due contesti di straordinaria importanza per quanto concerne la selezione e la conservazione di crani umani di tutte le classi di età e di ambo i sessi. Le due fosse comprendono da 27 a 31 crani per la prima e 6 per la seconda, in entrambi i depositi i resti umani giacevano gli uni accanto agli altri come una sorta di “nidi di uova” (fig. 9). Le fosse, poco profonde e distanti tra loro un metro, si situavano sotto l’entrata della cavità (ORSCHIEDT 1999, HOFMANN 2005, JEUNESSE 2012). Si ritrovano indistintamente sia individui adulti che bambini. Un infante di meno di un anno, 18 bambini tra i 2 e gli 11 anni, 14 adulti (di cui 10 tra i 20 e i 30 anni, due tra i 30 e i 40, uno tra i 40 e i 50, e uno tra i 60 e i 70 anni di età). Per quanto concerne il sesso, possiamo distinguere almeno 8 maschi, 17 femmine e 9 indeterminabili (Jeunesse 2012). I quattro individui che hanno passato la trentina sono due femmine (30-40 anni e 60-70) e due uomini (30-40 e 40-50); dunque la maggior parte degli adulti è morta abbastanza giovane. Tutti i crani sono accompagnati dalle loro mandibole e da almeno una vertebra cervicale, più spesso l’atlante. Gran parte dei resti umani di entrambe le fosse, inoltre, presenta tracce di violenza costituite da segni di taglio, scarnificazione e traumi da impatto sulle vertebre, mandibole e calotte (fig. 10). Osservando i segni di taglio presenti sulle vertebre è possibile confermare che almeno 9 individui sono andati incontro a una separazione della testa tramite decapitazione (ORSCHIEDT 1999). Sono da menzionare anche ricchi corredi che accompagnavano i crani: il sedimento delle due fosse è riccamente
FORMA VRBIS – Ottobre 2014
4
cosparso di ocra, carboni, qualche strumento in selce e pendagli. In quest’ultima classe di materiale si segnalano 4500 oggetti di ornamento, tra cui 223 canini di cervo e 4250 conchiglie forate di Columbella rustica, Gyraulus, Lithoglypus e Theodoxus (figg. 11-13). Le conchiglie provengono da molluschi locali ma anche da esemplari del Mediterraneo come la Columbella rustica (fig. 14). Le datazioni anche in questo caso convergono per la prima metà del VII millennio a.C. Stando ai dati qui descritti, è possibile elencare le seguenti caratteristiche:
1) La pratica della conservazione dei crani si presenta nella medesima sfera temporale e in un’area circoscritta (si veda i casi di Holhlenstein-Stadel, Kaufertsberg e Mannlefelsen) tra la pianura meridionale del Reno e il corso superiore del Danubio. Deposizioni deliberate di singoli crani le ritroviamo anche a sud delle gole del Danubio, in particolare nei siti di Vlasac e Lepenski Vir;
2) Le deposizioni sono composte maggiormente da individui femminili e infantili; 3) Una parte degli individui rappresentati ha subito morte violenta; 4) Alcune teste sono state distaccate dal corpo per decapitazione, tre invece mostrano segni di
taglio compatibili con scarnificazione; 5) La maggior parte dei resti umani è accompagnata da oggetti di corredo.
Abri du Mannlefelsen
Di poco distante dai corrispettivi siti bavaresi, la grotta di Mannlefelsen si estende presso i confini francesi dell’Alsazia. All’interno della cavità, un cranio isolato giaceva presso un’area caratterizzata da una forte concentrazione di piccoli blocchi di calcare a una profondità di 4,70 m, strato 02. Il contesto è senza dubbio intenzionale in quanto l’intera superficie della grotta presenta poche pietre, disperse e non raggruppate (BOULESTIN – HENRY GAMBIER 2012). Rispetto ai siti tedeschi, a Mannlefelsen il deposito è in superficie e non infossato. Si tratta di un individuo adulto, probabilmente maschio, che appoggiava la fronte sullo strato mentre il forame magno era rivolto verso l’alto con la mandibola a 23 cm dal blocco craniofacciale. Non si riscontra nessun oggetto di corredo, l’intero contesto è stato datato tra la fine del VIII e l’inizio del VII millennio a.C. Nella maggior parte dei resti umani si segnalano segni di violenza tra cui fratture intenzionali, segni di taglio e se consideriamo mandibola e calotta nel suo insieme, probabili tracce di scarnificazione presso le inserzioni muscolari del viso. Per quanto riguarda la struttura di deposizione vera e propria, sembra essere più simile a quelle viste in epoca Maddaleniana/Mesolitico antico come nel sito di Souveterre, ma se prendiamo in considerazione i segni di violenza, la cronologia e la vicinanza con Ofnet e gli altri siti, il deposito di Mannlefelsen è da legare più alle deposizioni bavaresi che a quelle maddaleniane.
Crani manipolati e corpi incompleti nell’Europa settentrionale
Resti umani manipolati sono stati segnalati anche nel Mesolitico svedese, infatti, dagli scavi del 2009-2011 presso Kanaljorden (Östergötland, Svezia) si rinvenne un complesso contesto cerimoniale con deposizioni di crani sulle rive di un ex bacino lacustre. Si tratta di manipolazioni straordinarie nella loro unicità in quanto alcuni crani sono stati deposti in acqua mentre altri due hanno subito un vero e proprio impalamento tramite supporti lignei, ancora conservati (HALLGREN 2011). In entrambi i casi, il palo è stato inserito per la quasi totalità della lunghezza attraverso il forame magno verso la volta cranica (fig. 15-16). Analisi al radiocarbonio datano il
FORMA VRBIS – Ottobre 2014
5
deposito tra 6029 e 5640 cal a.C., durante l’ultima fase del Mesolitico. Nella complessità delle deposizioni i resti umani dovrebbero rappresentare almeno 11 individui, tra cui un neonato, un infante sotto i 18 mesi, due bambini e 9 adulti sia maschi che femmine. Alcuni crani sono integri mentre altri risultano frammentari, le mandibole sono solo due. Risulta difficile interpretare con sicurezza il contesto, si tratta di nemici della comunità esposti sulle rive del lago? Pratiche funerarie di appannaggio a l’élite in vista della società? Occorre comunque ricordare che ci è giunto solo parte dell’atto pratico che si è svolto a Kanaljorden, i motivi che stanno dietro a queste pratiche ci sono per lo più ignote, la ritualità di per sé è sfuggevole. Un altro sito caratterizzato da manipolazioni antropiche sulle ossa, è quello del cimitero tardo Mesolitico di Skateholm nella Svezia meridionale. Rispetto ai precedenti esempi, non si registrano rinvenimenti di resti umani isolati ma bensì un’altra interessante categoria di manipolazioni attorno al cadavere: riapertura secondaria di sepolture con prelievo di particolari distretti ossei (NILSSON STUZT 2003). Il fine è la possibile conservazione di alcune ossa, specialmente crani e ossa lunghe, all’interno del mondo domestico dei vivi come possibili “reliquie”. Sepolture riaperte in un secondo momento, manipolate e private di alcune ossa, sono conosciute in tutti i periodi della preistoria europea (fig. 17) (ANDREWS-BELLO 2006). Ci sono differenti ragioni, o meglio ipotesi, per cui parti del corpo risultano mancanti da un contesto chiuso come quello della sepoltura primaria. Non sappiamo con esattezza se queste ossa fossero oggetto di un culto vero e proprio o rappresentassero un atto aggressivo a livello individuale verso il defunto, l’idea è che al morto venga negata la serenità dopo il trapasso tramite distruzione della tomba o la rimozione di ossa. Il prelievo doveva avvenire molto tempo dopo la morte della persona, in modo che le parti putrescibili fossero ormai scomparse, oppure in un momento in cui i tessuti molli erano ancora presenti e dunque si rendeva necessaria l’asportazione tramite scarnificazione attiva. Nel sito di Skateholm vi sarebbero almeno tre casi di manipolazione secondaria della tomba, si tratta degli individui 28, 35 e 7 che sono stati privati di alcune ossa lunghe dopo la scomparsa dei tessuti (FAHLANDER 2008). Il primo, individuo numero 28 (fig. 18), è un maschio adulto ben conservato di età compresa tra i 30 e i 50 anni, a cui è stato rimosso parte del lato sinistro del corpo: radio, ulna, coxale e femore sinistro. Tutte le altre ossa sono presenti e ben conservate, persino i resti ossei adiacenti a quelli scomparsi sono in situ e senza disturbi, come la rotula sinistra, la mano e l’omero sinistro. Non ci sono tracce di disturbi post-deposizionali o del passaggio di animali spazzini, in caso contrario non si sarebbero mantenute le connessioni anatomiche né avremmo trovato uno scheletro così ben conservato. Anche per gli individui adulti 35 e 7 la situazione è simile a quella osservata per la tomba 28, in questo caso è assente il femore sinistro per entrambi gli scheletri (figg. 19-20). Infine, è interessante notare che nella penisola Scandinava le manipolazioni sui corpi dei defunti del sito di Skateholm non sono affatto un caso isolato, ma si osservano in altri siti contemporanei e in altri ancora appartenenti al Neolitico medio, come nel vicino sito di Ajvide.
Deposizioni domestiche durante il Mesolitico finale / Neolitico antico dei Balcani
Una delle caratteristiche del Mesolitico della zona dei Balcani, denominata anche come Iron Gates o Gole del Danubio meridionali, è il rinvenimento costante di sepolture e resti umani isolati attorno e all’interno di case o focolari. In questi casi, le deposizioni potevano essere avvenute in momenti in cui le case erano ancora frequentate, come dimostrano i ritrovamenti di ossa umane isolate di età più antica rispetto all’abitazione in sé, oppure è stato suggerito che le medesime aree non furono usate in modo simultaneo per deposizione e occupazione, ma piuttosto gli edifici erano adibiti a
FORMA VRBIS – Ottobre 2014
6
scopo funerario dopo essere stati occupati (BORONEANT 2008). Due siti della transizione tra Mesolitico e Neolitico antico sul lato romeno del Danubio, Schela Clodovei (Drobeta-Turnu Severin, Romania) e Icoana (Mehedinti, Romania), hanno restituito entrambi vari resti umani in ambito domestico, tra cui alcuni crani. A Schela Clodovei, sul lato orientale del complesso, si rinvenne una fossetta piena di lische di pesce e a circa 50 cm, un cranio umano infantile (individuo M3/SB3). Altri crani furono ritrovati isolati all’interno delle case, il dato interessante è che il numero di questi resti corrisponde al numero delle sepolture acefale rinvenute attorno alle case (KOGĂLNICEANU 2012). Altri resti umani isolati provengono dal sito Mesolitico/Neolitico di Icoana dove presso una piattaforma abitativa si rinvenne un cranio umano depositato. A parte il cranio descritto sopra, resti umani isolati furono rinvenuti nella trincea SIV, alla profondità di 1.70 m: una mandibola frammentaria in un contesto con strumenti in osso e zagaglie e ancora in SVII, un’altra mandibola frammentaria. Spostandoci questa volta nella Serbia orientale, di particolare rilevanza è il legame tra le abitazioni trapezoidali e i resti umani nell’insediamento di Lepenski Vir I e II (Bor, Serbia) tra il VII e VI millennio a.C (Radovanovic 2000). Vi sarebbero 5 differenti tipi di deposizioni trovate presso le casi di Lepenski Vir, tra questi vari resti umani isolati presso focolari, angoli degli edifici oppure sopra o sotto i pavimenti. Un femore umano fu letteralmente incastrato/inserito nel pavimento delle case 3 e 54 (SREJOVIC 1972). Casi dove ossa umane isolate erano collocate nella parte anteriore o posteriore dei focolari potrebbero essere in relazione con l’abbandono delle case (CHAPMAN 2000). Tuttavia, tutti i resti umani posti sopra il pavimento sembrerebbero più antichi delle stesse case, infatti, l’omero umano nella parte posteriore della casa 43 (fase 2), è caratterizzato da caratteristiche antiche che si collocano nella fase del Mesolitico antico. Nella casa 40, una mandibola di donna adulta era collocata nella costruzione di pietra del focolare (prototipo di placche di pietra disposte triangolarmente intorno al focolare, tipici della fase più tarda di Lepenski Vir), e non ci sono ragioni per non considerare la forte connessione tra focolare e deposizione di ossa di antenati (fig. 21). Nella casa 35, coste umane e ulne erano dislocate nella zona posteriore del focolare insieme a una mandibola di cane. Dall’altra parte del focolare, invece, un femore umano era posto sotto un “tavolo” di pietra (SREJOVIC 1972). Entrambe le case furono usate nella fase II, ma le ossa sembrerebbero essere del medesimo periodo o più antiche. Infine, si menziona il sito serbo di Vlasac, non distante da Lepenski Vir, dove in un’area circoscritta si rinvennero una serie di sepolture disposte una sopra l’altra e appartenute a più generazioni, probabilmente una zona cultuale riservata a un élite della popolazione locale (BORIC 2014). L’ultima sepoltura, H63, conteneva tra le gambe del defunto un femore aggiuntivo appartenuto a un individuo più antico, mentre al di sopra della tomba, la zona fu obliterata con lastroni di pietra e la deposizione di un cranio di cervo rosso e 80 cm più a sud, allineato con un grande blocco di pietra, si trovava il cranio isolato di un bambino (fig. 22).
Conclusioni
Il termine “reliquia”, da me usato in questo elaborato, a prima vista potrebbe apparire improprio in quanto per definizione implicherebbe un forte aspetto cultuale, tuttavia credo che si presti molto bene per comprendere il grado e il tipo di manipolazione che dovevano aver subito alcuni resti umani nel mondo
preistorico europeo. Il significato di comportamenti volti alla selezione e conservazione di resti umani sopra menzionati, rimane per lo più oscuro, sebbene la ricorrenza del dato archeologico, combinata ad una manipolazione antropica delle ossa, conferisce un valore aggiunto alla pratica. Un contatto giornaliero con la morte doveva essere molto più comune rispetto alla relegazione del defunto nella
FORMA VRBIS – Ottobre 2014
7
tomba. Si tratta di cercare di comprendere il gesto che ha dato origine a tali pratiche. Da quali corpi provengono le ossa umane prelevate? In caso di ritrovamento del solo distretto craniale, in che modo è stato smaltito lo scheletro assiale? Le sepolture incorrotte erano forse destinate a individui che dovevano essere lasciati ai margini, esclusi dall’interazione col mondo vivente? Di conseguenza, gli individui manipolati erano nemici o persone di lignaggio superiore che in qualche modo dovevano continuare a “vivere” sotto diversa forma nella quotidianità domestica dei vivi? Nemici o “culti” ancestrali, atti di violenza o simbolici, al momento nessuna ipotesi può essere esclusa con certezza.
Bibliografia essenziale P. Andrews - S. Bello, Pattern in human burial practices, in The social Archaeology of funerary remains, Oxbow Books : Oxford, 2006, pp 14-29 D. Boric, “Late Mesolithic lifeways and deathways at Vlasac (Serbia)”, in Journal of Field Archaeology 39, 2014, pp. 4-31 D. Boric, “Happy forgetting? Remembering and dismembering dead bodies at Vlasac”, in D. Boric eds Archaeology and Memory, Oxbow Books 2010, pp 48-68 A. Boroneant, V. Boronenant, N. Miritoiu, D. Soficaru, ”The Icoana burials revisited”, in Studii de Preistorie 5, 2008, pp 51-60 B. Boulestin et Henry-Gambier, Le crane Mésolithique de l’abri du Mannlefelsen I a Oberlag (Haut-Rhin): étude des modifications osseuses, in B. Boulestin e D. Henry-Gambier (sous la direction de), Cranes trophées, cranes d’ancetres de la tete: problémes d’interprétation en archéologie, Bar Intenational Series 2415, 2012, pp 77-87 N. Cauwe, “Du cadavre a la relique: l’usage de l’os humain au Magdalenien”, in Mémoires Société préhistorique française 39, 2005, pp. 353-368 J. Chapman, Fragmentation in archaeology : people, places and broken objects in the prehistory of south eastern Europe, London, Routledge, 2000 S. Cucchiarini Cds, Morti tra i vivi: resti umani isolati e possibili manipolazioni antropiche sui defunti dal Paleolitico superiore al Neolitico. I casi di Grotta Paglicci (FG) e l’area del Fucino (AQ), in Ollus leto datus est Architettura, topografia e rituali funerari nelle necropoli dell’Italia meridionale e della Sicilia fra antichità e Medioevo, Atti del Convegno Internazionale di Studi Reggio Calabria 22-25 Ottobre 2013 F. Fahlander, A Piece of the Mesolithic Horizontal Stratigraphy and Bodily Manipulations at Skateholm, in F. Fahlander and T. Oestigaard eds The Materiality of Death Bodies, burials, beliefs, BAR International Series 1768, 2008, pp 29-45 D. Farembach, “Le crâne du Roc Allan (Sauveterre la Lémance)”, in Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, XIII° Série, tome 1 fascicule 1, 1974. pp. 159-170. F. Hallgren, “Mesolithic Skull Depositions at Kanaljorden, Motala, Sweden”, in Current Swedish Archaeology 19, 2011, pp 244-246
FORMA VRBIS – Ottobre 2014
8
D. Hofmann, The emotional Mesolithic: pas and present ambiguities of Ofnet cave, in N. Milner and P. Woodman eds, Mesolithic Studies at the Beginning of the 21st Century, Oxford: Oxbow Books, 2005, pp 194-211 C. Jeunesse, Ofnet et les dépots de tetes dans le Mésolithique du sud-ouest de l’Allemagne, in B. Boulestin e D. Henry-Gambier (sous la direction de), Cranes trophées, cranes d’ancetres de la tete: problémes d’interprétation en archéologie, Bar Intenational Series 2415, 2012, pp 69-75 B. Kaulich, “Das Paläolithikum des Kaufertsberges bei Lierheim, Gem. Appetshofen”, in Ldkr. Donau-Ries. Quartär 33/34, 1983, pp 29-97 R. Kogalniceanu, “Human Remains from the Mesolithic to the Chalcolithic Period in Southern Romania. An Update on the Discoveries”, in Archaeologia Bulgarica XVI, 3, 2012, pp. 1-46 L. Nilsson Stutz, Embodied rituals & ritualized bodies : tracing ritual practices in late mesolithic burials, Lund : Almqvist & Wiksell International, 2003 J. Orschiedt, Manipulationen an menschlichen Skelettresten. Taphonomische Prozesse, Sekundärbestattungen oder Kannibalismus?”, Urgeschichtliche Materialhefte 13, Tübingen, Mo Vince Verlag, 1999 J. Orschiedt, “The Neolithic and Mesolithic cave site “Blatterhohle” in Westphalia”, in Notae Prehistoricae 32, 2012, pp. 73-88 J. Orschiedt, Bodies, Bits and pieces: Burials from the Magdalenian and the Late Palaeolithic. In A. Pastoors - B. Auffermann, Pleistocene foragers: Their culture and environment. Festschrift in honour of Gerd - Christian Weniger for his sixtieth birthday. Wissenschaftliche Schriften des Neanderthal Museums 6, 2013, pp. 117-132 I. Radovanovic, “Houses and burials at Lepenski Vir”, in European Journal of Archaeology Vol. 3(3), 2000, pp 330-349 S. Rigaud, La parure : traceur de la geographie culturelle et des dynamiques de peuplement au passage Mesolithique-Neolithique en Europe, thése de docteur Sous la direction de F. d’Errico et M. Vanhaeren, L’Universite Bordeaux 1 Ecole doctorale Sciences et Environnements, 2011 P. Schröter, “Zum Schädel vom Kaufertsberg bei Lierheim, Gem. Appetshofen”, in Ldkr. Donau-Ries. Quartär 33/34, 1983, pp 99-109 D. Srejovic, Europe’s first monumental sculpture: new discoveries at Lepenski Vir, New York: Stein and Day, 1972
O. Völzing, “Die Grabungen 1937 am Hohlestein im Lonetal, Fundberichte aus Schwaben”, in Neue Folge, 1935-1938 IX, 1938, pp 1-7 R. Wallduck, Post-mortem body manipulation in the Danube Gorges’ Mesolithic--‐Neolithic: a taphonomic perspective, Dissertation submitted to the University of Cambridge for the degree of Doctor of Philosophy, 2013
FORMA VRBIS – Ottobre 2014
9
J. Wahl, Karies, Kampf und Schädelkult – 150 Jahre anthropologische Forschung in Südwestdeutschland, Materialhefte z. Archäologie in Bad.-Württ 79, 2007
Figura 1 : Esempio di riapertura secondaria di una tomba per la rimozione di particolari distretti scheletrici. (Immagine
modificata S. Cucchiarini)
FORMA VRBIS – Ottobre 2014
10
Figura 2 : Modello riassuntivo delle varie fasi di trattamento del corpo, dal cadavere alla “reliquia” (Immagine S. Cucchiarini)
FORMA VRBIS – Ottobre 2014
11
Figura 3 : Calotta isolata rinvenuta presso il sito di Blatterhohle (Germania) (da Orschiedt 2012, fig. 4)
Figura 4 : Uno dei tre crani di cinghiale rinvenuti attorno alla calotta umana (da Orschiedt 2012, fig. 3)
FORMA VRBIS – Ottobre 2014
12
Figura 5 : Localizzazione siti mesolitici con deposizioni di crani isolati (da Rigaud 2011, fig. 81)
Figura 6 : Ricostruzione del contesto di ritrovamento dei crani di Hohlenstein-Stadel (foto modificata da Jeunesse 2012)
FORMA VRBIS – Ottobre 2014
13
Figura 7 : Deposizione di tre crani da Holenstein-Stadel (da Volzing 1938)
Figura 8 : il deposito di crani da Holhestein-Stadel, visione dall’alto (da Volzing 1938)
FORMA VRBIS – Ottobre 2014
14
Figura 9 : Le due fosse con i depositi di crani dalla grotta di Ofnet (da Jeunesse 2012, fig. 4)
Figura 10 : Schema rappresentativo dei segni di taglio su alcuni crani di Ofnet (foto modificata da Jeunesse 2012)
FORMA VRBIS – Ottobre 2014
15
Figura 11 : Canini di cervo, divisi per gruppi, rinvenuti in associazione con i crani di Ofnet (da Rigaud 2011, fig. 29)
Figura 12 : Gyraulus sulcatus forati da Ofnet (da Rigaud 2011, fig. 52)
FORMA VRBIS – Ottobre 2014
16
Figura 13 : Denti di cervo forati che accompagnavano alcuni crani di Ofnet (da Rigaud 2011, fig. 28)
Figura 14 : Provenienza delle diverse tipologie di conchiglie rinvenute nel sito di Ofnet (da Rigaud 2011, fig. 70)
FORMA VRBIS – Ottobre 2014
17
Figura 15 : Cranio con palo ligneo inserito nel forame magno (da Hallgren 2011, fig. 5)
Figura 16 : Uno dei crani rinvenuti sul fondo dell’ex lago presso Kanaljorden (da Hallgren 2011, fig. 4)
FORMA VRBIS – Ottobre 2014
18
Figura 17 : Sepoltura acefala dal sito serbo di Lepenski Vir (da Srejovic 1972)
FORMA VRBIS – Ottobre 2014
19
Figura 18 : Sepoltura n° 28 con possibile rimozione intenzionale di alcune ossa lunghe della parte sinistra del corpo (da Nilsson
Stutz 2003)
FORMA VRBIS – Ottobre 2014
20
Figura 19 : Sepoltura n° 7 con possibile prelievo secondario del femore sinistro (da Nilsson Stutz 2003)
Figura 20 : Sepoltura n 35, in basso, altro possibile prelievo secondario del femore sinistro (da Nilsson Stutz 2003)
FORMA VRBIS – Ottobre 2014
21
Figura 21 : Mandibola femminile rinvenuta all’interno di una struttura litica per focolare a Lepeski Vir. Si noti la presenza di ocra
rossa negli alveoli dei denti incisivi (da Wallduck 2013, fig. 6.29)
Figura 22 : Ricostruzione ipotetica del contesto funerario di Vlasac. Dopo il seppellimento dell’ultimo individuo H63, l’area viene
obliterata attraverso la deposizione di lastroni di pietra, palchi di cervo, un cranio umano infantile e un femore di adulto (da
Boric 2010, fig. 3.9)





























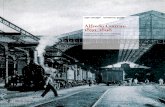



![Fra il nome e la stora. Trasformazioni del discorso politico e concetto di classe in Francia al principio della monarchia di Luglio (1831-1832) - [PhD Thesis - Ita]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6319729ce9c87e0c09102069/fra-il-nome-e-la-stora-trasformazioni-del-discorso-politico-e-concetto-di-classe.jpg)




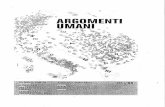

![Cronologia delle trasformazioni storico-architettoniche [Castel Capuano di Napoli]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631b5e873e8acd99770563ba/cronologia-delle-trasformazioni-storico-architettoniche-castel-capuano-di-napoli.jpg)

