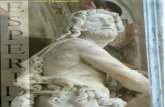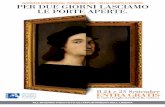La necropoli golasecchiana di Brembate Sotto. Revisione dei vecchi dati
Transcript of La necropoli golasecchiana di Brembate Sotto. Revisione dei vecchi dati
LA NECROPOLI GOLASECCHIANA DI BREMBATE SOTTO. REVISIONE DEI VECCHI DATI
Stefania Casini(1)
Riassunto. Una revisione dei dati relativi alle scoperte avvenute a Brembate Sotto tra il 1888 e il 1889, insieme al ritrovamento all’Archivio Centrale dello Stato a Roma della planimetria disegnata da Gaetano Mantovani, permette di ricostruire alcuni aspetti della necropoli, tra cui le strutture tombali, la composizione dei corredi, gli aspetti del rituale, la composizione del gruppo umano sepolto, arrivando a proporre l’esistenza di un numero minimo di 28 sepolture.
Résumé. Une révision attentive des données concernant les découvertes faites à Brembate Sotto entre 1888 et 1889, appuyée par la découverte dans les Archives Centrales de l’État de Rome du plan conçu par Gaetano Mantovani, permet de reconstituer certains aspects du cimetière : structures funéraires, composition des assemblages, aspects du rituel, recrutement humain. Un nombre minimum de 28 sépultures peut être restitué.
(1) Civico Museo Archeologico, piazza Cittadella 9 - I - 24129 Bergamo - [email protected]
La necropoli di Brembate Sotto è il principale ritro-vamento di carattere funerario della cultura di Golasecca nel territorio bergamasco.
La necropoli fu in uso tra la metà del VI e i primi del IV secolo a.C. con un numero elevato di tombe che rivelano l’esistenza di un importante abitato, non ancora identificato, nella zona interfluviale tra Adda e Brembo, particolarmente strategica nella geografia dei contatti a vasto raggio che la cultura di Golasecca intrattenne per più di un secolo.
I ritrovamenti avvennero casualmente nel maggio 1888 durante i lavori di costruzione della strada provin-ciale che da Osio porta a Trezzo. Sulla riva destra del fiume Brembo, gli operai trovarono ad un metro circa dalla superficie, urne cinerarie, vasetti, armi, apparte-nenti, a detta loro, a una ventina di tombe. Per la fretta di concludere i lavori i materiali furono dispersi e non fu data notizia all’autorità competente. Due possidenti del luogo, il cavaliere Vittore Tasca e il notaio Giuseppe Vertova, riuscirono a raccogliere una parte degli oggetti, consegnati poi a G. Mantovani, reale ispettore delle antichità del cir-condario, mentre altri furono da lui acquistati, ma i corredi andarono smembrati e le associazioni perdute per sempre.
Nel 1889 la Rappresentanza Provinciale promosse scavi regolari nello stesso luogo e, sotto la sorveglianza dell’Ing. Giuseppe Nievo e con numerosi sopralluoghi del Mantovani, fu esplorata una zona di 440,50 mq che portò al recupero di 14 tombe. La relazione dei ritrovamenti fu pubblicata dal Mantovani sulle Notizie Archeologiche Bergomensi (1884-90), insieme all’elenco completo dei materiali recuperati nel 1888 e con le fotografie dei corredi tombali, utili a identificare molti oggetti e talvolta unica testimonianza di ciò che non è più reperibile.
All’inizio del 1900 il materiale di Brembate Sotto fu depositato presso la Biblioteca Civica A. Mai di Bergamo e successivamente esposto nel nuovo Museo Archeologico allestito presso la Rocca. Nel 1960 tutto il materiale fu trasferito nella nuova sede del Museo, all’interno della Cittadella viscontea e tra il 1976 e il 1979 fu operato da D. Premoli Silva e R.C. de Marinis un lungo lavoro di riordino e di riconoscimento, che portò anche alla consta-tazione che molti oggetti erano stati irrimediabilmente perduti. Mentre R.C. de Marinis nel 1981 pubblicava 10 corredi databili al V secolo a.C., i restanti materiali erano oggetto della mia tesi di laurea.
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012). 387p. 387-392 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
Stefania Casini
388 Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012)p. 387-392 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
1. Le informazioni suLLo scavo e Le strutture tombaLi
Gaetano Mantovani stese la relazione del ritrova-mento basandosi sulle osservazioni effettuate durante i suoi sopralluoghi e sui dati registrati sul Giornale di scavo dall’ing. Giuseppe Nievo, che diresse i lavori. Redasse anche una planimetria dei ritrovamenti, rintrac-ciata nel 2007 presso l’Archivio centrale dei Beni cultu-rali a Roma, che ha permesso l’esatto posizionamento della necropoli nel paesaggio odierno e di stabilire che le tombe del 1888 si trovavano a sud di quelle scavate nel 1889.
Lo scavo del 1889 mise in luce un deposito così de scritto : 1) uno strato superficiale di humus variabile dai 0,25 a 0,35 m di spessore ; 2) un livello di terreno alluvionale profondo 0,80 m ; 3) uno strato di sabbia vergine. Le tombe erano al di sopra del livello di sabbia vergine, nel terreno alluvionale, a una profondità varia-bile tra 0,70 e 1,10 m dal piano di campagna.
Relativamente alle tombe scavate nel 1889 Mantovani non riferisce alcuna informazione circa le strutture delle tombe 1, 2, 3, 4, 10 e 11, facendo pensare a deposizioni in nuda terra. Si arguisce dalle descrizioni, che le tombe 5, 6, 7, 8, 9 e 12 avevano strutture con fosse foderate di ciottoli, mentre le tombe 11 e 13 avevano di ciottoli solo la copertura. Solo due tombe avevano una chiusura di pietra : il pozzetto della tomba 12 era coperto da un masso di ceppo di m 1,50 x 1 x 0,40, mentre la t. 14, in nuda terra, era chiusa da due grosse lastre di gra-nito di m 0,60 x 0,8 x 0,12.
2. iL rituaLe funerario
Le tombe scavate nel 1889 erano tutte a cremazione, come anche le tombe A e B del 1888 ; i materiali recupe-rati nel 1888, fino ad un intervento di restauro avvenuto
nel 1982-83, recavano incrostazioni della terra di rogo. Un solo dubbio resta riguardo alla tomba che conteneva la spada ad impugnatura antropoide, raccolta nel 1888, che non fu spezzata o deformata come avvenne, invece, per la identica spada della t. VIII/1926 della Ca’ Morta (de Marinis, 1981, p. 58, tav. 29, n° 9 e 30, n° 3), la cui lama fu staccata dall’impugnatura e arrotolata, mentre all’interno del foro dell’impugnatura fu inserita una punta di lancia, un chiaro atto di defunzionalizzazione. Non è possibile, dunque escludere con assoluta certezza che la spada di Brembate fosse pertinente a un’inumazione.
Nel VII e VI secolo, nelle necropoli della facies settentrionale della cultura di Golasecca (Mesolcina, Val d’Ossola e Sopraceneri), tombe a cremazione coesis-tono accanto a inumazioni, mentre nella facies orientale (Sottoceneri, territori di pianura fino al Serio) i morti sono solo cremati (Schindler, de Marinis, 2000).
Due sepolture a inumazione della necropoli di Pombia, tt. 12/95 e 15/95 della loc. Bau (Gambari, 2001, p. 93-94), della metà e seconda metà del VI secolo a.C., hanno posto l’attenzione sul problema della presenza del rito inumatorio anche al di fuori della Svizzera meridio-nale. In area novarese si conoscono anche la t. 1 di Motto Lagone di Arona del G. II B (Gambari, 2001, p. 93) con una donna inumata con ricco corredo, tra cui una fibula tardo-hallstattiana, e la t. XXXVI sotto tumulo di S. Bernardino di Briona, priva di resti del rogo (Gambari, 1987a e 1987b, p. 91-92). Gambari ritiene plausibile la presenza di inumazioni all’interno delle necropoli a cre-mazione della cultura di Golasecca nel Novarese, a partire dalla metà del VI secolo a.C., attribuita alla presenza di individui provenienti da altre aree culturali, come nel caso della tomba di Motto Lagone, o territori di confine con la cultura di Golasecca, come quello taurino-salasso, dove era praticata l’inumazione (Gambari, 2001, p. 93, nota 2).
Forse anche a Brembate si può ipotizzare la pre senza di un’inumazione, databile alla prima metà del V secolo
Fig. 1. Posizionamento della necropoli di Brembate Sotto sulla Carta tecnica regionale (non in scala) sulla base delle indicazioni topografiche della mappa disegnata da Gaetano Mantovani.
La necropoLi goLasecchiana di BremBate sotto. revisione dei vecchi dati
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012). 389p. 387-392 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
a.C., che accoglieva un soggetto maschile portatore di spada, la cui identità culturale non è più definibile, essendo perso completamente il corredo.
Le ceneri dei defunti erano poste entro urne fittili o di bronzo, con gli oggetti indossati al momento del rogo. Vicino all’urna era collocato il corredo, coppe, boccali e bicchieri.
Le urne, in osservanza ad una regola condivisa da tutta la cultura di Golasecca, erano prive di manici ; il
grande boccale cilindrico che fungeva da urna della t. 6 era stato privato dell’ansa. Le situle stamnoidi delle tt. 8 e 10 avevano i manici posati accanto al vaso ; i manici delle situle di tipo renano-ticinese delle tt. 12 e 14 furono staccati, ma non deposti nella tomba. La situla e la cista rinvenute nel 1888 prive dei manici erano urne, mentre non lo era la situla stamnoide, con i manici ancora attac-cati. La frantumazione rituale era prevista per alcuni tipi di fibule, rotte in 3 pezzi : staffa, corpo e molla con ardiglione.
Fig. 2. Brembate Sotto, recuperi del 1888. Selezione di fibule : 1-2, fibule di tipo tardo-alpino var. B ; 3, fibula di tipo tardo-alpino var. C. ; 4, fibula a sanguisuga tipo mazzucca di Montanaso ; 5, 7, fibule tipo Lodigiano var. A ;
6, fibula ad arco serpeggiante tipo Brembate Sotto (dis. S. Casini ; bronzo, rid. 1:2).
Stefania Casini
390 Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012)p. 387-392 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
Fig. 3. Brembate Sotto, recuperi del 1888. 1-3, selezione di pendagli a secchiello ; 4, piccola situla in frammenti della tomba B/1888, con all’interno una paletta in ferro (non in scala) ; 5, orlo di situla stamnoide con i manici ; 6-7, palette in ferro ;
8, spada in ferro a impugnatura antropoide (dis. e foto S. Casini ; 1-3, 6-7 rid. 1:2 ; 5 e 8 rid. 1:3).
La necropoLi goLasecchiana di BremBate sotto. revisione dei vecchi dati
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012). 391p. 387-392 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
È cospicuo il numero di spiedi di ferro, sempre deposti all’esterno dell’urna ; la loro presenza, in numero di 3, si registra solo nelle tombe maschili (tt. 6, 10, 14), nella tomba bisoma 8 e con un’unica eccezione nella t. 12, di un individuo femminile, dove però lo spiedo era singolo. Spiedi erano presenti anche nelle tombe C/1888 e 11 per le quali è impossibile, in assenza di ornamenti, stabilire il sesso del defunto. Queste evidenze contra-stano con i dati delle necropoli dell’area di Como (de Marinis, 1988, p. 211), dove gli spiedi erano deposti in tombe femminili, associati a vasi rituali, che farebbero pensare a pratiche sacrificali appannaggio di donne, come in altri ambiti culturali della penisola (paleoveneto, laziale, etrusco).
La posizione degli spiedi tra il vasellame allude forse alla pratica del banchetto funebre, con riferimento all’of-ferta della carne, anche se mancano oggetti funzionali al taglio di questo alimento. Un’eccezione è il coltello della t. 14, l’unico rinvenuto in un’associazione chiusa ; era poggiato trasversalmente sull’orlo dell’urna. Il coltello con impugnatura di bronzo, lama in ferro, fodero di legno di acero1 con puntale ad àncora di bronzo, recuperato nel 1888, è privo delle originarie associazioni.
La pratica dell’ossilegio è provata dalla presenza delle palette di ferro del 1888 e delle tombe B/1888 (femminile) e n. 8 (bisoma). La deposizione all’interno dell’urna, come è ancora visibile per l’esemplare della t. B/1888, le mette in relazione con la raccolta delle ceneri, escludendo l’allusione al loro utilizzo per la gestione del focolare domestico.
Mantovani riferisce di avere riscontrato tracce di tessuto sull’orlo della situla della t. 14, ritenendole parte di un involucro che conteneva le ossa combuste. Non si può, tuttavia, escludere che la tela coprisse l’urna, come una sorta di abito, similmente a quanto avveniva in ambiente paleoveneto. Non ci aiutano a dirimere la questione alcune tracce di tessuto mineralizzato, conser-vate su alcuni reperti della tomba B/1888. Le analisi del tessuto2, però, hanno permesso di stabilire che si tratta della stessa pezza di lana, caratterizzata da armatura bata-via da 4 (tweed). I fili hanno tutti torsione a Z.
Nelle tombe di Brembate Sotto erano presenti alcune armi (punte di lancia, una spada, un coltello), tutte rac-colte nel 1888, quindi provenienti da una specifica area della necropoli, forse riservata alla sepoltura di perso-naggi di cui era sottolineato il ruolo guerriero. La perdita di questi corredi è tanto più grave se si considera che
1. La determinazione paleobotanica è stata eseguita da Mauro Rottoli del Laboratorio di Archeobiologia dei Musei Civici di Como.2. Effettuate da M. Rottoli del Laboratorio di Archeobiologia dei Musei Civici di Como.
nella cultura di Golasecca tra la metà del VI e la metà del V secolo a.C. le armi sono di rado deposte nelle tombe. Da quest’area proviene anche un oggetto forse di carat-tere rituale, in forma di spillone, con la punta non idonea a infilzare. È possibile che si tratti di un oggetto rappre-sentativo di una determinata funzione (sacerdotale ?) e ciò conferma che questa specifica area ospitava tombe di personaggi con precise funzioni all’interno della comu-nità, sia guerriere sia sacerdotali.
Non si hanno informazioni su particolari offerte alimentari all’interno delle tombe. Da segnalare solo il ritrovamento nella tomba 12 di « ossa di un piccolo rosic-chiante ». Si trovavano all’interno dell’urna insieme a numerosi pezzetti di legno della cremazione. Se si tratta di un’offerta, forse era stata gettata sul rogo e posta nell’urna insieme ai resti carbonizzati.
3. La composizione deL gruppo umano deLLa necropoLi di brembate sotto
In assenza delle ossa calcinate dei defunti, la dis-tinzione di genere può essere effettuata solo attra-verso l’analisi degli oggetti di ornamento dei corredi. Mantovani riferisce che nel 1888 moltissimi pezzetti di ossa calcinate andarono dispersi, tranne quelli dell’urna della tomba A/1888. Delle sepolture del 1898 sappiamo che le ceneri della t. 4 furono lasciate fra la terra e quelle della t. 7 non furono raccolte, o vennero mescolate con quelle della t. 6, che non sono a tutt’oggi rintracciate al Museo.
Gli unici resti ossei conservati sono quelli della t. B/1888, anche se non sono citati da Mantovani. L’analisi antropologica del campione3, costituito da pochi fram-menti di osso spugnoso, di coste, ossa lunghe e frammenti vari, non ha permesso di risalire al sesso del defunto, che sappiamo femminile dagli ornamenti ; aveva tra i 25 e i 35 anni, sulla base del conteggio degli osteoni, eseguito su un campione di diafisi di osso lungo. Sono state rile-vate tracce di periostite in sede costale.
Tutte le tombe erano individuali, tranne la t. 8, pro-babilmente bisoma, a giudicare dalla presenza nella stessa urna di fibule ad arco serpeggiante e a drago e di fibule a sanguisuga e ad arco composto con elementi di corallo e fili d’oro e d’argento.
Delle 17 tombe superstiti, 7 erano deposizioni fem-minili (tt. A e B/1888, 1-2, 4, 12), cui si può aggiungere un’ot tava, indicata dalla fibula a sanguisuga pertinente a una sepoltura più antica distrutta dalla t. 14 ; tra il materiale del 1888 sono preponderanti gli ornamenti femminili e,
3. Eseguita da Elisabetta Castiglioni del Laboratorio di Archeobiologia dei Musei Civici di Como.
Stefania Casini
392 Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012)p. 387-392 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
poiché le fibule di tipo Mazzucca di Montanaso e Lodigiano di solito sono deposte in esemplare singolo, è possibile stabilire che vi erano almeno 8 tombe di donne tra quelle distrutte.
I soggetti maschili delle tombe del 1898 sono 5 (tt. 6, 8, 9, 10, 14), cui vanno probabilmente aggiunte la t. 7, se è corretta l’attribuzione della staffa ad una fibula ad arco serpeggiante tipo Fraore, e le tombe C/1888 e 11 per la presenza degli spiedi. Per quanto riguarda il materiale recuperato nel 1888, possiamo affermare che gli individui maschili erano almeno tre, per la presenza di altrettante
fibule ad arco serpeggiante di 3 fasi cronologiche diverse (G. II B, III A1 e III A2). Del tutto indeterminabile il sesso dei defunti delle tt. 3, 5 e 13, con sola ceramica.
In conclusione la necropoli comprendeva almeno 16 tombe di soggetti femminili e almeno 11 sepolture di indi-vidui maschili, mentre un’unica sepoltura bisoma acco-glieva un soggetto maschile ed uno femminile di età non definibile ; in conclusione è possibile accertare l’esistenza sicura di 28 sepolture, un numero certamente in difetto rispetto alla composizione originaria della necropoli.
Bibliografia sulla necropoli
casini s., 1992, La cultura di Golasecca e il territorio ber-gamasco, Le schede-guida del Museo Archeologico di Bergamo, Bergamo, Civico museo archeologico, 1 vol.
casini s., 2004, « Spada a impugnatura antropoide », in : marzatico f., gLeirscher p. dir., Guerrieri, principi ed eroi fra il Danubio e il Po dalla Preistoria all’Altome-dioevo, Catalogo della mostra, Trento, p. 674-675, n. 8.18.
casini s., 2007, « Le sepolture dei Celti golasecchiani nel ter-ritorio bergamasco », in : Storia economica e sociale di Bergamo. I primi millenni. Dalla Preistoria al Medioevo, Fondazione per la storia economica e sociale di Bergamo, Bergamo, p. 190-201.
casini s., c.s., « La necropoli protostorica di Brembate Sotto », Notizie Archeologiche Bergomensi, 15, 2007, in prepara-zione.
de marinis r.c., 1981, « Il periodo Golasecca III A in Lombardia », Studi Archeologici, I, p. 43-300.
mantovani g., 1884-90, « Brembate Sotto », Notizie Archeo-logiche Bergomensi, p. 35-83.
Riferimenti bibliografici
de marinis r.c., 1988, « Liguri e Celto-Liguri », in : pugLiese carrateLLi g. dir., Italia Omnium Terrarum Alumna, ed Scheiwiller, Milano, p. 159-259. (Antica Madre, Collana di studi sull’Italia antica).
gambari f.m., 1987a, « Riti funebri e organizzazione ter-ritoriale della necropoli di San Bernardino di Briona (Novara) », Bollettino Storico per la provincia di Novara, LXXVIII, 1, p. 145-167.
gambari f.m., 1987b, « La necropoli di San Bernardino di Briona : revisione critica alla luce dei risultati prelimi-nari dei nuovi scavi », Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 6, p. 63-95.
gambari f.m., 2001, « Aspetti del rito nella necropoli di Pombia », in : gambari f.m. dir., La birra e il fiume. Pombia e le vie dell’ovest Ticino tra VI e V secolo a.C., Catalogo della mostra, Torino, p. 93-98.
schindLer m.p., de marinis r.c., 2000, « L’età del Ferro nel Canton Ticino e nella Mesolcina », in : de marinis r.c., biaggio simona s. dir., I Leponti tra mito e realtà, 1, Catalogo della mostra, Armando Dadò editore, Locarno, p. 159-183.
bibLiografia