V. Bellelli, Le terrecotte architettoniche non a stampo di Cerveteri: nuovi e 'vecchi' ritrovamenti...
Transcript of V. Bellelli, Le terrecotte architettoniche non a stampo di Cerveteri: nuovi e 'vecchi' ritrovamenti...
Published byOxbow Books, Park End Place, Oxford OX1 1HN
© Oxbow Books, Patricia S. Lulof, Carlo Rescigno and the individual contributors 2010
ISBN 978 1 84217 426 5
A CIP record for this book is available from the British Library
This book is available direct fromOxbow Books, Park End Place, Oxford OX1 1HN
(Phone: 01865-241249; Fax: 01865-794449)
and
The David Brown Book CompanyPO Box 511, Oakville, CT 06779, USA
(Phone: 860-945-9329; Fax: 860-945-9468)
and
via our websitewww.oxbowbooks.com
Frontcover and backcover: Acroterio dal santuario di Cannicella a Orvieto; vista anteriore e posteriore(Stopponi, figg. 10-11)
Printed in Great Britain byShort Run Press Ltd, Exeter
Deliciae Fictiles IVArchitectural Terracottas in Ancient Italy
Images of Gods, Monsters and Heroes
Proceedings of the International Conference held in Rome (Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Royal Netherlands Institute) and Syracuse (Museo Archeologico Regionale ‘Paolo Orsi’)
October 21-25, 2009
Edited byPatricia Lulof and Carlo Rescigno
Oxbow BooksOxford and Oakville
Acknowledgements ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i IntroductIon .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i i i
I IMAGES OF GODS, MONSTERS AND HEROES: ACROTERIA AND PEDIMENTAL DECORATIONS 1
1 GENERAL SUBJECTS 2
Fictilia tecta. Riflessioni storiche sull’arcaismo etrusco e romano – mArIo torellI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akroteria in ancient Italy: Images and Architectural Traditions – IngrId edlund-Berry ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 The Late Archaic Miracle. Roof decoration in Central Italy between 510 and 450 B.C. – PAtrIcIA lulof ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Gli altorilievi tardo arcaici tra Roma e Lazio – mArIe José strAzzullA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Amazons in pre-roman Italy. Symbols of a new era – sArAh wIllemsen .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Sirens on the roof. Identification of terracotta bird-women in Central Italy – loes oPgenhAffen .... . . . . . . . . . 50
The evolution of bases for acroteria in Etruria and Latium (640/630-510 B.C.) – nAncy wInter ... . . . . . . . . . . . 62
Considerazioni sugli acroteri in forma di cavallo – AlIkI moustAkA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Darstellungen der Nike in der etruskisch-italischen Baudekoration klassischer und hellenistischer zeit – rudolf känel ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
An age without images: architectural decoration in the late republican period – BenJAmIn rous ... . . . . . . . . . 84
2 CENTRAL ITALY 95
Archaic Period
Gli dei sul tetto. Le basi acroteriali del tempio di Veio-Portonaccio: struttura e apparato decorativo – lAurA mArIA mIchettI .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Gli dei sul tetto. Le basi acroteriali del tempio di Veio-Portonaccio: messa in opera e funzione – dAnIele federIco mArAs ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Il repertorio figurativo del ciclo acroteriale del tempio dell’Apollo a Veio-Portonaccio – clAudIA cArluccI .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Le terrecotte architettoniche non a stampo di Cerveteri: nuovi e ‘vecchi’ ritrovamenti nella Vigna Parrocchiale – VIncenzo BellellI .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
TABLE OF CONTENTS
3
CONTENTS
Terrecotte acroteriali e frontonali di età arcaica da santuari di Cerveteri – mArIA AntonIettA rIzzo .... . . 138
Acroterio con scena di combattimento da Falerii al Museo di Villa Giulia – sIlVIA menIchellI .. . . . . . . . . . . . . 148
Terrecotte architettoniche da Guadocinto di Tuscania – AnnA mArIA morettI sguBInI -lAurA rIccIArdI .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Ancora sull’acroterio dal santuario di Cannicella ad Orvieto: la ricomposizione – sImonettA stoPPonI ............................................................................................................... 164
La dea col tutulo dal tempio arcaico del Foro Boario – AnnA murA sommellA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
La decorazione plastica tardo arcaica del santuario di Sol Indiges-Lavinium – AlessAndro JAIA ... . . . . . . . . . 188
Santuario in loc. Le Salzare, Fosso dell’Incastro, Ardea (Roma). Il frontone del tempio tardo arcaico – letIzIA ceccArellI .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
Post Archaic Period
Un nuovo altorilievo di età ellenistica da Civitavecchia (Roma) loc. Scarti di Sant’Antonio – BArBArA BelellI mArchesInI - mArIA crIstInA BIellA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Sull’acroterio da Fabrica di Roma conservato nel Museo di Civita Castellana – lAurA AmBrosInI .. . . . . . . . . 208
The winged horses on the Ara della Regina temple at Tarquinia – gIoVAnnA BAgnAsco gIAnnI ... . . . . . . . . . . . 222
Oreficerie sulle decorazioni figurate dei templi – AlessAndrA coen .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Altorilievi frontonali dall’arce minore di Vetulonia (appendice di P. Pallecchi) – sImonA rAfAnellI .. . . . . . . 236
Lastre di rivestimento ed altorilievi da Bevagna (Perugia), località Aisillo – mArIA romAnA PIcutI .. . . . . . . 243
Il grande tempio di Luni. Nuovi dati dal restauro del Frontone B – gIAndomenIco de tommAso - emAnuelA PArIBenI - elenA sorge ................................................................................................... 250
Architectural Terracottas from the ‘Sanctuary of the Dolphins’ on Monte Pallano (Abruzzo) – susAn kAne - mIchAel crAwford - sIlVAno AgostInI .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Frammenti fittili plasmati a mano da Chieti-Civitella – dAnIelA lIBerAtore ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Terrecotte architettoniche dal territorio marchigiano: vecchie conoscenze e nuove questioni – mAurIzIo lAndolfI - mArIA elIsA mIchelI - AnnA sAntuccI .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Santuario in loc. Le Salzare, Fosso dell’Incastro, Ardea (Roma). Il frontone del tempio tardo repubblicano – clAudIA rossI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
3 CAMPANIA AND MAGNA GRAECIA 295
La decorazione del vano e del fastigio frontonale tra Cuma e Capua – cArlo rescIgno - VAlerIA sAmPAolo .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
CONTENTS
Una ‘nuova’ antefissa capuana – elIAnA VollAro .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Cuma, un acroterio a disco con maschera di Gorgo. Dal ritrovamento all’ipotetica collocazione – mArtIne dewAIlly - PrIscIllA munzI sAntorIello ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
La decorazione del fastigio frontonale nei modelli fittili di tempio da Teanum Sidicinum – frAncesco sIrAno .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Schildfragmente aus Pompeji – Peter dAnner ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Le decorazioni architettoniche di Fratte: vecchie e nuove acquisizioni – AngelA PontrAndolfo - AntonIA serrItellA - PorfIdIo mondA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
La sfinge di Torre di Satriano e il suo contesto architettonico – mAssImo osAnnA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Acroteri e sistemi decorativi per tetti di età arcaica nel sito indigeno di Vaglio di Basilicata – gIoVAnnA greco .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Un tempio arcaico al Lacinio: elementi di una copertura fittile con figure plastiche dai recenti scavi sul promontorio di Capo Colonna di Crotone – gregorIo AVersA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
4 SICILY 388
Gorgoneia di lastre frontonali e di coppi maestri da Naxos di Sicilia – PAolA PelAgAttI - mArIA costAnzA lentInI .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
Terrecotte architettoniche e figurate nel Museo Paolo Orsi: osservazioni ed aggiornamenti – concettA cIurcInA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
The sanctuary to the west of the Santa Venera: a review – mArIA costAnzA lentInI - JArI PAkkAnen .... . . . 417
Il contributo della calcidese Leontini alla conoscenza dei rivestimenti sicelioti – gIusePPInA monterosso 426
Per una revisione delle terrecotte architettoniche di Gela – gIoVAnnA greco .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
Terrecotte architettoniche dell’entroterra sicano – rosAlBA PAnVInI .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
Acroteri a Gela alla luce delle nuove acquisizioni – BIAncA ferrArA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
Gli acroteri nell’architettura arcaica di Selinunte. Elementi noti e nuove acquisizioni – mArIA clArA contI .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
Ἱμεραα ἐξαίρετα. Figure femminili sul tetto del tempio B – lAurA gAsPArrI .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
II AddItIons 503
1 centrAl ItAly 504
Young Apollo: a new reconstruction of an acroterial statue from Veii – nAncy wInter - PAtrIcIA lulof ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
CONTENTS
Le terrecotte architettoniche dalla casa-torre di Veio-Piazza d’Armi: nuove acquisizioni – gIldA BArtolonI - sIlVIA ten kortenAAr - Iefke VAn kAmPen .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matrici di età ellenistica dal sito di Civita Musarna (Viterbo) – VIncent JolIVet - edwIge loVergne ... . . . . . . 514
Terrecotte architettoniche dalla colonia latina di Spoletium – VAlentInA BefAnI - lucA donnInI - chIArA mArIA mArchettI .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
Terrecotte architettoniche dall’acropoli di Populonia (LI). Le lastre di rivestimento dal Tempio C –frAncesco ghIzzAnI mArcìA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
2 MAGNA GRAECIA AND SICILY 527
I gocciolatoi a protome leonina di Kaulonìa: nuovi dati e vecchie questioni – nIcolA gIAccone ... . . . . . . . . . 528
Camarina. Nuove antefisse da recenti scavi: gorgoni e sileni – gIoVAnnI dI stefAno ........................... 532
Le terrecotte architettoniche di Monte San Mauro presso Caltagirone. Una proposta di revisione – VAlerIA PIrronello .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536
Frammenti di terrecotte architettoniche da Monte Altesina - Nicosia (EN) – cArmelA BonAnno .... . . . . . . . 539
Terrecotte architettoniche da Montagna di Marzo – AlessAndrA cAstorInA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548
ABstrActs BIBlIogrAPhy 567
colour PlAtes
508
551
LE TERRECOTTE ARCHITETTONICHE NON A STAMPO DI CERVETERI: NUOVI E ‘VECCHI’ RITROVAMENTI NELLA VIGNA PARROCCHIALE
Vincenzo Bellelli*
introduzioneNell’area centrale del pianoro urbano di Caere, coincidente con l’ampio appezzamento dei Vignali, è stato notato da tempo un addensamento di evidenze archeologiche riferibili a edifici monumentali databili fra la tarda età orientalizzante e il periodo ellenistico. Purtroppo, a causa degli scavi clandestini che si sono intensificati nel corso degli ultimi decenni, solo di rado è dato ritrovare in situ le terrecotte architettoniche che originariamente decoravano questi edifici. Per quanto riguarda la Vigna Parrocchiale, in particolare, le quantità di terrecotte architettoniche ritrovate durante gli scavi regolari del Consiglio Nazionale delle Ricerche e della Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Etruria meridionale riescono appena a dare un’idea dei sistemi di copertura dei complessi architettonici di pertinenza. La maggior parte dei frammenti raccolti fino a questo momento è riferibile a elementi fabbricati a stampo; una piccola parte di terrecotte – che si presenta in questa sede – è invece plasmata, almeno in parte, a mano senza ausili meccanici. Nel piccolo dossier allestito per l’occasione, figurano frammenti di statue di diverso formato plasmate a tutto tondo, a destinazione probabilmente architettonica; piccoli gruppi plastici adoperati verosimilmente come appliques, nonché alcuni frammenti di collocazione e interpretazione incerta.In questa sede si presentano alcuni dati inediti relativi agli scavi 2003-2005 condotti a Cerveteri dal CNR in collaborazione con la Soprintendenza di Villa Giulia nell’area compresa fra il cosiddetto edifico ellittico e il complesso noto in letteratura come ‘tempio di Hera’1. Alla breve presentazione di questi materiali seguiranno alcune considerazioni sul contributo che lo studio delle terrecotte architettoniche fornisce alla ricostruzione della società, dell’ideologia del potere a dei culti dell’antica Caere al culmine del suo sviluppo storico.
inquadramento topografico e storia degli studiPer il corretto inquadramento delle problematiche in discussione, può risultare utile un breve inquadramento topografico; un discorso introduttivo sui luoghi si rende oltremodo necessario perché la perdurante mancanza di una carta archeologica aggiornata relativa alla città etrusca e al suo territorio2
ha spesso indotto in errore, anche di recente, gli studiosi che hanno tentato di ricontestualizzare le terrecotte decorative di Caere disperse in tutto il mondo3. I dati essenziali da sottolineare sono la pluralità e la contiguità dei siti dell’area urbana centrale (fig. 1). Essi sono, nell’ordine di scoperta, l’area scavata nel 1869-1870 nella Vigna Marini-Vitalini; l’area del ‘tempio di Hera’ indagata da Raniero Mengarelli nel biennio 1912-1913; l’area scavata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche in due riprese, fra il 1983 e il 1989 e fra il 2003 e il 2005, nella Vigna Parrocchiale4. La seconda e la terza sono ubicate rispettivamente nella ‘vecchia’ e ‘nuova’ Vigna Parrocchiale5, ovvero nel fondo di proprietà ecclesiastica che già nel XIX secolo aveva rivelato le sue potenzialità di riserva archeologica intatta6. A parte la mole, oggi ridotta a rudere irriconoscibile, del teatro romano, fino ai recenti scavi del CNR nulla di quanto descritto era più visibile. Con le indagini di superficie incrociate con le ricerche in archivio è stato possibile ubicare con precisione l’area scavata da Mengarelli7; essa risulta posta a poche decine di metri (verso nord) in linea d’area dal teatro romano. Contrariamente a quanto pensava Mengarelli, si tratta probabilmente di un quartiere ‘industriale’8. Grazie ai recenti scavi, oggi siamo in grado di ubicare con precisione anche il luogo in cui si scavò nel 1869-1870: si tratta di un’area posta a sud del teatro romano, caratterizzata da una interessante sovrapposizione di strutture e, soprattutto, dalla presenza di un ipogeo monumentale – il noto ipogeo di Clepsina – e di un grande cavedio a forma di parallelepipedo in cui è stato recentemente proposto di identificare la cavità artificiale in cui fu recuperato il materiale pubblicato da W. Helbig nel 18709. Gli scavi del CNR, infine, hanno riportato alla luce, nell’area compresa fra il teatro romano e il complesso del ‘tempio di Hera’, un sito occupato sin dagli albori dell’età del ferro, che in età tardo-arcaica ha accolto un santuario apparentemente edificato ex-novo sui resti di strutture preesistenti, di carattere non sacro, demolite per l’occasione10.Il panorama delle terrecotte architettoniche provenienti da questi siti è ricchissimo11: dagli scavi del 1869-1870 provengono i numerosi pezzi oggi conservati
129LE TERRECOTTE ARCHITETTONICHE NON A STAMPO DI CERVETERI
a Berlino, Copenhagen e Villa Giulia/Cerveteri12; a questi vanno aggiunti quelli dagli scavi regolari dell’Università di Perugia recentemente pubblicati13. Dall’area del tempio di Hera provengono numerose terrecotte, di cui un’ampia selezione fu pubblicata a suo tempo da Mengarelli14, cui non ha fatto purtroppo seguito un’edizione esaustiva del complesso. Dagli scavi del CNR, infine, provengono numerose terrecotte tardo-orientalizzanti ed arcaiche pubblicate da M. Cristofani15: esse furono rinvenute in una grande cavità artificiale ubicata presso il tempio tuscanico della Vigna Parrocchiale e vanno riferite, per eterogeneità delle tipologie, dei moduli e delle rispettive cronologie, a differenti edifici arcaici ancora non localizzati, dismessi prima
del 490-80 a.C.16. Di altri rari frammenti (per lo più di prima fase) rinvenuti in situ nel corso degli scavi degli anni ’80, si è dato conto nell’edizione definitiva degli scavi pubblicata nel 200317. Le evidenze (di seconda fase) attribuibili alla copertura dell’edificio sacro innalzato intorno al 480 a.C., invece, sono state con pazienza ricomposte e discusse da A. Guarino, in un volume che vede ora finalmente la luce dopo una lunga gestazione18. Altri elementi decontestualizzati, di varia cronologia, sono stati pubblicati di recente da chi scrive e da A. Maggiani negli Atti della terza edizione di Deliciae Fictiles19. Un piccolo gruppo di elementi arcaici provenienti dagli scavi 2003-2005, infine, è stato pubblicato nel rapporto preliminare di scavo20.
Fig. 1. Cerveteri: area urbana centrale.
130 VINCENzO BELLELLI
presentazione di una selezione dei materiali dai recenti scaVi del cnr (2003-2005)Gli scavi del 2003-2005 cui si è appena fatto cenno hanno consentito innanzitutto di ripristinare la leggibilità delle strutture precedentemente esplorate dal CNR e, in particolare, quelle relative al c.d. edificio ellittico. L’allargamento del fronte di scavo e un sondaggio in profondità condotto ‘in trincea’ hanno inoltre fornito una importante conferma21: tutta l’area compresa fra il sito scavato dal CNR fra il 1983 e il 1989 e quella esplorata da Mengarelli è caratterizzata dalla medesima sovrapposizione di strutture riscontrata alla fine degli anni ’80 del secolo scorso al di sotto del tempio tuscanico. Infatti, le esplorazioni condotte hanno documentato una scansione spazio-temporale che prevede edifici di età arcaica distrutti intenzionalmente (?) tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C., probabilmente per far posto all’area sacra e alle sue pertinenze; alla fine della sequenza è stata riscontrata una radicale ristrutturazione dell’area da riferire alla prima età imperiale, forse opera dell’imperatore Claudio22.Gli strati più antichi finora intercettati, riferibili a livelli di distruzione di orizzonte tardo-arcaico, hanno restituito un cospicuo gruppo di terrecotte architettoniche di ‘prima fase’ riferibili non solo alle tipologie individuate da Cristofani, ma anche a sistemi di copertura finora non attestati23. Gli
elementi più caratteristici sono risultati finora alcune figurine plastiche di dimensioni contenute e buona qualità formale, che ora si presentano come appliques a basso rilievo, ora come veri e propri altorilievi in miniatura, anch’essi applicati a lastre piane, come indica inequivocabilmente il trattamento del retro24 (figg. 2, 10).
Fig. 2. Cerveteri, Vigna Parrocchiale: retro di figurina plastica utilizzata come applique.
Fig. 3*-4. Cerveteri, Vigna Parrocchiale: frammento di applique fittile a forma di cavallo.
Fig. 5. Cerveteri, Vigna Parrocchiale: frammento di applique (braccio).
Figg. 6a-b, 7. Cerveteri, Vigna Parrocchiale: frammento di applique (testa umana).
131LE TERRECOTTE ARCHITETTONICHE NON A STAMPO DI CERVETERI
Oltre ai frammenti riferibili a fregi ospitanti corse di cavalli presentati in altra sede25, si possono qui aggiungere altri frammenti di zampe, teste e treni di equini in movimento26 (figg. 3-4), nonché alcuni piccoli ma significativi frammenti di arti27 (fig. 5) e teste umani. In particolare, si presentano qui una testa maschile di profilo verso sinistra resa a basso-rilievo28 (figg. 6a-b, 7), scarsamente caratterizzata nella fisionomia, e una testina elmata di guerriero29 (figg. 8a-c, 9) a tutto tondo, stilisticamente prossima a quelle dei guerrieri delle placche di Copenhagen, studiate di recente da P. Lulof30. Il modulo è identico a quello della piccola Amazzone presentata da A. Maggiani nell’ultima edizione delle Deliciae Fictiles31 (fig. 10). A giudicare dalla resa tecnico-stilistica, e soprattutto, dalle caratteristiche del rilievo e della policromia, si tratta probabilmente di elementi applicati pertinenti a sofisticati apparati decorativi, concepiti come affollati fregi plastici, il cui esempio
più compiuto è al momento quello pubblicato da Volker Kästner32, di provenienza anch’essa ceretana. I temi iconografici, a quanto pare, sono di tipo per lo più militare (parate di carri, cavalli in corsa e al passo, scene di combattimento con Amazzoni e guerrieri). Oltre alla raffinata resa plastica e pittorica, non inattesa in ambiente ceretano, sono da sottolineare le ridotte dimensioni di queste appliques e la originale tecnica di fissaggio adoperata33, che confermano l’abilità della scuola coroplastica ceretana a predisporre, in insiemi tipologicamente nuovi, soluzioni iconografiche in parte già collaudate. La collocazione originaria di questi elementi rimane peraltro incerta. I dati finora acquisiti suggeriscono che questo originale complesso di piccole sculture di terracotta doveva trovare collocazione su fondali piani predisposti sui rampanti frontonali oppure sui rivestimenti dei lati lunghi di edifici di cui ignoriamo praticamente tutto.Di modulo superiore e differente collocazione architettonica sono altri elementi plastici recuperati nel corso degli scavi 2003-2005. Fra questi, il meno lacunoso è un arto maschile dalla possente muscolatura34 (fig. 11) rinvenuto nel corso della campagna del 2003, sul versante occidentale dell’ edificio ellittico. Lo stato di conservazione del pezzo non consente di stabilire con certezza se si tratta
Figg. 8a-c, 9. Cerveteri, Vigna Parrocchiale: frammento di applique (testa elmata).
Fig. 10.* Cerveteri, Vigna Parrocchiale: applique.
132 VINCENzO BELLELLI
di una gamba oppure, meno probabilmente, di un braccio maschile. La posizione reciproca dei due tratti che lo compongono, a formare un angolo acuto molto accentuato, e la potente dilatazione delle masse muscolari suggeriscono comunque l’idea che si tratti dell’arto di un personaggio maschile (un guerriero?) in concitato movimento. Il frammento può essere messo pertanto in relazione con la celebre serie di guerrieri di Copenhagen ristudiata da P. Lulof, che ne ha dimostrato la pertinenza ad altorilievi destinati originariamente a coprire la testata del columen e dei mutuli di un edificio monumentale dell’area centrale di Cerveteri35. A questo proposito giova ricordare che fra i materiali rinvenuti nello scarico della Vigna Parrocchiale già Cristofani aveva riconosciuto la presenza di due elementi scultorei tipologicamente e stilisticamente assimilabili a quelli dei guerrieri di Copenhagen: cioè una testa barbata e un frammento di gonnellino di corazza con pteryges36. A meno che non si tratti di elementi pertinenti al medesimo complesso, ipotesi recentemente ventilata da P. Lulof37, si dovrebbe supporre che altri tetti arcaici di ‘tipo Copenhagen’ fossero allestiti nell’area centrale di Cerveteri, probabilmente proprio nella Vigna Parrocchiale, oltre a quello portato alla luce nell’800. Ancora più problematici risultano due frammenti di statue fittili di incerta interpretazione. Il primo di essi è un viso maschile (?) parzialmente conservato, senza resti di colore, di cui si legge ancora bene soltanto l’occhio destro (rispetto a chi guarda) di forma oblunga con pupilla segnata ad incisione38 (figg. 12-13). Dal punto di vista stilistico, ad onta del precario stato di conservazione, il nostro volto fittile è classificabile con relativa precisione: si tratta di una ‘maschera’ di squisita impronta ionica assimilabile al tipo 5 A di Riis39, noto soprattutto nei suoi esiti non architettonici nei celebri sarcofagi degli sposi (fig. 14). Ricorda inoltre da vicino il volto della Vigna Parrocchiale, l’antefissa a testa
di Acheloo qui rinvenuta sotto le fondazioni del tempio tuscanico40, che originariamente poteva fare da pendant ad antefisse a testa femminile sulle rive di un tetto tardo-arcaico41 . Come ha notato F. Zevi42, la prossimità stilistica fra l’antefissa della Vigna Parrocchiale, i volti dei Sarcofagi degli Sposi e la celebre statua acroteriale dello Zeus di Paestum è veramente notevole e apre uno spiraglio interessante sulle convergenze stilistiche fra la fase ionica dell’arte etrusca, e ceretana in particolare, e alcuni esiti ‘straordinari’ della plastica fittile magno-greca, come la statua poseidoniate. Il piccolo frammento inedito della Vigna Parrocchiale si inserisce a pieno titolo in questo orizzonte storico-artistico.L’altro frammento di statua fittile di incerta collocazione su cui si vuole qui richiamare l’attenzione è un piccolo, ma notevole, frammento di panneggio43 (figg. 15-16) rinvenuto nel corso della campagna 2003 a nord dell’edificio ellittico. Si tratta di un frammento piatto sul retro, decorato a basso rilievo sulla faccia anteriore con cinque pieghe di himation (?) terminate in basso da volute che disegnano un inconsueto schema a cerchielli. Il frammento, di cui è conservato il limite sinistro, si può integrare a titolo di ipotesi ad una figura panneggiata femminile (?) con funzioni architettoniche, alta un po’ meno del vero; pur essendo la porzione superstite del pezzo decisamente esigua, le analogie con la veste panneggiata del famoso acroterio di Berlino con Eos e Kephalos (o Tithonos)44 (fig. 17) ci sembrano veramente notevoli: andamento e larghezza delle pieghe, altezza del rilievo, modulo della scultura, e – non ultimi – il tipo di impasto e il trattamento delle superfici sono infatti vicinissimi a quelli dell’acroterio berlinese, che, come il rilievo della Vigna Parrocchiale, si presenta piatto sul retro. Anche in questo caso, appare impossibile spingersi oltre una generica constatazione: nell’area centrale di Cerveteri, e forse proprio nella Vigna Parrocchiale, sorgeva un edificio decorato con un elemento fittile
Fig. 11. Cerveteri, Vigna Parrocchiale: fr. di altorilievo (? coscia di guerriero).
Figg. 12-13. Cerveteri, Vigna Parrocchiale: fr. di viso maschile.
133LE TERRECOTTE ARCHITETTONICHE NON A STAMPO DI CERVETERI
stilisticamente e funzionalmente analogo a quello dell’acroterio ceretano ora a Berlino portato alla luce nell’Ottocento.A conclusione della breve rassegna di terrecotte qui presentata, va ricordata la presenza, dai recenti scavi del CNR nella Vigna Parrocchiale, di diverse centinaia di terrecotte architettoniche fabbricate a stampo, qui non considerate, che ovviamente facevano parte dei medesimi sistemi di copertura. Fra queste terrecotte di prima fase di tipo più seriale (tegole e coppi, tegole di gronda, lastre di antepagmentum ecc.) attualmente in corso di studio in vista dell’edizione definitiva degli scavi CNR, si menzionano qui soltanto i numerosi frammenti di tori squamati ed elementi di kalypter hegemon decorati con registri embricati dipinti, in alcuni casi di dimensioni notevoli e squisita fattura, che vanno a sommarsi a quelli altrettanto numerosi recuperati sul sito negli anni ‘8045. Benché non si tratti stricto sensu di elementi che rientrano nelle categorie di plastica architettonica oggetto del presente convegno, va ricordato che si tratta nondimeno di elementi fondamentali per la ricostruzione non solo dell’aspetto compiuto dei sistemi di copertura degli edifici considerati – il che è scontato – ma anche per
la ricostruzione del ‘significato’ complessivo delle decorazioni plastiche46. Basta ricordare il ‘ruolo’ che tali elementi decorati con motivi ‘a squame’ giocano nei sistemi di copertura ricondotti alla propaganda erculea, come il tetto del tempio dorico di Pompei47, per rendersi conto che essi erano elementi tutt’altro che marginali nella messa a punto e definizione dei messaggi affidati ai sistemi di copertura48 .Altrettanto dovrebbe dirsi – ma qui si può appena accennare al tema – della funzione non solo decorativa delle antefisse a testa umana: anche in questo caso, come indicano i recenti tentativi di lettura49 delle sequenze di antefisse a testa di satiro, menade o ninfa lungo le falde dei tetti etruschi, si tratta di parti plastiche che non assolvevano a una funzione esclusivamente ornamentale, ma di segmenti di una sintassi di significati più complessa, che si affidava non solo alla ‘narrazione’ dei fregi, degli altorilievi e degli acroteri, ma anche ai messaggi che potevano essere veicolati da elementi più semplici, paratatticamente ripetuti sui lati lunghi degli edifici, come erano appunto le antefisse50.
terrecotte ed edifici: l’area urBana centrale di cerVeteri alla luce delle conoscenze attualiLa rapida rassegna del materiale recentemente rinvenuto nella Vigna Parrocchiale, andandosi a sommare alla massa consistente ma disordinata dei materiali di vecchio ritrovamento, suscita fatalmente la sensazione di trovarsi di fronte a un dossier lacunoso, difficilmente utilizzabile ai fini di una ricostruzione storico-archeologica compiuta delle vicende edilizie dell’abitato ceretano. Ciononostante, il quadro complessivo delle conoscenze guadagnato
Fig. 14. Cerveteri: sarcofago degli sposi: particolare dell’ esemplare di Villa Giulia.
Figg. 15-16. Cerveteri, Vigna Parrocchiale: frammento di statua panneggiata.
134 VINCENzO BELLELLI
a seguito delle ricerche recenti sul terreno consente di tracciare un pur sommario bilancio sulla situazione dell’area urbana centrale.Un buon punto di partenza per la ricontestualizzazione delle evidenze già note e di quelle di recente acquisizione è il quadro messo a punto da M. Cristofani nel suo ultimo lavoro dedicato a Caere51, apparso dopo la prematura scomparsa dello studioso. In questo brillante lavoro di sintesi, Cristofani ha ipotizzato l’esistenza nell’area centrale della città, compresa fra la Vigna Marini-Vitalini e la Vigna Parrocchiale, di ‘edifici di natura diversa, sacra e pubblica, costruiti fra il 540 e il 500 a.C. e poi distrutti’52. Quelli meglio identificabili, sia pure indirettamente, sulla base dei sistemi di copertura ricostruiti, sono un edificio di ‘medie dimensioni’, cui andrebbe riferito l’acroterio berlinese di Eos e Kephalos (o Tithonos), e una costruzione templare di grande impegno decorativo, paragonabile al tempio B di Pyrgi, cui andrebbero riferiti i gruppi plastici divisi fra Berlino, Copenhagen e Villa Giulia/Cerveteri53. Quest’ultimo accostamento operato da Cristofani nel suo contributo, risulta particolarmente convincente alla luce delle recenti acquisizioni sull’originalità della scuola coroplastica ceretana, che a quanto pare fece precocemente ricorso, tanto a Pyrgi quanto nella città madre, ai rivestimenti fittili delle testate di columen e mutuli entro il cavo frontonale54.Rimane però del tutto incerta la localizzazione
puntuale di questi edifici, anche perché – è importante ribadirlo – tutti questi materiali di prima fase sono stati rinvenuti in giacitura secondaria, inglobati in grandi scarichi di detriti, residui di materiali edilizi e rottami di ceramica. Dove sorgevano questi edifici e quando e perché furono costruiti? E, inoltre, quando, come e perché queste costruzioni furono demolite? Si tratta di questioni che sono evidentemente collegate e, per il primo fascio di domande, una prima via interpretativa l’ha indicata, ancora una volta, M. Cristofani55: poiché il programma decorativo del tempio decorato con altorilievi e acroteri, ora conservati per lo più all’estero, è incentrato sulle imprese di Herakles, come accade del resto nel santuario settentrionale di Pyrgi (tempio B), è verosimile che dietro queste fabbriche monumentali vi sia una medesima iniziativa di tipo ‘tirannico’. A giudicare dalle notizie preliminari pubblicate sul santuario in loc. S. Antonio56, anch’esso esaltante la figura di Herakles, si tratterebbe di un vasto programma edilizio riguardante l’intera compagine urbana, nonché la sua proiezione marittima (Pyrgi), che al principio del V secolo a.C., in seguito a profondi rivolgimenti politico-istituzionali, avrebbe subito una massiccia operazione di rimodellamento e/o annientamento. A fronte della pur giustificata enfasi che è stata posta negli ultimi anni sulla vicenda pyrgense57, va a questo punto sottolineato che il fulcro di questo grandioso intervento ‘tirannico’ nel settore dell’edilizia pubblica di carattere sacro a Caere va posto, prima ancora che nel santuario costiero di Pyrgi, proprio nel cuore dell’area urbana. A dimostrarlo basterebbe, oltre all’apparato decorativo ora diviso fra Copenhagen Berlino e Villa Giulia/Cerveteri, quell’esempio straordinario di coroplastica architettonica – purtroppo isolato – che è la statua fittile di Ercole rinvenuta alla Vigna Parrocchiale (fig. 18), rimasta
Fig. 17. Acroterio centrale da Cerveteri con scena di ratto.
Fig. 18.* Cerveteri, Vigna Parrocchiale: busto di statua fittile di Ercole.
135LE TERRECOTTE ARCHITETTONICHE NON A STAMPO DI CERVETERI
a torto ai margini della discussione58, benché Cristofani l’abbia tempestivamente pubblicata già nel primo rapporto preliminare di scavo59. Oggi, inoltre, grazie alle ricerche di F. Gaultier60, siamo in grado di riferire a un edificio sacro dell’area urbana centrale anche la nota antefissa del Louvre con Ercole ristorato da Athena, per cui si era pensato inizialmente a una provenienza dal santuario di S. Antonio61. Non va dimenticato, infine, che tutte le propaggini meridionali della rupe urbana di Caere e il relativo fondovalle vengono rimodellate in età tardo-arcaica ‘sotto il segno di Ercole’62, con modalità che hanno giustamente riportato alla ribalta il problema della localizzazione del Fons Herculis63. In questo quadro generale rivestono un’importanza notevole il più volte ricordato acroterio berlinese con Eos e Kephalos, che V. Kästner ha opportunamente riferito a un ‘Heraion’64, e i frammenti sporadici di statue fittili rinvenuti a Cerveteri, recentemente riferiti a un gruppo acroteriale con Ercole e Atena paragonabile a quello di S. Omobono a Roma65. Questi elementi, da soli, sono sufficienti per riproporre all’attenzione la forte analogia ‘strutturale’ fra il santuario romano del portus tiberinus e la situazione ceretana, su cui ha attirato alcuni anni fa l’attenzione F. Coarelli66. Anche se il parallelo risulta oggi indebolito dalla nuova interpretazione proposta da A. Sommella Mura del ‘secondo’ acroterio centrale di S. Omobono67 la simmetria nelle scelte delle due città in materia di edilizia sacra di stampo ‘tirannico’ rimane impressionante: sia a Roma che a Caere abbiamo, sia pure con un lieve décalage cronologico, un fiorire di culti legati a divinità femminili di spicco del pantheon etrusco-latino (Uni/Giunone e Thesan/Mater Matuta), valorizzati da autorità politiche che si incarnano in figure di tipo tirannico; queste fanno ampio ricorso alla vicenda paradigmatica dell’eroe diventato dio, Ercole68, e si presentano di conseguenza agli occhi delle rispettive comunità come individui speciali, ‘eletti’ e protetti da divinità femminili.I dati editi e inediti relativi alla Vigna Parrocchiale qui brevemente discussi confermano indirettamente questa ricostruzione, almeno nelle sue linee generali: essi infatti confermano l’esistenza nell’area centrale di Caere di una pluralità di edifici dotati di sontuosi apparati decorativi in terracotta frutto di una programmazione unitaria, che vengono improvvisamente distrutti, come ha suggerito Cristofani, agli inizi del V secolo a.C. In questo contesto, a quanto pare, la vicenda dell’area sacra della Vigna Parrocchiale scavata dal CNR segna una
profonda linea di demarcazione politico-ideologica nella storia dell’edilizia sacra ceretana. Essa infatti segna una svolta radicale dal punto di vista delle scelte di fondo: le divinità venerate nel nuovo tempio urbano sono ora quelle legate alla sfera agraria69 e tutto quello che ricordava il passato, in termini di programmi figurativi affidati alla coroplastica architettonica, viene cancellato dal nuovo edificio sacro. A questo punto si può tentare di interpretare, in conclusione, un dato apparentemente trascurabile, a cui si è fatto cenno in precedenza, che in realtà riveste un significato molto importante per il discorso affrontato: le condizioni di giacitura di questo materiale. Praticamente in tutti i contesti urbani finora indagati nell’area centrale di Cerveteri70, le terrecotte architettoniche di prima fase sono state trovate all’interno di scarichi eterogenei e non di cumuli, più o meno omogenei, di materiali ritualmente deposti, come quelli che talvolta si rinvengono entro i limiti delle aree sacre. Si tratta di una costante che a nostro avviso ha un significato preciso71, a conferma del quadro fin qui tracciato: quelli che abbiamo sotto gli occhi sono i riflessi di profonde trasformazioni politico-istituzionali, che appena intravediamo attraverso le complesse vicissitudini dei tetti degli edifici, dal loro originario utilizzo, alla loro rimozione, fino ad arrivare alle loro tormentate vicende ‘post-deposizionali’. Pertanto, anche se – come è certo – molte delle terrecotte architettoniche clandestinamente portate alla luce a Cerveteri sono state prelevate non da estesi palinsesti stratigrafici ma da ‘scarichi’ circoscritti rimossi con giganteschi sterri non autorizzati, resta comunque immane il danno procurato alla conoscenza di questi peculiari depositi archeologici. Come ha giustamente rilevato M.A. Rizzo72 a proposito dei donari di ceramica attica deposti nei santuari ceretani, infatti, non sapremo mai se le nostre lacune conoscitive dipendono da una effettiva scarsità di attestazioni oppure dalla sottrazione illegale di questi materiali.
* Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Studi sulle Civiltà italiche e del Mediterraneo Antico; [email protected] Recentemente è apparso il rapporto preliminare dello scavo: Bellelli 2009.2 In attesa della pubblicazione del volume di G. Nardi sulla topografia storica di Caere, vd. intanto, Caere 1 e i lavori di sintesi di G. Nardi: Nardi 1989, 2001 e 2005.3 Il problema principale è l’assenza di una buona base cartografica per il pianoro urbano cui si sopperisce,
136 VINCENzO BELLELLI
ancora oggi, ricorrendo a piante elaborate in modo approssimativo, come quella che compare in Kästner 1988 (fig. non numerata a 155). V. anche Tartara 2003.4 Per una breve storia degli scavi: Bellelli 2009, 65-69, con bibl. prec.5 Per gli aspetti toponomastici, v. le puntualizzazioni di Colonna 2004 (p. 77).6 E’ qui, non a caso, che nell’Ottocento si era scatenata la furia distruttiva degli scavatori di turno, attirati dalla presenza, allora certamente più cospicua, del teatro romano di Caere e degli altri edifici pubblici di età imperiale il cui arredo scultoreo era stato gettato, già in antico, in cavità e pozzi: dettagliata ricostruzione della vicenda ed esame delle evidenze superstiti in Caere 2.7 Un quadro generale delle scoperte avvenute in questo sito è tratteggiato da Nardi 2003. Sull’ubicazione del sito scavato da Mengarelli: Nardi 1986, 19, tavv. I.6-7 e X.1; Nardi 1989, 52, n. 9.8 Proietti 1986, 169; Bellelli 2000; Bellelli - guidi - trojsi 2001.9 ColiVicchi 2003; Torelli - fiorini 2009.10 Per la documentazione si rimanda a Caere 3.1-3.2 e 4; Per l’interpretazione storica v. Bellelli 2008. 11 Oltre ai pioneristici lavori di Vighi 1935 e Andrén 1939-1940 (pp. 11 ss.), v. i contributi di M. Cristofani citati oltre (nn. 15 e 16) e, soprattutto, la sistematica raccolta di Winter 2009a (p. 395 ss.).12 Kästner 1988; Lulof 2009; Winter 2009a e d.13 Romizzi 2003; Winter 2009a.14 Mengarelli 1936, 73-81, tavv. XXV-XXVIII.15 Cristofani 1991; Cristofani 1992b.16 Cristofani 1992b, 56-57.17 V. le schede di A. Guarino, in Caere 4, passim.18 Guarino 2010.19 Maggiani - Bellelli 2006.20 Bellelli 2009, 82-84, figg. 32-35; v. anche Bellelli 2004 e V. Bellelli, in Bellelli - Rizzo - roncalli 2007.21 Bellelli 2009, 72, 87.22 Bellelli 2009, 87.23 V. n. 20.24 A. Maggiani, in Maggiani - Bellelli 2006, 89, fig. 8.15.25 V. Bellelli, in Bellelli - Rizzo - roncalli 2007; Bellelli 2009, loc. cit. a n. 20.26 N. inv. provvisorio: VP-TR-IB-2; dimensioni: 9,3 x 6 x 3,6 cm; provenienza: trincea I, settore B (scavo 2003). Il frammento presenta due dettagli di lettura problematica: una piccola ‘ala’ con nervature dipinte e profilo frastagliato e, nel sottopancia della figura, un elemento a rocchetto, forse da correlare alla presenza del terminale di un timone.27 N. inv. provvisorio: VP-TR-IC-10; dimensioni: 4,8 x 1,3 cm; provenienza: trincea I, settore C (scavo 2003)28 N. inv. provvisorio: VP-S2-2004-1; dimensioni: 3,6 x 3,1 x 2,2 cm; provenienza: saggio 3, US 1 (scavo 2004).
29 N. inv. provvisorio: VP-TR- I – BC; dimensioni: 3,4 x 1,9 x 2,6; provenienza: trincea I, settore B-C (scavo 2003)30 Lulof 2009.31 A. Maggiani, in Maggiani - Bellelli 2006, loc. cit. a n. 24.32 Kästner 2006.33 Si sono finora riscontrati sia il ricorso a fissaggio meccanico tramite affissione con chiodi, sia il ricorso a una sostanza adesiva di composizione indeterminata.34 N. inv. provvisorio: VP-SP-2003-4; dimensioni: 16 x 13 cm. Il frammento è stato rinvenuto nel saggio 1, nel 2003, in occasione di un’estesa operazione di pulizia superficiale condotta con il coordinamento di A. Guarino nel quadrato E 7 VIII 1-2, 6-7.35 Lulof 2009.36 Cristofani 1992b, 34, nn. B 13.1-13.2, fig. 52, tav. II. Per l’interpretazione v. Cristofani 2000b, 395-425.37 Lulof 2009, 200.38 N. inv. provvisorio: VP-TR-IIB-15; dimensioni: 4 x 9 cm; provenienza: trincea II, settore B (scavo 2003).39 riis 1981, 25 ss.40 Cristofani 1991, 70-71, tav. IXa; M. Cristofani, in Caere 4, 122, n. 1376, tav. IV; V. Bellelli, in Veio, Cerveteri, Vulci 2001, 126, II.A.2.5., tav. VIII.41 Cristofani, artt. citt. a nota prec., locc. citt.42 ZeVi 1998a, 24-25.43 N. inv. provvisorio: VP-TR-IIB-19; dimensioni: 6,6 x 5,2 x 2,9; provenienza: trincea II, settore B (scavo 2003).44 Kästner 1990.45 Si tratta di numerosi frammenti inediti, di provenienza varia (nn. inv. provvisori: VP-TR-II-B-6; VP-TR-II-B-9; VP-TR-IIB-1).46 Sui ‘messaggi’ e sulla percezione dei significati veicolati dalla decorazione architettonica in ambito greco, v. i recenti contributi alla discussione di C. Marconi (Marconi 2007 e 2009).47 D’agostino 2001, 143-144.48 E’ qui d’obbligo segnalare gli acroteri a volute decorati a squame dipinte, di provenienza sconosciuta (ma sicuramente ceretana), ora esposti nel Museo di Villa Giulia, nella rinnovata sala di Cerveteri, insieme a un frammento di statua acroteriale: M.A. Rizzo, in questi Atti.49 Isler - Kerényi 2009.50 L’importanza di questi elementi della sintassi decorativa è paradossalmente colta e maggiormente enfatizzata a livello critico in ambito extra-archeologico, per lo più in scritti di argomento storico e storico-religioso; con riferimento ai soggetti dionisiaci, v. per esempio Mastrocinque 1988, 245-246 e Montanari 1988, 105-106.51 Cristofani 2000b.52 Cristofani 2000b, 399.53 Cristofani 2000b, 404.54 Colonna 2000, 283; Cristofani 2000b; Lulof 2009; Winter
137LE TERRECOTTE ARCHITETTONICHE NON A STAMPO DI CERVETERI
2009a.55 Cristofani 2000b, 404.56 Maggiani - rizzo 2005.57 Colonna 2000, 275 ss.58 Con l’eccezione di alcuni lavori di P. Lulof: Lulof 2000; Lulof 2005.59 Cristofani 1986, 15, tav. IIIc.60 F. Gaultier, ‘Héraclès à Cerveteri: sur quelques terre cuire étrusques du Musée du Louvre’, in corso di stampa. Conosco il testo per la cortesia dell’Autrice, che mi è gradito ringraziare in questa sede (vd. ora CRAI 2008, 1465-1493).61 Così ipotizza Colonna 2001d, 160.62 M.A. Rizzo, a questo proposito, è estremamente esplicita: per lei il santuario di Hercle in loc. S. Antonio, nella sua veste monumentale, è frutto di una operazione di tipo ‘tirannico’: Rizzo 2008, 83; Rizzo 2009b, 37. Per i rivestimenti decorativi degli edifici: Rizzo 2009a; Maggiani 2009.63 Discussione recente in Bellelli 2007.64 Kästner 1988, 170, B 6.1.18, con fig. a colori a 128. V. a questo proposito anche GoldBerg 1987.
65 Cristofani 2001, 804, tav. LXXXVIa-c; Lulof 2000, 210; Lulof 2005; M.A. Rizzo, in questi Atti.66 Coarelli 1992, 226-234.67 A. Mura Sommella, in questi Atti; Eadem, intervento alla giornata di studio organizzata all’Università ‘Sapienza’ di Roma da G. Bartoloni e C. Carlucci in occasione della presentazione del libro di N. Winter, Symbols of Wealth and Power (Winter 2009a). In precedenza, M. Mertens Horn aveva suggerito una suggestiva identificazione del gruppo di S. Omobono come scena di ratto: Mertens horn 1997b.68 Sul tema v. da ultimo Coarelli 2009, che ribadisce la matrice corinzia del fenomeno.69 Bellelli c.s.70 Si ricordino a questo proposito anche i materiali da ‘Campetti’ pubblicati da Moretti 1957 e quelli del Quartaccio di Ceri, recentemente riesaminati da Guidi - Bellelli - trojsi 2006.71 Abbiamo accennato al problema già in Bellelli 2008, 330.72 Rizzo 2009b.



















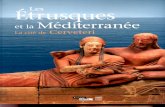
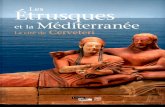







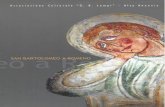

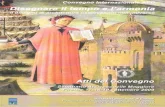
![Cronologia delle trasformazioni storico-architettoniche [Castel Capuano di Napoli]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631b5e873e8acd99770563ba/cronologia-delle-trasformazioni-storico-architettoniche-castel-capuano-di-napoli.jpg)





