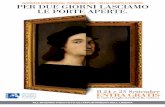Vecchi e nuovi dati sulle pavimentazioni e i mosaici dell'area di San Leucio a Canosa
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Vecchi e nuovi dati sulle pavimentazioni e i mosaici dell'area di San Leucio a Canosa
3
ALESSANDRO D’ALESSIO – PATRIZIO PENSABENE
VECCHI E NUOVI DATI SULLE PAVIMENTAZIONI E I MOSAICIDELL’AREA DI SAN LEUCIO A CANOSA
Le recenti indagini svolte nel 2005-2006 nel sito della Basilica di S. Leucio dal-l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in collaborazione con la Soprin-tendenza Archeologica e con il Comune di Canosa di Puglia, hanno portato all’in-dividuazione di un’ampia serie di testimonianze le quali gettano nuova luce sullo sviluppo storico e sull’organizzazione architettonica e spaziale dell’area rispetto a quanto precedentemente noto (fig. 1). Il rinvenimento di imponenti strutture mu-rarie e dei connessi livelli di occupazione e distruzione nei settori a ridosso del monumento e nelle zone a nord-est e sud-est di esso, consentono infatti di rico-noscervi una diversa e più complessa articolazione planimetrica e topografica, tan-to dell’edificio di culto cristiano che del tempio di Minerva, su cui come noto la basilica fu costruita1. Parte integrante delle attività di ricerca condotte sul monu-mento è stato anche il riesame di tutte le pavimentazioni conservate al suo inter-no: sia dei tappeti musivi che occupano i bracci di ambulacro e le absidi sud, est e ovest della chiesa, sia del pavimento a ciottoli compreso entro il perimetro del preesistente tempio e che presentiamo nella prima parte di questo contributo.
Il pavimento a ciottoli
Alternativamente attribuito al tempio ellenistico-italico2, ovvero alla basilica cri-
1 Fondamentali sul tempio ellenistico: P. PENSABENE, ‘Il tempio ellenistico di S. Leucio a Canosa’, in Italici in Magna Grecia. Lingua, insediamenti e strutture, a cura di M. Tagliente, Venosa 1990, pp. 269-337; IDEM, ‘Il tempio italico sotto San Leucio a Canosa’, in Principi, Imperatori, Vescovi. Duemila anni di storia a Canosa, Catalogo della mostra di Bari, a cura di R. Cassano, Venezia 1992, pp. 620-654; O. DALLY, Canosa. Località San Leucio. Untersuchungen zu Akkulturationprozessens vom 6. bis zum 2. jh. v. Chr. am Beispiel eines Daunischen Heiligtums, Heidelberg 2000 e ancora P. PENSABENE, in Atti del XLI Con-vegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 12-16 ottobre 2001, Napoli 2002, pp. 587-592. Sulla basi-lica cristiana: N. TARCHIANI, ‘Canosa - Scoperta di un’antica chiesa’, in Palladio, 2, 1938, pp. 149-150; F. SCHETTINI, ‘Nuovi elementi per lo studio del romanico pugliese, in Scritti in onore di M. Salmi, Ro-ma 1961, pp. 264-265; M. FALLA CASTELFRANCHI, ‘Le principali fasi architettoniche del San Leucio di Canosa di Puglia’, in Commentari, 1-2, 1974, pp. 3-8; R. CASSANO, ‘La Basilica di San Leucio’, in Prin-cipi, Imperatori, Vescovi, cit., pp. 841-855; R. GIULIANI, ‘Canosa, basilica di San Leucio’, in G. VOLPE, P. FAVIA, R. GIULIANI, ‘Edifici di culto dell’Apulia fra tardoantico e altomedioevo: recenti acquisizioni’, in Hortus Artium Medievalium, Zagreb-Motovun 2003, pp. 55-93, in part. pp. 68-70; M. FALLA CASTELFRAN-CHI, ‘La basilica detta di San Leucio a Canosa’, in Puglia preromanica dal V secolo agli inizi dell’XI, a cu-ra di G. Bertelli, Bari 2004, pp. 67-72. Per la bibliografia specifica sull’apparato musivo della basilica v. oltre. Sui principali risultati delle campagne di scavo del 2005-2006 v. P. PENSABENE, A. D’ALESSIO, ‘Il tempio di San Leucio a Canosa. Le nuove indagini dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Ro-ma’, in Atti del 26° Convegno sulla Preistoria - Protostoria e Storia della Daunia, San Severo, 10-11 dicembre 2005, San Severo 2006, pp. 317-331; IIDEM, ‘Il complesso di San Leucio alla luce dei nuovi scavi 2005-2006’, in Canosa. Ricerche storiche 2007, Atti del Convegno, Canosa di Puglia, 16-18 febbraio 2007, Canosa di Puglia c.s.
2 P. MORENO, in Atti del X Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 4-11 ottobre 1970, Na-poli 1971, p. 425; M. FALLA CASTELFRANCHI, ‘Continuità dell’antico. La basilica di San Leucio a Cano-
4 5
stiana3, il pavimento a ciottoli di S. Leucio rivela in realtà problematiche di inqua-dramento decisamente più complesse di quanto finora si è ritenuto e traspaia da questa pur limitata querelle scientifica. Vedremo infatti come la pavimentazione del-l’edificio di culto antico – ancora oggi parzialmente conservata al suo interno – sia stata riutilizzata e integrata in alcune porzioni, pure realizzate con ciottoli e altri elementi litici, ma da ricondurre certamente all’epoca di costruzione della chiesa, se non a posteriori interventi. In parte hanno certamente influito, nelle difficoltà di una corretta attribuzione, le opere di restauro cui essa è stata sottoposta (al pa-ri dei tappeti musivi) negli anni Sessanta del secolo scorso, e specialmente quelle condotte nel 1978-794. Come si è potuto infatti verificare, anche grazie alla docu-mentazione fotografica di Archivio conservata presso la Soprintendenza P.S.A.D. della Puglia, ebbe a trattarsi, specie in quest’ultima circostanza, di lavori di note-vole impegno e che comportarono il distacco e la successiva ricollocazione di am-pi brani del pavimento, sovente con il ricorso a integrazioni e ricuciture tramite riuso degli stessi ciottoli. Ne è conseguito pertanto che è risultato piuttosto arduo distinguere le parti certamente originarie e ancora in situ della pavimentazione del tempio, da quelle pertinenti invece alla basilica o a eventuali rifacimenti interme-di, cosicché a seconda che si sia orientata l’analisi verso determinate zone della sua superficie, ne sono scaturite conclusioni profondamente diverse5.
Per tali ragioni si è deciso di procedere a una mappatura sistematica di tutta la superficie esistente, la quale ha dato risultati nuovi e inaspettati consentendo-ci di ricostruire con buona approssimazione il susseguirsi delle vicende occorse al pavimento a ciottoli dall’epoca della sua prima stesura in età ellenistica a quella paleocristiana e altomedievale. In base ai dati scaturiti dal nostro studio, dunque, risulta chiaro come si conservino tuttora in situ alcune notevoli porzioni del pa-vimento originario in almeno tre settori all’interno del monumento (fig. 2): una prima nella zona sottostante e adiacente l’altare della basilica, all’incirca corrispon-dente alla metà settentrionale dell’ala ovest del tempio; una seconda che interes-sa una ristretta ma prolungata fascia a ridosso del lato est del tetraconco interno della chiesa, coincidente invece con il margine laterale dell’ala est e con l’angolo sud-orientale del pronao (ricostruibile come distilo ottastilo); infine una terza po-sta all’estremità est del pronao stesso, nello spazio originariamente compreso tra le due file di colonne. Altri cospicui resti sembrano individuabili nella restante fa-scia nord del pronao e ancora nell’ala est del tempio o nella metà meridionale della cella centrale, ma gli interventi di restauro moderni qui condotti non per-mettono di riferirli con assoluta certezza alla sistemazione originaria6.
sa. Nuove acquisizioni’, in VeteraChr, 22, 1985, pp. 387-394 (cfr. FALLA CASTELFRANCHI 2004, cit. a no-ta 1, pp. 67-68); DALLY 2000, cit. a nota 1, pp. 154-157; v. anche GIULIANI 2003, cit. a nota 1, p. 69 e nota 126.
3 CASSANO 1992, cit. a nota 1, p. 842, in base ad alcune osservazioni di PENSABENE 1990, cit. a no-ta 1, p. 276, riguardo ai lacerti posti a chiusura delle lacune corrispondenti alle colonne del tempio, realmente attribuibili alla chiesa (v. oltre).
4 V. rispettivamente SCHETTINI 1961, cit. a nota 1 e G. DE TOMMASI, ‘Canosa. Basilica di San Leu-cio’, in Restauri in Puglia 1971-1983, II, Catalogo della mostra di Bari, Fasano di Puglia 1983, pp. 155-158; cfr. inoltre M. CORRENTE, F. VONA, ‘Mosaici tardoantichi di Canosa. Prospettive di recupero e ana-lisi del rischio. Vecchi e nuovi interventi delle soprintendenze pugliesi a confronto’, in Apparati musi-vi antichi nell’area del Mediterraneo, 1, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Piazza Armerina 2003, Palermo 2004, pp. 521-533, in part. 525, figg. 4-8; R. LAVIANO et alii, ‘I mosaici della basilica di San Leucio in Canosa’, in AISCOM IX, pp. 387-398, in part. 388.
5 Tuttavia, proprio dalle fotografie di archivio ci appare confermato lo sforzo di rispettare le col-locazioni originarie anche per i brani di pavimento riposizionati.
6 Da notare invece come le parti sicuramente antiche risultano discretamente conservate – non a caso – nei tratti meno soggetti al calpestio (ad es. nella fascia a ridosso dell’ala est), o perché ricoperti da strutture che ne hanno impedito l’eccessiva consunzione (come nel caso dell’altare della chiesa).
4 5
Osserviamo più da vicino i requisiti tecnici e formali del pavimento ed esami-niamo i dati che ci consentono di ricondurlo senza dubbio al tempio ellenistico. In primo luogo, tutte le porzioni superstiti presentano modalità di realizzazione e caratteristiche formali decisamente omogenee e distintive per qualità, dimensioni, tipo di lavorazione e distribuzione dei litotipi impiegati: ciottoli di fiume verosi-milmente provenienti dal vicino Ofanto, appositamente dimezzati e posti in opera con le facce piane in luce, a costituire la superficie pavimentale medesima: spicca-no in particolare quelli bianchi, di dimensioni pari a cm tra 1 e 4 x 4 e 6 ca. e che vengono per così dire a punteggiare la composizione dell’intero ordito, seb-bene non siano disposti su linee rettilinee e regolari, quanto reciprocamente di-stanziati a intervalli più o meno costanti; attorno a questi si addensano fittamen-te gli altri ciottoli, di colore variabile dal grigio al bluastro, al verde scuro, al gial-lo e al marrone chiaro, di dimensioni comprese tra i cm 2-4 x 4-6 (in alcuni ca-si fino a 1 o a 8-10) (figg. 3-4)7. Ne risulta una superficie policroma che fu accu-ratamente lisciata e resa lucente, caratterizzata inoltre dalla presenza di un sottile strato di “rubricatura” di colore rosso8, elemento questo mai notato prima e che si conserva invece in diverse zone, specialmente nelle strette giunture tra i ciottoli, ma anche sulla superficie delle pietre: si tratta a quanto pare di una ‘pasta’ appli-cata a stesura ultimata del pavimento allo scopo di livellarne perfettamente il pia-no e simularvi una sorta di screziatura di fondo appunto di colore rosso, o, forse più probabilmente, di una successiva operazione di “restyling” eseguita al fine di ripristinarne la perfetta uniformità e rinnovarne al contempo l’aspetto. Per quan-to concerne invece le caratteristiche dello strato di allettamento dei ciottoli, osser-vabile in rari punti (ma v. oltre), esso è composto da una malta di colore grigio-chiaro ricca di inclusi calcarei e fittili di piccole dimensioni, che conferiscono al supporto una consistenza estremamente tenace9. Infine, possiamo far brevemente cenno ad alcune evidenze o tracce rilevate sulle porzioni superstiti nell’ala est del tempio (cfr. fig. 2), dove ben si riconoscono una serie di fasce parallele disposte in senso N-S o E-O, larghe tra cm 44 e 58 ed eventualmente riferibili anch’esse a modalità di posa in opera del pavimento per strisce o squadri tirati a filo, secon-do un uso altrimenti attestato in antico10.
Vediamo ora di esporre rapidamente i dati che inducono ad attribuire le por-zioni testé esaminate all’edificio antico. Innanzitutto, un elemento di per sé diri-mente in tal senso è rappresentato dagli evidenti rapporti stratigrafici che inter-corrono tra alcune strutture murarie pertinenti alla fase di costruzione della ba-
7 Posizione e distribuzione dei ciottoli rivelano, dunque, le modalità di posa in opera: stesura di porzioni all’incirca uniformi realizzate con elementi di diverso colore, entro cui furono di tanto in tanto inseriti quelli bianchi. Per la discussione su questo e altri aspetti tecnici inerenti ringrazio l’ami-co A. Lugari; un sentito ringraziamento inoltre al dott. A. Ottati per l’aiuto prestato nella raccolta e prima elaborazione dei dati.
8 Del tipo documentato soprattutto nei cocciopesti: v. ad es. E. PAPI, ‘I pavimenti delle domus del-la pendice settentrionale del Palatino (VI-II secolo a.C.)’, in AISCOM II, pp. 337-352, in part. 340-341; F. SLAVAZZI, ‘Nuovi pavimenti in battuto da Verona’, in AISCOM IV, pp. 1001-1012, in part. 1007 e no-ta 30; C. GUARNIERI, ‘Alcuni pavimenti in battuto da un recente scavo a Faenza (RA)’, in AISCOM VI, pp. 175-184, in part. 177-178; U. SPIGO, ‘I pavimenti della Domus di Porta Pasquale a Taormina: dati preliminari’, in AISCOM IX, pp. 399-418, in part. 403-404, tutti con altri rimandi specifici; in proposi-to cfr. anche M. GRANDI CARLETTI, ‘Opus Signinum e cocciopesto: alcune osservazioni terminologiche’, in AISCOM VII, pp. 183-197, in part. 187.
9 Sulla composizione e le caratteristiche chimico-fisiche del legante sono in corso analisi di laboratorio a cura di R. Laviano e F. Vona (Laboratorio di Restauro della Soprintendenza P.S.A.D. di Puglia).
10 Non è escluso tuttavia che esse siano da ricondurre almeno in parte (se non del tutto) a un’in-terferenza dei restauri del 1979, come parrebbero indicare alcune immagini di archivio: v. CORRENTE, VONA 2004, cit. a nota 4, fig. 8.
6 7
silica e il pavimento stesso. Infatti, se scarsamente probante è la citata sovrappo-sizione dell’altare e del circostante recinto della chiesa ai resti nell’ala ovest del tempio – dato che tale sistemazione parrebbe risalire a una posteriore ristruttura-zione del S. Leucio (v. oltre) –, inoppugnabili sono invece le prove costituite dal-le linee di asporto praticate nel pavimento a ciottoli per realizzare i cavi di fon-dazione del pilastro angolare di nord-est (fig. 5) e di quello successivo a ovest, facenti parte del tetraconco interno della basilica di prima fase. A questi aspetti di cronologia relativa può inoltre aggiungersi il recente rinvenimento di limitati ma preziosi resti del supporto cementizio in cui erano inseriti i ciottoli, a ridosso di uno dei blocchi posti alla base del muro laterale dell’ala est del tempio, con-tro il quale il pavimento poggiava. Da ultimo, una conferma pressoché definitiva per la sua attribuzione all’età antica si è avuta in occasione dei nostri scavi nel-l’area adiacente il monumento, e precisamente dal saggio effettuato presso l’an-golo nord-est (v. fig. 1). Qui, riutilizzato come inerte nelle fondazioni di uno de-gli ambienti rettangolari posti sul lato nord della chiesa e con ogni probabilità ri-salenti alla fase di costruzione originaria11, è venuto alla luce un grosso frammen-to di pavimento a ciottoli di fattura identica a quella delle porzioni in situ, ma in uno stato di conservazione decisamente migliore, sia nella superficie accurata-mente lisciata e “rubricata”, sia nella malta di supporto (alt. cm 16), in cui si di-stingue una progressiva diminuzione delle dimensioni degli inclusi fittili dal bas-so verso l’alto (fig. 6)12.
Ebbene, come si inquadra il pavimento a ciottoli del tempio sotto S. Leucio nel panorama delle consimili manifestazioni di area italica? Una delle ragioni ad-dotte da M. Falla Castelfranchi a sostegno dell’attribuzione all’edificio ellenistico – seppure ritenendone i resti tutti pertinenti al medesimo contesto, mentre come detto alcune porzioni sono certamente da ascriversi alla basilica – è che esso sa-rebbe direttamente paragonabile, se non ai celebri casi di Delo, Eretria, Olimpia o Atene, ai pur noti esempi di Ascoli Satriano, Ordona e Arpi in area daunia, di Taranto e Metaponto fino a Mozia in Sicilia, o ancora di Priene per le modalità di taglio dei ciottoli, rinvenimenti questi cui possono affiancarsi quelli di Tiati-Tea-num Apulum, Troia e Lavello13. Tuttavia, si tratta a mio avviso di confronti solo ge-nericamente pertinenti, rientrando quella di S. Leucio in un diverso orizzonte di testimonianze. Pavimento cementizio vero e proprio14, con caratteristiche tecnico-formali che sembrano apparentarlo a uno scutulatum, esso viene a collocarsi infat-ti più precisamente tra i mosaici c.d. ‘A’ e soprattutto ‘B’ della Casa-Palazzo di Ar-pi, ancora databili nei primi decenni del III sec. a.C. e in cui si riscontra già l’uso di ciottoli scapezzati in unione con motivi figurati e applicazione di uno strato di colore rosso15, e gli stringenti confronti con il pavimento a valve di ciottoli flu-
11 Al riguardo cfr. oltre e v. più ampiamente PENSABENE, D’ALESSIO c.s., cit. a nota 1.12 Cfr. sopra, nota 9. Verosimilmente, il frammento derivò proprio dalla citata apertura dei cavi di
fondazione dei pilastri sul lato nord del tetraconco interno della chiesa.13 FALLA CASTELFRANCHI 1985, cit. a nota 1, pp. 391-393. Cfr. D. SALZMANN, Untersuchungen zu den
Antiken Kieselmosaiken, Berlin 1982, tavv. 7, 57-58, 65-69, 71, 73; M. MAZZEI, ‘Nota sui mosaici a ciottoli in Daunia, fra IV e III secolo a.C.’, in Atti dell’11° Convegno sulla Preistoria-Protostoria e Storia della Daunia, San Severo, 2-3 dicembre 1989, San Severo 1990, pp. 171-191; EADEM, Arpi. L’ipogeo della Me-dusa e la necropoli, Bari 1995, pp. 189-197; EADEM, ‘Mosaici ellenistici di Arpi’, in AISCOM II, pp. 1-8; Ausculum I. L’abitato daunio sulla collina del Serpente di Ascoli Satriano, a cura di M. Fabbri e M. Osanna, Foggia 2002, pp. 30, 64, figg. 55-58; V. TUSA, ‘I mosaici di Mozia’, in AISCOM IV, pp. 137-146.
14 Secondo la definizione proposta da GRANDI CARLETTI 2001, cit. a nota 8.15 M. MAZZEI, S. PATETE, ‘I mosaici della Casa Palazzo di Arpi’, in Apparati musivi 2004, cit. a no-
ta 4, pp. 659-662.
6 7
viali della domus sotto la Curia Vescovile di Atri (prima metà del II sec. a.C.)16, o con quello, pure in ciottoli di fiume e pietre colorate, del complesso residenzia-le presso la chiesa di S. Rocco a Venosa (metà ca. del I sec. a.C.)17, entrambi già messi in relazione con l’esempio canosino; inoltre con il pavimento del presunto atrio di una struttura forse abitativa di Larino, anch’esso a ciottoli tagliati di vario colore (II-I sec. a.C.)18. Sempre al II e al I sec. rimontano d’altro canto alcuni si-gnificativi esempi pompeiani, tra i quali – rispettivamente – quello del marciapie-de sul lato sud-ovest della «Casa di Romolo e Remo», costituito da ciottoli dispo-sti però in modo da ottenere un motivo a esagoni inscritti in quadrati, e quello a crustae policrome ed emblema centrale con pesci del cubiculum 29 della «Casa di Cipius Pamphilus»19. Invece in Sicilia si può menzionare a Taormina la porzione di pavimento che circonda il riquadro con rosone centrale e delfini nel tappeto della Salita del Carmine20.
I confronti citati paiono indirizzare, dunque, a un ambito cronologico tra II e I sec. a.C., ancorché alcune analogie con i pavimenti a ciottoli di Arpi ci ab-biano anche spinto a ipotizzare che l’assenza della pavimentazione nella porzio-ne centrale della cella del tempio a S. Leucio possa essere dovuta a una eventua-le asportazione di parti figurate. Se, come ci sembra, la datazione del tempio al pieno o avanzato III sec. si debba ricavare dalla decorazione architettonica di ti-po tarantino cui rimandano i capitelli ionici e corinzi figurati21, la cronologia più bassa del pavimento potrebbe anche ricondursi a una fase di ristrutturazione del-l’edificio, forse da collegare con gli eventi bellici che coinvolsero Canosa in epo-ca tardo-repubblicana22.
Fin qui il pavimento a ciottoli del tempio. Caratteristiche molto diverse ri-spetto a questo, che fu come detto mantenuto parzialmente in uso all’interno del-la basilica, si ravvisano nelle porzioni riconducibili proprio alla costruzione della chiesa (v. fig. 2): in particolare si segnala un esteso tratto posto in corrispondenza del braccio di ambulacro nord, subito a est dell’abside, là dove lo smontaggio del-
16 G. AZZENA, Atri. Forma e urbanistica (Città antiche in Italia, 1), Roma 1987, pp. 52-53, figg. 51-52 e 54-55; A. CAMPANELLI, R. CAIROLI, ‘Nuovi mosaici dalle città romane d’Abruzzo: Hatria, Marruvium e Superaequum’, in AISCOM II, pp. 85-104, in part. p. 87.
17 M. L. MARCHI, M. SALVATORE, Venosa. Forma e urbanistica, Roma 1997 (Città antiche in Italia, 5), pp. 37-38, figg. 50-52; M. L. MARCHI, G. SABBATINI, M. SALVATORE, ‘Venosa: nuove acquisizioni archeo-logiche’, in Basilicata. L’espansionismo romano nel sud-est d’Italia, a cura di M. Salvatore, Venosa 1990, pp. 11-15, in part. 14, figg. 20-21.
18 E. DE FELICE, Larinum , Firenze 1994 (Forma Italiae, 36), pp. 104-105, nr. 123, figg. 123-124.19 V. SAMPAOLO, ‘Casa di Romolo e Remo (VII, 7, 10)’, in PPM, VII, pp. 258-276, in part. 259, fig.
1; EADEM, ‘Casa di Cipius Pamphilus (VII, 6, 38)’, ivi, pp. 210-223, in part. p. 210, figg. 12-13. Sempre a Pompei si veda anche la pavimentazione a ciottoli del marciapiede che fiancheggia il Tempio del-la Fortuna Augusta (VII, 4, 1) su Via della Fortuna-Via di Nola, per cui cfr. il contributo di L. Romiz-zi in questa stessa sede.
20 D. VON BOESELAGER, Antike Mosaiken in Sizilien. Hellenismus und römische Kaiserzeit, 3. Jahrhundert v. Chr.-3. Jahrhundert n. Chr., Roma 1983, pp. 34-36, Tav. V, 8; cfr. M. SANTANGELO, Taormina e dintor-ni, Roma 1950, p. 72.
21 V. da ultimo PENSABENE 2002, cit. a nota 1, che ritiene le maestranze provenienti da Taranto e non di Canosa, dove non vi sono confronti equiparabili stilisticamente.
22 Si ricordi ad esempio la defezione della città a Roma durante la guerra sociale e l’assedio da parte del pretore Caio Cosconio, poi abbandonato per l’accorrere dei Sanniti (APP. I, 42), ma che po-trebbe avere avuto un qualche effetto sul nostro edificio, posto non lontano dalle mura. Inoltre, an-che Canosa fu teatro di conflitto tra i partigiani di Silla e quelli di Mario, con la presunta caduta di 7000 soldati di Norbano che vi si erano rifugiati. Per quanto concerne direttamente il tempio, un in-tervento ascrivibile a una fase successiva a quella originaria è stato ipotizzato per le lastre di rivesti-mento del podio in calcare micritico grigio chiaro, attribuibili per le modanature del coronamento al tardo periodo ellenistico.
8 9
le colonne e delle sottostanti basi del pronao determinò la necessità di colmarne l’invaso integrando la pavimentazione stessa (fig. 7). Che non si abbia a che fare con un intervento di restauro moderno ci è assicurato dal raffronto tra la situa-zione attualmente visibile e alcune fotografie dell’agosto 1964 riferibili ai lavori di anastilosi seguiti agli scavi che avevano portato alla messa in luce di tutto il com-plesso: immagini dalle quali si evince chiaramente come la pavimentazione posta a riempire il cavo di alloggiamento delle basi – ivi rinvenuta e da attribuirsi appun-to all’epoca di costruzione della basilica – fu allora parzialmente smontata (fig. 8) al fine di segnalare a terra posizione e dimensioni delle basi medesime (peraltro con dubbia scansione degli intercolumni)23. Da sottolineare ancora come questo e altri brani pavimentali appartenenti alla chiesa differiscano nettamente da quel-li del preesistente tempio per qualità, dimensioni e posa in opera dei litotipi uti-lizzati, non solo di provenienza fluviale e di colore grigio e marrone, ma derivati anche dalla frantumazione di blocchi e/o lastre di calcare micritico, marmo bian-co e colorato ecc., tutti di dimensioni comprese tra i cm 2 o 4 x 4 o 8-12, collo-cati per lo più per fasce e con i lati lunghi accostati (fig. 9).
Per concludere, si segnala come dalla nostra analisi sia emersa la presenza di ampie porzioni pavimentate a ciottoli (v. fig. 2), la cui forma e disposizione (ge-neralmente piccoli e interi) lasciano il dubbio che possa trattarsi di una terza “ti-pologia”, forse attribuibile a uno o più rifacimenti eseguiti nel corso della lunga vita del tempio, certamente ancora esistente in epoca tardo-imperiale.
(A. D.)
I pavimenti a mosaico dell’ambulacro e del presbiterio della Basilica
Questa parte del nostro intervento vuole riproporre una lettura dei mosaici sulla base dei percorsi individuabili nella basilica, cercando di collegarne la distri-buzione, le dimensioni dei singoli tappeti e anche i motivi decorativi alla diversa funzione dei vani in cui sono collocati e al cambiamento architettonico e spazia-le che essi sottolineavano nel passaggio dall’uno all’altro di essi (fig. 2). È infatti questo il contributo che intendiamo portare alla conoscenza dei mosaici del monu-mento, per i quali resta ancora fondamentale lo studio di trent’anni fa della Cas-sano24. Tuttavia, abbiamo osservato come la lettura delle fasi architettoniche della basilica, l’analisi del pavimento a ciottoli e le ricerche d’archivio sui restauri dei mosaici, permettano ora di riconsiderare anche le tematiche di datazione; inoltre, i nuovi ritrovamenti in Puglia e nell’Adriatico inevitabilmente arricchiscono il qua-
23 Uno dei fusti di colonna con la relativa base venne artificiosamente ricostruito all’estremità est utilizzando i semirocchi rinvenuti e/o smontati dai muri perimetrali della basilica, dove erano stati co-me noto reimpiegati.
24 R. MORENO CASSANO, ‘Mosaici paleocristiani di Puglia’, in MEFRA, 88, 1976, pp. 277-373, cui ri-mando per un più ampia descrizione dei mosaici (v. anche CASSANO 1992, cit. a nota 1). In questo la-voro si sostiene la contemporaneità dei mosaici a decorazione geometrica con quelli floreali e anima-listici, datati entrambi alla prima metà del VI sec., e si attribuiscono le differenze stilistiche alla diver-sa funzione, in quanto i primi sono collocati nell’ambulacro, in un’area di passaggio, i secondi invece nelle absidi est e ovest, dove il repertorio scelto allude a temi paradisiaci (diversamente, FALLA CASTEL-FRANCHI 2004, cit. a nota 1, pp. 68-69, ritiene che i due gruppi appartengano a due periodi distinti di fine IV - prima metà del V e di VI sec.); inoltre vi si rileva una certa convergenza di motivi con S. Vitale a Ravenna e altri edifici dell’area ravennate e alto-adriatica (basiliche di Parenzo), pur notando similitudini con pavimenti dell’Africa settentrionale, in particolare con la Basilica d’Ippona.
8 9
dro, peraltro ancora valido, delle proposizioni della Cassano, in quando consento-no di affrontare con maggiori dati i temi delle officine e delle committenze25.
Braccio Est
Va subito detto che nel braccio est dell’ambulacro l’asse dell’abside determi-na la distribuzione dei mosaici che si contrappongono simmetricamente, disponen-dosi in modo da campire gli spazi dell’ambulacro secondo l’articolazione data dai pilastri in listato sporgenti (v. fig. 2); inoltre, il mosaico che occupa l’abside del tetraconco esterno (Cassano n. 6) è distinto dal mosaico che ricopre il tratto an-tistante di ambulacro (Cassano n. 5)26 e sottolineiamo come entrambi rivestissero un ruolo particolare, perché costituivano il pavimento del vestibolo di ingresso al-la basilica, cui si accedeva dalla scalinata aperta al centro dell’abside esterna. In conseguenza della funzione d’ingresso dell’abside, inoltre, anche quella corrispon-dente del tetraconco interno è non solo diversamente pavimentata (Cassano n. 4, fig. 10)27, ma presenta anche i passaggi tra le colonne ornati con piccoli tappe-ti28. A nord e a sud del mosaico centrale seguono due tappeti molto stretti (Cas-sano nn. 3, 7, fig. 11), in quanto la loro larghezza corrisponde a quella dei pila-stri in listato contrapposti che segnano il passaggio ai tratti laterali dell’ambula-cro, marcando anche il trapasso dallo spazio centrale absidato con copertura mol-to più alta e volta a botte orientata verso la semicupola dell’abside, a spazi coper-ti con volte a botte29. A questi due stretti tappeti seguono ancora, a nord e a sud, due ampi mosaici con motivo a stuoia ottenuto creando una maglia di bipenne (Cassano nn. 9, 2)30. Essi tuttavia non erano rettangolari, perché tagliati obliqua-mente sui fianchi esterni lungo una linea parallela alla diagonale dei due quadra-ti del tetraconco (v. fig. 2). In effetti qui i pilastri pentagonali in listato contrap-
25 Ai problemi di conservazione dei mosaici del S. Leucio è dedicato l’articolo di CORRENTE, VO-NA 2004, cit. a nota 4, dove appare anche un ampio interesse per gli aspetti culturali e storici in cui essi si inquadrano. Un più breve contributo, opera degli sforzi congiunti di storici dell’arte e archeo-metristi e dedicato all’identificazione dei materiali usati nelle tessere dei mosaici, è in LAVIANO et alii 2003, cit. a nota 4.
26 Rispettivamente, il primo presenta un motivo a pelte sovrapposte in tessere nere e orientate E-O, mentre quello antistante è un tappeto largo quanto l’abside stessa, occupato da un motivo a cer-chi incatenati generanti figure triangolari nere, che a loro volta compongono fiori a quattro petali; ta-le tappeto, inoltre, sul lato ovest segue la curva dell’abside del tetraconco interno, da cui è separato da una striscia nera e da una fascia.
27 Ossia con girali a tessere nere, giallognole e rosse che occupavano lo spazio fino alla testata della curva.
28 Questi decorati con la rappresentazione schematica di transenne con il campo rettangolare che inquadra losanghe, al centro nodi di Salomone e ai lati pelte da cui si originano brevi spirali.
29 I due tappeti, inquadrati da strisce nere e fasce bianche che rispettano i pilastri in listato, so-no decorati con motivo a scacchiera a rombi dai lati arcuati inseriti tra le caselle, che suggeriscono grandi cerchi inquadranti i rombi stessi. Nel tappeto sud, il modulo in larghezza è basato su 8 qua-drati alternativamente bianchi e colorati; se dunque i quadrati anche lungo i margini del tappeto so-no interi, al contrario i rombi sono sacrificati proprio lungo tali margini, mostrando sui lati nord e ovest un vertice tagliato, mentre sugli altri due lati ne rimane solo un vertice. Appare quindi una cer-ta incapacità o un disinteresse a riformulare il modello rispetto ai condizionamenti dello spazio dispo-nibile. Inoltre, poiché i pilastri in listato del tratto nord differiscono in larghezza da quelli del trat-to sud (m 2,10 e 2,35), il tappeto settentrionale è ancora più stretto, presentando un modulo di so-li 6 quadrati invece di 8.
30 Anche questi differiscono per dimensioni e varianti compositive, in quanto nel tratto sud le ma-glie della stuoia sono più grandi (m 0,64 x 0,34), mentre in quello nord sono più piccole (m 0,41 x 0,18) e si compongono con squame.
10 11
posti che occupavano gli angoli determinavano una zona di separazione tra i brac-ci di ambulacro. Inoltre, all’estremità nord si conserva uno stretto tappeto deco-rato con svastiche (Cassano n. 12) che appoggiava sul fronte del pilastro addossa-to allo spigolo del quadrato interno del tetraconco, testimoniando come tra que-sto e il pilastro contrapposto vi fosse uno stretto tappeto che segnava il passag-gio tra i due bracci contigui dell’ambulacro31. Infine, il passaggio tra l’abside in-terna e il pilastro angolare sud-ovest del tetraconco interno è segnato da un mo-saico a cerchi intersecati (Cassano n. 8)32, motivo questo che ritorna anche nei tappeti che si conservano nei due passaggi ai lati dell’abside interna sud (Cassa-no nn. 11, 17), indicando i fiori come decorazione preferita per gli accessi mag-giori al tetraconco interno.
Braccio nord
Tutto il braccio nord non presentava mosaici, ma solo il pavimento a ciotto-li (v. fig. 2), che fu come detto reintegrato al momento di costruzione della ba-silica (v. sopra). Un unico inserimento di mosaico appare dinanzi l’abside ester-na. Non è chiaro il motivo per cui in questo braccio non compaiono mosaici co-me negli altri, ma rileviamo che esso è in contatto con due passaggi dotati di so-glie ai lati dell’abside esterna, che comunicano con i due ambienti rettangolari in cui abbiamo identificato vani di servizio o addirittura i pastoforia, ai quali, come i nostri recenti scavi hanno dimostrato, si addossavano altri ambienti. Solo in cor-rispondenza del passaggio a ovest dell’abside è stato inserito un nuovo tratto pa-vimentale (fig. 12), costituito da tesseroni quadrangolari, anche con marmi bian-chi e colorati di reimpiego. Inoltre, il fatto che solo il braccio di ambulacro nord presenti il pavimento a ciottoli fa escludere che su questo lato vi sia stato mai un ingresso principale. L’entrata principale deve essere stata invece sempre dal lato est e, in conseguenza di ciò, anche se in origine vi fosse stato un altare al centro, questo era orientato a est.
Braccio ovest
Nel braccio ovest dell’ambulacro si conservano solo un lacerto di pavimenta-zione a ciottoli nel passaggio a nord dell’abside interna, riconducibile al periodo di costruzione della chiesa ma reintegrato, e un lacerto di mosaico a cerchi con croci esterne e separati da rombi e bipenne (Cassano n. 18), che ha la particola-rità di sovrapporsi all’estremità sud della fondazione dell’abside, per la cui com-prensione si deve fare riferimento al ciborio che occupa lo spazio antistante.
Ciborio
Lo spazio davanti l’abside ovest era occupato da un grande altare coperto da un ciborio (fig. 2) e circondato su tutti i lati da mosaici sopraelevati rispetto al pavimento originario della basilica. Un recinto in blocchi delimitava i mosaici sui
31 Anche in tal caso il passaggio era ulteriormente segnato dall’arco sostenente le unghie di con-giunzione tra le botti.
32 In modo che le zone di sovrapposizione campite in nero formano fiori a quattro petali.
10 11
fianchi e sul fronte, dove però si restringeva per rispettare i pilastri angolari con colonna della seconda fase della chiesa che reggevano la cupola centrale in cui era stata trasformata la copertura del tetraconco interno. Se ne deduce che il re-cinto e questi pavimenti sono contemporanei o successivi ai pilastri angolari stes-si e necessariamente posteriori ai mosaici dell’ambulacro. Brevemente rileviamo che i tappeti musivi sono costituiti sul retro dell’altare da piccoli rombi (Cassano n. 20), sui fianchi da pelte affrontate alternativamente verticali e orizzontali (Cas-sano n. 21), mentre in tutto lo spazio antistante da tondi accostati di dimensioni diverse e con vari motivi decorativi all’interno (nodi di Salomone, girandole, fio-ri a stella, corone: Cassano n. 22, fig. 13). Ancora lo spazio absidale è occupato dal noto motivo di tematica paradisiaca (Cassano n. 19, fig. 14): alla base vi era-no due pavoni affrontati ai lati di un fiore posto sopra ma non in asse, probabil-mente un grande cespo d’acanto o un kantharos da cui originano rami giralifor-mi carichi di fiori e frutta e “popolati” con uccelli e con motivo a treccia come incorniciatura33.
In sostanza emergono due aspetti che differenziano i mosaici con motivi ani-malistici e vegetali, ma anche quelli geometrici dell’abside ovest e del recinto del ciborio rispetto ai mosaici dell’ambulacro: in primo luogo la loro diversità stilisti-ca perché eseguiti in uno stile più affastellato e meno elegante, con linee che in-quadrano i tappeti non più nere ma colorate, secondo modalità riscontrabili so-lo in alcuni brani del braccio sud; in secondo luogo il collegamento disorganico tra i tondi del pannello nord. È per tale ragione che proponiamo di interpreta-re tale assemblaggio del pannello nord del recinto dell’altare e anche la mancan-za di rapporto assiale tra il motivo a pavoni e il cespo nel mosaico sul retro del-l’altare, come restauro antico dei mosaici dovuto forse alla necessità di adattarli all’inserimento dei pilastri angolari con colonne introdotti al centro della basili-ca in occasione della sua ristrutturazione: tale restauro è tuttavia operato su mo-saici che già nella stesura originaria potevano essere cronologicamente posteriori a quelli dell’ambulacro.
Braccio sud
Il braccio sud presenta nell’abside del tetraconco esterno un mosaico con mo-tivo a treccia a maglie sinusoidi larghe (Cassano n. 14), mentre nello spazio tra le absidi vi è un tappeto con meandro a chiave in cui si inseriscono rombi (Cas-sano n. 13)34. Degli intercolumni si conserva solo un mosaico con losanga che di nuovo richiama la decorazione delle transenne. Tra i pilastri in listato ai lati del-le absidi vi sono poi due stretti tappeti decorati da embricatura, di modulo leg-germente diverso (più grande nel tappeto est) che riflette anche la diversa lar-ghezza dei pilastri (m. 2,05 e 2,25) (Cassano n. 12 sud)35. Infine seguivano due ampi tappeti di cui si conserva maggiormente quello ovest, decorato con grandi fiori quadripetali che formano quadrati dai lati curvilinei (Cassano n. 16), men-
33 Si tratta di una composizione alterata dai restauri, ma che tradisce l’origine dal motivo del kan-tharos con girali e tra pavoni: cfr. G. BUCCI, L’albero della vita nei mosaici pavimentali del Vicino Oriente, Bologna 2001, pp. 29-30, 59-73.
34 Il tappeto è delimitato da due strisce di tessere colorate e da una fascia bianca, che in corri-spondenza dell’abside interna ne segue la curva.
35 Va notato che ai lati dell’abside interna si addossano speroni che inglobano parte dei pilastri in listato e si sovrappongono a questo primo gruppo di mosaici, restringendo i passaggi tra l’abside e l’ambulacro.
12 13
tre quello est mostra solo un nodo di Salomone in un angolo36. Gli spazi nei va-ni di passaggio tra l’ambulacro e il quadrato interno sono occupati invece da cer-chi che s’intersecano in modo da formare fiori, con pistilli al centro nel tappeto ovest e con rombi in quello est.
Osservazioni conclusive
I mosaici dell’ambulacro di S. Leucio, dunque, sono ben databili perché la loro stesura è contemporanea o di poco successiva all’inserimento dei pilastri in listato agli angoli dell’ambulacro e ai lati delle absidi, di cui seguono il contorno incorniciandolo con una linea di tessere nere. Inoltre, la presenza all’interno dei pilastri aggiunti di mattoni decorati del tipo frequentemente attestato in associazio-ne con laterizi col monogramma sabiniano, e il ritrovamento, nel corso dei nostri scavi, di tre mattoni con bolli sabiniani nel crollo di uno dei muri di elevato dei presunti pastofori a nord e di un altro muro del lato ovest del tetraconco esterno, rappresentano un importante termine cronologico per la datazione dell’intervento di consolidamento e posa in opera dei mosaici ai primi decenni del VI sec.37. Es-si s’inquadrano in un periodo in cui si afferma una predilezione evidente per la decorazione geometrica e per caratteristici partiti ornamentali38.
A una seconda fase è attribuibile il rialzamento del ciborio e del relativo pa-vimento, compreso quello retrostante con pavoni e girali, perché il recinto che lo racchiude tiene conto dei pilastri angolari con colonne nel suo allargamento. I mosaici con motivi animalistici e vegetali, ma anche quelli geometrici, del presbi-terio ci paiono diversi stilisticamente rispetto ai mosaici geometrici dell’ambulacro e a girali dell’abside est perché eseguiti in uno stile più affastellato e meno ele-gante, con le linee che inquadrano i tappeti musivi non più nere, ma con tessere colorate, secondo modalità che si riscontrano solo in alcuni brani dell’ambulacro sud e che forse sono stati parzialmente restaurati nella seconda fase della basili-ca, quando anche la parte meridionale subisce notevoli interventi di rinforzo. Più difficile l’attribuzione di questo seconda fase, forse ancora nel VI sec., ma di epo-ca post-giustinianea data l’introduzione della cupola centrale con volte a botte di-sposte a croce (e non necessariamente un quincunx), quando lo stato di prospe-rità dell’episcopato canosino rendeva possibile un intervento di restauro, rinforzo delle murature e ricostruzione delle coperture della portata che si è riscontrata. In effetti dopo la morte di Sabino nel 566 pare sia avvenuto un lento ridimensiona-
36 Si tratta di quella parte dell’ambulacro occupato da tre tombe con tracce di pittura, forse del periodo longobardo, che devono aver distrutto buona parte del pavimento.
37 Cfr. GIULIANI 2003, cit. a nota 1, p. 70. Tale datazione potrebbe confermare l’intervento diret-to sabiniano e forse avvalorare l’ipotesi che in S. Leucio sia da riconoscere la basilica dei Ss. Cosma e Damiano che Sabino «extruxit eademque diversis columnis ac musivo decoravit» (Historia vitae inventionis tran-slationis s. Sabini episcopi, 2. 6): A. CAMPIONE, ‘Note sulla vita di Sabino di Canosa: inventio e traslatio’, in VeteraChr, 25, 1988, pp. 617-639; N. LAVERMICOCCA, ‘Memorie cristiane di Puglia’, in Studi in onore di Giuseppe Chiarelli, I, Galatina 1972, pp. 302-305; C. D’ANGELA, ‘Architettura paleocristiana in Puglia’, in L’Italia meridionale fra Goti e Longobardi, XXXVII Corso di cultura sull’arte ravennate e bizantina, Ra-venna, 30 marzo-4 aprile 1990, Ravenna 1990, pp. 147-168, in part. 157-158; CASSANO 1992, cit. a no-ta 1, p. 854; G. BERTELLI, M. FALLA CASTELFRANCHI, Canosa di Puglia tra Tardo antico e Medio Evo, Ro-ma 1981, pp. 16-17, dove si propone anche una più antica dedica agli Angeli.
38 Cfr. M. SALVATORE, ‘I mosaici nell’area del complesso episcopale della SS. Trinità a Venosa’, in AISCOM IV, pp. 473-490, in part. 480; cfr. K. WERNER, Mosaiken aus Rom. Polyhrome Mosaikpavimente und Emblemata aus Rom un Umgebung, Würzburg 1994, pp. 222-225, 251-252, 381.
39 G. OTRANTO, ‘La cristianizzazione, la diocesi, i vescovi’, in Principi 1992, cit. a nota 1, pp. 824-832, in part. 830.
12 13
mento delle condizioni di floridezza della diocesi canosina, come sembra ricavarsi da alcune epistole di Gregorio Magno del 591 e poco oltre (I, 42, 51) da cui ap-prendiamo dello stato d’indigenza del clero locale e della necessità di ricostituir-ne la gerarchia39: erano iniziate le incursioni longobarde ed è noto come dagli inizi del VII sec. l’occupazione longobarda aveva messo in crisi le strutture orga-nizzative civili e religiose non solo di Canosa, ma di tutta la Puglia centro-setten-trionale. Se non è da condividere l’opinione di chi nega (G. Otranto) che possa-no considerarsi segni di forte ripresa della città agli inizi del IX sec. la costituzio-ne del gastaldato, l’attenzione della duchessa di Benevento, Teodorada, e altri av-venimenti come la traslazione delle reliquie di Sabino nella cattedrale di Canosa – i nuovi dati archeologici sembrerebbero indicare proprio in questo periodo una certa vitalità –, tuttavia non ci pare possibile attribuire agli anni tra VIII e IX sec. la fase ricostruttiva di grande portata di S. Leucio, ma solo interventi limitati co-me la costruzione della basilichetta e alcune tombe dipinte del lato sud.
Ma torniamo ai mosaici, che, dunque, anche se di due fasi diverse, sono da collocare nel VI sec. Oltre che in S. Leucio, brani importanti di decorazione mu-siva sono conservati nei complessi di piano S. Giovanni e dell’annesso Battiste-ro40, con testimonianze anche parietali, e di S. Pietro, da cui risulta una prospe-rosa committenza ecclesiastica, cui fanno capo anche figlinae, e che sono titolari di numerose proprietà (perfino in Sicilia)41. Possiamo ancora citare la chiesa ester-na della SS. Trinità a Venosa nella sua fase alto-medievale, nei cui mosaici com-paiono nodi di Salomone, rombi in cerchi contigui, cerchi intrecciati che forma-no fiori quadripetali simili a quelli di S. Leucio42. Riferimenti sono inoltre possi-bili a Egnatia, Siponto, Trani (basilica di seconda metà V-VI sec. preesistente al-la cattedrale), in Abruzzo a S. Stefano in Rivo Maris43, a Pesaro con i mosaici di età paleocristiana della cattedrale emersi nel 2000-2002, dove simili a mosaici di S. Leucio sono quelli decorati con fiori quadripetali44, con embricature o con lo-sanghe con occhi. Al mondo mediterraneo (Spalato, Ravenna45) rimandano moti-vi come le scacchiere bianche e nere talvolta con rosette e pistilli inseriti46, o an-che le eleganti girali dell’abside est trattate secondo schemi compositivi con con-fronti dalla Siria, alla Campania ecc.47.
È chiaro, dunque, come la Canosa paleocristiana e bizantina sia del tutto in-serita nei circuiti architettonici e artistici che interessano l’alto Adriatico, l’area greco-illirica e più in generale il Mediterraneo e come i mosaici delle sue basili-che testimonino un orizzonte non solo locale, delle aree pugliese e limitrofe, ma correnti artistiche che percorrono l’intero Adriatico e altre aree mediterranee. Si
40 FALLA CASTELFRANCHI 2004, cit. a nota 1, p. 69; M. CORRENTE, R. GIULIANI, D. LEONE, ‘I pavi-menti musivi nell’area del Battistero paleocristiano di S. Giovanni a Canosa: nuovi rinvenimenti’, in AISCOM X, pp. 79-98.
41 OTRANTO, cit. a nota 39, pp. 829-831.42 SALVATORE 1997, cit. a nota 38, p. 476, figg. 5-7.43 Ivi, p. 479.44 G. DE MARINIS, P. QUIRI, ‘Nuovi mosaici della Cattedrale di Pesaro’, in Apparati musivi 2004, cit.
a nota 4, pp. 595-596; cfr. G. DE MARINIS, ‘La cattedrale di Pesaro e altre nuove scoperte tardo an-tiche e medievali nelle Marche’, in L’archeologia dell’Adriatico dalla preistoria al Medioevo, Atti del Con-gresso Internazionale, Ravenna 2001, pp. 636-653. Per i motivi in età imperiale romana cfr. M. DON-DERER, Die Cronologie der römischen Mosaiken in Venetien und Istrien bis zur Zeit der Antonine, Berlin 1986 (in part. p. 596, fig. 5).
45 I repertori simili ravennati e alto-adriatici sono stati già messi in rilievo da MORENO CASSANO 1976, cit. a nota 24.
46 WERNER 1994, cit. a nota 38, p. 224.47 J. BALTY, Mosaique de Syrie, Bruxelles 1977, p. 138, n. 64; M. AMODIO, ‘Mosaici paleocristiani dal-
la Basilica di San Lorenzo Maggiore’, in NapoliNob, 5, 2004, pp. 3-18.
14 15
tratta delle stesse considerazioni che potremmo fare osservando l’architettura dei suoi edifici religiosi: in particolare i due che denunciano i rapporti, diciamo co-sì, internazionali tenuti dai vescovi canosini e non solo da Sabino: la Basilica di S. Leucio, a pianta centrale e a doppio tetraconco, e il Battistero di S. Giovanni, nella cui pianta si fondono lo schema ottagonale di origine palestinese e quello a croce microasiatico48. Infatti le loro piante, la prima di origine orientale e in Ita-lia testimoniata solo da S. Lorenzo a Milano, la seconda con rimandi immediati agli schemi planimetrici adottati a Roma tra V e VI secolo, sono la testimonianza diretta dell’attenzione verso l’“esterno” della committenza ecclesiastica.
(P. P.)
48 R. KRAUTHEIMER, Architettura paleocristiana e bizantina, Torino 1986, pp. 106-107.
Fig. 1 – Canosa, San Lucio. Pianta dei resti del Tempio ellenistico e della Basilica cristia-na e saggi di scavo 2005-2006.
14 15
Fig. 2 – Canosa, San Lucio. Pianta dei resti del Tempio ellenistico e della Basilica cristiana con evidenziazione diacronica delle porzioni di pavimento a ciottoli (campite quelle in situ, delimitate quelle oggetto di restauro e/o ricollocazione): in grigio scuro la pavimentazione originaria del tempio; in grigio medio le porzioni riconducibili all’epoca di costruzione del-la basilica; in grigio chiaro le porzioni di dubbia attribuzione (elaboraz. A. D’Alessio). Nei bracci di ambulacro e nella zona intorno all’altare i resti dei tappeti musivi della chiesa.
16 17
Fig. 4 – Canosa, San Lucio. Idem, restituzione grafica (dis. A. Ottati).
Fig. 3 – Canosa, San Lucio. Porzione originaria del pavi-mento a ciottoli in corrispon-denza dell’ala ovest del Tem-pio ellenistico (zona sotto-stante l’altare della Basilica cristiana) (foto A. D’Alessio).
16 17
Fig. 5 – Canosa, San Lucio. Linea di asporto praticato nel pavimento a ciottoli in corrispondenza del pronao del Tempio ellenistico per la realizzazione del cavo di fondazione del pilastro angolare di nord-est della Basili-ca cristiana (foto A. D’Alessio).
Fig. 6 – Canosa, San Lucio. In-dagini di scavo 2006 (Saggio II): rinvenimento di un frammento di pavimento a ciottoli del Tem-pio ellenistico in una delle fon-dazioni dell’ambiente rettango-lare est sul lato nord della Ba-silica cristiana, particolare della sezione (foto A. D’Alessio).
Fig. 7 – Canosa, San Lucio. Porzione di pavimento a ciot-toli e altri elementi litici ap-partenente alla Basilica cri-stiana (foto A. D’Alessio).
Fig. 8 – Canosa, San Lucio. Rimozione di una porzione di pavimento a ciottoli e al-tri elementi litici apparte-nente alla Basilica cristiana nel corso dei lavori del 1964 (foto Archivio Soprintenden-za P.S.A.D. di Puglia).
18 19
Fig. 9 – Canosa, San Lucio. Parti-colare della porzione di pavimen-to a ciottoli e altri elementi litici appartenente alla Basilica cristiana in corrispondenza dell’alloggiamen-to di una delle basi di colonna già pertinenti al pronao del Tempio el-lenistico (foto A. D’Alessio).
Fig. 10 – Canosa, San Lucio. Basilica, abside interna est: pan-nello ‘Cassano n. 4’ (foto P. Pensabene).
18 19
Fig. 11 – Canosa, San Lucio. Basilica, braccio di ambulacro est: pan-nello ‘Cassano n. 7’ (foto P. Pensabene).
Fig. 12 – Canosa, San Lucio. Basili-ca, braccio di ambulacro nord: pa-vimento a grandi tessere presso il passaggio all’ambiente rettangolare ovest (foto P. Pensabene).






















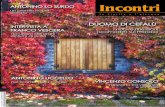





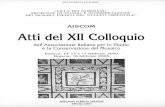



![Il ruolo di Bisanzio nella Venezia del XIV secolo. Nota introduttiva a uno studio sui mosaici del battistero marciano [2013]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6314d91d5cba183dbf07be70/il-ruolo-di-bisanzio-nella-venezia-del-xiv-secolo-nota-introduttiva-a-uno-studio.jpg)