Vecchi e nuovi dati sulle pavimentazioni e i mosaici dell'area di San Leucio a Canosa
NUOVE RIFLESSIONI (SCOMODE) ATTORNO AI MOSAICI DEL DUOMO DI CEFALÙ
Transcript of NUOVE RIFLESSIONI (SCOMODE) ATTORNO AI MOSAICI DEL DUOMO DI CEFALÙ
3INCONTRI - ANNO III N.10 GEN/MAR 2015
INCONTRO CON I LETTORI
Un legittimo dubbioGentile Direttore,
passeggiando per il centro storico di Catania, sono rimasto sorpreso dalla lettura di una targa accanto al portone di Palazzo Geraci-Guerrera, segnalato come Palazzo Manganelli. Per averlo letto sulla sua rivista, sapevo che quello di via Antonio di Sangiuliano non era Palazzo Manganelli; e, più che mai, non poteva essere stato edificato nel XVIII secolo perché lo stile architettonico è, fuor di dubbio, più recente rispetto a quello del vero Palazzo Manganelli che si affaccia nella dirimpettaia e omonima piazza.
Nel confessarle il mio stupore per la clamorosa svista, sono pervaso dal dubbio che anche le segnalazioni riguardo ad altri palazzi del centro storico possano depistare l’ignaro turista che, in un susseguirsi di passa parola, potrebbe stendere un velo di inconsapevole menzogna sulla verità strapazzata dai responsabili dell’informazione.
Marco Saporita, Sant’Agata li Battiati (CT)
Lo stupito lettore è assalito da un dubbio più che legittimo. Dopo la segnalazione, mossi da curiosità, abbiamo censito 28 palazzi del centro storico di cui ventiquattro con le informazioni certificate da: Comune di Catania, Università degli Studi, Rotary club Catania est e Sostare. Undici cartelli risultano carenti o errati, per cui torneremo presto sull’argomento per fare chiarezza come abbiamo scritto nell’editoriale.
Elio Miccichè
Palazzo Geraci-Guerrera, via Antonino di Sangiuliano, 269
Incontri - La Sicilia e l’altroveRivista trimestrale di cultura – fondata da E. Aldo Motta nel 1987
Nuova serie, anno III, numero 10Gennaio-Marzo 2015ROC n°22430 - 22 Maggio 2012ISSN 2281-5570 Incontri (Catania)
Direttore editorialeElio MiccichèComitato di DirezioneGiamina Croazzo, Elio Miccichè, Antonio Parisi, Gino Sanfilippo Direttore responsabileAlfio PattiComitato ScientificoAldina Cutroni Tusa (Università degli Studi di Palermo: già docente di Numismatica antica); Rosalba Galvagno (Università degli Studi di Catania: Letterature comparate); Claudia Guastella (Università degli Studi di Catania: Storia dell’arte medievale); Paolo Militello (Università degli Studi di Catania: Storia urbana e Cartografia)RedazioneMariella Bonasera, Carmela Costa, Francesco Giuf-frida, Agatino Reitano, Sibylle KreiselTestiMercedes Auteri, Ray Bondin, Beat Brenk, France-sco Cappellani, Giacomina R. Croazzo, Alessandro Santino Cugno, Matteo Donato, Antonino Fran-china, Rosalba Galvagno, Giuseppina Lo Coco, Davide Macaluso, Elio Miccichè, Alessandra Nico-tra, Giancarlo Poidomani, Irenea Privitera, Gabriella Rossitto, Daniele Russo, Giuseppina Salerno, Ines Tolic
Progetto grafico e impaginazioneDavide MiccichèStampaTipografia Kromatografica - Ispica
WebmasterArmando Villani
Associazione Culturale IncontriViale Tirreno, 6/O – 95123 CataniaContattiTel. 328 [email protected] Edizioni Incontri
Un numero: euro 6,50Numero arretrato: euro 6,50 più spese postali
Quota associativa annua (quattro numeri):Ordinaria: euro 25,00Sostenitore: euro 50,00Estero: euro 25,00 più spese postaliC.c.p. n° 1006273229 (IBAN: IT05 O076 0116 9000 0100 6273 229)intestato a Associazione Culturale Incontri Viale Tirreno, 6/O - 95123 Catania
Rivista omaggio per gli associatiGli autori sono unici responsabili del contenuto degli articoli.
INCONTRI - ANNO III N.10 GEN/MAR 2015 7
Cefalù deve aver attirato l’attenzione di Re Rug-gero a causa della sua
spettacolare posizione geogra-fica perché questa includeva un porto idoneo, un castello in cima a una collina inespugna-bile, molteplici fonti e di conse-guenza anche terme e mulini, oltre a un mercato e a tante al-tre cose [1].
La fondazione della catte-drale avvenne nella Pentecoste (7 giugno) dell’anno 1131, in onore del Salvatore e dei princi-pi degli apostoli Pietro e Paolo, il che si renderà manifesto nel programma dei mosaici dell’ab-side. L’antipapa illegittimo di allora, Anacleto II, convalidò a settembre dello stesso anno la cattedrale come sede del ve-scovo, e fu lo stesso antipapa che confermò Ruggero II come re di Sicilia e dell’Italia meridio-nale e che predispose la sua coronazione (dalla prospettiva ortodossa illegittima).
L’arcivescovo di Messina, dal canto suo, nominò l’abate
del convento agostiniano di S. Maria in Bagnara, Iocelmo, ve-scovo di Cefalù, senza aspettare la conferma del papa legittimo, ai cui occhi questa scelta era il-legale. Questi deficit, sanati solo nel 1166 col riconoscimento del vescovo Boso da parte di papa Alessandro III, erano ben pre-senti a Ruggero II: proprio per legittimarsi, egli doveva costru-ire il duomo di Cefalù partico-larmente grande, arredarlo in maniera sontuosa e nello stesso momento portarlo a compi-mento il più presto possibile. Il duomo serviva come dimostra-zione del potere reale nei con-fronti del papato e della popo-lazione maggioritaria islamica della Sicilia.
LA DATAZIONE DEI MOSAICI NORMANNI IN SICILIAFin qui la ricerca ha interpretato le date della cappella Palatina (1143) e del duomo di Cefalù (1148) come se fossero vinco-lanti per la cronologia dei mo-saici. Poiché la decorazione a
mosaico dell’abside del duomo di Cefalù è datata al 1148 grazie a un’iscrizione [2], tutta la deco-razione interna a mosaico - in-clusi le parti marmoree del coro, gli altari, i troni del re e del ve-scovo, le suppellettili dell’altare come croci, candelabri, turiboli, e i paramenti - doveva essere fi-nita a questa data. Questo viene provato nella frase dell’iscrizio-ne Hoc opibus ditat variis vario-que decore / Ornat magnificat in Salvatoris honore.
La costruzione della catte-drale invece doveva essere già
compiuta subito dopo il 1131, perché si trattava per Rugge-ro di mascherare la mancata legittimazione papale con la realizzazione di un edificio stra-ordinariamente monumentale. A tal riguardo dovrebbe desta-re interesse il fatto che anche la cappella palatina di Carlo Magno ad Aquisgrana è stata costruita in pochi anni, cioè tra il 795 e l’803. Il primo progetto della cattedrale di Cefalù non prevedeva ancora mosaici, che sembrano essere stati aggiun-ti in una seconda fase. In un
NUOVE RIFLESSIONI (SCOMODE) ATTORNO AI MOSAICI DEL
DUOMO DI CEFALÙ
La fondazione della cattedrale di Cefalù e l‘assenza di una legittimazione papale
di BEAT BRENK(Professore emerito di archeologia cristiana e medievale - Università di Roma 1 “La Sapienza”)
NELLA SICILIA NORMANNA
INCONTRI - ANNO III N.10 GEN/MAR 20158
documento del 1145 Ruggero stabilì che il suo sarcofago do-veva essere esposto nella cat-tedrale assieme a un secondo per la commemorazione del suo nome [3], perché Dio stes-so (e non il papa) avrebbe de-corato il nome di Ruggero con l’onore reale, (nomen nostrum laude regia decoravit). Siccome una sepoltura può avere sede solo in una chiesa dedicata, la cattedrale doveva essere sen-za dubbio dedicata prima del 1145, esattamente quando non lo sappiamo.
Augusta Acconcia Longo ha recentemente formulato la tesi che la Martorana a Palermo serviva come sepoltura della madre dell’ammiraglio Giorgio di Antiochia già nel 1140, il che prova che la chiesa doveva ne-cessariamente essere dedicata
per poter ospitare tombe. Da questo, Acconcia Longo giun-ge alla inevitabile conclusione che la Martorana doveva essere costruita prima della Cappella Palatina e doveva essere deco-rata con mosaici prima di essa: quindi i mosaici della Marto-rana sarebbero i primi mosaici normanno-bizantini in Sicilia. Questa tesi ha senso perché Giorgio di Antiochia, nato greco di Antiochia, possedeva le ne-cessarie conoscenze per procu-rarsi mosaicisti greci: il medium del mosaico non poteva essere introdotto in Sicilia da Ruggero ma piuttosto da Giorgio, greco ortodosso bizantino.
I pochi mosaicisti bizantini - a mio avviso non più di una doz-zina - che l’ammiraglio fece ve-nire dal Mediterraneo orientale a Palermo, erano impossibilitati
a decorare con mosaici Martora-na, Cefalù e Palatina contempo-raneamente. Si dovevano reclu-tare ulteriori artisti da vicino e da lontano - Venezia? - e anche addestrare questi mosaicisti in Sicilia. Solo così è pensabile che tutti e tre i monumenti potesse-ro essere decorati con mosaici più o meno simultaneamente, ma la vera cronologia di questi mosaici non si potrà mai e poi mai sbrogliare.
IL ROVESCIAMENTODELLA PROSPETTIVA C’è però un fatto trascurato da quasi tutti gli storici dell’arte che ci permette una distinzione tra il ‘prima’ e il ‘dopo’. La tecnica del mosaico richiede che si la-vori dall’alto in basso; questo significa che le parti superiori negli edifici menzionati dove-vano essere eseguite prima, e cioè: nella Martorana la cupola e il tamburo, a Cefalù l’abside [4], il presbiterio e le parti superiori del presbiterio, nella Palatina la cupola, col tamburo, l’abside centrale [4] e anche le volte dei transetti [6]. Le date, 1143 per la Palatina e 1148 per Cefalù, sono date finali per gli ultimi lavori che si trovavano sulle pa-reti inferiori, e poiché i mosaici di Cefalù sono stati fatti dopo quelli della Martorana risulta per questi una data tra il 1140 e il 1148. La data 1148 significa che anche i mosaici del presbi-terio erano finiti: non posso as-solutamente immaginare che uno dei più ricchi re dell’Europa di allora celebrasse la liturgia in una cattedrale non finita, piena di ponteggi.
IL SENSO DEL PANTOCRATORELa formulazione molto accen-tuata in un documento del 1132, nostra a Deo coronata maiestate, corrisponde alla scel-ta inusuale del Pantocratore nell’abside centrale.
In un saggio del 2003 mi sono occupato del Pantocratore nel catino dell’abside, e l’ho chia-mato il Megalopantocratore [4]. Si tratta di una composizione in-consueta sotto ogni aspetto, as-solutamente non-bizantina, una manifestazione altamente origi-nale che ha il fine di impressio-nare ed emozionare i fedeli con la sua intera monumentalità e corposità e col suo fisico profon-damente severo, con la retorica della gravità. La grande iscrizio-ne latina che corre intorno alla calotta dell’abside dice “FAC-TUS HOMO FACTOR HOMINIS FACTIQUE REDEMPTOR IUDICO CORPOREUS CORPORA CORDA DEUS”. Nello spirito l’iscrizione risulta totalmente antigreca. Essa annuncia letteralmente che Cristo è stato fatto uomo (factus homo), contemporaneamente però egli è il creatore dell’uomo (factor hominis) e il redentore del creato (factique redemptor). Nessuna iscrizione al di sotto di un Pantocratore aveva finora annunciato in modo così mi-naccioso: io giudico (iudico), in quanto Dio corporeo, i corpi e i cuori degli uomini. Si vede Dio in corpore.
Mark Johnson ha segnalato le fondamenta di due troni che erano apparsi durante gli scavi nel presbiterio, ed egli ne con-clude che Ruggero e i suoi eredi avevano il diritto di sedere nel santuario durante la liturgia. Il re si sedeva a nord [3], alla destra
INCONTRI - ANNO III N.10 GEN/MAR 2015 9
di Cristo e il vescovo guardava da sud a nord. In un più ampio senso il Megalo-Pantocratore il-lustra una frase dai versetti 8.15 che, nell’ideologia cristiana del governo, ha sempre giocato un ruolo importante: «Attraverso me regnano i re».
Il concetto dell’immagine del Pantocratore di Cefalù può essere stato inventato unica-mente da un concepteur nor-manno; nessun artista bizantino avrebbe mai avuto l’idea di siste-mare un Pantocratore talmente grande in un’abside, perché questo era il luogo della Madre di Dio. Ai mosaicisti greci si sa-ranno drizzati probabilmente i capelli quando furono chiamati a realizzare questa raffigurazio-ne inconsueta in una abside di ben 24.13 metri di altezza. Il con-cetto del Pantocratore nel cati-no dell’abside e del trono del re
sottostante è stato ripetuto nel-la Cappella Palatina e più tardi a Monreale. Si tratta di un concet-to tipicamente normanno, mai ripetuto fuori della Sicilia.
MANIERA BIZANTINAE MANIERA LOCALEVictor Lazarev, Otto Demus e Ernst Kitzinger e molti altri storici dell’arte ritengono che i mosaici absidali di Cefalù siano della più purissima forma della tradizione greca importata in Sicilia duran-te il dodicesimo secolo. Se ana-lizziamo il disegno degli abiti degli apostoli [2, 7] risulta che questi sono tutti di tre taglie più grandi, così che l’artista lotta con le masse delle stoffe in piena re-gola e perde un po’ il senso delle proporzioni. L’apostolo Giaco-mo [5, a sinistra], per esempio, ha due piedi ma solo una gamba che si trova fatalmente
al centro del corpo: è questa allora la spesso lodata qualità bizantina? Penso che si tratti piuttosto di un malinteso equi-voco del disegnatore che non capì come rappresentare una gamba appoggiata e una gam-ba libera. L’artista che disegnò l’abito di Giacomo a Cefalù era senza dubbio un apprendista, mentre il disegnatore dell’apo-stolo Giacomo nella Martorana [5, a destra] era un esperto gre-co. Confrontando invece i volti dell’apostolo Giacomo di Cefalù col Giacomo nel braccio meri-dionale della Cappella Palatina [6], si rivela che due maestri bi-zantini lavorarono su un unico modello interpretandolo però in maniera differente. Forse è stato addirittura il medesimo artista l’autore responsabile per le due teste. Concludo che a Cefalù solo i ritratti degli apostoli sono stati lavorati da artisti bizantini, mentre le figure stesse sono sta-te disegnate ed eseguite da aiuti locali che non disponevano del-la stessa maestria come gli artisti
greci. È interessante notare che certi apostoli a Cefalù ripetono i colori e il disegno - ma non le proporzioni! - degli apostoli della Martorana [7]. Il sottile di-segno dell’apostolo Paolo alla Martorana riflette la mano abile di un artista bizantino, mentre l’apostolo Paolo a Cefalù è tar-chiato e le sue mani e piedi piatti sono enormi. Sembra che questi artisti avessero a disposizione modelli disegnati su sottili lastre di legno che erano facilmente trasportabili. Cennino Cennini parla di tali lastre di legno su cui si faceva il disegno. Appare chiaro che gli artisti bizantini importarono queste lastre dal Vicino Oriente e proposero una iconografia e uno stile bizanti-no che poi vennero cambiate drasticamente dal concepteur normanno.
Tutto sommato l’iconogra-fia dell’abside di Cefalù [2] non riflette per niente una abside bizantina, ma è una creazione originale normanna. La produ-zione di una tale quantità di mo-
INCONTRI - ANNO III N.10 GEN/MAR 201510
DIDASCALIE1. Cefalù visto da occidente.2. Cefalù, Abside del Duomo: apostoli sul lato sinistro.3. Cefalù, assonometria del presbiterio del Duomo.4. Il Cristo Pantocratore del Duomo di Cefalù (sopra) e della Cappella Palatina di Palermo (sotto).5. L’apostolo Giacomo nei mosaici di Cefalù (sinistra) e della Martorana (destra).6. L’apostolo Giacomo nei mosaici della Palatina (sinistra) e di Cefalù (destra).7. L’apostolo Paolo nei mosaici di Cefalù (sinistra) e della Martorana (destra).
BIBLIOGRAFIA- BRENK, BEAT, Arte del potere e la retorica dell’alterità: La Cattedrale di Cefalù e San Marco a Venezia, in «Römisches Jahrbuch der Biblioteca Hertziana», 35 (2003/04), pp. 83-100.- ACCONCIA LONGO, AUGUSTA, Considerazioni sulla chiesa di Santa Maria dell’Ammira-glio e sulla Cappella Palatina di Palermo, in «Νέα ‘P ώμη. Rivista di Ricerche bizantini-stiche», 4 (2007), pp. 269-293.- JOHNSON, MARK J., The Episcopal and the Royal View at Cefalù, in «Gesta» 33/2 (1994), pp. 118-131.
saici tra 1140 e 1148 ca. necessi-tava di una divisione del lavoro e l’uso di molteplici modelli. A Cefalù il concepteur ha ripetu-to la stessa serie di apostoli con Pietro, Paolo, Marco e Luca, che incontriamo nella scena della Pentecoste nella volta meridio-nale del transetto della Cappella Palatina. Poiché la cattedrale di
Cefalù è stata fondata il giorno di pentecoste del 1131, sem-bra logico che i dodici apostoli commemorino questa festa. Così si spiega anche la presenza della Vergine nel registro supe-riore. I quattro arcangeli invece non appartengono alla Pente-coste, ma piuttosto alla guardia di Gesù Cristo. Tenendo conto
di questi elementi dobbiamo abbandonare l’idea di un’arte pura e compatta bizantina a Ce-falù; riteniamo che i lavori siano
stati divisi fra specialisti per i vol-ti, le figure e i fondi d’oro: solo i volti sono da attribuire ad artisti bizantini.








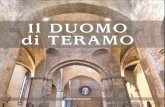




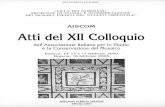
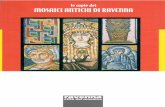










![[Spilimbergo] Il duomo e gli altri edifici di culto](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6312c47d5cba183dbf06cb45/spilimbergo-il-duomo-e-gli-altri-edifici-di-culto.jpg)

