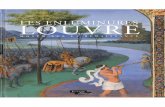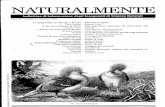Marco FRATI, La Piazza del Duomo di Pisa: un millennio di miracoli, in Il Duomo di Pisa, a cura di...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Marco FRATI, La Piazza del Duomo di Pisa: un millennio di miracoli, in Il Duomo di Pisa, a cura di...
47
È solo un secolo, da quando cioè Gabriele D’Annunzio (1910) l’ha icasticamente ribattezzata, che la Piazza del Duomo di Pisa è diven-tata, per tutti, il Prato dei Miracoli, evocando favolose suggestioni e favolistiche assonanze che voglio-no questo spazio, indubbiamente meraviglioso e unico al mondo, letterariamente e letteralmente cristallizzato da sempre e per sem-pre, ignorandone la genesi e ne-gandone possibili sviluppi futuri.I processi di formazione e trasfor-mazione di una piazza del duomo, invece, appaiono sovente assai complessi, ancor più che di altri spazi pubblici, perché su di essa convergono solitamente gli inte-ressi di molti attori. E, quanto più essi tendono a conservare posizio-ni di prestigio e di rendita, tanto più resistono a una progettazione
unitaria sia negli intenti sia nella forma. Pertanto, una piazza mo-numentale come quella di Pisa va letta come l’esito di un lungo processo dialettico e diacronico i cui protagonisti si esprimono a diverse scale (territoriale, urbani-stica, architettonica, decorativa), intrecciandole.La questione storiografica delle piazze è da tempo al centro delle riflessioni degli storici della città, ma è solo da un quarto di secolo (Le piazze 1993) che anche urbani-sti e architetti ne hanno sempre più consapevolmente raccontato il divenire. In particolare, delle piazze del duomo si è prima con-siderata filologicamente l’evolu-zione dei principali edifici che vi si affacciano (Agazzi 1991, Gurrieri 1995, Rocchi 1996) nonché dell’in-vaso (completo delle sue spon-
de) come manufatto (Bergaglio 1993); poi ci si è posti il problema di una definizione non anacro-nistica degli aspetti funzionali e formali (La piazza 1997), indagan-do le tappe e le ragioni dei lunghi processi di ogni sua costituzio-ne, con particolare riguardo per quelle medievali. Più di recente, ad aver attirato l’attenzione degli studiosi sono, più che l’adesione della realizzazione a un proget-to conchiuso (Le piazze 2006), gli usi liturgici (Toker 2009) e le loro trasformazioni (Schwartz 2010) che, sommati a mille altre spin-te, fanno della piazza del duomo “uno spazio incompiuto e costan-temente negoziato” (Barbot - Mo-carelli 2011). E il caso pisano (Fig. 1) appare sempre disponibile all’immediata verifica – se non alla formulazione
A Vittorio Franchetti Pardo,che venticinque anni fa incendiò le nostre menti
La Piazza del Duomo di Pisa. Un millennio di miracoliMarco Frati
48 La Cattedrale di Pisa
1. Mappa del Catasto Generale della Toscana, 1835: Comunità di Pisa, sez. C, f.° 1, scala originale 1/1250 (Archivio di Stato di Pisa, Catasto terreni, Mappe, Pisa, Allegati, 1).
stessa – delle più aggiornate ipo-tesi storiografiche. Dopo le clas-siche descrizioni di Sanpaolesi (1949), Carli (1956), Nuti (1964) e Tobino (1982) e le visionarie inter-pretazioni numerico-astrologiche (Guidoni 1970, pp. 49-67, Burga-lassi 1983, De Angelis d’Ossat 1986a, Speiser 1994, Dezzi Barde-schi 2003), nell’osservazione del fenomeno urbanistico si assiste – finalmente – alla combinazione dei dati storici con quelli mate-riali, secondo i filoni di ricerca già segnalati, da parte di Micalizzi (1989), Redi (1996), Ronzani (1997) e, da ultimo, von der Höh (2006), particolarmente attento ai mec-canismi di comunicazione visiva presenti nella piazza. Questi e altri studi dimostrano come la Piazza del Duomo pisano abbia avuto forma e dimensioni quanto mai variabili (Fig. 2) ma il suo fulcro sia sempre stato la mole della cattedrale. Anche il rapporto fra la chiesa madre di Pisa e la sua città appare assai dinamico (Fig. 3 a-h), a causa della presenza (o dissolvenza) di barriere fisiche (le mura, i corsi d’acqua) e di colle-gamenti fisici e visivi (le strade). E ciò impone di considerare anche la relazione del duomo con il pae-saggio storico, di cui naturalmente fa parte anche il mare, per valutarne appieno il valore.
Foris Pisa prope ecclesiam Sancte Marie: prima di tutto
Vecchi sterri (Manghi - Nicco-lai - Severini 1942), poi riesami-nati (Schmiedt 1967, Pani Ermini - Stiaffini 1985) e confrontati con più moderne e corrette indagini archeologiche (Archeologia 1993, Bruni 1995, Gattiglia 2010, Archeo-logia 2011) e con i dati offerti dal-la ricerca storica (Garzella 1990, pp. 81-84, Redi 1991, pp. 59-76) hanno permesso di ricostruire la situazione di buona parte della piazza prima della costruzione del duomo (Tolaini 1992, pp. 3-35, Redi 1996, pp. 39-54), anche se sussistono ancora molti dubbi fra cui quelli, fondamentali, sul rap-porto dell’area con la città antica e sull’ubicazione della primitiva sede episcopale (Gelichi 2011). Già sede di culto in età etrusca, l’area era delimitata a nord dall’as-sai instabile paleoalveo dell’Auser verso cui il terreno scendeva con una sensibile pendenza. La zona, inserita nella fitta rete di strade e idrovie e vicina al porto e ad altri servizi urbani, divenne residenzia-le in età ellenistica e in età roma-na fu caratterizzata da abitazioni di lusso orientate secondo i punti cardinali. Il degrado delle strut-ture e la loro distruzione avvenne nel corso del V secolo: successi-
vamente, una volta livellato il ter-reno, vi venne impiantato un cimi-tero cristiano (una Chiesa guidata da un vescovo era nata prima del 313) in cui, mescolate a strutture in materiali deperibili, trovarono posto anche ricche tombe longo-barde (dal VII secolo), forse attrat-te dalla presenza dell’episcopio, ricordata per la prima volta nel 748 ma non ancora provata da eviden-ze materiali (cfr. Redi 1999).Le più recenti indagini stratigra-fiche (Archeologia 2011) hanno messo in dubbio la cronologia (tardoantica-altomedievale) e la funzione (battesimale) della strut-tura ottagonale absidata scavata nel Camposanto mentre conver-gono sulla datazione intorno al 1000 per l’impianto basilicale a tre navate con abside e cripta rin-tracciata fra Duomo e Battistero. Questo grande (per l’epoca: cfr. Frati 2013) edificio, poi spogliato e impiegato come cimitero, potreb-be essere uno dei due poli cultuali altomedievali (Santa Maria) citati dai documenti e distrutti per far posto alla cattedrale romanica. L’altro, dedicato a San Giovanni e noto dall’816, potrebbe ancora in-dicarsi nel già supposto battiste-ro ottagono (da ultimo, Frati 2011, p. 46), da essa separato da una strada d’incerta datazione (Bruni 1995, p. 166) forse diverticolo della
La Piazza del Duomo di Pisa. Un millennio di miracoli 49
via Aemilia Scauri. Il passaggio fra il 910 e il 934 della mensa vescovi-le dal duomo di Santa Maria alla chiesa urbana di San Giorgio (sito dell’attuale curia arcivescovile) suggerisce una divisione di com-petenze fra i canonici e il vesco-vo (Ronzani 1997b, pp. 24-25) che potrebbe aver avuto importanti riflessi sulla riorganizzazione e/o ricostruzione delle loro sedi in un momento considerato, a torto, di totale inattività edilizia (cfr. Frati 2014).
All’epoca, non c’è ragione di dubi-tarne, la cattedrale si trovava già qui, in Catallo (Fig. 3a): un’area stretta fra l’Auser (a nord), la pa-lude (a ovest e sud) e le mura che circondavano la città altomedieva-le (Garzella 1990, pp. 26-58, Gelichi 1998). Come tanti altri complessi cattedrali (Fonseca - Violante 1966, pp. 326-327), quello di Pisa occu-pava dunque una posizione perife-rica, diventata rurale e suburbana con la contrazione della città e l’allontanamento della linea di co-
sta dopo la formazione dell’alveo del Serchio. L’eccentricità non si spiega soltanto con la continuità d’uso: piuttosto, va considerata la specificità marittima della città (Tangheroni 1995, Garzella 2011), con il porto sempre funzionante fra età tardoantica e altomedie-vale e il costante rapporto col Tir-reno, le cui sponde più immediate (Arcipelago Toscano e Corsica) sono facilmente visibili da terra in giornate particolarmente limpide e si propongono come obiettivo da
50 La Cattedrale di Pisa
raggiungere e limite da superare. Dunque, il complesso episcopa-le va visto proiettato sul mare (e sulle isole di cui sarà primaziale) piuttosto che sull’angusta diocesi di terraferma, e la città un’attrez-zatura del porto, piuttosto che il contrario.
Procul haud est edes ab urbe: il Duomo di Guido e Buscheto
Nel 1064 Buscheto dava avvio alla nuova cattedrale, che sareb-be diventata il ‘motore immobile’ dell’area fino all’attualità (Fig. 3b). L’enorme edificio, una basilica a
cinque navate ipostila con tran-setto immisso sporgente e con-tinuo (Peroni 1995, Tigler 2006, pp. 41-54), nonostante la longitu-dinalità dell’impianto, manifesta-va esternamente anche una forte centralità, data dalle dimensioni complessive (l’intero organismo è inscrivibile in un quadrato di
2. Fotografia aerea (da Schmiedt 1967) successiva agli scavi nel Camposanto (1936) e intorno al Duomo (1949) e ai restauri al Camposanto (1953) e al Duomo (1959). Si notano emergere le tracce del supposto battistero, del duomo protoromanico e del chiostro romanico.
La Piazza del Duomo di Pisa. Un millennio di miracoli 51
20 pertiche pisane di lato: Tolaini 1992, p. 40) e dalla presenza della cupola sotto la quale si dipartono quattro corpi di forma basilica-le distesi nelle direzioni dei punti cardinali Il Duomo appare unitariamente concepito come perno di un nuo-vo spazio in via di riconfigurazione ma esso è il risultato della fusio-ne di più istanze e di più influssi culturali, così come il suo attuale aspetto cristallino e simmetrico è frutto di più fasi costruttive (e di-struttive) a cui si dovrà anche solo brevemente accennare. Il primo committente ne fu il ve-scovo Guido da Pavia (1060-1076), “noto al re e al papa per la fama della cattedrale” come si può in-tendere dall’apocrifa iscrizione celebrativa (Scalia 1982, pp. 833-845, Rossetti 1995, pp. 84-85) e dal fatto che i pisani nel 1069, dopo la vittoria sui genovesi, sentissero il bisogno di edificare un proprio tempio civico votivo (San Sisto, consacrato nel 1087: Scalia 1971, Ronzani 1983, Tigler 2006, pp. 226-227) diverso dal duomo.Guido (Ronzani 1997a, Ceccarelli Lemut 2004), di probabile nomina imperiale e impegnato con Matil-de nella politica di distensione fra papato e impero culminata pro-prio nella primavera del 1064 nel felice concilio di Mantova, dovet-
te conoscere i modelli icnografi-ci circolanti nell’aristocrazia ec-clesiastica lombarda della prima metà del secolo (cfr. Silva 1996, Tosco 1997, pp. 167-181), fra i qua-li spicca, per la scelta singolare del transetto ad absidi di testata (Tosco 2011), il duomo di Parma (episcopato di Ugo, 1027-1044: Luchterhandt 2009), coevo alla ter-minazione orientale del duomo di Spira I e all’abbaziale di Limburg an der Haardt.Altri importanti attori nelle prime fasi del cantiere furono senz’altro il capitolo, al quale nel 1077 Matil-de donò importanti beni in solido con il vescovo Landolfo da Milano per orientare le due istituzioni agli ideali della riforma e alla collabo-razione, e i cives, investiti nello stesso atto di compiti tipicamente vescovili fra i quali la costruzione della cattedrale (Ronzani 1994, pp. 42-44). I canonici, sulla spinta della sinodo lateranense (1059), avevano ripreso a operare (almeno dal 1063) presso il vecchio duomo, che, fino ad allora, era stato la ‘loro’ chiesa (Ronzani 1993, pp. 79-85). E, dunque, fu necessario prov-vedere a uno spazio loro riserva-to anche nella nuova cattedrale: forse ciò avvenne fin dalle fasi progettuali o a seguito della dona-zione marchionale. Fatto sta che un chiostro esisteva già nel 1089
(Ronzani 1997b, pp. 26-27) lungo il fianco meridionale del duomo e se ne possono osservare le tracce sulle murature e sul terreno (Redi 1991, p. 380). Esso era allineato con la facciata di Buscheto ed era costituito da un quadriportico cir-condato da tre corpi. Il portale me-ridionale, in fase con un paramen-to di qualità decisamente inferiore destinato a restare invisibile, e i portalini in quota dimostrano che un chiostro a due piani fu proget-tato da subito.Ne risultava un complesso asim-metrico, parzialmente condizio-nato da vecchi edifici (stesso orientamento delle preesistenti costruzioni romane e altomedie-vali: Sanpaolesi 1975, p. 153), ma quasi “per nulla lontano dalla città”, come recita la lapidina di Guido, per quanto ne restasse fuori dai limiti giuridici, ampliati-si nel 1081. Città che sempre più attivamente partecipava alla co-struzione della propria cattedrale attraverso l’Opera (destinata a diventare l’embrione amministra-tivo del comune), il bottino delle incursioni antisaracene, i lasciti dei ricchi cittadini e la spettaco-lare competenza dei suoi uomini migliori, capitanati da Buscheto, a cui vengono riconosciute stra-ordinarie capacità tecniche e ar-tistiche condensate nell’adozione
52 La Cattedrale di Pisa
dell’ordine architettonico e, in par-ticolare, delle colonne, da lui trat-te “dalle profondità marine” (Sca-lia 1986). La colonna è l’elemento linguistico generante lo spazio liturgico (Peroni 1995) che viene proiettato sull’involucro (Sanpao-lesi 1975, p. 157) ottenendo unità spaziale fra interno ed esterno ma non è il solo richiamo simbolico. Frammenti di iscrizioni imperiali e di arredi liturgici, tarsie marmo-ree, bronzei trofei stabilivano un legame continuo con il passato più o meno remoto e coll’esaltan-te presente dei variabili rapporti con l’Impero, il Papato, l’Islam e dell’autogoverno (praticato du-rante le lunghe assenze del vesco-vo e riconosciuto da Matilde nel 1103 col trasferimento all’Opera di importanti castelli e del suo-lo palatino: Ronzani 1993, p. 86). Una maggior concentrazione di elementi decorativi si nota a nord e ad est del duomo, da dove pas-sava la via publica (von der Höh 2009) lungo la quale erano situate le sedi dei poteri cittadini (Ron-zani 1997b, pp. 28-40): l’ospedale dei canonici (entro il 1086: Patetta 2001, pp. 55-59) all’incrocio fra le vie dell’Arcivescovado e di Santa Maria, le case dell’Opera (entro il 1085) e del vescovo (entro il 1112) dietro il Duomo.
Assumitur Pisa in locum Rome: il Foro di Villano e Rainaldo
Fra XI e XII secolo si assiste a un’impressionante escalation della Chiesa pisana, il cui titolare divenne arcivescovo e metropoli-ta della Corsica (1092), patriarca di Gerusalemme (1099), ospite del papa (1118, 1120, 1130) e di un concilio (1135) durante il quale san Bernardo propose Pisa come nuova Roma. La città era ormai cosciente della propria forza nel Mediterraneo, dopo le numerose conquiste ai danni di musulmani e genovesi grazie alle quali il co-mune era a capo di un impero sui mari, quasi alla pari con quello terrestre (Borchardt 1965, Tan-gheroni 1995). La romanitas pi-sana si esplicava nelle istituzioni (regime consolare, diritto) e nella raccolta di frammenti semantici, già messi in bella vista in tutta la cattedrale (Scalia 1972, Redi 1996, pp. 55-59) ma necessitava di specchiarsi in un rinnovato pae-saggio urbano. Nella prima metà del XII secolo (Fig. 3c) si provvide a saldare il duomo con la città altomedie-vale, i cui confini giuridici erano stati estesi al suburbio da Enrico IV nel 1081: completati chiesa e chiostro, essi vennero isolati de-
molendo la vecchia domus Sancte Marie (probabilmente intorno al 1118: Scalia 1995), le mura furono abbattute (entro il 1142), il fossato fu riempito e coperto da un’ampia strada verso i nuovi quartieri ur-bani (via di Santa Maria), men-tre alla nuova sede arcivescovile in San Giorgio (curia nel 1120, palazzo nel 1141) si accedeva dall’ampio asse cerimoniale di via dell’Arcivescovado, lungo il quale aveva soggiornato la corte papale (Ceccarelli Lemut 1995, Ronzani 1997b, pp. 40-44).Alla metà del secolo tutto era pronto per elaborare un grandioso progetto di riqualificazione dell’in-sula episcopi e di espansione urba-na (Fig. 3d), probabilmente orche-strato dall’arcivescovo, il cardinal Villano (cfr. Ronzani 1997b, p. 46), e progettato dal prudens operator et ipse magister Rainaldo (Peroni 1995). In rapida sequenza, da lui fu prolungato il Duomo con una nuo-va facciata (entro il 1179: cfr. Bacci 1917, Smith 1980, Boeck 1988, Cal-deroni Masetti 1992, Milone 1995) e vennero iniziati il battistero da Diotisalvi (nel 1152: Smith 1978, Caleca 1991, Tigler 2006, pp. 55-64, Frati 2011, pp. 56-57), le mura (nel 1154: Tolaini 1969, Luperini - Tolai-ni 1988, Tolaini 2005, Bevilacqua 2011, Luperini 2013) e il campanile da Gerardo (nel 1172: Ragghian-
La Piazza del Duomo di Pisa. Un millennio di miracoli 53
ti 1986, Caleca 2002, Tigler 2006, pp. 65-72, Ascani - Ronzani 2011). Nonostante il lungo protrarsi nel tempo dei lavori e le diverse re-sponsabilità artistiche e ammini-strative sui cantieri (ad esempio battistero e campanile erano sot-toposti ai canonici e realizzati da opere specifiche: Hunnikin 1973, Ronzani 1993 p. 92), il complesso può essere letto in senso unitario e lineare. Venendo dal contado e dalla via Emilia si accedeva attraverso la porta del Leone, vero e proprio arco di trionfo verso il Duomo ri-cavato nell’unica porzione di mura eretta subito a tutt’altezza, presi-diata da un’enorme fiera di marmo (Tedeschi Grisanti 2004) in segno di saluto all’imperatore (Ronzani 1997b, pp. 50-51), moltiplicata in piccolo nella nuova facciata (Cri-stiani Testi 2009). L’improvvisa e meravigliosa prospettiva si apriva sullo sfuggente volume cilindrico del battistero e sulla nuova fac-ciata traforata della cattedrale, il cui disassamento fra terzo e quar-to ordine la rende assai dinamica. Il battistero, circondato dagli orti dei canonici, dialogava con il duo-mo di Buscheto per il medesimo linguaggio fatto di arcate cieche su semicolonne e per il paramento bicromo. La Rotonda fu disposta, rispetto alla nuova facciata, a una
distanza doppia del proprio dia-metro (De Angelis d’Ossat 1986) mentre sul sagrato un’ulteriore corrispondenza è costituita dai portali principali dei due edifici (Peroni 1999, Id. 2001, Longhi 2003, p. 114). La scelta archeologizzan-te di allungare la basilica e di di-sporle assialmente il battistero – che, va ricordato, è una copia del Santo Sepolcro di Gerusalemme (Krautheimer 1942 e, da ultimi, Frati 2000, Benassi - Pierotti 2001) in memoria dei particolari rappor-ti di Pisa con la Terra Santa – ap-pare come un esplicito richiamo all’architettura paleocristiana e, in particolare, costantiniana (Pe-roni 1995; Collareta 2006).Una volta giunti presso lo spigolo nordoccidentale della cattedrale, le epigrafi celebrative e la tomba di Buscheto (Scalia 1982) avevano il compito di spiegarne la genesi e il complesso valore monumentale e invitare all’ingresso del tempio pisano. Proseguendo il percor-so lungo il fianco settentrionale, le numerose iscrizioni imperiali avrebbero convinto il visitatore del naturale avvicendamento di Pisa a Roma. Così il campanile, destina-to a crescere fino al settimo ordi-ne sul terreno occupato dalla casa del vescovo, avrebbe richiamato il Settizonio o, per il suo andamento apparentemente spiraliforme (a
causa dell’inclinazione), una co-lonna istoriata. Ma l’idea di una sequenza di loggiati praticabili viene dalla facciata di Rainaldo e la loro forma e dimensione dall’ab-side maggiore di Buscheto (il cui diametro è quasi uguale), ottenen-do una totale omogeneità lingui-stica con il modello.L’accesso dalla città era segnato dalla nuova porta di San Ranie-ri che si apre nel braccio sud del transetto. Essa, accompagnata dal sarcofago di Beatrice di Ca-nossa, era ornata da un architrave scolpito a girali e da battenti bron-zei simili a quelli del portale mag-giore (Bonanno, 1180), con cui si stabiliva una ovvia corrisponden-za. La grande basilica, connotata e circondata da molte reminiscenze imperiali, agiva da piazza coperta o da via porticata, penetrabile dai numerosi accessi e in osmosi con il territorio circostante (Sanpao-lesi 1975, p. 57). Il duomo, infatti, si trovava come alla convergenza di 4 quadranti di cui è il centro simbolico: a nord-ovest l’Impero, attraverso la porta del Leone, a nord-est il contado, appena oltre-passata porta Santa Maria, a sud est la città, collegata dalle vie di Santa Maria e dell’Arcivescovado, a sud-ovest il mare, per il portello. La stessa idea è forse all’origine delle quattro porte del battistero,
54 La Cattedrale di Pisa
corrispondenti ai quartieri da cui proveniva il clero amministrante il battesimo (Bruderer Eichberg 2011, pp. 26, 27).L’area circostante il duomo era lambita da percorsi che si cristal-lizzavano in vie pubbliche (Ron-zani 1997b, pp. 20, 52-72): a nord due strade parallele all’Auser e alle mura, a est il sedime della carbonaia che fiancheggiava il muro altomedievale prolungato fino a una porta anonima nelle mura nuove, a sud una via rettili-nea fra il portello e l’ospedale di Santa Maria che si estendeva fino al palazzo vescovile. In particola-re, quest’ultimo tracciato attra-versava un’area controllata dai canonici, che vi si affacciavano a nord dal chiostro, abbastanza grande e confortevole da ospitare la corte pontificia nel 1187-1188,
a ovest dal battistero, fondato a seguito di privilegi papali del 1150 circa (Ronzani 1993, p. 92), a sud dagli orti, estesi verso Paludozeri, a est dall’ospedale di Santa Maria e dalla Torre pendente. Questa via era detta anche arringo dei cava-lieri: luogo di esercitazioni milita-ri e manifestazione della potenza dell’aristocrazia, intimamente le-gata al capitolo. Esso, in assenza del vescovo (ad esempio nel 1189-1196), assunse il governo spiritua-le della città, approfittandone per proiettarsi verso l’Arno e i nuovi settori di espansione urbana: motivo per il quale furono aperte nuove strade – via di Porta Buoza e via Roma – che dal duomo an-davano in Pratuscello e in Pellic-ceria, dove si trovavano impianti produttivi e chiese di patronato dei canonici.
Ut arringum et platea ibi sit et fiat: la Piazza di Federico e Giovanni
All’inizio del Duecento lo spazio intorno al duomo appariva poli-centrico, in quanto polarizzato dai suoi centri monumentali, e multifunzionale (Smith 1978, p. 30, von der Höh 2009), in quanto occu-pato da varie attività permanenti (cimitero, cantieri) e temporanee (mercato, parlamento, processio-ni), come, del resto, era il suo polo principale, ma mancava ancora di una forma definita, visto che il suo perimetro slabbrato era aggredito dal proliferare di piccoli edifici. Per ovviare a questa situazione, nel 1197-1202 il vescovo Ubaldo progettò l’isolamento del duomo spostando il cimitero più a nord e il chiostro dei canonici più a sud
3a. Fino al 1064. 3b. Dal 1064 al 1118.
3. Mappa diacronica delle fasi di trasformazione della piazza (disegno dell’autore su mappa catastale).
La Piazza del Duomo di Pisa. Un millennio di miracoli 55
ma il progetto non fu realizzato perché nel 1201, durante la vacan-za del vescovo, il comune aveva assunto il controllo dell’Opera bloccando l’iniziativa episcopale (Ronzani 1997b, pp. 19, 62-67). Al tentativo dell’arcivescovo Lan-franco di recuperare a sé l’Opera in un momento di vuoto di potere civile (1212), i reggitori del comune (in carica dal 1213) reagirono deci-dendo la formazione di una platea publica intorno al duomo demolen-do il chiostro e altri edifici. Alle la-mentele dei canonici fece seguito una permuta: il capitolo avrebbe rinunciato al chiostro (da demolire) e a una striscia di terreno fra arrin-go e via Galli Tassi, in cambio della sede dell’Opera (attuale suo Mu-seo); quest’ultima avrebbe perso anche le casupole fra l’ospedale e il campanile (demolite entro il 1220)
ricevendo un edificio e i materiali delle demolizioni per poter costru-ire la propria nuova sede. Quella del nuovo regime comunale appare come un’iniziativa ‘rivoluzionaria’: per ottenere il decoro pubblico (or-dine, isolamento dei monumenti e delle sedi istituzionali) non si esi-tò a demolire edifici privati sorti e cresciuti disordinatamente (Cale-ca 1986b, Ronzani 1997b, pp. 73-81). I canonici non accettarono subito la nuova sistemazione (da ade-guare a spese di chi?), ma il comu-ne demolì comunque il chiostro ed essi si trasferirono nel loro ospe-dale di Santa Maria entro il 1216, aggiungendovi case e un chiostro. Alla metà del Duecento il capitolo occupava stabilmente sia il com-plesso dell’ospedale sia l’ex-casa dell’Opera, dotata di un chiostro porticato e solariato e interessa-
ta da grandi lavori nel 1258-1259 (Caleca 1986a, De Angelis D’ossat 1986b, Redi 1991, pp. 382-383, Ron-zani 1997b, pp. 82-95), presidiando così l’accesso al Duomo dalla cit-tà, di grande importanza durante lo svolgimento della processione in onore della Madonna, e l’ingres-so al presbiterio. La Cattedrale, da loro officiata, era definita come capo della città e del distretto (e non della diocesi!) e dunque rap-presentava materialmente il pote-re politico della collettività, erede della Chiesa di cui il capitolo era il più stabile rappresentante.Nel 1257-1263, come clausola del-la revoca dell’interdetto sulla cit-tà, frate Mansueto, penitenziere del papa, fece edificare ai pisani un grande nuovo ospedale (Ron-zani 1990, Redi 1991, pp. 386-388, Ronzani 1997b, pp. 96-101, Patetta
3c. Dal 1118 al 1152. 3d. Dal 1152 al 1214.
56 La Cattedrale di Pisa
2004) sul terreno dell’opera (già dei canonici) lungo l’arringo. La coscienza delle implicazioni ur-banistiche dell’operazione si nota nella scelta di allineare la faccia-ta al chiostro della canonica, oc-cupando una parte dell’arringo e regolarizzando il fronte stradale, nella richiesta di riaprire la por-ta accanto a quella del Leone di fronte all’ospedale, offrendo un accesso orientato al nuovo edifi-cio, e, più tardi (1287), nel divieto di costruire fra il nuovo battistero e l’ospedale, mantenendo comple-tamente sgombra l’area. Decisivi per la definizione della piazza (Fig. 3e) furono gli sviluppi a nord del duomo (Ronzani 1997b, pp. 101-114). I terreni un tempo agricoli vennero via via occupati da edifici (Redi 1991, p. 383): una capanna in cui si lavoravano i mar-
mi per il campanile (entro il 1232), la nuova sede dell’Opera (entro il 1260), una casa per la scuola dei chierici cantori (1265-1271), altre case dell’Opera. Nel 1260 l’operaio Guido giurò impegnandosi a rea-lizzare un nuovo cimitero al posto del vecchio, che coi suoi sarcofagi e tombe terragne circondava in-decentemente il duomo sul fian-co sud e davanti alla facciata. Ma solo dopo 17 anni di pressioni e di trattative volte a riorganizzare e compattare la frammentata pro-prietà, il grande arcivescovo Fe-derico Visconti poteva finalmente assumere formalmente l’iniziativa (e l’onore) di permutare con l’ope-ra il terreno per lo spostamento del cimitero (che occupava la pla-tea ormai pubblica e pertanto non si poteva chiudere) in un luogo remoto e chiuso dove poter collo-
care i sepolcri (Ronzani 1988). Con questa decisione si poteva dunque liberare e delimitare la piazza nella forma nitida offerta dalle facciate di ospedale e cimitero, all’interno della quale duomo, battistero e torre trovavano una propria monu-mentalità. L’esclusività delle fun-zioni qui collocate (la cattedrale, il campanile, il fonte, gli ospedali riuniti, il cimitero monumentale) e l’omogeneità linguistica degli edifici resero unico e unitario il centro religioso della città. E la precisa perimetrazione della piaz-za rendeva più facile l’imposizione di regole particolari entro chiari limiti da parte del comune. Così, la Piazza del Duomo si faceva, da spazio intrinsecamente pubblico (accessibile, aperto, libero), spazio estrinsecamente pubblico (delimi-tato, utilizzabile entro regole date)
3e. Dal 1214 al 1299. 3f. Dal 1299 al 1406.
La Piazza del Duomo di Pisa. Un millennio di miracoli 57
evidente emanazione del potere (Herlihy 1973, von der Höh 2009).Il Campo Santo (così chiamato per esser stato asperso di humus proveniente dalla Terrasanta già ai tempi della IV Crociata) inglobò orti, un cimitero privato e il terre-no dove si trovava il battistero (?) ottagono, certamente uscito di funzione dopo il 1246 (nuovo fonte) e probabilmente demolito già da tempo (Sanpaolesi 1975, pp. 155-156). Inizialmente il nuovo cimite-ro consisteva in un basso recinto scoperto il cui serrato ripetersi delle nude lesene all’esterno pro-duceva un rapido fluire dell’inte-ra parete e costituiva un fondale per gli altri monumenti (Redi 1991, p. 385, Tolaini 2008, pp. 45-47). Que-sta scelta era coerente con le par-ticolari visuali che si erano create dopo la costruzione di Ospedale
e Camposanto, disassati rispetto al duomo: “due diverse e opposte situazioni prospettiche: accele-rata nello spazio compreso fra il Camposanto e il Duomo, in modo da crearvi l’apparenza di una stra-ordinaria lunghezza; rallentata sul lato dello Spedale, con effetto op-posto” (Tolaini 1992, p. 45).Negli anni seguenti la costruzione del cimitero (dal 1278) e della sua cappella (entro il 1287) avvenne il lento trasferimento delle sepoltu-re (effettivamente attestate solo dal 1295), che permise il completo isolamento del duomo (Ronzani 1997b, pp. 115-117). Come già Ar-nolfo al battistero di Firenze, nel 1297-1299 Giovanni Pisano (autore anche del Campo Santo secondo Pierotti 2011, che riassume anche le posizioni critiche altrui) ricu-cì il basamento del duomo, na-
scondendo le irregolarità dovute alle diverse fasi costruttive e alle manomissioni funerarie: alcune ripide gradule elevavano la basi-lica sulla piazza circostante e ne consentivano il libero e pubblico accesso (Peroni 2007, per la con-figurazione liturgica); le formelle figurate permettevano un rap-porto ravvicinato con l’enorme mole della cattedrale. La piazza era pronta per ospitare grandi ce-rimonie collettive, tanto religiose (la processione della luminara su tutte), quanto civili (il giuramento a Enrico VII del 1312) e non a caso sotto Giovanni fu dato nuovo im-pulso alla costruzione della torre, sebbene già all’epoca inclinata in modo preoccupante, per farne il faro sonoro della città e un otti-mo punto di contemplazione della piazza appena compiuta.
3g. Dal 1406 al 1807. 3h. Dal 1807 a oggi.
58 La Cattedrale di Pisa
Verso e versus la cristallizzazione
Una volta definita la forma della piazza, l’impegno costruttivo fu rivolto al suo intorno (Fig. 3f): l’im-bocco della via Santa Maria, che conduceva verso il centro (anche politico: Garzella 1997) della città, fu sistemato con la realizzazione della chiesa di San Giorgio dei tedeschi (fra 1313 e 1319) e dell’o-spedale della Pace (1316, poi dei Trovatelli: Patetta 2001, pp. 199-202), mentre il fondale della pla-tea dell’Arcivescovado fu defini-to dall’ampliamento del palazzo inglobante la chiesa di San Gior-gio (entro il 1331: Ronzani 1997b, pp. 123-124).Poi fu la volta dei monumenti e degli edifici loro circostanti, il cui completamento ebbe importanti conseguenze sulla loro percezione dall’esterno. L’ospedale fu esteso verso ovest con la costruzione del pellegrinaio (1319-1338) invadendo i terreni del battistero, dipenden-te dalla canonica, e tentando di uniformare il linguaggio al resto della piazza con un rivestimento a finte lastre bicrome (Redi 1991, pp. 387-388, Ronzani 1997b, p. 98). Il recinto del cimitero fu elevato e il terreno fu coperto, ottenendo una specie di moderna basilica fu-neraria (cfr. Carli 1937, Carmassi
1993, Il Camposanto 1996, Ronza-ni 2005, Tolaini 2008, Pierotti 2011). Più tardi (1374), sarebbero state abbattute le case della scuola dei cantori permettendo il com-pleto isolamento del Camposan-to e la costruzione del suo nuovo coro: per dissimulare l’asimmetria provocata dall’espansione verso ovest venne variato il ritmo delle lesene e spinta verso l’alto l’as-sialità dei portali con l’aggiunta di ricchi tabernacoli. Nel frattempo (1349-1374) Cellino di Nese aveva atteso al completamento del bat-tistero, facendone una “cappella coronata”: all’esterno con la cu-pola intorno alla copertura tronco-conica e all’interno con quadrifore nel matroneo. Ancora una volta gli edifici della piazza dialogavano fra loro: pinnacoli simili ottene-vano un coordinamento decorati-vo fra le cupole (1380-1388, quella del Duomo: Redi 1991, p. 388), la stessa finestra richiamava i ‘giri’ di battistero e camposanto (Frati 2011, pp. 65-66).Nei due secoli successivi la piaz-za fu assai influenzata dalle scel-te difensive di e per una città che aveva ormai perso il dominio sui mari dopo la battaglia della Melo-ria (1284). Nel 1364 il doge Giovan-ni dell’Agnello fece costruire una fortezza turrita presso la porta del Leone, abbattendo le case dell’o-
pera di San Giovanni: solo cinque anni dopo, caduta in mano agli imperiali, fu attaccata dagli stes-si pisani dall’alto del battistero e, avutala, fu da essi distrutta (Ron-zani 1997b, pp. 126-128). Nel clima d’insicurezza e di perdita di presti-gio acuitosi con la presa della città da parte dei fiorentini (1406) il ca-pitolo abbandonò la canonica (en-tro il 1430: Ronzani 1997b, p. 129). L’area a sud del Duomo fu poi riconfigurata in stile rinascimen-tale e in senso fiorentino (Fig. 3g) con la ricostruzione dell’ospedale dei trovatelli nel 1462-1465 (Tolaini 1992, p. 78). Infine, con l’apertura nel 1562 di Porta Nuova, ora unico accesso da nord-ovest alla città, furono riattivati i percorsi lungo l’Ospedale e mutò profondamente la prospettiva sul duomo, privile-giandone la visione da sud (Tolaini 1992, p. 101).L’incendio alla cattedrale del 1595 fu l’occasione per il rapido ade-guamento liturgico del presbite-rio (1602) ma il dialogo fra interno ed esterno non fu modificato se non nei battenti delle tre porte di facciata (1605), essendo an-dati perduti quelli romanici con i loro programmi iconologici. An-che l’allacciamento dell’Opera all’acquedotto (1650-1659) ebbe importanti conseguenze: nel 1747 la nuda fontana collocata davanti
La Piazza del Duomo di Pisa. Un millennio di miracoli 59
al transetto sud fu spostata e ri-fatta in cima a via Santa Maria: la ricca Fontana dei putti di Giu-seppe Vaccà costituisce un punto di riferimento assoluto, col suo basamento orientato secondo i punti cardinali e non allineato alla strada (Castelfranco 1931, Nofe-ri 2001), suggerendo la contem-plazione della piazza secondo un punto di vista privilegiato, poi ce-lebrato dai vedutisti.La visione estetizzante della piaz-za motivò l’eliminazione dei giardi-ni dietro il battistero verso la fine del Settecento, la musealizzazio-ne del Camposanto nel 1807, giu-stamente considerato una scuola per la pittura e la scultura tardo-medievali (Il Camposanto 1996), e l’abbattimento delle case dietro il battistero (1827). Decisivi per la percezione attuale della piazza (Fig. 3h) furono però i lavori avviati dall’architetto Alessandro Gherar-desca (Lucchesi 1987, Tolaini 1992, pp. 145-153, Nuti 1998, pp. 221-225, Melis - Melis 2002) con la nuova residenza capitolare in stile neo-gotico (fra palazzo dell’Opera e campanile: 1836-1838) a cui segui-rono il progetto di isolamento del-la torre (1838-1841) e, soprattutto, il piano di ordinamento dell’intero complesso e sua riduzione a “sce-nografia di stile pisano del secolo XIII”, con la completa liberazione
dei monumenti, il ridisegno dei percorsi, la sistemazione a pra-to, la chiusura della piazza entro un muro perimetrale. Delle mol-te proposte, furono attuate solo il rifacimento della porta sud del battistero, l’eliminazione della sua residua quadrifora trecente-sca, alcune demolizioni intorno al campanile (case del Capitolo, dei Curati, chiesa di San Ranierino) e la sostituzione del gradus con un nuovo marciapiede. Una incalco-labile quantità di piccoli interventi creò l’immagine perfetta e nitida dei monumenti giunta fino a oggi e la nuova pavimentazione eliminò e nascose i dislivelli. Il campanile, isolato per accentuare l’effetto della sua pendenza (che aumentò ulteriormente a causa del dirada-mento), non trovava più un serrato confronto col volume semicilindri-co dell’abside maggiore del duo-mo, mentre le platee in marmo e il prato all’inglese ponevano i monu-menti in un nuovo e asettico rap-porto col terreno. Subito dopo, a cura di Pietro Bellini, fu effettuato il restauro stilistico della facciata del duomo e la demolizione del-la casa del Becchino a ovest del Camposanto: quest’ultima pose il problema del suo completamento in stile, cosa che non venne attua-ta per una salomonica decisione del Comune.
Nel frattempo (1852), però, l’inge-gnere dell’Hoste aveva maturato proposte di sventramenti con-vergenti sulla Piazza del Duomo, di cui fu realizzato solo quello di via Torelli, spalancando la veduta – priva di sorpresa – sul transet-to del duomo e sul campanile dal Parlascio. Dopo i diradamenti, gli sventramenti, i ripristini, i restau-ri stilistici la piazza attirava uno sguardo nuovo su di sé: quello dell’esteta attento solo agli episo-di eclatanti, quello del D’Annun-zio ‘dei miracoli’.La nostra storia potrebbe circo-larmente finire qui, ma, dopo i restauri del secondo dopoguerra (copertura del Camposanto, ripri-stino della cupola del Duomo: Nuti 1953, Sanpaolesi 1959), si sono moltiplicate le proposte di riqua-lificazione, musealizzazione, libe-razione dello spazio (Marchesini 1994, Perniola 2005, Cossu 2008) che testimoniano quanto la storia della piazza sia proiettata verso il futuro, se, in un continuo dialogo con il divenire della città (cfr. Fon-tanelli 2008), si contempera la ne-cessità di conservarne e valoriz-zarne i contenuti simbolici con la possibilità di viverla come spazio pubblico nel più ampio senso del termine.