Introduzione a «L’ultimo oro di stelle cadute». Strutture e genesi testuale della lirica di...
Transcript of Introduzione a «L’ultimo oro di stelle cadute». Strutture e genesi testuale della lirica di...
L’ULT
IMO
ORO
DI S
TELL
E CA
DU
TE
Strumenti di Filologia e Critica
Collana del Dipartimento di Filologia e Critica della LetteraturaUniversità di Siena
L’ULTIMO ORO DI STELLE CADUTEStrutture e genesi testuale della lirica di TraklELISABETTAMENGALDO
La lirica di Georg Trakl (1887-1814) oscilla tra la ripetizione ossessiva di alcuni motivi simbolici che la percorrono trasversalmente e la tendenza maniacale alla correzione, a torturare il verso con variazioni di grande respiro o con spostamenti minimi che, lungi dal chiarire una poesia che rimane, nella sua più profonda essenza, oscura e chiusa nel suo bozzolo, fanno apparire però in sempre diversa luce i richiami che intercor-rono tra i testi. Questi sono talmente fitti e costanti da aver indotto Martin Heidegger a interpretare la Dichtung (“poesia”) traklia-na come un unico grande Gedicht (“com-ponimento poetico”).In questo volume l’autrice analizza l’evo-luzione di alcuni aspetti della lirica del poeta austriaco (suono, sintassi, le metafo-re cromatiche, i Leitmotive e le loro varia-zioni) nella fitta trama delle varianti, ma anche nell’evoluzione diacronica: come cioè, certe caratteristiche del linguaggio trakliano siano mutate nel passaggio dalla prima fase più influenzata dal simbolismo francese, attraverso quella più elegiaca, in cui risuona Hölderlin, fino allo sfrangiarsi e insieme purificarsi della lingua poetica nello stile teso e angoscioso delle ultime liriche. L’ultimo capitolo è dedicato all’ana-lisi della genesi e all’interpretazione di due liriche, Geistliche Dämmerung e Die Heimkehr.
Elisabetta Mengaldo è nata a Padova nel 1977, dove si è laureata in Lingue e Letterature straniere nel 2003; nel 2007 si è addottorata presso le Università di Siena e di Hildesheim con una tesi sulla lirica di Georg Trakl, di cui il presente volume rappresenta la rielaborazione e l’amplia-mento. Risiede in Germania, collabora con l’Università di Greifswald e con la Freie Universität di Berlino ed è professore a contratto di Letteratura tedesca all’Univer-sità di Trieste. Ha pubblicato su rivista o in volumi collettanei diversi contributi sulla lirica di Georg Trakl, su Friedrich Nietzsche e sulla fortuna del mito di Medea in diverse opere della letteratura europea.
€ 20,00
VOLUMI pUBBLICATI
1. Stefano Dal Bianco, L’endecasillabo del Furioso 2. Alex R. Falzon, Le nozze alchemiche di Salomè. Oscar Wilde e la traduzione ermetica3. Annalisa Nesi - Nicoletta Maraschio (a cura di), Discorsi di lingua e letteratura italiana per Teresa Poggi Salani4. Duccio Colombo, Scrittori, in fabbrica! Una lettura del romanzo industriale sovietico5. Fabrizio Podda, Il senso della scena. Lirica e iconicità nella poesia di Franco Fortini (con un inedito)6. Elisabetta Mengaldo, Evoluzione e struttura nella lirica di George Trakl
DI pROSSIMA pUBBLICAzIONE
7. Stefano Carrai, Il caso clinico di Zeno e altri studi di filologia e critica sveviana
La collana presenta studi di taglio interdis-ciplinare sulle letterature e lingue moderne. Ospita ricerche su autori italiani e stranieri, su generi letterari, su problemi o periodi di storiografia letteraria e di linguistica o dialettologia, ma anche edizioni di testi e traduzioni. L’analisi linguistica, stilistica, retorica e metrica (quando si tratti di testi poetici), l’accertamento dei dati relativi alla tradizione del testo oppure alla sua elaborazione, l’indagine storico-culturale ovvero sul versante tematico o sociologico o ideologico sono tutte componenti di una metodologia peculiare per ciascun testo richiesta di volta in volta allo studioso dal testo stesso, a seconda delle sue specifiche caratteristiche.
Direttore: Stefano CarraiStRUMENti Di FiLoLogiA E CRitiCA 6
Elis
abet
ta M
enga
ldo
6
Pacini
Editore
PaciniE d i t o r e
Ricerca
L’uLtimo oro di steLLe cadute strutture e genesi testuale della lirica di trakleLisabetta mengaLdo
PaciniE d i t o r e
ricerca
strumenti di Filologia e CritiCa 6
Strumenti di Filologia e CriticaCollana del Dipartimento di Filologia e Critica della Letteratura dell’Università di Siena
DirettoreStefano Carrai
Comitato scientificoRomano LuperiniAntonio MelisGiovanna MochiGiuseppe NavaAntonio PreteRoberto Venuti
Comitato di redazioneRiccardo CastellanaStefano Dal BiancoMaria Rita DigilioPaola Italia
Questo libro è il frutto della rielaborazione della tesi di dottorato scritta in cotutela tra l’Univer-sità degli Studi di Siena e l’Universität Hildesheim e discussa a Siena nel 2007. Al finanziamento della pubblicazione hanno contribuito il Dipartimento di Lingue e Letterature anglo-germani-che e slave dell’Università di Padova e il Dipartimento di Filologia e Critica della Letteratura dell’Università di Siena.
In copertina: Franz Marc, Tierschicksale (Die Bäume zeigten ihre Ringe, die Tiere ihre Adern), 1913 (inv. 1739), olio su tela (particolare), 195 x 263,5 cm, Kunstmuseum Basel (Martin P. Büler).
Sul retro: Max von Esterle, Georg Trakl (caricatura), 1914, Georg-Trakl-Forschungs- und Ge-denkstätte, Salzburg.
Riproduzioni da Georg Trakl, Sämtliche Werke und Briefwechsel. Innsbrucker Ausgabe (ITA), Historisch-Kritische Ausgabe, a cura di Eberhard Sauermann e Hermann Zwerschina, Copyright (c) Stroemfeld Verlag, Frankfurt am Main/Basel. Reprinted by arrangement with Stroemfeld.
© Copyright 2009 by Pacini Editore SpA
ISBN 978-88-6315-104-6
Realizzazione editoriale
Via A. Gherardesca56121 Ospedaletto (Pisa)
Rapporti con l’UniversitàLisa Lorusso
Responsabile redazionaleFrancesca Petrucci
ImpaginazioneFabrizio Sodini
Fotolito e StampaIndustrie Grafiche Pacini
L’editore resta a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare e per le eventuali omissioni.
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fa-scicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, e-mail [email protected] e sito web www.aidro.org
indice
Introduzione ........................................................................ p. 9
capitolo primoiL Lavoro di trakL suL suono e Le sue impLicazioni con La semantica
1.1. Alcune osservazioni introduttive ................................... » 251.2. Signifiant e signifié ......................................................... » 291.3 Fonetica e semantica ..................................................... » 38
capitolo secondo tensione tra tradizione e innovazione.aLcuni aspetti deLLa sintassi e deL metro in trakL
2.1. Tre testi paradigmatici ................................................... » 552.2. Il nuovo e il noto: processi di straniamento e di astrazione nell’uso degli articoli ............................. » 732.3 Il singolo e il molteplice .................................................. » 862.4. “Worte, Worte - Substantive”: la sintassi nominale ........ » 91 2.5. Amplificazione e ambiguità sintattica: apposizioni ed epifrasi. Apposizione metaforica come identificazione ............................................................... » 1102.6. Alcuni aspetti salienti della metrica trakliana .............. » 126
capitolo terzoaspetti di semantica: uso e composizione dei coLori 3.1. Semantica del colore: la tavolozza di Trakl tra realismo e astrazione .................................................................... » 139 3.2. Le tecniche di simbolizzazione e astrazione del colore . » 159 3.3. Varianti cromatiche: le correzioni potenziative e quelle
contestuali ...................................................................... » 174
capitolo quartodue testi esempLari: struttura e genesi 4.1 Riduzione linguistica e principio della corrispondenza in Geistliche Dämmerung .............................................. » 1934.2 Disgregazione della forma e purificazione della parola poetica in Die Heimkehr ................................................ » 213
Riproduzione dei manoscritti, delle trascrizioni diplomatiche e delle ricostruzioni genetiche della Innsbrucker Trakl-Ausgabe delle liriche Geistliche Dämmerung, Heimkehr, Herbstliche Heimkehr e Die Heimkehr ...................................................... » 237
appendice al capitolo quartoQuestioni di fiLoLogia d’autore: L’evoLuzione deLLa editionswissenschaft in germania e Le edizioni critiche di trakL .................................................................. » 267
Conclusioni ........................................................................ » 291
Bibliografia ........................................................................ » 303
Ringraziamenti ...................................................................... » 314
Indice dei nomi ...................................................................... » 315
So kann es auch nicht die Aufgabe des Schriftstellers sein,den Schmerz zu leugnen, seine Spuren zu verwischen, über ihn
hinwegzutäuschen.Er muß ihn – im Gegenteil – wahrhaben und noch einmal,
damit wir sehen können, wahrmachen. Denn wir wollen alle sehend werden1.
Ingeborg Bachmann
1 [Così il compito dello scrittore non può essere quello di negare il dolore, di cancellare le sue tracce, di creare false illusioni sulla sua vera natura. Egli deve, al contrario, riconoscerlo e metterlo in atto nuovamente, affinché noi riusciamo a vedere. Poiché noi tutti vogliamo diventare capaci di vedere].
NOTA
L’edizione di riferimento per le citazioni da Trakl è la Innsbrucker Trakl-Ausgabe a cura di Eberhard Sauermann e Hermann Zwerschina, di seguito abbreviata con la sigla ITA. Poiché, tuttavia, di questa edizione non è ancora stato pubblicato l’ultimo volume con le lettere, per le citazioni da queste ultime rinvierò sempre alla prima edizione critica delle opere di Trakl, la Historisch-kritische Ausgabe curata da Walther Killy e Hans Szklenar (ab-breviata d’ora in poi con la sigla HKA). Poiché la ITA segue un severo cri-terio cronologico, il suo ordinamento delle poesie non è quello in cui esse si trovano nelle due raccolte pubblicate da Trakl, Gedichte e Sebastian im Traum. La collocazione dei testi all’interno di queste raccolte è però veri-ficabile in qualunque edizione delle opere di Trakl, nonché nell’anastatica delle due princepes edite dal Kurt-Wolff-Verlag rispettivamente nel 1913 e nel 1915, ristampate dalla ITA e allegate all’edizione critica.
AbbreviazioniH sta per Handschrift e indica dunque un testimone manoscritto; T sta per Typoskript (“dattiloscritto”); D, infine, sta per Druck (“stampa”). In tutti e tre i casi la maiuscola indica che il testimone è di mano di Trakl (H o T) o, nel caso di una stampa, che è stata da lui autorizzata (D); per manoscritti o dattiloscritti non redatti da lui ma da qualcun altro, per esempio come copia di un originale poi andato perduto, oppure come testimone scritto da qualcuno o battuto a macchina sotto dettatura di Trakl si usano le minusco-le (“h” e “t”). La minuscola (“d”) si usa invece per le stampe non autorizzate dal poeta, tipicamente quelle postume (per esempio, tutti i testi pubblicati nel «Brenner-Jahrbuch» del 1915).
Nelle citazioni in cui vi sono delle varianti vengono adoperati i seguenti segni diacritici:→: indica correzione da un termine o un’espressione all’altro (es. roter
→ schwarzer). Nei casi in cui la correzione riguarda solo una parola o una piccola porzione di testo all’interno di un passo più ampio, tutto ciò che è interessato dalla correzione viene sottolineato (es. «Ein roter (→ schwarzer) Mantel»).
√: correzione immediata, cioè avvenuta non appena l’autore aveva ab-bozzato la parola o il passo in questione.
[ ]: nella rappresentazione scalare delle varianti viene posto sotto una parola o una porzione di testo per indicare che nella rielaborazione subito successiva tutto ciò che è compreso nelle parentesi quadre viene eliminato, mentre rimane il resto del verso o della frase.
Es.: «schweigen lange im Rohr». (dunque eliminazione del solo lange). [ ]xxxx: parola o porzione di testo illeggibile.
TraduzioniPer i brani citati da lingue straniere (per lo più in tedesco) la regola seguita è la seguente. Le poesie o i passi in prosa di autori di lingua tedesca (o, più raramente, francese) vengono citate a testo sempre in lingua originale con a seguire la traduzione italiana. Nel caso in cui si citi una poesia per intero o una grossa porzione di essa, si darà sempre una traduzione uffi-ciale, quando essa esista. Nel caso di piccole porzioni (fino a tre versi) in cui spesso mi preme che venga compresa la lettera del testo, la traduzione è quasi sempre mia.I brani di filosofi e critici letterari vengono citati sempre in italiano con l’indicazione bibliografica della fonte originale (traduzione ufficiale o, se questa non esiste, traduzione dell’autrice).
9
introduzione
Nessuno scriverebbe versi se il problemadella poesia fosse quello di ‘farsi capire’E. Montale
Un paradigma della critica sostiene che la poesia del Novecento abbia potentemente virato verso l’oscurità, l’ermetismo1. Questo non è sempre vero, perché il Novecento ha avuto tutto un filone di poe-sia engagée – a cominciare da Brecht – che ha volutamente puntato verso la chiarezza del messaggio, e altri poeti – come per esempio Saba – che non hanno mai coltivato l’oscurità semplicemente per-ché questa non era nelle loro corde. Ma la scuola poetica e la teoria estetica uscite dal romanticismo tedesco, da Poe e dal simbolismo francese hanno senz’altro prediletto questo filone della lirica perché esso sembrava più adatto a rappresentare il fulcro della modernità come epoca opposta all’ottimismo della ragione, che si allontana dal realismo a favore del simbolismo e del soggettivismo (spezzan-do dunque anche i codici estetici convenzionali) o che concepisce il piacere estetico come puro gioco (dal Witz romantico all’art pour l’art, al surrealismo e al Dada). Georg Trakl fa sicuramente parte del filone “oscuro” della poesia moderna: la sua è un’oscurità densa, generata da una tragicità di fondo dell’esperienza esistenziale, da un profondo senso della colpa individuale e del declino di un’intera ci-viltà, e segnata da una volontà di riscatto attraverso la parola poetica che non è mai solo di tipo estetico, ma ha sempre un forte contenu-to etico che conferisce alla sua poesia verità e necessità intrinseche, pur nell’inafferrabilità di molti motivi. Nel suo articolo Dello scrivere oscuro, Primo Levi ha formulato un’interpretazione molto suggesti-va dell’oscurità di poeti come Trakl e Celan, che sarebbe una sorta di prefigurazione della morte, e dunque un “non-voler-essere” (in questo senso è valida dunque più per la tarda poesia di Trakl):
1 Cfr. per esempio H. Friedrich, La struttura della lirica moderna, Milano, Gar-zanti, 2002 (19581). Ediz. orig.: Hamburg, Rowohlt, 1956. Inoltre K. Hamburger, Die Logik der Dichtung, Stuttgart, Klett, 1968 (19571); per quanto riguarda le poetiche simboliste francesi, soprattutto Mallarmé, cfr. per esempio K.-H. Stierle, Möglichkeiten des dunklen Stils in den Anfängen moderner Lyrik in Frankreich, in Immanente Ästhetik - Ästhetische Reflexion. Lyrik als Paradigma der Moderne - Kolloquium 1964, a cura di W. Iser, München, Fink, 1966, pp. 157-194.
10
strutture e genesi testuale della lirica di trakl
L’effabile è preferibile all’ineffabile, la parola umana al mugolio animale. Non è un caso che i due poeti tedeschi meno decifrabili, Trakl e Celan, siano entrambi morti suicidi, a distanza di due generazioni. Il loro co-mune destino fa pensare all’oscurità della loro poetica come ad un pre-uccidersi, a un non-voler-essere, ad una fuga dal mondo, a cui la morte voluta è stata coronamento. Sono da rispettarsi, perché il loro “mugolio animale” era terribilmente motivato: per Trakl, dal naufragio dell’Impero Asburgico, in cui egli credeva, nel vortice della Grande Guerra; per Ce-lan, ebreo tedesco scampato per miracolo alla strage tedesca, dallo sra-dicamento, e dall’angoscia senza rimedio davanti alla morte trionfatrice. […] Se il suo [di Celan] è un messaggio, esso va perduto nel “rumore di fondo”: non è una comunicazione, non è un linguaggio, o al più è un lin-guaggio buio e monco, qual è appunto quello di colui che sta per morire, ed è solo, come tutti lo saremo in punto di morte2.
L’oscurità trakliana, che sembra spesso non diminuire ma al contrario aumentare quando se ne studino le varianti, è alla base del sostanziale pessimismo di uno degli studi pionieristici su Trakl, Über Georg Trakl di Walther Killy, che ritiene che Trakl rimanga sostanzialmente non interpretabile. Il suo libro si apre con queste righe:
La lingua di questo poeta è oscura. È stato annoverato, con comprensio-ne molto superficiale, tra gli impressionisti, per via delle impressioni che si allineano l’una all’altra in una compagine apparentemente scomposta. Ci si può aprire al suono sensuale delle parole, ai molti colori e ombre, ma non è facile scorgervi dietro qualcosa di più, e cioè ciò che oggi (for-se a torto) siamo abituati ad aspettarci dalla poesia: soccorso nello smar-rimento del nostro mondo, risposta alle domande sulla nostra esistenza, immagini ordinate in mezzo al disordine dell’anima e del tempo. Non è questo il luogo adatto per decidere se la poesia sia in grado di soddisfa-re tali aspettative. E persino se lo potesse non ne guadagneremmo una migliore comprensione dei versi di Trakl3.
E vent’anni più tardi anche Heinz Wetzel ha sostenuto che l’oscurità di molti motivi è del tutto costitutiva e inerente alla poesia trakliana stessa:
2 P. Levi, Dello scrivere oscuro (1976), in Id., L’altrui mestiere (1985), in Opere, a cura di M. Belpoliti, Torino, Einaudi, 1997, pp. 679 sg. Cfr. anche U. Dogà, Dello scrivere oscuro: Paul Celan e Primo Levi, «dereck. judaica urbinatensia», 3 (2005), pp. 47-57.
3 W. Killy, Über Georg Trakl, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1967 (19601), p. 5.
11
introduzione
La maggior parte degli elementi visivi della lirica Contemplazione sono familiari, cosa che rafforza il carattere semico di quelli che sono in grado di significare altro rispetto a se stessi. Ma lo sono quasi tutti. Solo che il significato di questi supposti segni difficilmente si può fissare, e questo non solo perché nel raffronto tra diverse redazioni di una poesia essi appaiono interscambiabili a piacere, ma anche perché il loro uso nelle stesure considerate definitive e stampate nel volume Poesie non è in alcun modo omogeneo. […] La domanda sempre attuale e insolubile sul significato dei segni genera un’insicurezza che è un effetto caratteristico di quasi tutte le liriche di Trakl4.
Vedremo come molti motivi diventino Leitmotive, come cioè, anche attraverso il lavoro di correzione, essi si approprino di un contenuto simbolico e di un’intensità affettiva. Sembra comunque che i Leitmotive in Trakl non abbiano un vero e proprio significa-to precisamente individuabile, quanto un’“aura”, uno “sciame” di significato, come se ci si potesse avvicinare al punto in cui è stato gettato il sasso attraverso dei cerchi concentrici sempre più piccoli, facendo quindi il percorso contrario a quello della dispersione se-mantica che un motivo subisce quando è incastonato in un contesto nuovo. Per queste ragioni preferisco, a differenza di Walther Killy, adoperare il termine Leitmotiv e non quello di “cifra”, come tenterò di spiegare nel capitolo secondo.
L’oscurità trakliana è sicuramente anche una questione di stile, ed è una croce non solo per chi si occupa in senso stretto di esegesi ed ermeneutica trakliane, ma anche per chi entra nel vivo delle stra-tegie linguistiche magari studiando le varianti, come ci proponiamo di fare con il presente lavoro. In un saggio intitolato Oscurità e dif-ficoltà, Franco Fortini ha messo in luce la differenza sostanziale tra queste due categorie stilistiche in poesia, osservando come l’oscuri-tà debba almeno in parte rimanere tale:
‘Oscurità’ sia dunque la condizione di un testo o di una sua parte che non consentano una rapida parafrasi capace di soddisfare le esigenze proprie della parafrasi stessa, cioè il massimo possibile di riduzione degli elementi autoreferenziali a favore di quelli referenziali. […] Se si guarda poi alla funzione espressivo-stilistica e conoscitiva della (sempre relati-va) incomprensibilità o impenetrabilità di un testo o di una sua parte, si può ben dire che quella ‘oscurità’ non può né deve mai essere ‘vinta’ o ‘superata’ perché la sua ragione è di essere, in definitiva, una particolare
4 H. Wetzel, Über Georg Trakls Gedicht “Nachtergebung”. Eine Untersuchung der fünf Fassungen, «Text + Kritik», Heft 4/4a «Georg Trakl» (1985), pp. 16-29, qui p. 17.
12
strutture e genesi testuale della lirica di trakl
categoria di ‘figura’, come la reticenza o l’eufemismo. Pena la scomparsa di una essenziale parte del ‘messaggio’, tale ‘oscurità’ deve permanere; mimesi, oltre tutto e come sappiamo, della ‘oscurità’ delle relazioni in-fraumane.‘Difficoltà’ è invece un tratto di oscurità che non si pone come costitutivo ma solo come momentaneo e che può essere risolto da un dato grado di competenza del lettore. Anche la ‘difficoltà’ è un tratto stilistico, anzi è or-ganizzata e intenzionale in moltissime tradizioni letterarie. Ma differisce dalla ‘oscurità’ perché accetta anzi esige l’interpretazione e la parafrasi. […] si pone come enigma provvisorio risolvibile con determinati stru-menti e quindi mediante esegesi critica o ermeneusi […]5.
Possiamo senz’altro affermare che Trakl è un poeta oscuro, non solo difficile. Ma di che genere di oscurità si tratta?
Nella poesia moderna vi sono svariate tipologie di oscurità, di ermetismo e di ambiguità che sono state molto indagate dalla critica (si pensi per esempio al classico di William Empson Seven Types of Ambiguity6). Silvio Vietta parla di due campi semantici da cui, nella letteratura moderna, sgorga la libera associazione che crea le grandi difficoltà esegetiche con cui notoriamente si misurano gli interpreti: l’esperienza biografica e il libero gioco con la lingua7. Il peso del primo fattore è evidente, per esempio, in molte poesie di Celan o Montale, per cui parecchie interpretazioni (per esempio quelle di Peter Szondi per Celan) sono veramente possibili solo sulla base di una conoscenza profonda di alcuni episodi biografici che, rielaborati e trasfigurati, sono confluiti nel testo poetico: con Fortini potremmo dire che questi componimenti sono ‘difficili’ ma forse non propria-mente ‘oscuri’8, anche se questo non toglie che i poeti in questione, soprattutto Celan, possano essere alle volte anche veramente oscuri. A questi due fattori aggiungerei senz’altro quello culturale, che vale per poeti come Ezra Pound, il Rilke delle Elegie Duinesi o l’Enzen-sberger di Mausoleum: raccolte nate da stratificazioni di sedimenti culturali, di riferimenti, di citazioni, senza la conoscenza dei quali non è veramente possibile un’interpretazione. Per quanto riguarda
5 F. Fortini, Oscurità e difficoltà, «L’asino d’oro», II, 3 (1991), pp. 84-88, qui p. 87.
6 W. Empson, Seven Types of Ambiguity, London, Chatto and Windus, 1930. Ediz. it.: Sette tipi di ambiguità, Torino, Einaudi, 1965.
7 S. Vietta, Ästhetik der Moderne. Literatur und Bild, München, Fink, 2001, p. 256.
8 Si veda in proposito il cap. terzo del presente lavoro, pp. 150 e 163 sg. Anche Fortini, nel saggio appena citato (p. 88), considera Montale un poeta difficile, a differenza degli Ermetici che sono oscuri.
13
introduzione
Trakl, quest’ultimo fattore non gioca un ruolo così decisivo, perché non abbiamo a che fare con un poeta dotto, e molte delle fonti sono ormai note: la poesia di Hölderlin, quella del simbolismo francese, la Bibbia9 e un po’ di mitologia antica; meno indagato è il rappor-to con il Romanticismo10. L’esperienza biografica è fondamentale per addentrarsi meglio nell’universo simbolico trakliano, ma di essa conosciamo solo pochi frammenti, le lettere non ci dicono molto e l’epistolario con Grete è andato perduto o distrutto dai familiari11. Sono tuttavia importanti altri tipi di fonte biografica: fondamentali anche se forse non sempre del tutto attendibili sono le testimonian-ze contenute nel volumetto Erinnerung an Georg Trakl12, nonché quelle di Ludwig von Ficker, che è vissuto abbastanza a lungo per poter discutere della figura e della poesia di Georg Trakl con più di una generazione di studiosi. Un’ulteriore fonte di oscurità in Trakl è anche data dalla sua tendenza, sempre più marcata nell’ultimo anno e mezzo di vita, a suggestionare ed evocare più che a “spiegare” e “convincere” attraverso le immagini. Come vedremo per esempio nella genesi di Geistliche Dämmerung (cap. quarto), Trakl modifica
9 La Bibbia è una fonte nota, ma paradossalmente non abbastanza indagata, nel senso che molti studiosi la danno per scontata parlando di Trakl, ma nes-suno se n’è veramente occupato a fondo. Anche il capitolo Elemente der Bibel-sprache del libro di Alfred Doppler su Trakl (Die Lyrik Georg Trakls: Beiträge zur poetischen Verfahrensweise und zur Wirkungsgeschichte, Salzburg, Otto Müller, 2001 (19921), pp. 82-87) accenna a molti temi che Trakl riprenderebbe dai testi sacri, ma senza svolgere un’analisi approfondita e un confronto delle occorrenze. Per il motivo dell’ultima cena nell’opera di Trakl (simboleggiato dall’immagine evangelica e poi anche hölderliniana di pane e vino) cfr. J. Höri-sch, Gesprengte Einbildungskraft. Trakls poetisches Abendmahl, in Id. (a cura di), Armaturen der Sinne. Literarische und technische Medien 1870 bis 1920, München, Fink, 1990, pp. 201-214.
10 Si veda H. Esselborn, “Blaue Blume” or “Kristallene Tränen”? Trakl’s Poeto-logy and Relation to Novalis, in The dark flutes of fall: critical essays on Georg Trakl, edited by E. Williams, Columbia SC, Camden House, 1991, pp. 203-232, nonché E.E. Metzner, Trakl, die moderne Lyrik und Eichendorff. Zum Thema Traditionsbestimmtheit im Spätwerk Georg Trakls – im Hinblick auf unerkann-te Eichendorff-Anverwandlung, «Aurora», 36 (1976), pp. 122-150. Mi permetto inoltre di rimandare al mio saggio Eredità romantiche. L’influsso di Novalis e del secondo Romanticismo su Georg Trakl, in I classici rileggono i classici. Studi in onore di Emilio Bonfatti, a cura di M. Scattola e G. Pelloni, Padova, Unipress, 2009, pp. 73-104.
11 Cfr. in proposito H. Szklenar, Ein vorläufiger Bericht über den Nachlass Georg Trakls, «Euphorion», 54 (1960), pp. 295-311 e O. Basil, Georg Trakl, Ham-burg, Rowohlt, 2003 (19651), pp. 71-72.
12 Erinnerungen an Georg Trakl. Zeugnisse und Briefe, Salzburg, Otto Müller, 1959 (19261).
14
strutture e genesi testuale della lirica di trakl
a volte immagini metaforiche in immagini simboliche che però, più che definire, suggeriscono una situazione simbolica.
In questo lavoro ho preso in considerazione alcuni aspetti for-mali della lirica di Georg Trakl che a mio avviso sono stati in parte trascurati dalla critica, oppure osservati, ma non in tutte le loro implicazioni, come molti problemi di sintassi: quest’ultima è di cen-trale importanza per una lirica come quella dell’espressionismo che punta così tanto sullo straniamento prodotto da effetti di ambiguità e contorsione sintattica («Krank von der Syntax mythischem Du» dice Benn della coscienza dell’uomo moderno13, e una lirica di Be-cher si intitola La nuova sintassi). Ho tentato di indagarne i legami con aspetti poetologici e tematici, sempre tenendo presente l’evo-luzione, sia in senso del mutamento dello stile trakliano negli anni, sia nel senso della genesi dei testi.
Negli ultimi quarant’anni la Trakl-Forschung ha spaziato dagli aspetti storico-culturali a quelli psicoanalitici, da quelli estetico-filosofici a interpretazioni basate soprattutto su rico-gnizioni di tipo tematico, ma anche linguistico (queste ultime soprattutto negli anni Sessanta-Settanta). Tra i numerosi contri-buti (per cui si rimanda alla bibliografia), sono imprescindibili quelli di Alfred Doppler, tra cui una raccolta di saggi di vario argomento e taglio critico su Trakl (del 1992, ma riedita con pa-recchi aggiornamenti nel 2001), nonché i lavori di Clemens He-selhaus (importante soprattutto il saggio sulla metafora in Trakl del 1961), di Walter Methlagl, di Hans Weichselbaum (tra cui una bellissima biografia di Trakl, nonché interventi in tre importanti volumi collettanei da lui curati) e, più di recente, di Eberhard Sauermann soprattutto su problemi legati alla genesi dei testi e alle edizioni delle opere di Trakl, ma anche su singoli testi (Ka-spar-Hauser-Lied e Helian). Importante anche il recente studio sulla relazione tra décadence e poetica in Trakl di Ariane Wild. In Italia, si ricordano il volume di Paola Gheri sugli inizi poetici di Trakl, la monografia di Dolei del 1974 di recente ristampata e i lavori di Grazia Pulvirenti; in Francia la Trakl-Forschung ha dato buoni risultati nei lavori di Rémy Colombat e Adrien Finck, mentre negli USA spiccano gli studi di Eric Williams. I contributi di taglio psicanalitico sono stati in auge fino agli anni Ottanta,
13 «Malata del Tu mitico della sintassi» (Das moderne Ich, in Sämtliche Werke, a cura di G. Schuster e H. Hof, Stuttgart, Klett-Cotta 2001, vol. III, pp. 94-107, qui p. 105. Ediz. ital. L’io moderno, in G. Benn, Lo smalto sul nulla, a cura di L. Zagari, Milano, Adelphi, 1992, pp. 11-26, qui p. 23).
15
introduzione
e poi sono pressoché spariti (si ricordano qui quelli di Kleefeld e di Goldmann).
Parecchi sono gli studi sulle fonti e sul contesto storico-cul-turale in cui era inserito Trakl. A mettere l’accento sul rapporto con la poesia di Hölderlin sono stati, già molti anni fa, soprattutto Theodor Fiedler e Bernhard Böschenstein, mentre su Trakl e Rim-baud va ricordato, oltre all’articolo pionieristico di Reinhold Grimm del 1959, il libro di Colombat su Rimbaud, Trakl e Heym del 1987. Fausto Cercignani ha dedicato nel 1989 uno studio all’influenza di Nietzsche, Büchner e Hölderlin sui poemi in prosa di Trakl e infine è da ricordare un recente volume di Hannah Klessinger (2007) che indaga il dialogo di Trakl con Nietzsche, Dostoevskij, Hölderlin e Novalis.
Negli anni Novanta la Trakl-Forschung ha approfondito un aspetto che fino ad allora, a parte per certi aspetti fondamentali (Kraus e il «Brenner») era stato trascurato, e cioè il contesto stori-co-culturale in cui il poeta ha operato e pubblicato, a cominciare dall’influsso della filosofia di Nietzsche (Methlagl), ma anche al-l’importanza di molte tematiche del pensiero kulturpessimistisch di Otto Weininger, soprattutto per quanto riguarda il “femminile” e il rapporto tra i sessi (si veda la monografia di Ursula Heckmann del 1992). Alle strettissime relazioni con il «Brenner» sono dedicati alcu-ni importanti saggi di Methlagl (1978 e 1981) e di Doppler (1979), nonché una monografia in inglese di Richard Detsch (1991), mentre già nel 1976 uno studio di Gerald Stieg aveva ricostruito attentamen-te i rapporti con Karl Kraus e la «Fackel»14. Sieglinde Klettenham-mer ha dedicato nel 1990 un’ampia e interessante monografia al contesto culturale delle varie riviste con cui ha collaborato Trakl e ha mostrato come la tendenza ad applicare alla realtà biografi-ca del poeta le figure-chiave (in senso poetologico ed esistenziale)
14 I rapporti tra la «Fackel» e il «Brenner» furono molto fecondi anche se non sempre del tutto positivi (negli anni Venti, per esempio, le posizioni del «Bren-ner»-Kreis nei confronti di Kraus si fecero più critiche). Trakl conobbe Kraus nell’estate del 1912 a casa di Ludwig von Ficker e poi gli dedicò la lirica Psalm. Nella «Fackel» del 7 novembre 1912 Kraus rispose con un aforisma che Trakl ringraziò in un breve, commosso telegramma («Ich danke Ihnen einen Augen-blick schmerzlichster Helle»: «La ringrazio di un istante di dolorosissima luce», in G. Trakl, Gli ammutoliti. Lettere 1900-1914, a cura di C. Pizzingrilli, Macerata, Quodlibet, 2006, p. 55). Dopo il fallimento del contatto con il Langen-Verlag di Monaco, nel 1913 fu Kraus a proporre al Kurt-Wolff-Verlag di pubblicare nella sua collana «Der jüngste Tag» la prima raccolta di poesie di Trakl. Quest’ultimo scrisse infine per il «Brenner» una breve lirica su Kraus (Karl Kraus), uscita il 15 giugno 1913.
16
strutture e genesi testuale della lirica di trakl
del Fremdling e dello Abgeschiedener vada corretta. Prima che col «Brenner» e oltre a questo, Trakl intrattenne rapporti molto fecondi con le riviste viennesi «Der Merker» e «Ton und Wort» negli anni 1910-11 e soprattutto, nel 1912-13, con «Der Ruf», organo ufficiale dell’«Akademischer Verband für Literatur und Musik» di Vienna, che si proponeva di promuovere l’arte d’avanguardia non ben accolta nei circoli ufficiali: attraverso concerti (soprattutto quello del marzo 1913 con musiche di Schönberg, Webern e Berg, culminato in un’ac-cesa protesta da parte del pubblico filomahleriano), illustrazione da parte di artisti maudits (Kokoschka, Schiele) delle proprie pri-me pagine e dei manifesti che annunciavano delle serate di lettura, nonché conferenze: di Kraus, ma anche di Adolf Loos, architetto e teorico di un’architettura d’avanguardia e antidecorativa, a cui Trakl dedicherà la lirica Sebastian im Traum15.
Tra gli studi con taglio interdisciplinare, e cioè soprattutto di confronto con la pittura espressionista, si ricorda soprattutto il bel libro di Roland Mönig del 1996 che confronta Trakl e Franz Marc, nonché alcuni saggi su Trakl e Kandinskij (Saas 1981) e su Trakl e Kokoschka e Kubin (Orendi-Hinze 1971). Molti sono anche i lavori sulla metaforica del colore nella lirica espressionista o in particolare in Trakl: dal vecchio ma ottimo saggio di Kurt Mautz (1957), a quelli di Jacob Steiner (1984) e di Avemarie Becht sul colore azzurro (1980, ma cfr. anche il volume del 2002 di Amelia Valtolina sul colore blu nella lirica tedesca, che pecca però spesso di una certa genericità). Infine, sono state avanzate molte interpretazioni di singole liriche, tra cui vale la pena ricordare il volume di vari autori pubblicato dalla Reclam nella collana Interpretationen (a cura di H.-G. Kem-per), il classico di Benno von Wiese Die deutsche Lyrik, in cui sono presenti interpretazioni di liriche di Trakl di Clemens Heselhaus e di Walter Höllerer, il commento di Marianne Hepp del 1987, nonché il recente volume di Hartmut Cellbrot Trakls dichterisches Feld (2003), che tenta di interpretare alcune poesie di Trakl attraverso il concetto di “campo poetico” mutuato dalla fenomenologia, e quello di Eva Thauerer Ästhetik des Verlusts (2007) sul rapporto tra memoria e presente in Trakl.
Al di là dei singoli risultati, tutti questi approcci sono natural-mente fondamentali, ma soprattutto negli ultimi due decenni sono
15 Cfr. S. Klettenhammer, Georg Trakl in Zeitungen und Zeitschriften seiner Zeit. Kontext und Rezeption, Innsbruck, Institut für Germanistik, 1990, pp. 93-102. Cfr. anche G. Pulvirenti, Oltre la scrittura. Frammento e totalità nella lette-ratura austriaca moderna, Pasian di Prato, Campanotto, 2002, pp. 105 sgg.
17
introduzione
spesso mancate proposte interpretative che avessero un coerente fondamento filologico e linguistico-stilistico (tranne certi lavori di Eberhard Sauermann), e in particolar modo sono state del tutto as-senti ricerche aventi come base un’analisi delle varianti: quest’ultimo aspetto risulta tanto più urgente ora che è uscita la nuova edizione critica delle opere di Trakl, la Innsbrucker Trakl-Ausgabe. Prescin-dendo da singoli articoli (comunque non molti in materia), gli studi più importanti che hanno affrontato anche dal punto di vista forma-le le grandi problematiche poste dalla difficile poesia trakliana risal-gono agli Sessanta-Settanta: quelli di maggiore utilità sono il libro di Heinz Wetzel16 sulla metrica trakliana, quello di Hans Esselborn sulla crisi della Erlebnislyrik in Trakl (in cui l’autore analizza la pre-sa di distanza di Trakl dalla tradizione poetica ottocentesca anche alla luce di determinati aspetti formali)17, lo studio di Hermann von Coelln (tesi di dottorato del 1960, pubblicata però solo nel 1995) e quello di Albert Berger del 1971, che trattano anche alcuni problemi di sintassi18, nonché il succitato libro di Killy del 1960 e quello di Hans-Georg Kemper sugli abbozzi di Trakl19: questi ultimi due studi sono gli unici a concentrarsi sistematicamente sul problema delle varianti in Trakl, e sono dunque quelli dai cui risultati sono partita per la mia ricerca e su cui tornerò più spesso nel corso del lavoro.
L’analisi degli aspetti più propriamente formali di un testo è uno strumento notevole per cogliere la differenziazione della lingua di un poeta importante rispetto alla lingua standard, lo “scarto” rispetto alla “norma”: questo taglio interpretativo è centrale nei lavori della stilistica letteraria e in particolar modo di Leo Spitzer, per il quale «a qualsiasi allontanamento dallo stato psichico normale corrisponde, nel campo espressivo, un allontanamento dell’uso linguistico nor-male»20. Il mio lavoro tenta di situarsi nel punto di sutura tra stilistica ed ermeneutica letteraria, così com’è stata fondata e praticata da Peter Szondi, di analizzare cioè alcune tendenze formali cercando
16 H. Wetzel, Klang und Bild in den Dichtungen Georg Trakls, Göttingen, Van-denhoeck & Ruprecht, 1968.
17 H. Esselborn, Georg Trakl. Die Krise der Erlebnislyrik, Köln/Wien, Böhlau, 1981.
18 H. von Coelln, Sprachbehandlung und Bildstruktur in der Lyrik Georg Trakls, Essen, Die Blaue Eule, 1995; A. Berger, Dunkelheit und Sprachkunst. Studien zur Leistung der Sprache in den Gedichten Georg Trakls, Wien, Notring, 1971.
19 H.-G. Kemper, Georg Trakls Entwürfe. Aspekte zu ihrem Verständnis, Tübin-gen, Niemeyer, 1970.
20 L’interpretazione linguistica delle opere letterarie, in Id., Critica stilistica e semantica storica, Bari, Laterza, 1954, pp. 67-104, qui p. 67.
18
strutture e genesi testuale della lirica di trakl
di collegarle il più possibile agli aspetti tematici o poetologici, nella ferma convinzione che le prime siano una manifestazione necessa-ria dei secondi (o addirittura non veramente separabili da questi), e che quindi dicano molto di più di quello che sembrano promettere. Come sostiene Szondi in conclusione al suo programmatico saggio Sulla conoscenza filologica, «la scienza della letteratura… dovrebbe ricavare il proprio metodo da un’analisi del processo poetico; essa può auspicare una vera comprensione solo dallo sprofondamen-to nelle opere, nella ‘logica del loro essere prodotte’ [Adorno]»21. Il metodo ermeneutico nel senso di una «scienza dell’interpretazione che, se non intende prescindere dalla filologia, vuole però sposare questa all’estetica»22 altro non è che questo voler affondare nel testo, il quale fornisce da sé le premesse della propria interpretabilità. Oppure, nel caso di certe oscurità intrinseche allo stile dell’autore, il testo vuole affermare la propria resistenza all’interpretazione che va presa seriamente anche (e anzi in particolar modo) dall’interprete per non violare il testo con un’esegesi forzata. In questo senso l’ana-lisi formale è sempre un sano contrappeso allo sbilanciamento sul “contenuto”, sul “significato”, come se ogni testo richiedesse in ogni momento di essere interpretato, come se tutto fosse significante che aspira a essere tradotto, reso comprensibile e manifesto. In un cele-bre saggio degli anni Sessanta Susan Sontag afferma:
La conseguenza di questa sopravvalutazione del contenuto è l’eterno pro-getto, mai completamente realizzato, dell’interpretazione. E, inversamen-te, è l’abitudine ad accostarsi alle opere d’arte per interpretarle a rafforza-re l’illusoria convinzione che l’opera d’arte abbia realmente un contenuto. […] Ciò che occorre è anzitutto una maggiore attenzione alla forma23.
21 P. Szondi, Über philologische Erkenntnis, in Id., Hölderlin-Studien. Mit ei-nem Traktat über philologische Erkenntnis, in Schriften I, Frankfurt a.M., Suhr-kamp, 1978, pp. 263-286, qui p. 286.
22 Id., Introduzione all’ermeneutica letteraria, Torino, Einaudi, 1992 (19791), p. 17.
23 S. Sontag, Contro l’interpretazione, in Ead., Contro l’interpretazione, Mi-lano, Mondadori, 1998 (19671), pp. 24 e 34, (Ediz. orig.: Against Interpretation and other essays, New York, Farrar, Straus & Giroux, 1964). Il provocatorio e un po’ eccessivo ma brillante saggio della Sontag va naturalmente collocato nell’epoca in cui è stato scritto, nella quale molte delle ricerche formali più spinte (per esempio nella narratologia) erano ancora di là da venire o comun-que non così note. Affermazioni come «Ciò che ancora ci manca è una poetica del romanzo, un’idea chiara sulle forme della narrazione» (ivi, p. 34 nota), oppure quella per cui il film viene considerato esclusivamente come appar-tenente alla cultura di massa e dunque ignorato dalla critica (p. 33) non sono ovviamente più valide oggi, se pensiamo, tanto per citare due grandi nomi, ai
19
introduzione
In questo doppio senso ho sempre fatto riferimento alla gene-si dei testi, cioè alle varianti d’autore, fondamentali anzitutto per comprendere l’evoluzione di molti processi stilistici attraverso le tendenze che un poeta manifesta quando corregge: se le correzio-ni avvengono più spesso da A a B che non il contrario, ciò non può non essere significativo, quale che sia la correzione. E se ad un certo punto, nello sviluppo diacronico, si manifesta un’inver-sione di tendenza, questa è altrettanto significativa perché molto probabilmente sintomo di un avvenuto mutamento di orizzonti, di poetica. Inoltre l’osservazione delle varianti permette di far luce su molti punti oscuri o incerti di un testo a fini esegetici. Già più di due secoli fa, cioè ben prima che nascesse la critica delle varianti, Goethe, nell’ambito dei suoi studi sulla metamorfosi e nella convin-zione che la dottrina delle forme sia dottrina della trasformazione, scriveva che «le opere della natura e dell’arte non le si conosce quando sono finite; bisogna coglierle nel loro sorgere per poterle in qualche modo comprendere»24. E qualche decennio prima anche Lessing aveva raccomandato lo studio delle varianti d’autore: «Ma le modifiche e i miglioramenti che un poeta come Klopstock realizza nelle sue opere meritano di essere non solo notati ma anche di ve-nire studiati con il massimo zelo. Si imparano in essi le più raffinate regole dell’arte; […]»25.
La grande differenza fra tali concezioni sette-ottocentesche e la variantistica come branca degli studi letterari sviluppatasi nel XX secolo è però che quest’ultima non ha intenti normativi, bensì de-scrittivi e che dunque le varianti sono degne di essere studiate non solo in previsione del risultato finale (spesso, ma non sempre mi-gliore), ma anche in sé. Jan Mukařovský osserva in proposito che le varianti sono da studiare
come mezzo efficace nella ricerca di principi strutturali che determina-no lo stile di uno scrittore: nei miglioramenti e cambiamenti apportati al testo, infatti, tali principi appaiono, in quanto tendenze attive che indicano la direzione del miglioramento, molto più chiaramente che
lavori di Genette sulla forma-romanzo (che risalgono alla fine degli anni Ses-santa-inizio anni Settanta) o a quelli di Deleuze sul cinema (prima metà degli anni Ottanta).
24 J.W. Goethe, lettera a Zelter del 4 agosto 1803, cit. in A. Bohnencamp, Autor-Varianten, «editio», 17 (2003), p. 21. In generale, tutto il saggio di Anne Boh-nenkamp fornisce un’ottima panoramica sulla storia dell’interesse della critica letteraria per le varianti d’autore.
25 G.E. Lessing, Briefe die neueste Literatur betreffend, cit. in Bohnencamp, op. cit., p. 19
20
strutture e genesi testuale della lirica di trakl
nell’opera pronta, conclusa, nella quale si trovano in uno stato latente e statico26.
E uno dei classici sull’argomento, il Saggio d’un commento alle correzioni del Petrarca volgare di Gianfranco Contini, si apre con queste considerazioni:
La scuola poetica uscita da Mallarmé, e che ha in Valéry il proprio teo-rico, considerando la poesia nel suo fare, l’interpreta come un lavoro perennemente mobile e non finibile, di cui il poema storico rappresenta una sezione possibile, a rigore gratuita, non necessariamente l’ultima. È un punto di vista di produttore, non d’utente. Sennonché, se il criti-co intende l’opera d’arte come un “oggetto”, ciò rappresenta soltanto l’oggettività del suo operare, il “dato” è l’ipotesi di lavoro morale della sua abnegazione; e una considerazione dell’atto poetico lo porterà a spostare dinamicamente le sue formule, a reperire direzioni, piuttosto che contorni fissi, dell’energia poetica. Una direttiva, e non un confine, descrivono le correzioni degli autori; e soltanto oggi la coscienza mal-larméana, alla pari con la riduzione unitaria della personalità imposta dall’estetica dell’espressione, ne consente uno studio rigoroso e poetica-mente fecondo27.
L’evoluzione poetica di Trakl è fatta di continue correzioni, ri-pensamenti, migliorie: i suoi manoscritti sono un vero e proprio groviglio di varianti come nella storia della poesia tedesca si era visto forse solo nei manoscritti di Hölderlin. Questa messe di cor-rezioni, questa continua insoddisfazione nei confronti del proprio operare, ha probabilmente svariate motivazioni di ragione molto diversa. Una è di ordine estetico-formale: Trakl è un poeta che tende molto alla sperimentazione, quantunque questa non sia mai puro gioco estetizzante con la lingua. Essa va poi certamente collegata anche alla straordinaria rapidità dell’evoluzione stilistica di Trakl: anche la continua spinta al perfezionamento ha prodotto questa abnorme quantità di varianti in così poco spazio e in così poco tem-po. Ma questa ossessione della variazione, nel dettaglio (attraverso la variante manoscritta) e, in senso più ampio, nel rapido passaggio da una fase produttiva all’altra, può anche avere a che fare con un senso generale di dolorosa insoddisfazione per la propria arte, con il divario tra la necessità etica di dire il vero attraverso la poesia e
26 J. Mukařovský, Varianten und Stilistik (1930), «Poetica», 2 (1968), pp. 399-403, qui p. 403.
27 G. Contini, Saggio d’un commento alle correzioni del Petrarca volgare, in Id., Varianti e altra linguistica, Torino, Einaudi, 1970, p. 5.
21
introduzione
il presentimento dell’incapacità di conferire alla propria opera quel compimento estetico degno dell’esigenza etica che l’ha generata. È significativa, in proposito, una testimonianza di Hans Limbach, scrittore svizzero vicino al circolo del «Brenner», che conobbe Trakl all’inizio del 1914 ad una cena a casa di Ludwig von Ficker a Müh-lau in occasione della terza serata di letture di Kraus a Innsbruck. In quell’occasione egli assistette a una conversazione fra Trakl, al-l’apparenza reticente, e Carl Dallago, altro collaboratore della rivista di Innsbruck, che incalzava il poeta con domande provocatorie28. Limbach riporta tra gli altri questo scambio di battute:
Dallago insisteva a voler sapere se egli non provasse nessuna gioia di vivere, se la sua arte, per esempio, non gli procurasse soddisfazione alcuna.“Certo” ammise Trakl, “ma bisogna essere diffidenti nei confronti di una tale soddisfazione”.Dallago si lasciò cadere all’indietro nella sedia per l’enorme stupore.“Ma perché non ve ne andate in un convento allora?” chiese infine dopo un breve silenzio.“Sono protestante” rispose Trakl cupo.“Pro – te – stan – te?” chiese Dallago rallentando volutamente. “Questo proprio non l’avrei detto! Ma allora dovreste per lo meno vivere non in città, ma in campagna, dove sareste più lontano dallo smodato affaccen-darsi della gente e più vicino alla natura!”“Non ho alcun diritto di sottrarmi all’inferno” replicò Trakl29.
Queste parole del poeta, in particolare quelle a proposito della soddisfazione provata nel comporre, sembrano confermare l’ipo-tesi che lo sperimentalismo formale trakliano sgorghi non da una fiducia nella propria capacità di giocare con la lingua e dal piacere estetico puro, bensì, al contrario, da una sostanziale sfiducia nelle proprie potenzialità e anche tout court nelle potenzialità del mezzo linguistico, ed è perciò una della manifestazioni più dolorose del senso di inadeguatezza insieme etica ed estetica che caratterizza molta poesia della modernità. Quella di Trakl si rivela essere una posizione di profonda diffidenza nei confronti della soddisfazione puramente estetica, e quindi un’affermazione che va contro l’esteti-smo puro e l’art pour l’art per una riaffermazione della critica alla civiltà e dell’etica – che nel suo caso è un’etica di stampo religioso.
28 Su Trakl e Dallago cfr. il cap. VI in R. Detsch, Georg Trakl and the Brenner Circle, New York, Peter Lang, 1991, pp. 175-203.
29 H. Limbach, Begegnung mit Georg Trakl, in Erinnerung an Georg Trakl, cit., p. 116.
22
strutture e genesi testuale della lirica di trakl
Questa concezione, come anche quella del poeta come un escluso, un Abgeschiedener con la sua necessità di ritirarsi dal mondo, si differenzia peraltro molto da posizioni di un’avanguardia più ag-gressiva nella sua protesta e anche più “futuristicamente” favorevole alla tecnica (come quella del circolo del «Ruf») e collima invece con le posizioni comuni in quegli anni alla cerchia del «Brenner» e a Dallago (quest’ultimo riteneva che il poeta avesse un “destino da paria”)30, anche se Trakl le porta avanti con una sorta di solitaria e quasi folle ostinazione.
È la costante sfiducia nella soddisfazione personale e l’idea di dover espiare una colpa («Non ho alcun diritto di sottrarmi all’in-ferno») che costringono il poeta di volta in volta al tavolo di lavoro. E in un pensiero annotato poche settimane prima di morire Trakl scriverà: «Gefühl in den Augenblicken totenähnlichen Seins: Alle Menschen sind der Liebe wert. Erwachend fühlst du die Bitternis der Welt; darin ist alle deine ungelöste Schuld; dein Gedicht eine unvollkommene Sühne»31.
30 Anche Alfred Doppler sottolinea il passaggio, intorno alla fine del 1912-inizio del 1913, dal “bel tono” romanticheggiante, estetizzante e “orfico” delle prime poesie (in cui Trakl risente non solo dello Jugendstil e del simbolismo, ma anche della filosofia nietzscheana della Nascita della tragedia), alla tematiz-zazione di problematiche esistenziali e dunque anche etiche, e poi lo mette an-che in relazione con la collaborazione sempre più assidua di Trakl al «Brenner»: «La rivista stava all’epoca nel segno di Carl Dallago e di Karl Kraus, e a partire dalla fine del 1912 le liriche di Trakl vennero intese dall’editore del «Brenner», Ludwig von Ficker, come pendant poetico ai saggi di critica della cultura e della civiltà e vennero assegnate ai singoli numeri secondo un consapevole principio compositivo» (Id., «Der Brenner» als Kontext zur Lyrik Trakls, in Id., Die Lyrik Georg Trakls, cit., pp. 159 sg.).
31 ITA, IV 2, p. 323 [Sensazione nei momenti di un’esistenza simile alla morte: tutti gli uomini sono degni di amore. Al risveglio senti l’amarezza del mondo; in questo vi è tutta la tua colpa irrisolta; la tua poesia un’espiazione imperfetta]. Ludwig von Ficker riferisce nell’ultimo numero del «Brenner» (1954) che Trakl, poco prima di partire per il fronte, gli aveva consegnato un biglietto (ora per-duto) che conteneva queste righe, aggiungendo però a voce che «certo nessuna poesia può mai costituire l’espiazione per una colpa» (ivi). Il piccolo testo fu pubblicato nel «Brenner-Jahrbuch» del 1915.























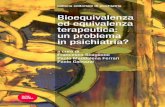



![Signori-trovieri in Borgogna: una lirica attribuita a Gautier de Berzé ["Medioevo romanzo", 21, 1997]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633d61679dcb0c30ee05f092/signori-trovieri-in-borgogna-una-lirica-attribuita-a-gautier-de-berze-medioevo.jpg)












