Bertolome Zorzi: “En tal desir mos cors intra”, in A. D’Agostino, Il pensiero dominante. La...
Transcript of Bertolome Zorzi: “En tal desir mos cors intra”, in A. D’Agostino, Il pensiero dominante. La...
Prima edizione Maggio 2009 © CUEM Soc. Coop. Via Festa del Perdono 3 20122 Milano www.accu.it Per ordini: fax 0258307370 [email protected] È vietata la riproduzione anche parziale ad uso interno o didattico, effettuata con qualsiasi mezzo, non autorizzata. Stampa: Globalprint s.r.l. Via degli Abeti, 17/1 – 20064 Gorgonzola – Milano In copertina: Canzoniere provenzale C, f. 202v. Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 856.
edico questo libro non a una singola persona, ma a un’intera stagione della mia vita, con-
cretamente a quanti, maestri e compagni dei miei anni universitarî, sono stati importanti per la mia formazione; con alcuni di loro è poi nato un rap-porto di sincera e profonda amicizia. Prima di tutti il mio caro maestro
Alberto del Monte
grande provenzalista e filologo romanzo rifinito, e poi, in ordine alfabetico:
Franco Brioschi Anna Maria Finoli Marina Fumagalli Giuseppe Lozza
Andrea Masini Giovanni Orlandi
Maurizio Vitale
Senarius namque, qui partibus suis perfectus est, perfectionem mundi quadam numeri sui significa-tione declarat.
Isidoro di Siviglia, Etymologiarum liber III, 4.
«O frate» disse, «questi ch’io ti cerno col dito» e additò un spirto innanzi, «fu miglior fabbro del parlar materno. Versi d’amore e prose di romanzi soverchiò tutti; e lascia dir li stolti che quel di Lemosí credon ch’avanzi»
Dante Alighieri, Purgatorio XXVI, 115-120. [...] e poi v’era un drappello di portamenti e di volgari strani: fra tutti il primo Arnaldo Danïello, gran maestro d’amor, ch’a la sua terra ancor fa onor col suo dir strano e bello...
Francesco Petrarca, Triumphus Cupidinis IV, 38-42.
D
Ritorno a dirvi che piú grave suono rendono le rime piú lontane. Perché gravissimo suono da questa parte è quello delle sestine, in quanto mara-vigliosa gravità porge il dimorare a sentirsi che alle rime si risponda primieramente per li sei versi primieri, poi quando per alcun meno e quando per alcun piú, ordinatissimamente la legge e la natura della canzone variandonegli. Senza che il fornire le rime sempre con quelle medesime voci genera dignità e grandezza; quasi pensiamo, sdegnando la mendicazione delle rime in altre voci, con quelle voci, che una volta prese si sono per noi, altera-mente perseverando lo incominciato lavoro mena-re a fine. Le quali parti di gravità, perché fossero con alcuna piacevolezza mescolate, ordinò colui che primieramente a questa maniera di versi diede forma, che dove le stanze si toccano nella fine dell’una e incominciamento dell’altra, la rima fosse vicina in due versi. Ma questa medesima piacevo-lezza tuttavia è grave; in quanto il riposo che alla fine di ciascuna stanza è richiesto, prima che all’altra si passi, framette tra la continuata rima al-quanto spazio, e men vicina ne la fa essere, che se ella in una stanza medesima si continuasse.
Pietro Bembo, Prose della volgar lingua, II,12. Sei idee tormentose...
Ugo Angelo Canello, La vita e le opere del trovatore Arnaldo Daniello
Se lei cerca un poeta meccanico vero e proprio, dovrà aspettare ancora qualche mese: è in fase di avanzata progettazione presso la nostra casa ma-dre, a Fort Kiddiwanee, Oklahoma. Si chiamerà The Troubadour, «Il trovatore»: una macchina fan-tastica, un poeta meccanico heavy-duty, capace di comporre in tutte le lingue europee vive o morte, capace di poetare ininterrottamente per mille car-telle, da – 100º a + 200º centigradi, in qualunque clima, e perfino sottacqua e nel vuoto spinto.
Primo Levi, Il versificatore (in Storie naturali).
II.4(*) BERTOLOME ZORZI En tal dezir mos cors intra
(PC 74,4) Mss.: I 99v; K 83v; d 273. Attribuzione: unanime a Bertolome Zorzi. Autodesignazione: sirventes (v. 37). Metrica: identica a quella della sestina di Arnaut Daniel. Edizioni diplomatiche: I (MG 573). Altre edizioni: Raynouard, Choix, V, p. 58 (str. I). Edizioni critiche: Levy 1883, 11, p. 68; Mantovani 2009 (con traduzione alineare).
Manoscritto di base è I, collazionato con la lezione di K; non rientra nella colla-zione la lezione di d, notoriamente descriptus di K.
Bibliografia scelta: Rohleder, Zu Zorzi’s Gedichten, 1885; Folena, Tradizione e cultura, 1976, 131-132; Frasca, La furia della sintassi, 1992, pp. 112-8.
Il contrafactum della sestina arnaldina, che ne utilizza il sistema delle parole-rima e ne acquisisce sotterraneamente qualche immagine, rivela – pur mantenendosi sulla «linea del pastiche e dell’aemulatio dei grands rhétoriqueurs provenzali» (Folena, Tradizione e cultura, 1976, p. 131) – l’intento però di veicolare un messaggio differente, così come avviene in Atressi cum lo camel, rifacimento della celeberrima Atressi cum l’orifanz di Rigaut de Berbezilh. Laddove infatti l’ur-sestina di Arnaldo si sforza di rappresentare, con l’invenzione di un’elaboratissima architettura retorica, il circolo chiuso e quasi l’os-sessività della situazione amorosa trobadorica, l’esercizio di Bertolomè traduce il dis-sidio tra corpo, cuore e anima dall’«immobile cosmo verbale del modello» (ibidem) a una prospettiva immanente non più a sé stessa ma al mondo reale, dal ferm voler al tal dezir, con l’inevitabile implicazione cristiana del peccato e di una prospettiva “inferna-le”. Con un difetto certo di originalità, com’è logico che sia per un’arte che già nei presupposti è del tutto imitativa, e mostrando talora non poco imbarazzo nella ge-stione della “gabbia” rimica, ma tuttavia esibendo alcune figurazioni potenti e un ela-boratissimo pedigree di lettore.
(*) Il paragrafo II.4 è curato da Dario Mantovani.
Il pensiero dominante
148
I In tal desiderio entra il mio cuore né più se ne stacca come la carne dall’unghia, così che temo che lui stesso perderà l’anima e colei che lo colpisce con l’amorosa verga, se per lasciar morire amico o zio può l’anima entrare nella camera infernale. 6
II Ché esso desidera entrare nella camera dove conviene che entri l’amante fino, ma non può farci nulla, dato che né amico, né fratello, né zio possono fare in modo che ci posi neppure l’unghia, poiché colei cui appartiene la difende con tale verga che contro di lei non vale esercito né arma. 12
III Perché gli è necessario pensare all’anima e distruggere il volere d’entrare in tale camera, ché altrimenti lo dovrà uccidere infilzandolo con la sua verga: per cui l’anima dovrà entrare all’inferno, poiché quello si è perso nel gaudio, dopo che amore ci ha messo l’unghia, come Perceval, finché si recò dallo zio. 18
IV Ma se avessi godimento da mio zio, non distruggerei il mio volere e penserei alla dannazione dell’anima, tanto questo ha stabilmente ficcato in lei l’unghia, sebbene si senta torturare in quella camera da cui non esce più dolore, né più vi entra dolcezza, da cui nasce morte come verga da una radice. 24
V Anzi, (il cuore) dice che lo colpisce una tal verga che lascerà piuttosto perire cugino e zio, ché quello non si sforza in questo finché non accada che entri o che così danni sé stesso, e me e l’anima: poiché l’amore non ha cuore nutrito nella sua camera, se in tale sforzo considera la morte quanto un’unghia. 30
II.2 – Bertolome Zorzi, En tal dezir mos cors intra
149
I En tal dezir mos cors intra ni s’en depart plus com la chars da l’ongla, qu’eu vauc doptan qu’el eis en perda l’arma e cil qu’o fer ab l’amorosa versza, si per laissar morir amic ni oncle pod arm’entrar inz en l’enfernal chambra. 6
II Qu’el dezir entrar en chambra on taing que cors de fin’amador intra, mas res no·i val, qu’amic, fraire ni oncle non podon far que sol hi pauza l’ongla, quar cil cui es la defen ab tal versza que contra leis non val esfortz ni arma. 12
III Per qu’obs l’es penzar de l’arma e vol delir d’entrar en aital chambra, qu’estiers l’aur’a ponher mortz ab sa versza: don convenra que l’arma l’enfern intra, qu’el si gaudet, pois amors hi mes l’ongla com Percevaus, tro qu’anet a son oncle. 18
IV Mas s’aia gaug de mon oncle vol no·i delis, ni penz’al dan de l’arma, tant ha en lieis fermamenz ficha l’ongla, si tot si sent turmentar en tal chambra don ges non eis de dolor, ni no intra mas dolz, on nais mortz com de rasitz versza. 24
V Anz ditz qu’a lui fer tals versza, qu’el laisser’anz perir cozin ni oncle, qu’el no·i puingnes tro qu’avenga qu’el intra o qu’en perda si eis, e mi e l’arma: qu’amors non a cor norrit en sa chambra, s’en tal puingnar preza mort sol un’ongla. 30
I 3 doptan] dueptan Kd. ~ perda] perdra IKd 5 oncle] ocle K II 9 fraire] franc K (-1). III 13 l’es] yhes IKd. 14 e vol] ovol IKd. 18 com] ocom Kd (+1). IV 24 rasitz] irasietz IKd. V 25 tals] tal Kd. 26 ni oncle] zonde IKd (-1).
Il pensiero dominante
150
VI Ma poiché tanto quanto un bianco d’unghia
non si può in lei migliorare rami o foglie, dovrei dir grazie e lode della sua camera, poiché l’amo più di quanto Americ non amò suo zio, poiché si perde il pregio, e il corpo e il cuore e l’anima, solo a sopportare che la morte ci invada. 36
VII Vai sirventese, ficca l’unghia a suo zio e assicurati che s’armi di malvagia verga una donna amante, quando entra in una camera d’orgoglio. 39
II.2 – Bertolome Zorzi, En tal dezir mos cors intra
151
VI Mas car tant quant us blancs d’ongla
no·s pogr’en leis meillurar rams ni versza, deuria far merce e lau de sa chambra, pueis qu’eu l’am mais qu’Aimiers non fetz son oncle, quar hom pert pretz, e cors e cor e arma, sol per soffrir que la mortz els sieus intra. 36
VII Vai sirventes, ficha l’ongl’en son oncle, et encertaill que d’avol versza s’arma domna amanz, qu’en chambra d’ergueill intra. 39
VI 32 rams] cams IKd. VII 39 domna] dome IKd.
Il pensiero dominante
152
NOTE
3. eis < IPSE, normalmente attestato nel provenzale. ♦ Accolgo la proposta di correzione del testo avanzata da Emil Levy (p. 68 e la nota corrispondente a p. 88), che ipotizza un ‘refuso’ perdra in luogo del congiuntivo perda, richiesto dalla sintassi del verbo doptar (cf. Jensen, The Syntax of Medieval Occitan, 1986, § 850, p. 288: «Doptar ‘to doubt’ is constructed with the subjunctive because of its semantic value»); risulta complicato stabilire se il ‘refuso’ sia dei due testimoni (IK), talmente solidali da essere definiti “gemel-li”, ovvero del trovatore, italiano, che eccepisce alla regula sintattica dell’occitano; di fatto, il sistema linguistico dei due canzonieri (esemplati in Veneto, forse proprio a Venezia, come potrebbe risultare da una prima expertise sulle miniature) coincide con quello di Bertolomè, veneziano anch’egli: doven-do scegliere, preferisco però pensare a un errore dell’antigrafo di I e K, consi-derando che, qui e altrove, il rispetto del trovatore per la sintassi del provenza-le è senz’altro corretto. 4. versza è grafia particolarissima e con ogni probabilità altoitaliana, pada-na, adottata per indicare il suono affricato: la si conserva nel testo critico (lad-dove ad esempio Levy corregge sistematicamente in verja, come nel testo di Arnaut), in quanto il sistema linguistico dei canzonieri “gemelli” coincide, co-me si è detto, con quello del trovatore. 10. sol, “solamente”, in senso negativo-asseverativo vale “neppure”. 12. “anima” o “arma”? Seguendo il contesto, il significato migliore è senz’altro il secondo, che pure in provenzale conosce più che altro attestazioni al plurale (armas, cfr. Levy, Petit dictionnaire e idem, Provenzalische Supplement-Wörterbuch; ma cfr. anche il FEW, s. v. arma, ‘waffen’, a. pr. arma, al singolare), ma che solo nel significato “bellico” si incastra perfettamente nella dittologia con esfortz, che vale “sforzo”, “forza” ma anche “esercito” (cfr. Levy, Petit dic-tionnaire). 13. Si corregge yhes dei manoscritti in l’es: un i/y pronominale non è infat-ti possibile a causa della res metrica, in quanto sconcerebbe il verso e lo rende-rebbe ipermetro; si è o-ptato per una forma pronominale minima (l’) da ap-poggiare all’impersonale ops es, così da puntare il fuoco, una volta di più, sul soggetto (il cuore). 14. Ho corretto la versione dei manoscritti (o vol delir), affinché la tradu-zione suoni, pressappoco, “per questo gli è necessario pensare all’anima e di-struggere il volere di entrare”, con delir in dipendenza da ops es del verso prece-
II.2 – Bertolome Zorzi, En tal dezir mos cors intra
153
dente; l’intervento è del tutto minimo - una sostituzione vocalica - e serve a re-stituire la coerenza a una sintassi altrimenti compromessa. 15. L’espressione aver a si traduce come espressione d’obbligo, come nota Jensen (cf. The Syntax of Medieval Occitan, 1986, § 665, p. 223): «The impersonal locutions esser a, aver a, venir a, avenir a serve to express obligations or to denote a happening which is bound to occur»; letteralmente, ponher mortz è “infilzare morto”, che ho sciolto traducendo in modo più libero. 17. el è a mio parere il “cuore”, soggetto della cobla e di tutta la sestina: se infatti è grammaticalmente possibile che el indichi anche un soggetto femmini-le (arma, come ad esempio vorrebbe in questo caso Folena, Tradizione e cultura, 1976, pp. 131-2), è logicamente più lineare il passaggio per cui l’anima si danna a causa dell’abbandonarsi del cuore ai piaceri dell’amore, una sequenza che ri-corda nella sua struttura l’episodio dantesco di Paolo e Francesca. La traduzio-ne è qui libera (“si è perso nel gaudio”), mentre letteralmente suona “ha così goduto”. 18. Al tono apocalittico-religioso (con un riferimento esplicito alla con-danna per lussuria) che caratterizza tutta la sestina di Zorzi si affianca qui l’exemplum romanzesco: un tratto, questo, che si affaccia sovente nel suo can-zoniere, come ad esempio in Atressi cum lo camel (PC 74,2, cfr. Levy, p. 44), in cui è nominata l’amoroseta bevanda, il filtro che strinse in amore Tristano e Isotta (cfr. i vv. 50 e ssg.: L’amoroseta bevanda / non feric ab son cairel / Tristan n’Iseut plus fortmen / quand ilh venion d’Irlanda). Qui, il godimento -peccaminoso- del cuore evoca un’altra tipologia di godimento materiale, quella cui si trova di fronte Perceval dopo il suo ingresso nel palazzo del Re Pescatore, che scoprirà essere suo zio. Non a caso dunque Bertolomè utilizza tro, “finché”, congiunzione che segna un punto di non ritorno, in perfetto parallelismo con l’exemplum roman-zesco (allo stesso modo per Perceval l’ingresso al palazzo del Re Pescatore si-gnifica confrontarsi con il mistero del Graal e nel contempo acquisire la rivela-zione del proprio destino). 19. Non del tutto ialino il senso di questa cobla, che sembra ruotare una volta di più, come quella precedente, sul tema del piacere e della dannazione che esso procura: l’aggancio capfinido con l’oncle rinvia all’immagine appena evocata di Perceval e delle meraviglie che egli ha di fronte al castello del Re Pescatore, e al godimento che queste procurano; godimento di fronte al quale il trovatore sembrerebbe reagire con un’assunzione di responsabilità (“non an-nullerei la mia volontà, e penserei alla mia dannazione”, con la congiunzione ni che avrebbe, come spesso accade, un valore positivo); anche se nella seconda parte della cobla questa fermezza sembra venire meno per lasciare piuttosto spazio a un sentimento di inesorabilità del peccato, quando il trovatore descri-ve la chambra (senz’altro, quella enfernal evocata nella strofe precedente) da cui può nascere soltanto morte.
Il pensiero dominante
154
24. Ho corretto irasietz, espressione priva di significato che compare in tutti e due i testes, in rasitz, come già Levy, introducendo così una soluzione les-sicale adeguata a legare il verbo nais (“nascere”) e la parola-rima versza. L’immagine “quasi botanica” della verga che nasce da una radice rinvia una volta di più, per contrasto, alla sestina arnaldina (la “secca verga” del v. 25, che fiorisce e dà origine alla stirpe di Adamo). Si noterà infine che la concordanza in errore dei testimoni è qui decisamente flagrante, così da lasciar pensare a un antigrafo comune ad ambedue. 26. Il verso è caduto, evidentemente in fase di editing, nell’edizione di E-mil Levy (p. 68): che fosse presente è chiaro dall’apparato, che segnala l’emendamento et oncle per l’incomprensibile zonde dei manoscritti; la d di zonde nasconde qui il nesso consonantico cl, che si sono unite nell’antigrafo a forma-re la pancia e l’asta della d; quanto all’emendamento nel suo complesso, manca una sillaba tra cozin e oncle: ho preferito ni a et di Levy, scegliendo tra i due allo-tropi quello che meglio corrisponde alla situazione grafica di partenza, e im-maginando che si sia verificato un errore paleografico per confusione di aste. 28. Con molta probabilità, si tratta di “entrare” nella camera, così ben di-fesa, della cobla II. 29. Nel significato di “condurre alla perdizione”, che costituisce il fil rouge di tutta la sestina. 34. Aimiers è molto probabilmente Aimeric de Narbonne, condottiero le-gato sia a Carlo I d’Angio che a suo figlio Carlo II lo Zoppo; la fama del vi-sconte di Narbona è legata in modo particolare alla battaglia di Campaldino dell’11 giugno 1289, ma potrebbe trattarsi di un terminus temporale eccessiva-mente tardo (anche se l’attività poetica di Bertolomè può collocarsi in una fi-nestra cronologica che va dal 1260 al 1290). Un terminus post quem invece del tutto certo è il 1271, data in cui la presenza di Aimeric a Narbona è avvalorata dai documenti d’archivio (cfr. A. Radaelli, Raimon Gaucelm de Béziers. Poesie, Fi-renze, 1997, p. 15). Lo “zio”, in questo caso, è forse uno dei due re angioini al cui seguito Aimeric conseguì i suoi maggiori successi; per l’identificazione di Aimiers con Aimeric seguo l’indicazione, non meglio precisata, di Folena (cfr. Tradizione e cultura, 1976, p. 130).
INDICE
Avvertenza 7
I. Il pensiero dominante I.1. Introduzione: invarianza e variazione, p. 11 – I.2. Un illustre pre-cedente: Raimbaut d’Aurenga (parossismi fonici e parodici), p. 14 – I.3. Arnaut Daniel: la struttura della sestina (Spirali, chiocciole, dadi, scacchi, graticci, talismani e passi di danza), p. 31 – I.4. I possibili si-gnificati della sestina di Arnaut Daniel, p. 49 – I.5. Il futuro prossimo della sestina, p. 60.
11
II. Testi II.1. Raimbaut d’Aurenga, Er resplan la flors enversa, p. 71 – II.2. Arnaut Daniel, Lo ferm voler qu’el cor m’intra, p. 93 – II.3. Guilhem de Saint Gregori, Ben grans avolesa intra, p. 139 – II.4. Bertolome Zorzi, En tal dezir mos cors intra, p. 147 – II.5. Pons Fabre d’Uzès, Quan pes qui sui, fui so que·m fraing, p. 155 – II.6. Dante Alighieri, Al poco giorno, p. 165.
69
III. Materiali filologici per la sestina di Arnaut Daniel III.1. Trascrizioni diplomatiche, p. 175 – III.2. Collatio codicum, p. 199 – III.3. Classificatio, p. 221 – III.4. Le precedenti edizioni, p. 279 – III.5. Vocabolario della sestina, p. 293.
173
IV. Appendici IV.1. Vida di Raimbaut d’Aurenga, p. 299 – IV.2. Vida di Arnaut Da-niel, p. 303 – IV.3. Guglielmo IX, Pos vezem de novel florir, p. 305 – IV.4. Jaufre Rudel, Quan lo rius de la fontana, p. 311 – IV.5. Jaufre Rudel, Lanquan li jorn son lonc en mai, p. 317 – IV.6. Raimbaut de Aurenga, Lonc temps ai estat cubertz, p. 325 – IV.7. Bernart de Ventadorn, Ara no vei luzir solelh, p. 331 – IV.8. Bernart de Ventadorn, Can vei la lauzeta mover, p. 337 – IV.9. Bernart de Ventadorn, Tant ai mo cor ple de joya, p. 343 – IV.10. Dante Alighieri, dal De vulgari eloquentia, p. 349.
297
V. Congedo 355
VI. Bibliografia scelta 359

















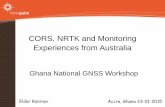








![Signori-trovieri in Borgogna: una lirica attribuita a Gautier de Berzé ["Medioevo romanzo", 21, 1997]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633d61679dcb0c30ee05f092/signori-trovieri-in-borgogna-una-lirica-attribuita-a-gautier-de-berze-medioevo.jpg)








