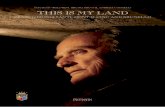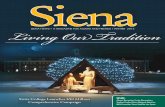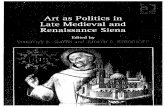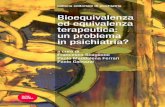G. PICCINNI, Siena 1309-1310: il contesto, in Siena nello specchio del suo Costituto in volgare del...
Transcript of G. PICCINNI, Siena 1309-1310: il contesto, in Siena nello specchio del suo Costituto in volgare del...
SIEN
A N
ELLO
SPE
CCH
IO D
EL S
UO C
OST
ITUT
O IN
VO
LGA
REDE
L 13
09-1
310
8
Ricerca
8
SIENA NELLO SPECCHIO DEL SUOCOSTITUTO IN VOLGARE DEL 1309-1310A CURA DINORA GIORDANO GABRIELLA PICCINNI
Dentro il Medioevo
€ 18,00
ISBN 978-88-6315-613-3
9 7 8 8 8 6 3 1 5 6 1 3 3
Siena si specchia nel Costituto del 1309-1310, traduzione dal latino al volgare italiano di una vasta raccolta normativa, monumento della cultura politica e giuridica, e della lingua. La norma, integrata con il complesso documentario conservato negli archivi e con il grande documento materiale rappresentato dalla intera città, si trasforma in una fonte inesauribile di informazioni che spaziano dalla politica all’e-conomia, alla società, al diritto, all’edilizia, al decoro urbano, agli ideali civici. Un contributo alla storia formidabile dell’Italia comunale del primo Trecento.
Gabriella Piccinni insegna Storia Medievale all’Università di Siena. Ha dedicato studi a diversi aspetti della storia della società e dell’economia dell’Italia medievale.
Nora Giordano, laureata in Filologia classica, lavora dal 2001 presso il Complesso Museale Santa Maria della Scala di Siena dove si occupa delle attività espositive e della conservazione del patrimonio storico-artistico.
In copertinaSimone Martini, Maestà (particolare della cornice), 1315-1321, Siena Palazzo Pubblico.
DENTRO IL MEDIOEVO. TEMI E RICERCHE DI STORIA ECONOMICA E SOCIALE
COLLANA DEL DIPARTIMENTO DI STORIA DELL’UNIVERSITÀ DI SIENADIRETTA DA GIOVANNI CHERUBINI, FRANCO FRANCESCHI E GABRIELLA PICCINNI
DENTRO IL MEDIOEVO.TEMI E RICERCHE DI STORIA ECONOMICA E SOCIALE
Collana del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena
diretta da Giovanni Cherubini, Franco Franceschi e Gabriella Piccinni
8
La grafica del logo è di Augusto Mazzini, libera rielaborazione dell’immagine del mese di otto-bre, di anonimo, in Salterio, The Hague, conservato nella Biblio-teca Reale del Belgio.
SIENA NELLO SPECCHIO DEL SUO COSTITUTO IN VOLGARE DEL 1309-1310A CURA DINORA GIORDANOGABRIELLA PICCINNI
PaciniE d i t o r e
Ricerca
DENTRO IL MEDIOEVO
8
INDICE
SALUTI
Bruno Valentini, Sindaco di Siena pag. 7Carla Zarrilli, Direttrice dell’Archivio di Stato di Siena » 9
PREFAZIONE Gabriella Piccinni, Direttrice del Dipartimentodi Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena » 11
SIENA NELLO SPECCHIO DEL SUO COSTITUTO IN VOLGARE DEL 1309-10Siena 1309-10: il contesto, di Gabriella Piccinni » 15
Il governo dei Nove nella Sesta Distinzione del Costituto,di Sergio Raveggi » 37
Il palazzo del Comune di Siena e il suo Campo, di Fabio Gabbrielli » 51
Il bene comune e l’emergere di ideali civici, di Paolo Cammarosano » 67
Il Costituto del Comune volgarizzato nel 131O e il diritto vigentea Siena nel suo tempo, di Mario Ascheri » 83
Ranieri Ghezzi Gangalandi, il volgarizzatore del Costituto,di Laura Neri » 97
Lo spazio pubblico nel Costituto volgarizzato: genesi dei principidi ordine, decoro e igiene nell’urbanistica di Siena,di Thomas Szabó » 133
Uso del volgare e “Civiltà senese”, di Attilio Bartoli Langeli » 177
Giustizia, politica e società al tempo dei Nove: una nota sulla fama,di Roberta Mucciarelli » 193
Tra lavoro e rivolta: i carnaioli senesi nello specchio del Costitutodel 1309-10, di Valentina Costantini » 219
La norma della pubblica pietà. Istituzioni comunali, religione epia loca nella normativa statutaria senese fino al Costituto volgaredel 1309, di Michele Pellegrini » 249
TAVOLA ROTONDA
A proposito degli studi storico-giuridici sul Costituto in volgaredel 1309-10, di Paolo Nardi » 295
A proposito di un governo che decide di parlare in volgare,di Giovanni Cherubini » 301
A proposito di regimi di Popolo, oligarchie e bene comune,di Giuliano Catoni » 307
BIBLIOGRAFIA E FONTI EDITE » 313
11
PREFAZIONE
È una autentica gioia vedere finalmente pubblicati gli atti del convegno tenuto, nell’aprile 2010, durante le celebrazioni del sette-centesimo anniversario della traduzione dal latino al volgare italia-no del Costituto, una raccolta di norme ‘costitute’ cioè deliberate dal Comune di Siena. Si tratta di un testo stupendo nei suoi contenuti legislativi e superbo nella sua godibilissima lingua, nella bella scrit-tura e nelle miniature che ornano il codice, conservato oggi nell’Ar-chivio di Stato di Siena.
Il Costituto, frutto di un lavoro di traduzione che si protrasse dal 1309 al 1310, non certo per caso vanta due impegnative e prege-voli edizioni, l’unico tra gli statuti del Comune di Siena ad aver avu-to questo privilegio. La prima, peraltro già eccellente, risale al 1903 e fu curata da Alessandro Lisini, che era allora direttore dell’Archi-vio di Stato di Siena, sotto gli auspici del Ministero dell’Interno1. La seconda impegnativa edizione è stata promossa nel 2002 dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, curata dal filologo Mahmoud Salem Elsheikh2, membro dell’Accademia della Crusca, e arricchita da imponenti indici di nomi di persona e di luogo, glossario, sog-gettario, e completata da una serie di saggi di commento di Attilio Bartoli Langeli, paleografo e storico della scrittura (I manoscritti del Costituto), Mario Ascheri, storico della cultura giuridica e delle isti-tuzioni (Il Costituto di Siena fondamento del «Buongoverno»), Enzo Mecacci, codicologo (Gli statuti del periodo dei Nove).
Gli anni del settecentesimo anniversario hanno poi visto una serie di iniziative editoriali di diversa fisionomia: sono stati pub-blicati gli Atti di una giornata di studio organizzata dall’Accademia senese degli Intronati, curati da Enzo Mecacci e Marco Pierini, e due agili volumetti, il primo di Mario Ascheri e Cecilia Papi, il secondo di Duccio Balestracci, quest’ultimo corredato da un saggio del costi-tuzionalista Enzo Cheli, a sottolineare il valore del testo senese nel complesso percorso che, nel mondo occidentale, trasforma il costi-tuzionalismo antico in quello moderno (Il Costituto del Comune di
1 Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX, sotto gli au-spici del Ministero dell’Interno, a cura di A. Lisini, Siena, Tipografia e litografia Sordomuti di L. Lazzeri, 1903, voll. 2.
2 Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX, edizione critica a cura di M.S. Elsheikh, Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 2002, voll. 4.
12
SIENA NELLO SPECCHIO DEL SUO COSTITUTO IN VOLGARE DEL 1309-10
Siena, tappa nel percorso del costituzionalismo antico e moderno)3. Lo spunto per quest’ultima riflessione è ben noto, perché la volga-rizzazione del Costituto, scritto «de bona lictera crossa bene legibili et bene formata in bonis cartis pecudinis», era stata voluta perché esso potesse essere letto facilmente anche dalle «povare persone et altre persone che non sanno grammatica», cioè che non conosceva-no il latino; o almeno così si voleva far credere, dato che è proba-bile che tra coloro che facevano fatica con un testo latino ci fossero prima di tutto molti membri del ceto dirigente. Si tratta, comunque, di un principio importante che parlava della necessità di favorire la diffusione e la conoscenza del diritto in Siena, e di esso è dunque opportuno sottolineare il significato civico. Infine nell’ottobre 2010 si è tenuto un altro convegno (se ne attende la pubblicazione de-gli atti), dal titolo Beata Civitas. Pubblica pietà e devozioni private nella Siena del ’300, che ha colto l’occasione delle celebrazioni per il settimo centenario del Costituto insieme alla recente canonizza-zione di san Bernardo Tolomei per richiamare il ruolo della pietas quale componente etica del sistema civico medievale, perché l’orga-nizzazione comunale, specialmente nelle fasi di maggiore consape-volezza istituzionale, avocò a sé buona parte della rappresentazione del sacro cittadino e la gestione pubblica della devozione e della misericordia private, assumendosene, come soggetto collettivo, la piena responsabilità.
Il Costituto del Comune di Siena del 1309-10, come si vede, è un complesso normativo molto studiato. Ma, in mezzo ai tanti studi, il convegno scientifico del quale qui si pubblicano gli atti si differenzia dalle altre iniziative per aver posto l’accento non tanto sul testo in sé quanto sull’immagine della città che esso ci tramanda. Siena, come recita il titolo, ‘si specchia’ nel suo Costituto. Certo, an-che il Costituto del 1309-10, come ogni raccolta normativa, racconta un ‘dover essere’, più che una realtà. Esso, tuttavia, ad una attenta lettura si trasforma in una fonte quasi inesauribile di informazioni che, negli interventi che si leggono in questo volume, vengono sa-pientemente integrate da tutto il ricchissimo complesso documenta-rio che è conservato nell’Archivio di Stato di Siena e con il grande
3 Dagli Statuti dei Ghibellini al Constituto in volgare dei Nove con una riflessione sull’età contemporanea, Atti della giornata di studio dedicata al VII Centenario del Constituto in volgare del 1309-1310 (Siena, 20 aprile 2009), a cura di E. Mecacci e M. Pierini, Siena, Accademia senese degli Intronati, 2009; M. ASCHERI - C. PAPI, Il «Costituto» del Comune di Siena in volgare (1309-1310). Un episodio di storia della giustizia?, Firenze, Aska, 2009; D. BALESTRACCI, Il potere e la parola. Guida al Costituto volgarizzato di Siena (1309-1310), con un saggio di Enzo Cheli, Siena, Protagon editori Toscani per Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 2011.
13
PREFAZIONE
documento materiale rappresentato dalla intera città di Siena. Una scorsa all’indice è sufficiente per comprendere la vastità dei temi trattati, che spaziano dalla politica, all’economia, al diritto, all’edili-zia e al decoro dello spazio urbano, alla società urbana, all’emergere di ideali civici, alle forme della protesta sociale, alla religione civica, alla lingua4, come contributo alla storia formidabile dell’Italia comu-nale del primo Trecento.
Gabriella PiccinniDirettrice del Dipartimento di Scienze Storiche e
dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Siena
4 Come spesso accade nelle edizioni degli atti dei convegni, per motivi vari mancano due contributi di quelli che erano stati presentati oralmente, di Duccio Balestracci su Le forze produttive e la loro organizzazione e Maria Ginatempo su Città e contado: il sistema fiscale (fine ’200-metà ’300), oltre all’intervento di Andrea Zorzi alla tavola rotonda finale.
15
SIENA 1309-1310: IL CONTESTO
di Gabriella Piccinni
Quando ’mezzani diventan tiranniprieghi Iddio la città che.lla guardi
dalli affamati e pessimi liopardiche hanno assaggiato el giglio e san Giovanni1.
Con questi versi un poeta senese di nome Bindo Bonichi, vis-suto a cavallo tra XIII e XIV secolo, puntava il dito contro coloro che chiamava i mezzani e che a Siena esprimevano la guida politi-ca della città. Quello che noi denominiamo ‘governo dei Nove’ era espresso, infatti, da un gruppo che si autodefiniva di «mercanti della città di Siena o vero de la meza gente»2. Esso si presentava, dunque, con una connotazione professionale e di ceto, situando la propria posizione nel corpo sociale a metà strada tra i ricchi e i poveri, come aveva spiegato tra 1277 e 1279 il filosofo politico Egidio Ro-mano al futuro re Filippo il Bello3: cioè, nel caso senese, a metà tra
1 L’edizione critica delle rime di Bindo Bonichi (per le quali si dispone del vecchio Rime di Bindo Bonichi da Siena, a cura di L. Banchi, Bologna, Romagnoli, 1867) è in corso di stampa per le Edizioni del Galluzzo-Fondazione Ezio Franceschini, a cura di Fabio Zinelli (in LirIO. Corpus della lirica italiana delle Origini su cd-rom, 1. Dagli inizi al 1337, a cura di Lino Leonardi et alii), che ringrazio sia del fruttuoso scambio di idee che dell’anteprima dei pochi testi che qui utilizzo. Con il giglio e San Giovanni si intende la moneta fiorentina, il fiorino d’oro, che aveva appunto su un lato l’emblema della città, il giglio, e sull’altro l’effige del suo santo protettore; e forse si allude, più in generale, ad una accentuazione dei rapporti dei governi noveschi con il governo di Firenze.
2 Le definizioni dei Nove suonano tutte allo stesso modo: «sint et esse debeant de mercatoribus et de numero mercatorum civitatis senensis vel de media gente»; «mercanti della città di Siena o vero de la meza gente» o della «gente media», «do-mini Novem […] sint et esse debeant de mercatoribus et de numero mercatorum civitatis Senarum vel de media gente» (La norma del 1287 è citata da W. BOWSKY, Un comune italiano nel Medioevo, Siena sotto il regime dei Nove (1287-1355), trad. it., Bologna 1986, p. 107; per le altre Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX, ediz. critica a cura di M. Salem Elsheikh, Siena, Fondazione Monte dei Paschi, 2002, D. VI, r. 5, vol. II, p. 535 e Archivio di Stato di Siena (da ora ASS), Consiglio Generale 91, cc. 139v-140, dicembre 1318). Ma per tutto questo più riccamente vedi il saggio di Sergio Raveggi in questo stesso volume.
3 Egidio Romano, allievo di Tommaso d’Aquino, discutendo delle «signorie, e quali sono buone e quali sono rie» scrive tra le altre cose: «La quinta signoria si è quan-do la città ha molti signori, sì come tutto ’l popolo; e sed essa entende el bene dei povari e dei mezzani e dei ricchi, e di ciascuno secondo el suo estato, cotale signoria è buona, e la potemo chiamare covernamento di popolo; e sed elli aviene
16
SIENA NELLO SPECCHIO DEL SUO COSTITUTO IN VOLGARE DEL 1309-10
i casati magnatizi da una parte e, dall’altra, il popolo artigiano e la multiforme plebe dei salariati e dei marginali. Di Popolo, dunque, i Nove, – cioè non-nobili, potremmo dire, insieme a Brunetto Latini, ‘borghesi’4 – però anche non-artigiani; di ceto medio, secondo loro, o più probabilmente medio-alto, secondo noi; in più, di orientamen-to filopapale nello scacchiere delle alleanze.
Grazie agli studi di William Bowsky, peraltro grande utilizzato-re del Costituto volgarizzato, conosciamo piuttosto bene i Nove. Si trattava di un governo scaturito dalla crisi degli equilibri politici in cui la città era precipitata nel cuore del XIII secolo, quando aveva affrontato il conflitto tra le fazioni interne, con il drammatico stra-scico di due ondate di fuoruscitismo, resa dei conti, repressione5; quando il papa aveva dichiarato la cancellazione dei crediti delle compagnie senesi in tutto il mondo e gli uomini d’affari che agiva-no su un raggio europeo e soprattutto nelle aree francesi, inglesi e fiamminghe in cui il papato era influente6, spesso nobili di casato, fossero di più calda o di più tiepida osservanza filosveva, si erano
che ’l popolo nonne entenda el bene di ciascuno secondo el suo estato, anzi voglia esser tiranno e tollare el loro ai ricchi, cotale signoria non è buona, e chiamala el Filosafo perversità e malvagità di popolo; donde noi vedemo comunemente che le città d’Italia, che tutto ’l popolo è a chiamare ed elleggere el signore e a punirlo quand’elli fa male, e che tutto chiamin ellino alcuno signore che li governi, tuttavia el popolo è più signore di lui, perciò ch’esso l’elegge ed esso el punisce quand’elli fa male. Donde en questo capitolo appare quante maniere di signorie sono, e quali sono buone e rie»: Egidio Romano, Versione del «Livre du gouvernement des rois» (De regimine principum), in La prosa del Duecento, a cura di C. Segre - M. Marti, in La Letteratura italiana. Storia e testi, vol. 3, Milano-Napoli, Ricciardi, 1959, pp. 267-295, libro III, parte II, alle pp. 271-273, di recente commentato da A. Zorzi, Le signorie cittadine in Italia (secoli XIII-XV), Milano, Bruno Mondadori, 2010. Il volume di Zorzi va oltre il fine didattico che si propone e dichiara, e ad esso dunque mi riferisco come alla più recente sintesi sulle signorie italiane. Il volgarizzamento del trattato di Egidio ebbe vasta diffusione in Italia, anzi la sua prima versione italiana, del 1288, fu compilata proprio in area senese e «intercettò la diffusa attenzione per la tradizione della letteratura retorica e morale sui trattati di governo che aveva accompagnato l’evoluzione della cultura politica comunale sin all’affermazione del regime podestarile» (ivi, p. 79). Il termine mezzani si trova, per fare un altro esempio, anche nella cronaca di Dino Compagni, che la scrisse tra il 1310 e il 1312 (Dino Compagni, Cronica, a cura di D. Cappi, in Fonti per la storia dell’Italia medievale. Rerum Italicarum scriptores, vol. 1, Roma 2000).
4 Brunetto usa bourgeois per indicare il mezzano: BRUNETTO LATINI, Tresor, a cura di P.G. Beltrami - P. Squillacioti - P. Torri e S. Vatteroni, Torino, Einaudi, 2007.
5 A. GIORGI, Il conflitto magnati/popolani nelle campagne. Il caso senese, in Magnati e popolani nell’Italia comunale, Pistoia, Centro Italiano di Studi di Storia e d’Arte, 1997, p. 151.
6 P. CAMMAROSANO, Tradizione documentaria e storia cittadina, in Il Caleffo Vecchio del Comune di Siena, vol. V, Siena, Accademia senese degli Intronati, 1991, p. 71.
17
SIENA 1309-1310: IL CONTESTO
scoperti quasi tutti guelfi nella borsa7; quando, infine, dopo gli anni più rabbiosi del conflitto interno, si era aperto un processo di ricon-ciliazione che, come scrive Roberta Mucciarelli, aveva reclamato «il sacrificio di tutto un modo di intendere l’azione politica […] nutrito di attitudini aggressive, di vocazione al dominio e di concezione fa-miliare del potere che era proprio dei vecchi ceti dirigenti urbani»8. I magnati vi avevano partecipato, anche se poi avevano accettato la propria esclusione dai collegi di governo (1277), tuttavia ben negoziandola in forza del proprio contributo nelle magistrature fi-nanziarie, nelle quali le loro ricchezze personali rappresentavano una garanzia della quale nessun governo, per quanto convintamen-te popolare, avrebbe potuto all’epoca fare a meno. Il mondo artigia-no, escluso dal governo, pur se nella pratica ne fece parte qualche lanaiolo più influente, non era stato invece in grado di negoziare granché9.
Nonostante tutto, nel 1310, mentre si concludeva il volgariz-zamento del Costituto, la città non era pacificata. In nome della turbolenza dei magnati venivano riorganizzate le milizie del Popo-lo e messi in sicurezza con catene i ‘luoghi sensibili’ della città10. Nell’autunno del 1311 la continuazione dell’esperienza novesca era messa in forse da un gruppo di congiurati «in non modica quanti-tate, tam de nobilibus et magnatibus quam de popularibus»11. Pochi mesi dopo, nel gennaio 1312, mentre la presenza alle porte di Siena delle truppe imperiali poteva rendere concreta una prospettiva di cambiamento, i Nove ordinavano che gli accessi al Campo fossero blindati con le catene («Diliberoro per la forteza de la città, di fare le catene e incatenare tutta la città»12). E pensare che da soli due anni l’esecutivo si era installato nel Palazzo Pubblico che aveva acquisito quella forma così peculiare e spalancava le sue ali ad abbracciarlo.
7 Per la ricostruzione di questa fase si vedano ora R. MUCCIARELLI, Il traghettamento dei «mercatores». Dal fronte imperiale alla pars ecclesiae, in Fedeltà ghibellina affari guelfi. Saggi e riletture intorno alla storia di Siena fra Due e Trecento, a cura di G. Piccinni, voll. 2, Pisa, Pacini Editore, 2008, pp. 61-102 e S. RAVEGGI, Siena nell’Italia dei guelfi e dei ghibellini, ivi, pp. 29-61.
8 MUCCIARELLI, Il traghettamento dei «mercatores» cit., p. 95.9 BOWSKY, Un comune italiano cit., pp. 113-116; M. ASCHERI, Arti, mercanti e Mercan-
zie: il caso di Siena, in ID., Siena nel Rinascimento. Istituzioni e sistema politico, Siena, il Leccio, 1985, pp. 109-137.
10 ASS, Consiglio Generale 76 cc. 140-142 e D. CIAMPOLI, Il Capitano del popolo a Sie-na nel primo Trecento, introduzione di M. Ascheri, Siena, Consorzio Universitario della Toscana Meridionale, 1984, pp. 30-31.
11 ASS, Consiglio Generale 79, c. 106 (1311, ottobre 4).12 Cronaca senese attribuita a Agnolo di Tura del Grasso detta la Cronaca Maggiore,
in Cronache senesi, a cura di A. Lisini e F. Iacometti, in Rerum Italicarum Scripto-res, tomo XV, parte VI, Bologna, Zanichelli 1931-1939, p. 330.
18
SIENA NELLO SPECCHIO DEL SUO COSTITUTO IN VOLGARE DEL 1309-10
Avanziamo ancora di tre anni. Nel 1315, al termine di una delle tante zuffe tra Salimbeni e Tolomei, fu decapitato uno dei campa-gnoli che avevano eluso il bando di ingresso, nonostante fosse stato difeso da una gragnola di sassi contro le milizie del Podestà: la sua testa venne lanciata nel Campo da una finestra del palazzo. Il gesto, orribile e ingiusto, fu anche un errore politico perché, invece di ribadire la forza del governo, fece esplodere la rabbia nei suoi con-fronti «che poco mancò che non si mutò regimento»13.
A carnevale 1318 una seconda violenta sassaiola piombò sul Podestà e i Nove, dopo che un gioco «di pugna» era degenerato in una nuova battaglia14. Dopo pochi mesi alcuni magnati, giudici, notai, macellai, fabbri ed altri della plebe, disse il cronista, «insie-me fecer congiura d’ammazzare i Nove che risedevano allora nel magistrato […] domandando, con l’arme in mano, di partecipare al Governo»15. Alla domanda di allargamento della base sociale del go-verno si unirono molti «popolari minuti», dunque il popolo artigia-no. Dall’insieme minaccioso di circa 300 uomini, armati anche con arnesi da lavoro, si levò il grido: «rompiamo le catene e rompiamo la porta del palazo de’ Nove e le loro case e buttighe di certi ricchi!»16. L’attacco fu represso con le armi. La congiura, finora trascurata dal-la storiografia ma sulla quale sta lavorando Valentina Costantini17, dette forma politica al malcontento e – per la prima e forse unica volta – mise davvero in pericolo il regime novesco.
A dicembre si tenne infatti una seduta infuocata del Consiglio18, che il cronista interpreta però come una messa in scena «per dare pastura agli artefici e tenerli in isperanza […] d’essare per l’avenire de’ Nove»19. Una riunione di partito, dove ben 109 noveschi avevano discusso su come affrontare il malcontento, decise quasi all’una-nimità (104 contro 5) che il governo ponesse la fiducia invitando
13 Cronaca senese attribuita a Agnolo di Tura cit., pp. 349-350. Per i due casati, si vedano le monografie di A. CARNIANI, I Salimbeni quasi una signoria. Tentativi di affermazione politica nella Siena del ’300, Siena, Protagon, 1995, e R. MUCCIARELLI, I Tolomei banchieri di Siena. La parabola di un casato nel XIII e XIV secolo, Siena, Protagon, 1995.
14 Cronaca senese attribuita a Agnolo di Tura cit., p. 370. Per le battaglie cittadine, si veda D. BALESTRACCI, La festa in armi: giostre, tornei e giochi del Medioevo, Roma-Bari, Laterza, 2001.
15 O. MALAVOLTI, Dell’historia di Siena, Bologna, Forni, 1982, p. 80.16 Cronaca senese attribuita a Agnolo di Tura cit., p. 372; ASS, Consiglio Generale 92,
c. 164v (1319, dicembre 13).17 Vedi il saggio in questo stesso volume V. COSTANTINI, Tra lavoro e rivolta: i carnaioli
e EAD., Siena 1318: la congiura di carnaioli, notai e magnati contro il governo dei Nove, «Studi Storici», LII (2011), pp. 229-252.
18 Tutta la questione è trattata da BOWSKY, Un comune italiano cit., p. 109-110.19 Cronaca senese attribuita a Agnolo di Tura cit., pp. 373-374.
19
SIENA 1309-1310: IL CONTESTO
il Consiglio a votare se la signoria «dovesse continuare o essere cambiata e che genere di persone dovesse servire nella signoria e con quali caratteristiche». La questione aveva come premessa che «alcune persone della città di Siena, di diverse condizioni sociali, de-siderano un cambiamento e vogliono cambiare il governo del detto ufficio, appaiono attualmente scontente».
A soccorso dei Nove corsero alcuni magnati. Una mozione pre-sentata dal capofila del casato dei Salimbeni, tra i più ricchi e au-torevoli della città, propose che l’ufficio di governo «sia retto e go-vernato dalla mezzana gente come è stato giustamente governato in passato». La mozione passò con 298 voti favorevoli contro 140 con-trari, questi ultimi coagulati intorno ad un altro magnate, questa vol-ta un Piccolomini. L’opposizione poté dunque contare le sue forze, che non erano esigue tanto più se si considera che i Nove avevano il controllo della composizione dell’assemblea, ma non bastarono per partorire alcun allargamento verso il basso del blocco sociale che partecipava al governo e della sua base politica, anche se fu leg-germente ampliato l’elenco degli eleggibili20. Il consenso incontrato dalla mozione-Salimbeni mostra invece qualcosa di importante in direzione dei ceti più alti: cioè che un gruppo influente di magnati decideva di collaborare al governo della città, e confermava il pro-prio appoggio esterno alla continuità del regime novesco. Ma poi «gli artefici e popolo minuto e i più dei grandi si tenero ingannati e furo poi più malcontenti che prima»21.
Va detto che, come molti dei nati nella generazione che a Siena chiameremmo di Montaperti, Bindo Bonichi aveva fatto in tempo a conoscere una città molto diversa, prima di tutto perché i circa 25.000 abitanti che contava, più o meno, al momento della sua na-scita erano quasi raddoppiati nella sua maturità. Con inquietudine registrava il cambiamento connesso ad una fase di forte mobilità professionale: quando «El calzolaio fa ’l figliuolo barbiere, / così ’l barbier fa ’l figliuol calzolaio / e ’l mercatante fa ’l figliuol notaio, / così ’l notaio fa ’l figliuol drappiere.»
Bindo soprattutto ad un certo punto si trovò a rimpiangere il disinteresse dei Nove per come l’aveva – o credeva di averlo – co-nosciuto negli anni della giovinezza. Come Dante scriveva della sua Firenze22, Bindo segnalava i danni prodotti in Siena dal «maledetto
20 BOWSKY, Un comune italiano cit., p. 103.21 Ivi, p. 374.22 Si veda il saggio di S. CARRAI, Aspetti della letteratura toscana nei secoli XIII e XIV,
in Etruria, Tuscia, Toscana. L’identità di una regione attraverso i secoli, Ospeda-letto (PI), Pacini Editore, 1998, pp. 133-146. La citazione dantesca è DANTE ALIGHIERI, La Commedia, Inferno XVI e Paradiso IX.
20
SIENA NELLO SPECCHIO DEL SUO COSTITUTO IN VOLGARE DEL 1309-10
fiore», la splendida moneta d’oro che, da ardita impresa che aveva fornito uno strumento e un simbolo prestigioso alla partecipazione fiorentina ai grandi commerci23, si era trasformata in una fonte ine-sauribile di atti di orgoglio per gli arricchiti, con una perdita secca di ricchezza collettiva. Bindo ne aveva per tutti:
MERCANTI: Gli asin del mondo so’ li mercatanti GOVERNANTI: e li tiranni son leon’ maggiori / GIUDICI: chi ’n corte avoca so’ e’ can’ latranti / PRETI: e’ porci so’ e’ cherci e.male usanti/ e’ lupi so’ e’ malvagi pastori / MEMBRI DI CONSIGLI: ipocriti so’ e coniellatori.
E così via moraleggiando.
Anno più anno meno, quando Bindo maturava la sua critica, a Sassoferrato nasceva Bartolo (1314), colui che fu il più fine giurista dell’Italia comunale. Bartolo non aveva conosciuto i padri fondatori del regime novesco nella loro fisionomia originale di ‘mercanti di ceto medio’, e li definì per come gli apparivano nel 1355, a conclu-sione del loro cammino al governo di Siena: un ordo divitum ho-minum (ordine di uomini ricchi)24. Non magnati, certo, però ricchi.
I Nove, come abbiamo detto, governarono per una settantina di anni ed è inverosimile che essi rimanessero per questo lungo tempo sempre uguali a se stessi. Mettendo in sequenza generazionale le considerazioni di Bindo e quelle di Bartolo, i Nove, ad un certo pun-to della loro storia di governo, avrebbero tradito il proprio status di mezzani e il proprio mandato politico, tanto che il sistema sarebbe degenerato verso la tirannia politica del ceto medio. Per di più, il ceto medio non era più tale – se lo era mai stato – ma era, come
23 G. CHERUBINI, La Toscana di fronte all’Italia e all’Europa al tempo di Arnolfo di Cambio, in La Toscana ai tempi di Arnolfo, a cura di C. Bastianoni - G. Cherubini - G. Pinto, redazione di C. Nenci, Firenze, Olschki, 2005, pp. 175-190.
24 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Tractatus de regimine civitatis, in D. QUAGLIONI, Politica e diritto nel Trecento italiano. Il «De Tyranno» di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357), con l’edizione critica dei trattati «De Guelphis et Gebellinis», «De regimine civitatis» e «De Tyranno», Firenze, Olschki, 1983, p. 163: «Fuit enim annis fere lxxx. quidam ordo divitum hominum regentium civitatem bene et prudenter»; come si vede Bartolo colse subito la singolarità della lunga durata dei governi noveschi. Commentò il passo in questione G. SALVEMINI, La teoria di Bartolo da Sassoferrato sulle costituzioni politiche, ora in La dignità cavalleresca nel Comune di Firenze e altri scritti, a cura di E. Sestan, Milano, Feltrinelli, 1972, p. 336. Lo ha di nuovo segnalato M. ASCHERI, Siena sotto i «Nove» in un libro di W.M. Bowsky, «Nuovi studi cateriniani», 3 (1988), p. 132 e ID., La Siena del «Buon governo» (1287-1355), in Po-litica e cultura nelle repubbliche italiane dal Medioevo all’età moderna. Firenze, Genova, Lucca, Siena, Venezia, a cura di S. Adorni Braccesi e M. Ascheri, Roma, Istituto storico italiano per l’Età moderna e contemporanea 2001, p. 106.
21
SIENA 1309-1310: IL CONTESTO
dire, salito di grado. Bartolo confermava. Egli avrebbe infatti utiliz-zato l’esempio senese per spiegare che quando in una città l’autorità era in mano ai ricchi – ai ricchi, scrive, non ai mezzani – essi erano per forza di cose pochi, e dunque solo con la forza potevano mante-nere il potere: questo rendeva il sistema non buono sul piano gene-rale, anche se i Nove avevano retto la città, dice, bene et prudenter.
Il Bonichi, dal quale mi farò accompagnare in questa ricostru-zione, pare fosse nato tra gli anni Sessanta e Settanta del Duecento, ed era al massimo ventenne quando un gruppo determinato di mer-canti guelfi di ceto medio aveva mosso i primi passi verso il gover-no. Una escalation di impegni politici lo aveva portato dal Consiglio generale, dal 1299, tra i consoli di Mercanzia, dal 1307, e su su fino al collegio di governo al quale approdò per la prima volta proprio nel 130925. I mezzani, perciò, erano letteralmente la «sua» gente.
Bindo aveva fatto parte dei Nove a quanto ne sappiamo per l’ultima volta nell’autunno del 1318, le sue orecchie si erano pro-babilmente riempite dell’urlo della folla, aveva visto la testa volare dalla finestra e poi la guerriglia urbana intrecciarsi con le finezze della politica patteggiata, aveva assistito alla sceneggiata in consi-glio e poteva aver misurato, in quell’occasione drammatica, quanto gli stesse a cuore la natura non tirannica del potere: tirannico, nel lessico politico corrente e come spiegava Bartolo, era da conside-rare ogni dominio autoritario che non perseguisse il bene comune. Del resto già intorno al 1270 Tommaso d’Aquino aveva ammonito, nella sua Summa, che il regime tirannico non era giusto in quan-to non indirizzato al bene comune bensì a quello privato di chi governa.
La discussione sulla tirannide, del resto, era esplosa in tutta Italia con il fallimento della spedizione dell’imperatore Enrico VII nel 1310-1313, che anziché restaurare gli ordinamenti politici tra-dizionali della civiltà cittadina italiana legittimò con titoli vicariali l’affermazione, fino ad allora di incerta legalità, di molti signori e il loro esercizio tirannico del potere. E lo stesso Dante Alighieri non aveva risparmiato un aspro giudizio sulla natura tirannica dei regimi signorili cittadini – nonostante la protezione e il sostegno che essi gli avevano offerto – immortalandoli in un noto verso del Purgato-rio «Ché le città d’Italia tutte piene / son di tiranni»26.
La degenerazione del dominio della mezza gente Bindo la leg-geva, appunto, nelle tentazioni di tirannide (leggi signoria), ma non
25 La biografia di Bindo Bonichi è ricostruita da FABIO ZINELLI nell’edizione critica in corso di stampa.
26 DANTE ALIGHIERI, La Commedia, Purgatorio, VI, 124-125.
22
SIENA NELLO SPECCHIO DEL SUO COSTITUTO IN VOLGARE DEL 1309-10
di un singolo bensì di un ceto divenuto gruppo di potere. I toni disillusi dei suoi versi fanno ipotizzare che la vibrante denuncia uscisse dalla sua penna dopo quella data, quando sembra non ri-conoscersi più nella politica dei ‘mezzani’, perché arricchiti e inte-ressati, e rifugiarsi nella nostalgia di un passato più puro, quando essi non avevano ancora assaporato il gusto dei fiorini d’oro e non si erano mutati in tiranni pericolosi. Dopo alcuni anni, ancora ben attivo, Bindo si fece oblato della Casa della Misericordia.
Dunque cosa era accaduto, e quando?Utilizzando ancora il nostro compagno di viaggio, provo a cer-
care se qualcosa di davvero importante fosse avvenuto tra il suo primo e l’ultimo mandato tra i Nove, e dunque nel decennio che andò esattamente dal 1309 al 1318. Qualcosa che avesse fatto arric-chire ulteriormente i noveschi, avesse spinto il gruppo dirigente a serrare le file, avesse creato non la tirannia di un uomo forte, come in altre città nemmeno troppo lontane, bensì la signoria di fatto di un gruppo di potere.
Inizierò dall’evento numero uno, ricordando che proprio nel febbraio 1309 il Consiglio generale, con qualche opposizione, de-legò alla Mercanzia di confiscare le proprietà dei Bonsignori27, che erano i soci principali della compagnia di mercanti e banchieri se-nesi detta Gran Tavola. Si era allora alle battute conclusive di una travolgente crisi nella quale la società si dibatteva da undici anni. La delibera è considerata l’apertura ufficiale della liquidazione falli-mentare. Si trattò di un evento clamoroso che riempì di discussioni i verbali di molte sedute del Consiglio generale che nel solo giugno 1309 esaminò ben ventuno ricorsi di creditori dei Bonsignori. Tra i
27 L’apertura della procedura fallimentare si ebbe il 1 febbraio 1309, quando il Con-siglio generale incaricò la Mercanzia di confiscare e vendere le proprietà dei Bon-signori per pagare i debiti con il re e indennizzare i mercanti senesi vittime di rap-presaglie (ASS, Consiglio Generale 74, c. 70). La liquidazione dei debiti connessi al fallimento si trascinò per decenni: BOWSKY, Un comune italiano cit., pp. 341-355; E.D. ENGLISH, Enterprise and Liability in Sienese Banking, 1230-1350, Cambridge, Massachussetts, The Medieval Academy of America, 1988, pp. 55-100; MUCCIARELLI, I Tolomei cit., pp. 285-297. La normativa sui fallimenti, con le risoluzioni del 1312 e del 1319, fu poi accolta negli Statuti di Siena del 1337-1339. Si veda ora anche G. PICCINNI, Sede pontificia contro Bonsignori di Siena. Inchiesta intorno ad un fallimento bancario (1344), in L’età dei processi. Inchieste e condanne tra politica e ideologia nel ’300, Atti del convegno di studi svoltosi in occasione della XIX edi-zione del Premio internazionale Ascoli Piceno (30 novembre - 1 dicembre 2007) a cura di A. Rigon e F. Veronese, Roma, Istituto Storico italiano per il Medioevo, 2009, pp. 213-246. A quel mio lavoro e a EAD., Il banco dell’ospedale di Santa Maria della Scala e il mercato del denaro nella Siena del Trecento, Pisa, Pacini Editore, 2012, rinvio per le notizie e le considerazioni che seguono.
23
SIENA 1309-1310: IL CONTESTO
molti, che avevano già ricevuto rimborsi per 200.000 fiorini, e insie-me ai mercanti senesi vittime di rappresaglie all’estero, due creditori eccellenti erano rappresentati nientemeno che dal re di Francia28 e dal pontefice (per 80.000 fiorini): le somme che ballavano sui tavoli erano enormi, e solo considerando quei due numeri si arriva a più di tre volte quanto sarebbe servito al papa per comprare l’intera città di Avignone. La Gran Tavola, dunque, non era una società qualsiasi. Non solo era stata la più grande compagnia finanziaria senese – costruita anche con vari apporti societari esterni alla fa-miglia – ma anche una delle più importanti a livello europeo, e gli stessi soci non avevano mancato di farlo notare quando avevano chiesto il sostegno pubblico dichiarando con orgoglio: «ricordatevi sempre che tra le altre società di Toscana e Lombardia e di tutto il mondo la nostra è stata la più onorevole e nota, quella alla quale è stata data maggior fiducia dai pontefici, dai cardinali, dai patriarchi, dagli arcivescovi, dai vescovi e dai prelati, dai re, dai baroni, dai conti, dai mercanti e da tutti gli uomini, di qualunque condizione siano stati»29.
Non tutto, certo, era accaduto in un giorno, né finì da un giorno all’altro. Altre compagnie, come quelle di Piccolomini e Salimbeni, già avevano riconvertito i loro affari a scala locale. Dato che le società erano legate tutte tra sé, nel 1310 si fece evidente quello che gli economisti chiamano l’effetto domino30. A ruota si aggiunsero le crisi dei Tolomei, dei Gallerani (tra 1311 e 1317) e di altre società in un alternarsi di brevi periodi di ripresa e di nuovi tracolli31. In quegli anni le carceri europee, specie quelle francesi
28 Cronaca senese attribuita a Agnolo di Tura cit., p. 298.29 «Et ideo, licet credant vos scire, tamen ad memoriam vobis redu cunt quod inter
alias sotietates Tuscie, Lombardie, ac etiam totius mundi, ipsa fuit honorabilior omnibus aliis et magis nominata, et cui maior fides fuit adhibita a romanis pon-tificibus, a cardinalibus, patriarchis, archiepiscopis, episcopis et aliis ecclesiarum prelatis, a regibus, baronibus, comitibus, mercatoribus et aliis hominibus cuiu-scumque conditionis sint; etiam utilis, immo utilissima, Comuni Senarum in ro-mana Curia, ultra montes et citra montes, et ambassiatoribus Comunis Senarum ad expeditionem negotiorum pro quibus mictebantur, et etiam pro solutione pecunie tam pro ipsis negotiis expediendis quam pro eorum expensis»: edito in M. CHIAUDA-NO, I Rothschild del Duecento. La Gran Tavola di Orlando Bonsignori, «Bullettino senese di Storia Patria», VI (1935), pp. 135-139.
30 Nel 1310 Cino di Ugo e compagni, soci del banco omonimo, presentano una petizione al Consiglio generale riguardante il fallimento Bonsignori: BOWSKY, Un comune italiano cit., p. 347: ASS, Consiglio Generale 77, cc. 65-69.
31 Ad esempio alcuni discendenti degli antichi fondatori della società dei Tolomei decisero, proprio nel 1310, di costituirne una nuova, peraltro chiusa per debiti entro tre anni (MUCCIARELLI, I Tolomei cit., pp. 285-297). L’altalena si protrasse fino al 1338, quando una nuova crisi bancaria si manifestò in Siena in coincidenza con
24
SIENA NELLO SPECCHIO DEL SUO COSTITUTO IN VOLGARE DEL 1309-10
e fiamminghe, si riempirono di senesi, vuoi perché direttamente implicati in questioni debitorie, vuoi perché accusati di malver-sazione, vuoi perché colpiti da rappresaglie in nome di società di falliti32, ed è molto interessante che fosse senese uno dei due assessori che assistettero il commissario del re di Francia, quando, nello stesso 1309, a Parigi, inquisì un certo numero di banchieri e mercanti italiani33.
l’avvio della guerra dei Cent’anni, e al 1339 quando Benedetto XI affidò, a quanto se ne sa per l’ultima volta, ad una compagnia senese, quella dei Nicolucci, il po-tere di riscuotere fondi apostolici in Italia, Ungheria, Polonia e Romania. Si veda la sintesi in G. PICCINNI, Il sistema senese del credito nella fase di smobilitazione dei suoi banchi internazionali. Politiche comunali, spesa pubblica, propaganda contro l’usura (1332-1340), in Fedeltà ghibellina affari guelfi. Saggi e riletture intorno alla storia di Siena fra Due e Trecento, a cura di G. Piccinni, Pisa, Pacini Editore, 2008, pp. 209-289.
32 Il 28 maggio 1291 Nicola IV chiese la liberazione dei mercanti italiani della Ca-mera imprigionati da Filippo il Bello «et specialiter illos de scocietatibus filiorum Bonsignoris de Senis», e il 1 ottobre 1291 e 15 marzo 1292 insistette per la loro liberazione: Les Registres de Nicolas IV, a cura di E. Langlois, I, Paris 1905, nn. 7326, 7384, 7393. Nel 1307 il re di Francia per rappresaglia contro i debiti dei Bonsignori nei suoi confronti fece imprigionare dei senesi presenti nel territorio: dati in R-H. BAUTIER, I lombardi e i problemi del credito nel regno di Francia nei secoli XII e XIV, ora in L’uomo del banco dei pegni. «Lombardi» e mercato del denaro nell’Europa medievale, a cura di R. Bordone, Torino, Scriptorium 1997, pp. 31-35 (trad. it. di ID., Les Lombards et les problèmes du crèdit en France aux XIIIe et au XIVe siècles, in Rapporti culturali ed economici tra Italia e Francia nei secoli dal XIV al XVI, Roma 1979), che riporta anche una serie di più antichi e più recenti provvedimen-ti di reazione che più volte spinse le autorità inglesi, francesi e catalane contro i prestatori «lombardi» con il pretesto della loro voracità usuraria. Nel 1310 uno dei soci del banco di Ugo Cinughi, Cione di Filippo, si trovava in prigioni francesi per insolvenza (BOWSKY, Un comune italiano cit., p. 347; ASS, Consiglio Generale 77, cc. 65-69). Di recente Roberta Cella ha pubblicato tre stupende lettere al figlio Pie-tro di Ranieri (socio della compagnia dei Gallerani) finito in prigione a Genova per debiti nel 1307, aggiungendo nuovi dati sull’accusa di malversazione dalla quale è colpito in Fiandra Tommaso Fini nel 1309: R. CELLA, Le carte della filiale londinese della compagnia dei Gallerani e una Ricordanza di Biagio Aldobrandini (ottobre 1305), «Bollettino dell’Opera del Vocabolario Italiano», VIII (2003), pp. 403-414; EAD., Libri, conti e lettere della Compagnia senese dei Gallerani. I testi, Pisa, Edi-zioni ETS, 2005; EAD., La documentazione Gallerani-Fini nell’Archivio di Stato di Gent (1304-1309), Firenze, Sismel Edizioni del Galluzzo, 2009. Per altri senesi imprigionati si veda anche Q. SENIGAGLIA, Le compagnie bancarie senesi nei secoli XIII-XIV, Torino, Bocca, 1908, p. 15. Ricostruisco la biografia di Pietro Ranieri, nella seconda parte della sua vita oblato dell’ospedale di Santa Maria della Scala, in PICCINNI, Il banco dell’ospedale di Santa Maria della Scala cit., pp. 144-154, nel paragrafo dal titolo Piccola storia di Pietro Ranieri: da agente dei Gallerani in Francia a frate Piero al banco dell’ospedale.
33 BAUTIER, I lombardi e i problemi del credito cit., p. 45. Il senese è Francesco Iacobi, probabilmente un socio Tolomei: CELLA, La documentazione Gallerani-Fini cit., p. 357.
25
SIENA 1309-1310: IL CONTESTO
Fin dall’avvio della crisi i soci estranei alla famiglia avevano chiesto, in deroga alle norme vigenti nella città, che i ‘correntisti’ fossero rimborsati secondo un principio di responsabilità limitata, anziché illimitata. Ne avevano ottenuto uno scandalizzato rifiuto: la normativa che troviamo nel Costituto nel 1310 ribadiva, così, che i creditori potevano rifarsi innanzi tutto sul patrimonio della società, ma in subordine anche su quello particolare dei soci34. Però le socie-tà in nome collettivo funzionano solo finché tra i soci c’è la fiducia e in questo frangente sembra proprio che fosse stata questa a venir meno, soprattutto tra quelli esterni alla famiglia. Divenne irrinuncia-bile, perciò, una riflessione sui limiti della normativa sui fallimenti che fu infatti perfezionata negli anni successivi (tra 1312 e il 1318)35.
Quello nel quale il fallimento della Gran Tavola si inserì fu, per-ciò, un potente processo di de-internazionalizzazione della banca senese, sulle cui molte motivazioni generali non mi fermo qui, se non per ricordare che nel 1306 il pontefice per qualche anno fece eseguire in curia le operazioni finanziarie delegate fino ad allora alle società toscane36. Mi pare che questi elementi di crisi genera-le abbiano avuto in Siena conseguenze particolarmente gravi, non solo per la consistenza delle somme in ballo, ma soprattutto a cau-sa della struttura tutto sommato monocorde dell’economia senese: finché le era stato possibile, la città aveva infatti costruito quasi interamente la sua clamorosa fortuna sui flussi di denaro che la col-legavano a Roma e all’Europa, e non si era mai preoccupata davvero di darsi una struttura produttiva continuativa in grado di fornirle una spina dorsale alla quale agganciare l’economia finanziaria, che avrebbe potuto permettere almeno di ammortizzare le inevitabili fasi di debolezza o di crisi37, come avvenne a Firenze, dove meglio si diversificarono gli investimenti.
Poteva un processo di questa portata avere conseguenze solo per i soci debitori e i creditori in attesa di rimborso? Non credo. Se assumiamo, perciò, il 1309 come metafora – ma non si trattò solo di una metafora – per la fine della stagione internazionale della banca
34 A. ARCANGELI, Gli istituti del diritto commerciale nel costituto senese del 1310, in ID., Scritti del diritto commerciale ed agrario, I, Padova, Cedam, 1935, II, p. 350.
35 BOWSKY, Un comune italiano cit., p. 353.36 Dal 1306 al 1314: D. DEGRASSI, I rapporti tra compagnie bancarie toscane e patriar-
chi d’Aquileia (metà XIII-metà XIV secolo), in I toscani in Friuli, a cura di A. Mal-cangi, Firenze, 1992, pp. 169-199, alla p. 189; Y. RENOUARD, Les relations des Papes d’Avignon et des Compagnies commerciales et bancaires de 1316 à 1378, Paris, E. de Boccard, 1941 (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, 151), pp. 94-98.
37 G. PICCINNI, Come introduzione. Gli anni delle svolte, in Fedeltà ghibellina affari guelfi cit., pp. 9-28.
26
SIENA NELLO SPECCHIO DEL SUO COSTITUTO IN VOLGARE DEL 1309-10
senese, il fondale contro il quale vediamo muoversi i nostri attori diventa quello di un frenetico cambio di scala, riconversione, diver-sificazione degli investimenti, tesaurizzazione, normazione.
I Nove si trovarono a gestire questa fase cruciale, quando alcu-ne delle condizioni che avevano fatto la fortuna delle società d’affari del Duecento, e con esse quella della città, venivano meno. Doveva-no dunque reagire.
Prima di tutto si preoccuparono di proteggere le ricchezze di coloro che avevano fallito. La Mercanzia, che curò fin dall’inizio i fallimenti per conto del Comune, e che ebbe l’enorme potere di esa-minare le ragioni dei debitori e dei creditori e fissare l’ammontare e le modalità dei rimborsi, si preoccupò di salvaguardare i patrimoni dei soci più degli interessi dei creditori. Alcuni di questi ultimi pre-sentarono ricorso (1310) perché i curatori li avevano indennizzati con certi castelli, fortezze, terre e rocche, pur di gran valore, dei quali però non riuscivano ad entrare in possesso perché i Bonsi-gnori continuavano ad opporre resistenza e a non consegnarli38; la-mentavano anche che una parte dei beni personali dei soci era stata esclusa qualche anno prima dalla massa fallimentare perché si era dichiarato che proveniva dalle doti delle loro mogli e nuore. Ovvia-mente poteva essere vero che si trattasse di beni delle donne, e che dunque metterli al riparo dalle rivendicazioni dei creditori fosse una scelta di giustizia, ma in ogni caso trentaquattro anni dopo ancora la si ricordava come una decisione scottante e contestata39. Del resto delle compagnie era socio anche un certo numero di noveschi40, e una tendenza generale ne vedeva molti, Bindo compreso, sposare figlie di magnati, talvolta anche di membri di compagnie fallite41, ed è impensabile che in questi casi il padre della sposa non si consul-tasse con familiari e amici sulla scelta del futuro genero.
Ancora non bastava. Era fondamentale che più soldi possibile rimanessero in patria, e dunque si discusse molto se dare ai credi-
38 BOWSKY, Un comune italiano cit., pp. 347-348.39 Ricostruisco la vicenda in PICCINNI, Sede pontificia contro Bonsignori di Siena cit.40 BOWSKY, Un comune italiano cit., p. 120.41 Solo a titolo di esempio ricordo Mino di Cino Cinughi, novesco, a partire proprio
dal 1310 più volte Provveditore di Biccherna ed Esecutore di Gabella, membro egli stesso di una famiglia di prestatori, che aveva sposato Meuccia di messer Orlando Malavolti nel 1295 ed era, quindi, cognato di quel Meo di messer Orlando che era stato tra i soci Bonsignori che nel 1298 avevano chiesto al Comune la dilazione del termine fissato per i rimborsi. Traggo le informazioni da L. BANCHI, I Rettori dello Spedale di Santa Maria della Scala di Siena, Bologna, Tipografia Fava e Garagna-ni, 1877 e dal data base su Gli uomini di governo al tempo dei Nove, di prossima pubblicazione a cura di S. Raveggi e A. Zombardo. Mino sarebbe stato dei Nove nel 1323: CHIAUDANO, I Rothschild del Duecento cit., pp. 122-123.
27
SIENA 1309-1310: IL CONTESTO
tori senesi la precedenza su quelli stranieri42, provocando le ire e le rappresaglie del re di Francia.
Sia come sia, questa operazione di protezione del patrimo-nio immobiliare e fondiario dei titolari della compagnie in cri-si riuscì talmente bene che quello dei membri di quattro casati (Bonsignori, Tolomei, Salimbeni, Gallerani) nel 1316-20 rappre-sentava ancora un buon quinto (il 20,2%) di quello in mano a tutti i cittadini43.
I Nove, inoltre, blindarono l’archivio della Gran Tavola, dove si trovavano le prove dei debiti, e lo stesso fecero per quello dei Tolomei, ambedue prima sequestrati44 e infine lasciati a marcire, sospetto non senza malizia, nelle cantine di San Domenico45.
La gestione del fallimento della Gran Tavola mi pare uno snodo fondamentale per le nuove alleanze sociali e politiche strette dai Nove. Appena qualche mese prima, nel 1308, il Comu-ne aveva comprato un palazzo sul Campo, pagandone tre quarti, da Ciampolo Gallerani, che era il suocero di un Buonsignori e titolare a sua volta di una compagnia che proprio nel 1309 incon-trava serie difficoltà in Fiandra46. In esso trovò sede la Mercanzia
42 Il tema controverso della concessione o meno della priorità di risarcimento ai creditori senesi aveva provocato discussioni fin dal 1301 (D. WALEY, Siena e i senesi nel XIII secolo, Siena, Nuova immagine, 2003, p. 61, BOWSKY, Un comune italiano cit., pp. 267-268, 350, 353-354). Per la protezione dei diritti dei creditori nel Costi-tuto del 1309 vedi SENIGAGLIA, Le compagnie cit., p. 69. Nel 1337 fu data la priorità di risarcimento ai senesi difendendoli dalle rivendicazioni di stranieri nonostante che gli statuti garantissero i diritti di questi ultimi.
43 La proporzione scende di poco (al 19,1%) se alla ricchezza privata si aggiunge quel-la degli enti e dell’Arte della Lana: G. CHERUBINI, Proprietari, contadini e campagne senesi all’inizio del Trecento, in ID., Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana del basso Medioevo, Firenze, La Nuova Italia, 1974, pp. 248-251.
44 Il 9 aprile del 1302, in occasione dell’incarico dato dal Consiglio alla Mercanzia di nominare una commissione ad hoc, Federico di Rinaldo Tolomei cercò di arginare la possibilità che i libri di amministrazione della compagnia fossero sequestrati (ASS, Consiglio Generale 61, cc. 80-83v cit. da ENGLISH, Enterprise cit., p. 66). Il 26-27 aprile 1312 il Consiglio, chiamato a deliberare sulla richiesta di moratoria nella soddisfazione dei propri creditori, avanzata da soci Tolomei, concedette loro quattro mesi di tempo, trascorsi i quali il Podestà avrebbe potuto perseguirli a richiesta di ogni creditore che presentasse domanda valida: qualsiasi annotazione nei libri della compagnia e qualsiasi lettera di cambio poteva essere prodotta come prova dal creditore mentre il debitore poteva difendersi solo con un contratto di annullamento o una quietanza di pagamento. La questione è trattata da MUCCIARELLI, I Tolomei cit., pp. 290-291; il verbale della riunione è in ASS, Consiglio Generale 80, cc. 119-124. Si veda anche, per il 1318, ASS, Consiglio generale 91, c. 37v.
45 Ricostruisco la vicenda in PICCINNI, Il sistema senese del credito cit. e in EAD., Sede pontificia contro Bonsignori di Siena cit.
46 M. LUZZATI, Fini (Fin, di Fino), Tommaso (Massino, Macy), in DBI, vol. 48, 1997, e CELLA, La documentazione Gallerani-Fini cit.
28
SIENA NELLO SPECCHIO DEL SUO COSTITUTO IN VOLGARE DEL 1309-10
che stava curando i fallimenti47. A pochi metri i Nove misero le catene.
È il momento di affrontare un tema complesso e delicato. Il quadro dell’arricchimento personale dei Nove, della loro fame di potere, la chiusura politica, il restringersi degli orizzonti, forse an-che in politica estera, l’obiettivo mancato della pacificazione48, la città ripetutamente in preda della guerriglia, entrano in conflitto con altre immagini che si concretizzano nello splendore e nella cre-atività delle realizzazioni artistiche, letterarie e architettoniche che consentirono a tanti talenti di esprimersi, nelle ardite innovazioni di gestione e amministrazione della cosa pubblica, nell’incremen-to della produzione documentaria e nell’affinamento delle tecniche della sua conservazione, nella gestione del boom edilizio, nell’am-pliamento del circuito murario, nella linea di sviluppo delle relazio-ni con il territorio, completato dall’acquisto e il potenziamento di un porto sul Tirreno, che finì per attribuire a Siena il controllo su un buon terzo della Toscana, nello sforzo di affrontare i problemi dei ceti più bassi attraverso la messa a punto di un sistema di assistenza importante, in grado di gestire quello che oggi chiameremmo il wel-fare della comunità. Tutte cose stupende, oppure importanti o forti, che i Nove promossero e sembrano quasi aver deciso di spruzzarci negli occhi e che ce li fanno tuttora socchiudere, abbagliati.
Ragionare intorno a questa domanda – cosa rese possibile una tale fioritura della città, sul piano architettonico, urbanistico, giuri-dico, artistico, assistenziale, in anni di così forti difficoltà? – diventa ineludibile per comprendere se e quanto il testo del principale cor-pus normativo senese, che celebriamo oggi, possa rappresentare, come recita il titolo del nostro incontro, lo ‘specchio’ della città. Ma probabilmente le cose si farebbero un po’ più comprensibili se riuscissimo a immaginare gli anni del volgarizzamento del Costituto come uno di quei momenti che ogni tanto la storia regala, carichi di inquietudini e conflitti proprio perché un mondo inizia a morire, ma molti di coloro che vivono in quella fase non possono ancora accorgersene perché il nuovo non è ancora nato.
47 D. BALESTRACCI - G. PICCINNI, Siena nel Trecento. Assetto urbano e strutture edilizie, Firenze, Clusf, 1977, p. 55.
48 La città aveva continuato a fare i conti con tentativi di riscossa ghibellina (RAVEGGI, Siena nell’Italia dei guelfi e dei ghibellini cit., p. 54) con le continue rotture della convivenza civile rappresentate dalle violenze dei casati e tra i casati, fino ad assi-stere ad episodi di vera e propria guerriglia urbana contro i quali poco ottennero i Nove con la politica delle ‘paci’ solennemente imposte alle famiglie rivali: CAMMA-ROSANO, Tradizione documentaria cit., pp. 73-74.
29
SIENA 1309-1310: IL CONTESTO
Torniamo ‘al pezzo’, agli intrecci tra finanza e potere politico, tra potere politico e consenso, tra affari ed etica. Provo a connet-tere tutto questo intorno al punto di snodo e coagulo di scelte e decisioni rappresentato dal 1309 e 1310: partendo dal constatare l’addensarsi di eventi, non solo locali, in quelle date, non esclusi, all’orizzonte, il trasferimento della curia papale ad Avignone, il rogo dei templari, il processo a Bonifacio VIII.
Dopo la crisi delle società internazionali si assistette ad una riconversione dell’economia senese. Sullo sfondo, una consonanza di intenti pressoché perfetta tra il governo e il blocco sociale che lo sosteneva, del quale facevano parte i più ricchi della città, magnati e popolani, legati da parentele, affari e clientele49. Una parte, tutt’altro che insignificante, dei capitali ritirati dalla finanza internazionale venne orientata verso la rendita fondiaria. I senesi più ricchi com-prarono altra terra e questo con l’avanzare del Trecento avrebbe fatto loro accentuare la tendenza a vivere di rendita quando ad una minore dinamicità e voglia di rischiare fece da spalla un’agricoltura molto ben sostenuta dal ‘pubblico’, che incoraggiò la diffusione del-la mezzadria sulle terre dei proprietari cittadini.
Sarebbero bastati 1000 fiorini per aprire un laboratorio tessile. Eppure, la de-internazionalizzazione della banca non avviò, come pure avrebbe potuto, una riconversione dell’economia senese in direzione della produzione artigiana, verso la quale ben più tie-pidi furono anche gli interventi di sostegno. Il mondo produttivo, limitato nella rappresentanza politica, fu più volte colpito anche da provvedimenti di abolizione delle proprie organizzazioni e non a caso fu lì che covò lo scontento.
Negli affari, nel denaro, nel rischio, nell’ambizione di orizzonti internazionali era risieduta la forza trasformatrice della città; nella finanza a scala locale e nella terra, nei suoi redditi e diritti50, con-tinuò a cercarsi la base d’appoggio solida, e anche la reputazione e la sicurezza di ogni continuità familiare. Non altro turbò questo sostanziale bipolarismo economico.
Molti di coloro che studiano o anche solo visitano Siena nota-no, poi, che l’edilizia privata, pur con alcuni momenti alti, appare tutto sommato modesta rispetto all’imponenza di quella pubblica. Il fatto è che una parte della ricchezza rientrata in patria in vari
49 BOWSKY, Un comune italiano cit., p. 120.50 La rendita e il credito avevano rappresentato i due soli poli anche delle attività
dei magnati, e il dispiegamento delle attività finanziarie era stato per loro anche veicolo di acquisizione di castelli: GIORGI, Il conflitto magnati/popolani cit., p. 169. Ha sviluppato invece il tema del rapporto tra i mercanti senesi e la terra G. PINTO, I mercanti e la terra, in Banchieri e mercanti di Siena, Roma 1987, pp. 221-290.
30
SIENA NELLO SPECCHIO DEL SUO COSTITUTO IN VOLGARE DEL 1309-10
modi, anche sotto forma di rimborsi, fu impegnata nel prestito al Comune. Fu così che, in modo proporzionale alla potenza delle operazioni finanziarie fino ad allora gestite, i denari si riconverti-rono anche nelle stupende opere di edilizia pubblica che abbiamo sotto gli occhi, materializzandosi, con una ambizione quasi smoda-ta, nell’unicum composto dalla vallata del Campo e dal Palazzo Pub-blico che trasformava il cuore della città in splendide opere d’arte di committenza pubblica, nelle porte imponenti, nelle belle fonti. È impossibile non registrare l’esplosione di forza comunicativa di questi cambiamenti.
Con perfetta sincronia e comuni intenti civici, nel 1310, si av-viava anche il completamento della facciata occidentale della catte-drale51, che dominava dal poggio il panorama cittadino, nella quale si erano e si sarebbero impegnate generazioni di senesi, e un anno dopo Duccio consegnava la sua Maestà che gli era stata commis-sionata il 9 ottobre 1308 per l’altar maggiore, sotto il controllo del Comune52, arricchendo l’alfabeto della religione civica senese53.
Nell’insieme mi pare che investire nel disavanzo crescente dei bilanci comunali54 fornisse all’investitore una sorta di doppia ren-dita. La prima era propriamente finanziaria, dato che prestare al Comune garantiva tempi brevi di restituzione55, basso rischio e tassi medi intorno al 15%. La seconda ‘rendita’ consisteva nell’interesse di lungo periodo di un ‘investimento in consenso’ perché un buona spesa pubblica garantiva la tenuta del sistema, che in effetti funzio-nò per la bellezza di 70 anni, e il risultato è ancora più straordinario se consideriamo che fu raggiunto in una città non pacificata e in mezzo alla crisi dei principali punti di forza dell’economia.
Nel governo della cosa pubblica non venne impiegato solo il
51 A. GIORGI - S. MOSCADELLI, Costruire una cattedrale. L’Opera di Santa Maria di Sie-na tra XII e XIV secolo, München, Deutscher Kunstverlag, 2005 [Die Hirchen von Siena, Beiheft 3], p. 314.
52 Duccio. Alle origini della pittura senese, a cura di A. Bagnoli - R. Bartalini - L. Bel-losi - M. Laclotte, Milano, Silvana Editoriale, 2003, pp. 511-513.
53 Nei comuni italiani, sintetizza André Vauchez, anche il culto divino finiva per es-sere considerato come un servizio pubblico, vitale quanto l’organizzazione anno-naria o la difesa, tanto da essere considerato ‘religione civica’: A. VAUCHEZ, Intro-duction, in ID., La religion civique à l’époque médiévale et moderne, Rome 1995, pp. 1-5 (alla p. 4).
54 R. MUCCIARELLI, Potere economico e potere politico a Siena tra XIII e XIV secolo: percorsi di affermazione familiare, in Poteri economici e poteri politici. Secoli XIII-XVIII, a cura di S. Cavaciocchi, Atti della XXX settimana di Studi dell’Istituto Internazionale di Storia economica F. Datini (Prato 1998), Firenze, Le Monnier, 1999, pp. 569-590, con esempi di prestiti al Comune di Massa Marittima da parte di esponenti di famiglie magnatizie senesi.
55 BOWSKY, Un comune italiano cit., p. 262, 270-271, 274 e la tabella a pp. 264-265.
31
SIENA 1309-1310: IL CONTESTO
denaro ma anche l’esperienza di tanti uomini di affari e fu lì che crebbero sperimentazioni nuove e talvolta ardite di amministrazio-ne, tra le quali ricordo almeno la Tavola delle possessioni, avviata appena sei anni dopo, nella quale vennero descritti i beni immobili della città e di 295 comuni del territorio, un’operazione gigantesca considerando l’epoca, primo tentativo organico in Italia di valutare le proprietà utilizzando dei professionisti anziché poggiando sulle auto-dichiarazioni dei proprietari56.
Per una parte della liquidità fu poi cercato un rifugio sicuro, meglio se remunerativo, che ne fosse scudo nell’attesa di tempi migliori in cui la si potesse impegnare di nuovo. Ecco entrare in campo un altro protagonista importante della Siena di quegli anni, l’ospedale di Santa Maria della Scala. Era rettore Ristoro di Giunta, che era stato in passato uno dei soci dei Bonsignori e dunque di rischi e investimenti sapeva qualcosa.
Fu ancora una volta nel 1309 che, nel quadro di una ridefinizio-ne degli assetti istituzionali del mondo della carità, il Comune, che già sosteneva l’istituzione ospedaliera e ne nominava i revisori dei conti, decise di collocare le proprie insegne alla porta d’ingresso, per con-fermare che «lo detto spedale Sancte Marie sia del Comune di Siena»57. Questo atto, anche se fu annullato per le proteste, rappresentò un segno dell’impegno crescente dei poteri municipali nell’assistenza, in sintonia con un processo testimoniato in tutta Europa. Molte ope-
56 G. CHERUBINI, I mercanti e il potere, in Banchieri e mercanti di Siena, Siena, Monte dei Paschi, 1987, p. 187. Il valore della fonte fu per la prima volta messo in luce da L. BANCHI, La Lira, la Tavola delle Possessioni e le Preste nella Repubblica di Siena, «Archivio Storico Italiano», s. III, t. VII (1868), parte II, pp. 53-58. Il più impor-tante lavoro di elaborazione dei dati della Tavola è stato coordinato da Giovanni Cherubini negli anni Settanta del secolo scorso; i risultati sono stati restituiti in G. CHERUBINI, Proprietari, contadini e campagne senesi all’inizio del Trecento, in ID., Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana del basso medioevo, Firenze, La Nuova Italia, 1974, pp. 230-311.
57 Il tormentato processo è ricostruito da M. PELLEGRINI, L’ospedale e il Comune. imma-gini di una relazione privilegiata, in Arte e Assistenza a Siena. Le copertine dipinte dell’Ospedale di Santa Maria della Scala, Siena, Pacini Editore per Santa Maria del-la Scala, 2003, pp. 29-46 e ID., La comunità ospedaliera di Santa Maria della Scala e il suo più antico statuto (Siena, 1305), prefazione di A. Bartoli Langeli, Pisa, Pacini Editore, 2005. L’ospedale senese, il suo grande patrimonio documentario e il suo notevole patrimonio artistico sono oggetto in questi anni di studi vivaci: ai recenti B. SORDINI, Dentro l’antico Ospedale. Santa Maria della Scala, Uomini, cose e spazi di vita nella Siena medievale, Siena-Pisa, Fondazione Monte dei Paschi di Siena-Pacini Editore, 2010, e Ospedale di Santa Maria della Scala: ricerche stori-che, archeologiche e storico-artistiche, Atti della giornata di studi (Siena, 28 aprile 2005), a cura di F. Gabbrielli, Siena 2011, si può attingere anche per la bibliografia risalente.
32
SIENA NELLO SPECCHIO DEL SUO COSTITUTO IN VOLGARE DEL 1309-10
razioni venivano concordate tra capitolo ospedaliero e governo, e per gestirle erano impegnati personaggi autorevoli nella vita politica, professionalità sperimentate dell’amministrazione pubblica o formate in mezzo alla contabilità delle compagnie di affari.
È probabile che, mentre si chiedeva ad una targa di possesso di sgombrare il campo da ogni dubbio, nelle stanze del palazzo si cominciasse a formare l’idea che l’Ospedale poteva rappresentare il luogo di rifugio del quale c’era bisogno per quei denari. Le sue casse, in effetti, di lì a qualche anno, accolsero centinaia di depositi di conto corrente che garantivano interessi sicuri, dal 5% al 10%58.
C’era di più. Il denaro depositato non era solo custodito ma ve-niva messo a frutto dall’Ospedale, che poteva farne ciò che credeva per il tempo pattuito: poteva finanziare le attività istituzionali, inve-stirlo nell’acquisto di terre produttive, prestarlo al Comune. Un forte ruolo l’impresa-ospedale rivestiva dunque anche nell’intermediazio-ne creditizia perché l’Ospedale riceveva dai privati denaro sul quale pagava un interesse, e lo prestava allo Stato, dal quale riceveva a sua volta un interesse. L’Ospedale, proprio come una qualsiasi compa-gnia di mercanti e banchieri, finanziò le proprie attività ottenendo capitali anche da depositi di terzi, oltre che dalla carità pubblica e privata. Insomma questa istituzione di carità, approdata al patro-nato del Comune, iniziò ad assumere una fisionomia articolata che la mise in grado di erogare assistenza, di gestire con competenza consistenti proprietà immobiliari, di amministrare conti correnti e di prestare denaro al Comune.
Tutta una questione di soldi, allora? Sarebbe troppo semplice. Direi piuttosto che per capire cosa accadde ci rimane ancora da com-
58 Sulle dinamiche economiche connesse ai depositi scritti nel registro in questione (il n. 173 del fondo Ospedale Santa Maria della Scala, conservato presso l’ASS), sulla consistenza degli interessi corrisposti, sulla collocazione sociale dei deposi-tanti si veda ora PICCINNI, Il banco dell’Ospedale di Santa Maria della Scala cit., (ne avevo già dato breve notizia, segnalandone aspetti diversi, in G. PICCINNI, L’Ospedale e il mondo del denaro: le copertine dipinte come specchio dell’impresa, in Arte e Assistenza a Siena. Le copertine dipinte dell’Ospedale di Santa Maria della Scala, a cura di G. Piccinni - C. Zarrilli, Pisa, Pacini Editore, 2003, pp. 17-27; G. PICCINNI (con L. TRAVAINI), Il Libro del pellegrino (Siena, 1382-1446). Affari, uomini, monete nell’Ospedale di Santa Maria della Scala, Napoli, Liguori Editore, 2003; EAD., El hospital como empresa de la caridad pública, in Ricos y pobres. Opulencia y desar-raigo en el Occidente medieval, XXXVI Semana de Estudios Medievales de Estella (2009), Pamplona 2010, pp. 87-103; EAD., Conti correnti di donne presso l’ospedale senese di Santa Maria della Scala. Interessi, patti, movimenti di denaro (1347-1377), in Dare credito alle donne. Presenze femminili nell’economia tra medioevo ed età moderna, Convegno internazionale di studi (Asti, 8-9 ottobre 2010), a cura di G. Petti Balbi e P. Guglielmotti, Centro studi Renato Bordone sui Lombardi, sul credito e sulla banca, Asti 2012, pp. 121-147.
33
SIENA 1309-1310: IL CONTESTO
prendere fino in fondo il rapporto tra le aspirazioni e i bisogni della gente – singoli, gruppi, ceti e collettività urbana –, la possibilità di soddisfarli che la società offriva loro e le forme che questa possibilità a sua volta determinava. L’economia, la politica, le scelte religiose di impegno nella società contavano ognuna per la propria parte, perché plasmavano la dimensione relazionale in cui gli individui vivevano59. Alla fine di questo complesso esame potranno balzar fuori davvero i connotati di una organizzazione assistenziale che diventava sempre più una impresa che, per garantire la protezione sociale della po-polazione, doveva funzionare bene dal punto di vista economico e incontrarsi, e non scontrarsi, con le volontà politiche e con la spinta etica che lubrificava la donazione di ricchezze e sosteneva il lavoro volontario di tante persone alle quali cominciavano a stare stretti gli egoismi del profitto e che cercavano di fuoriuscire dall’infelicità per-sonale e sociale attraverso le buone pratiche civili e religiose.
La costruzione di questa ‘impresa della carità pubblica’ fu, a mio avviso, una delle più innovative operazioni messe in piedi dai noveschi.
Per concludere. Nati nel 1287 per gestire una fase di rinnova-mento, i Nove perseguirono una politica di riconciliazione e me-diazione tra gli interessi dei ceti sociali medi ed alti60 e si disinte-ressarono degli strati del popolo artigiano se si escludono le sorti di qualche lanaiolo più ricco. Anche i mutamenti che la città poi affrontò, in sé e in rapporto alla Toscana, alla penisola, al continen-te, e che la allontanarono dallo scacchiere dell’economia interna-zionale avvicinandola alla terra e alla finanza a scala locale, di fatto ‘saltarono’ ancora una volta ogni scelta convinta di sviluppo delle produzioni artigiane. I senesi, in compenso, si voltarono anche ver-so la finanza pubblica, la committenza artistica pubblica, le opere pubbliche: al punto che anche l’elegante ‘monumentalità’ della città appare riconducibile non, come accadde altrove, ad una fase di pre-dominio aristocratico, ma all’età, all’opera, agli orientamenti di un governo popolare di mercanti della classe medio-alta, «a ulteriore riprova dell’originalità di questa storia cittadina», come scrive Gio-
59 È la tesi di fondo di S. BARTOLINI, Manifesto per la felicità. Come passare dalla so-cietà del ben-avere a quella del ben-essere, Roma, Donzelli, 2010. Si veda per il Me-dioevo anche G. PICCINNI, La ricerca del benessere individuale e sociale. Ingredienti materiali e immateriali (città italiane, XII-XV secolo). Introduzione al convegno, in La ricerca del benessere individuale e sociale. Ingredienti materiali e immate-riali (città italiane, XII-XV secolo), Pistoia 15-18 maggio 2009, Roma, Viella, 2011, pp. 1-25.
60 CAMMAROSANO, Tradizione documentaria cit., 71-73.
34
SIENA NELLO SPECCHIO DEL SUO COSTITUTO IN VOLGARE DEL 1309-10
vanni Cherubini61. In tutti questi ‘luoghi’ non mancarono né i capita-li per finanziare le grandi opere che cambiarono la fisionomia della città, né il coraggio di alcune sperimentazioni ardite, né, probabil-mente, una qualche forma di consenso di popolo, sostenuto anche attraverso cerimoniali religiosi o carnevaleschi e giochi collettivi e giostre. Perché è evidente che tutto quello che vediamo non poteva essere ottenuto solo con la prepotenza.
Così, se non riuscirono a praticarla come avrebbe forse voluto Bindo Bonichi, i Nove una loro etica provarono se non altro a scri-verla, o a disegnarla, elaborando forme originali di comunicazione politica, espresse nel volgarizzamento delle raccolte normative o in stupendi affreschi che resero visibili e lanciarono attraverso i secoli concetti astratti, messaggi ideologici e principi politici di armonia in una società che voleva scoprirsi unita dall’idea del bene comune, in alternativa alla lacerazione partigiana62.
Il volgarizzamento del Costituto – che come ogni raccolta nor-mativa racconta un dover essere, più che una realtà – fu promosso perché esso potesse essere letto anche dalle «povare persone et altre persone che non sanno grammatica», cioè non conoscono il latino: o almeno così si volle far credere, dato che è probabile che tra co-loro che facevano fatica con un testo latino ci fossero prima di tutto molti membri del ceto dirigente. Si tratta, comunque, di un principio importante, che parla della necessità di favorire la diffusione e la conoscenza del diritto: di esso va dunque sottolineato il significato civico. Alcuni anni dopo i principi di difesa dei deboli, cioè degli inermi, evocati contro i soprusi dei potenti armati e che rappresen-tavano l’antica missione del Capitano del Popolo, furono ribaditi nei versi che trasformarono in testimone parlante l’immagine muta della Madonna dipinta da Simone Martini nella sala del Consiglio generale, attorniata da santi. Sulla datazione esatta dei versi che seguono non è stata detta ancora una parola definitiva, non siamo certi cioè se appartengano al momento stesso della pittura (1314 e 1315) o se siano stati aggiunti nell’intervento successivo dello stesso
61 G. CHERUBINI, Città comunali di Toscana, Bologna, CLUEB, 2003, pp. 328-329, che ricorda «l’elegante, leggera e colorita ‘monumentalità’ gotica della città». Per un quadro insieme generale e dettagliato dell’architettura senese dispone ora del bel lavoro di F. GABBRIELLI, Siena medievale. L’architettura civile, Siena, Protagon Edito-ri per Fondazione Monte dei Paschi, 2010, corredato da stupende ricostruzioni.
62 In alternativa alle parti veniva «agitata e difesa l’idea del bene comune»: per l’ela-borazione intorno al concetto di bene comune si può partire da F. BRUNI, La città divisa. Le parti e il bene comune da Dante a Guicciardini, Bologna, il Mulino 2003 (la citazione è a p. 16) e da P. SCHIERA, Dal bencomune alla pubblica felicità. Appunti per una storia delle dottrine in Italia e Germania, in Liber amicorum Arnold Esch, Tübingen, Max Niemeyer Verlag Tübingen, 2001, pp. 113-131.
35
SIENA 1309-1310: IL CONTESTO
Simone, nel 132163: sta di fatto che il 12 dicembre del 1314 e poi nel novembre del 1315 il Consiglio Cittadino precisò meglio i poteri del Capitano del Popolo proprio come «difensore dei poveri e dei mi-serabili» ampliandolo con una serie di provvisioni «contro i potenti (potentes) che offendono i deboli (debiles)»64.
li angelichi fiorecti rose e giglionde s’adorna lo celeste pratonon mi dilettan piu’ che i buon consiglima talor veggio chi per proprio statodisprezza me e la mia tera ingannae quanto parla peggio e’ piu’ lodatoguardi ciascun cui questo dir condanna
dilecti miei ponete nelle mentiche li devoti vostri prieghi onesticome vorete voi faro’ contenti.ma se i potenti a’ debil fien molestigravando loro o con vergogne o dannile vostre orazion non son per questine’ per qualunque la mia terra inganni.
Torniamo per un attimo al punto dal quale siamo partiti: ai mezzani che si trasformano in tiranni.
Gran parte della trattatistica in voga nella prima metà del se-colo XIV, come in parte abbiamo visto, aveva dibattuto se il potere concentrato nelle mani di un signore – che lo rendeva tiranno agli occhi dei contemporanei – potesse ancora essere qualcosa di diver-so da un regime tirannico quando egli si mostrasse ancora capace di perseguire il bene comune, di nuovo stringendo quel rapporto ora allentato con la comunità cittadina che era stato alla base dell’af-
63 Infatti, dal punto di vista degli storici della letteratura, si tratta di una testimonian-za preziosa della prima diffusione della Commedia a Siena (soprattutto perché sono terzine, metro che Dante è il primo a utilizzare, e perché ci sono tracce ‘inter-testuali’ del Purgatorio), e se i versi fossero del 1314-15 significherebbe che a Siena c’era chi scriveva terzine in un’epoca molto alta. Su queste terzine vedi soprattut-to F. BRUGNOLO, Le terzine della maestà di Simone Martini e la prima diffusione della Commedia, «Medioevo Romanzo», 12 (1987), 1 Studi in memoria di Alberto Limentani, pp. 135-154. A. BAGNOLI, La Maestà di Simone Martini, Milano, Silvana Editoriale, 1999, pp. 84-86, 147 dopo un attento esame condotto anche con i raggi ultravioletti, rimane dell’idea che i versi citati appartengono alla ‘stesura’ dell’affre-sco del 1315, di fatto una continuazione del lavoro del 1314, mentre all’intervento del 1321 possono risalire ulteriori versi che qui non ci interessano.
64 BOWSKY, Un comune italiano cit., p. 76, che cita Capitano del Popolo, 1, c 40v, r. 55, c. 47-49, rr. 76-81 e Consiglio Generale 86, cc. 166v-169v, 19 novembre 1315.
36
SIENA NELLO SPECCHIO DEL SUO COSTITUTO IN VOLGARE DEL 1309-10
fermazione e dell’effettivo consenso goduto dalla maggioranza dei signori nel corso del Duecento. La polemica politica si era poi allar-gata ad ogni regime dispotico, anche non di un uomo solo, racco-gliendo l’inquietudine dei cittadini per il pericolo che l’evoluzione in atto dei regimi comunali verso forme di governo più concentrate sfociasse in soluzioni tiranniche, comprendendo in questo quadro più ampio ogni governo degenerato65.
Dunque la riflessione manteneva la sua validità se a rischio tiran-nia non erano le città governate dai signori ma anche quelle gover-nate dai mezzani, dal ceto medio. Questo sembra essere il punto che sta a cuore a Bindo Bonichi, lo stesso che inquieta e talvolta spacca i Nove, lo stesso che li spinge a cercare strade, soluzioni e consenso.
Bartolo da Sassoferrato concluse il suo trattato con una massi-ma di forte realismo, scrive Andrea Zorzi66: «è raro trovare qualche regime nel quale si attenda soltanto al bene pubblico e nel quale non vi sia qualche aspetto tirannico», ed è dunque «un buon regime, e non tirannico, quello nel quale prevale l’utilità comune». Per lui i Nove furono un ordine di uomini ricchi che governarono bene e a lungo: «Fuit enim annis fere LXXX. quidam ordo divitum hominum regentium civitatem bene et prudenter»67.
Io non intendo concludere né condannando i Nove sul piano etico, con Bindo Bonichi, né assolvendoli su quello politico, con Bartolo da Sassoferrato. Mi limito a constatare che essi avevano compreso quanto fosse importante la costruzione del consenso e che, se volevano mantenere in vita il sistema che li aveva resi po-tenti e ricchi, dovevano con efficienza far funzionare la comunità e i suoi servizi, compresa l’assistenza, dovevano tutelare l’economia, affinare la normativa e renderla più fruibile, e insieme favorire e propagandare la crescita del sentimento della città come patrimonio comune della civitas, in modo che un numero più ampio possibile di cittadini si riconoscesse orgoglioso nelle loro scelte di governo della cosa pubblica.
65 Per Bartolo la tirannide consisteva nel carattere essenzialmente oppressivo di ogni governo che non si fondasse sul diritto. Per Dante ad aprire la strada alla tiranni-de erano state avidità, egoismo e caduta delle virtù civiche, e lo stesso pensiero aveva espresso anche il notaio Albertino Mussato che nel 1315, a Padova, aveva fatto rappresentare con grande successo una tragedia sulla «tirannia» di Ezzelino da Romano, e nel 1321 aveva scritto, in esilio, una storia degli eventi italiani dopo la morte di Enrico VII (nel De gestis italicorum post mortem Henrici VII Caesaris istoria). Per tutto questo quadro mi ispiro ancora una volta alla sintesi di ZORZI, Le signorie cittadine cit. e ad essa rinvio per le citazioni puntuali.
66 ZORZI, Le signorie cittadine cit., p. 162.67 Vedi la nota 24.