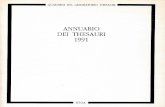La Lárentíus saga biskups nel sistema letterario antico nordico
pa rt h i c a INCONTRI DI CULTURE NEL MONDO ANTICO 15 · 2013 PISA · ROMA
Transcript of pa rt h i c a INCONTRI DI CULTURE NEL MONDO ANTICO 15 · 2013 PISA · ROMA
pa rt h i c aINCONTRI DI CULTURE NEL MONDO ANTICO
15 · 2013
PISA · ROMAFABRIZIO SERRA EDITORE
MMXIV
estratto
Fondatore della rivista / Journal founderAntonio Invernizzi
Direttore / Editor in chiefCarlo Lippolis
*
Comitato scientifico / Scientific CommitteeMichael Alram, Wien · Paul Bernard, Paris · A. D. H. Bivar, London
Edward Da browa, Kraków · Hideo Fujii, Tokyo · †Bernard Goldman, MichiganErnie Haerinck, Gent · Dietrich Huff, Berlin · Gennadij A. Košelenko, Moskva
†Heleen Sancisi-Weerdenburg, Utrecht · A. Schmidt-Colinet, WienKatsumi Tanabe, Tokyo
*
Redazione scientifica / Editorial AssistantsCarlo Lippolis · Niccolò Manassero · Vito Messina
Si prega di inviare manoscritti, dattiloscritti e stampati e la posta redazionale al seguente indirizzo:Carlo Lippolis, Dipartimento di Studi Storici,
Via S. Ottavio 20, i 10124 Torino.I testi originali di contributi e/o recensioni sottoposti all’attenzione della redazione scientifica
non saranno restituiti.Contributors are kindly requested to send manuscripts, typescripts, print-outs and correspondence to the
following address: Carlo Lippolis, Dipartimento di Studi Storici,Via S. Ottavio 20, i 10124 Torino.
Please note that materials submitted for potential publication and/or critical review will not be returned.
*
«Parthica» is an International Peer Reviewed Journal.The eContent is Archived with Clockss and Portico.
anvur: a.
*
Per la migliore riuscita delle pubblicazioni, si invitano gli autori ad attenersi, nel predisporre i materialida consegnare alla redazione ed alla casa editrice, alle norme specificate nel volume Fabrizio Serra,
Regole editoriali, tipografiche & redazionali, Pisa-Roma, Serra2, 2009.(ordini a: [email protected]).
Il capitolo «Norme redazionali», estratto dalle Regole, cit., è consultabile Onlinealla pagina «Pubblicare con noi» di www.libraweb.net.
*
Registrazione presso il Tribunale di Pisa n. 12 del 21 luglio 1999.Direttore responsabile: Fabrizio Serra.
SULLA SYLLOGE NUMMORUM PARTHICORUMDA VOLOGESE I A PACORO I I
Antonio Invernizzi
Fabrizio Sinisi, Sylloge Nummorum Parthicorum - New York - Paris - London - Vienna - Tehran - Berlin,vol. vii, Vologases I - Pacorus II (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philolo-gisch-Historische Klasse, «Denkschriften», 433, «Veröffentlichungen der NumismatischenKommission», 56), Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2012, pp.432, 94 tavole e numerosissime illustrazioni al tratto e b/n nel testo.
a pubblicazione della nuova serie Sylloge Nummorum Parthicorum è un evento degno di particola-re segnalazione per il suo alto interesse come strumento di lavoro e più in generale come
iniziativa di una promozione degli studi sull’età arsacide che va al di là dello specifico campo della numismatica. La serie viene pubblicata dall’Österreichische Akademie der Wissenschaften nel-l’ambito di un progetto internazionale al quale assicurano una stretta collaborazione l’AmericanNumismatic Society di New York, il Cabinet des Médailles della Bibliothèque nationale de France,il Department of Coins and Medals del British Museum, l’Institut für Numismatik und Geldge-schichte dell’Università di Vienna, il Münzkabinett del Kunsthistorisches Museum di Vienna, il Muzeh-ye Melli-ye Iran (Museo Nazionale dell’Iran) di Tehran, il Münzkabinett degli StaatlicheMuseen zu Berlin e il British Institute of Persian Studies presso la British Academy di Londra.
Dell’edizione hanno assunto la cura Michael Alram, Vesta Sarkhosh Curtis e Daryoosh Akbar-zadeh, che nella prefazione al volume inaugurale, il vii, ne illustrano gli scopi e i metodi di orga-nizzazione e di analisi del materiale (pp. 7-9), analoghi a quelli collaudati nella Sylloge NummorumSasanidorum (sns). I curatori ne propongono l’abbreviazione snp per le citazioni bibliografiche; ene comunicano il piano di articolazione programmato in nove volumi. Essi non si soffermano aspiegare le ragioni dell’inizio del progetto con il vol. vii, che comprende le monete coniate in unperiodo avanzato della monetazione arsacide, dal 362 al 408 e.s. (= 51-96 d.C.), corrispondente ai regnanti da Vologese I a Pacoro II. Ma è un fatto che, motivazioni contingenti a parte, il periodoscelto si distingue per la sua coerenza produttiva, tanto che l’A. lo definisce come una delle «subu-nits» individuabili nello sviluppo storico della monetazione arsacide, perché in esso si stabilisconoe si rispettano precise convenzioni (p. 27).
La snp, di cui il volume in questione è il primo tassello, verrà ad affiancare come insostituibilepunto di riferimento la storica opera di David Sellwood, dilatandone enormemente i confini. Cer-to una riedizione aggiornata di quest’ultima resta auspicabile per la sua utilità come strumento diagile consultazione e per l’ampiezza del suo orizzonte in quanto moderna sintesi globale sulla mo-netazione arsacide, a dispetto della modestia del titolo, An Introduction to the Coinage of Parthia.1 Marispetto a questa storica ‘introduzione’, il volume in oggetto rende immediatamente evidenti nonsolo il progresso delle conoscenze intervenuto, ma gli straordinari vantaggi offerti dalla disponibi-lità di un repertorio tanto prezioso per l’inusitata vastità della documentazione messa a diretta di-sposizione degli utilizzatori. Il ricchissimo catalogo è infatti basato sulla sistematica visitazione dialcune delle più ricche raccolte numismatiche, quelle appunto delle collezioni indicate nel titolo,alle quali non mancano naturalmente di aggiungersi le possibili necessarie integrazioni non rap-presentate nelle sedi di riferimento.
L’ambizione dei curatori del progetto e le aspettative dei fruitori sono ben ripagate dall’eccellentelavoro svolto dall’A. di questo volume inaugurale, il vii. La presentazione del catalogo acquista in-fatti anche un suo carattere monografico di ampie prospettive, perché nel perseguire lo scopo pri-
1 Sellwood 1980.
L
«parthica» · 15 · 2013
76 Antonio Invernizzi
mario della silloge – l’organizzazione cronologica delle serie monetali –, che nei limiti del possibi-le viene egregiamente soddisfatto, la valutazione critica di queste, procedendo in linea con le di-rettive metodologiche già sperimentate nella sns, offre approfondimenti di svariata natura su aspet-ti che non restano vincolati alle questioni di natura strettamente numismatica. La discussione siapre sistematicamente a ben più ampie considerazioni, e porta anzi in primo piano proprio alcunedelle più importanti problematiche storiche dell’età partica, storiche nel senso più ampio, alla cuidiscussione le testimonianze monetarie possono portare un contributo o che all’inverso servono diutile inquadramento culturale alle emissioni.
In questa prospettiva, la chiarezza esemplare della trattazione di un materiale tanto abbondantetrova un supporto di straordinaria efficacia nell’eccezionale ampiezza dell’apparato illustrativo, chedel progetto costituisce un punto di forza primario. Questa disponibilità non solo chiarisce e con-ferisce massima evidenza ai tratti descrittivi dei singoli tipi iconografici, ma è di giusto supporto al-le argomentazioni valutative elaborate dall’A. Infatti non solo sono riprodotte, recto e verso, tuttele 1.326 monete in catalogo (dove la lettera A che segue il numero di identificazione della monetaindica la provenienza dell’esemplare da altre collezioni), oltre alle poche monete aggiuntive con-trassegnate da N (così evitando di interrompere la numerazione progressiva degli esemplari, a mi-glioramento del sistema seguito nella sns). Ma sono presentati con generosa dovizia ingrandimentigrafici di ottima qualità tecnica e stilistica di tutti i tipi monetali. Questi disegni sono via via inseri-ti nel testo accanto alla descrizione, e la ripresa delle immagini ingrandite di singoli nominali nelsuccessivo sviluppo critico del discorso risponde a specifiche esigenze di chiarezza della discussio-ne, esigenze poi ulteriormente soddisfatte dalle numerose tabelle. Tanta ricchezza risulta quindifondamentale anche e soprattutto per un pubblico di ricercatori molto più ampio e diversificato diquello degli studiosi di numismatica o dei collezionisti di monete.
Con simili premesse dunque, è chiaro che il volume è molto più che un catalogo o un reperto-rio di tipologie monetali. Esso offre un punto di osservazione globale da cui si sviluppa un argo-mentare che persegue con costanza e sistematicità il proposito di tener conto, ove necessario o con-veniente, di tutto il divenire storico della monetazione arsacide, precedenti e seguenti inclusi.
Dopo una introduzione in cui trovano posto le osservazioni di carattere generale (pp. 11-14) e unprofilo storico dei regni tra Vologese I e Pacoro II, evidentemente aggiornato alla luce dei risultatidella sistemazione delle rispettive serie monetali (pp. 15-23), il volume si divide in due parti, com-prendenti lo studio numismatico e il catalogo delle monete.
Lo studio numismatico si suddivide a sua volta in due sezioni separate da un capitolo dedicatoagli aspetti della metrologia (pp. 117-136). Nella prima sezione viene anzitutto descritta e commen-tata la tipologia di recto e verso delle monete, articolata in rapporto ai singoli nominali, tetra-drammi, dracme e bronzi (pp. 25-55), poi i tipi monetali vengono riconsiderati sovrano per sovrano(pp. 56-115).
La descrizione è sempre accurata e pertinente, ma la terminologia antiquaria richiede una osservazione di carattere generale riguardo alla denominazione scelta per l’abbigliamento dei so-vrani, rappresentati a mezzo busto sul recto. Nella letteratura numismatica e archeologica questaveste regale è variamente denominata. Tra le diverse occorrenze l’A. scarta giustamente l’inter-pretazione che intende il re indossare una corazza (pp. 31-32). Questa lettura è basata sull’ornato del-le bordure della veste, che è in molti casi costituito da una serie di cerchietti, passibili di essere iden-tificati con le borchie metalliche di una corazza. Ma prescindendo dalla stranezza di una corazzache, pur di parata, si apre in una profonda scollatura a V a scoprire il petto, questi cerchietti sonomolto meglio paragonabili alle perlinature che spesso decorano in vari modi le tuniche dei devotiche hanno dedicato le loro statue nel santuario di Hatra. I cerchietti d’altronde non sono che unodei possibili motivi ornamentali delle bordure.
Gli abiti hatreni, che ovviamente sono meglio definibili sulle sculture in formato naturale, sonospesso coperti da ricchissime decorazioni, ricamate o applicate nella realtà, le quali lasciano talvol-ta spazio anche a figurazioni umane. Le cornici delle bande decorative sono spesso costituite da cer-chietti a rilievo, tangenti o parzialmente sovrapposti, che fanno pensare ora a ricami ora ad appli-cazioni di brattee d’oro. La pratica di cucire alle vesti placchette auree di svariate forme è diffusa in
Sulla Sylloge Nummorum Parthicorum da Vologese I a Pacoro II 77Oriente e in Occidente fin da età achemenide etardoclassica-ellenistica, ed è ben documentataad es. nel tesoro dell’Oxo e nelle tombe dell’ari-stocrazia macedone. Ma nella scultura hatrenaalcuni elementi di questa diffusa ornamentazio-ne si distinguono per un maggiore rilievo che ac-cenna una lieve calotta e che li avvicina ai gioiel-li, collari e bracciali.
Il dettaglio è particolarmente evidente nellaguarnizione al braccio destro di una statua ace-fala di Sanatruq I che teneva nelle mani come of-ferta una statuetta di divinità2 (Fig. 1). Nell’ori-ginale, questa larga banda sulla manica lungadella tunica poteva corrispondere a una decora-zione cucita sul tessuto e composta da calottinemetalliche, ma anche da autentiche perle. Latecnica di applicazione di perle agli abiti regali ècerto ben più antica di quella splendidamentedocumentata dai regalia confezionati nella Sicilianormanna. Essa risponde nel modo più adegua-to al gusto bizantino per lo sfarzo delle vesti il-lustrato nei mosaici ravennati e negli avori. Ladiffusione di questo gusto può ben aver avutoinizio nell’Oriente partico, vista l’origine orien-tale di perle e gemme. Non è pertanto inverosi-mile che la veste regale arsacide, riprodotta informe semplificate sulle monete, potesse venire ornata sia da ricami sia da applicazioni di materia-li preziosi, incluse perle e gemme, come accade per le vesti in uso nello stato vassallo di Hatra ri-flesse nella statuaria della città.
Scartata dunque giustamente la corazza, tra le denominazioni in uso per la veste regale dei ritrattimonetali l’A. sceglie il termine «tunic», che in effetti è particolarmente diffuso nella letteratura dilingua inglese. Questa denominazione però, pur in un impiego convenzionale, contrasta sia con laforma della veste riprodotta sulle monete sia con il modo di indossarla. Qui il nome «tunic», di ori-gine latina, appare del tutto inadeguato perché, dai Romani in poi, la tunica è propriamente un ca-po di vestiario chiuso davanti, e sono tuniche a scollatura rotonda e manica lunga quelle, molto di-verse, indossate da gran parte dei personaggi hatreni. Al contrario, la veste con profonda scollaturaa V dei busti reali arsacidi è chiaramente la stessa indossata dal principe bronzeo di Shami, una ca-sacca a maniche lunghe aperta sul davanti, dove si incrociano le due falde laterali. Il nome casaccaderiva forse dal turco qazaq, che significa ‘vagabondo’, ‘nomade’,3 ed è un significato perfettamen-te consono con l’origine centroasiatica della veste. Anche nella letteratura archeologica in lingua in-glese altri nomi sono saltuariamente ma più correttamente impiegati per questo caratteristico capodi vestiario iranico, partico e nomadico, nomi come jacket, coat, o simili, che traducono in manierapiù generica il termine orientale ‘casacca’, ma che sono più fedelmente descrittivi e della forma e delmodo di indossare questo caratteristico capo di vestiario. L’uso sbrigativo, benché affatto conven-zionale, del termine «tunic» dà una descrizione non solo imprecisa ma erronea dell’abito.
A parte l’adesione a questo termine, però, la descrizione degli aspetti iconografici è puntuale eprecisa,4 e naturalmente critica, volta a mettere in luce il ruolo che ogni dato svolge nel panorama
2 Safar, Mustafa 1974, 61, n. 2.3 Finzi 1931, 277.4 Un solo dettaglio fa eccezione. Nella descrizione della
veste della dea con corona murale e scettro che porge la co-
rona al re in trono sul tipo 1 (1a) dei tetradrammi di VologeseI, salta all’occhio una incongruenza. Di essa è detto infatti cheindossa un peplo a maniche lunghe (p. 68), ma si tratta chia-ramente di una svista. Che il braccio destro sia nudo appare
Fig. 1. Hatra, Sanatruq I.
78 Antonio Invernizzi
generale non solo del periodo ma dell’intera monetazione arsacide. Il testo pertanto si apre spessoa toccare argomenti di interesse più generale e ampio come, per fare un paio di esempi, le conven-zioni rappresentative del busto regale in rapporto con la «frontalità partica» (pp. 27-29), e il signifi-cato della scena del verso dei tetradrammi in cui una dea tende la corona al re in trono, scena cheè comunemente ma impropriamente definita di investitura (pp. 44-49).
Il messaggio diffuso dall’azione della divinità che offre la corona al re diademato in trono non siriferisce infatti al concetto di investitura divina del sovrano, ma è un atto di omaggio reso figurati-vamente alla greca, da leggere come rappresentazione allegorica del favore divino verso la regalitàdegli Arsacidi, di cui comunica una sintetica espressione visiva. L’attributo offerto, meglio di dia-dema, andrebbe chiamato più propriamente corona (termini usati interscambiabilmente negli scrit-ti di numismatica partica e nel volume di Sellwood). In alcuni casi esso è riconoscibile come coro-na d’alloro, e si alterna in effetti con la palma. Corona e palma sono entrambi simboli di buonauspicio, di successo e di vittoria, fin dai tempi antichissimi del premio conferito ai vincitori dellegare nei giochi panellenici. Ed è questa cerimonia agonistica da porre in capo alla lontana originedella simbologia, così appropriata al re che è per antonomasia vincitore.
Quanto alla specifica identità di questa dea, che è per lo più Tyche, con o senza corona turrita,essa viene interpretata diversamente a seconda della presenza di questo specifico attributo, che laqualifica come dea poliade. Per Tyche, nella sua iconografia più generale, l’A. propone l’identifica-zione con la dea Nana, che in età partica ha acquisito il rango supremo di grande dea e massima di-vinità, e che è strettamente associata alla regalità, una proposta sulla quale l’A. è intervenuto piùdiffusamente altrove.5 L’identificazione è già suggerita dall’essere Tyche sostituita nell’atto diomaggio della corona, pur in via eccezionale, con Atena, che è una delle divinità greche corri-spondenti a Nana. Ma è soprattutto validamente motivata nel caso dell’immagine della Tyche, fem-minile e però con la lunga barba di un viso maschile, rappresentata in trono in luogo del re arsaci-de sui tetradrammi S17 di Fraate II (138-127 a.C.) nell’atto di venire incoronata da Nike, mentre tienela cornucopia ed ha sul capo il polos6 (p. 46). D’altronde la polivalenza delle immagini divine par-tiche, soprattutto in presenza di iconografie greche, e nella fattispecie della Tyche monetale, trovaun altro caso di ambiguità iconografica nella figura del bronzo tipo 6 di Vologese I, emesso dallazecca di Ecbatana, dove di Tyche la figura ha solo la corona turrita.7
La valutazione del materiale descritto nella prima sezione viene ripresa dopo l’intermezzo me-trologico, seguendo come filo conduttore la sua evoluzione cronologica, nella prospettiva di evi-denziare lo sviluppo storico della produzione monetale da Vologese I a Pacoro II (pp. 137-206). Quisi deve segnalare in modo particolare l’utilissimo sincronogramma che conclude la sezione pre-sentando in forma tabellare i disegni di tutti i tipi sistemati in successione temporale. È una effica-ce sintesi storica illustrata, che permette quindi di avere chiare con un unico colpo d’occhio, ben-ché necessariamente su più pagine (pp. 201-206), affinità e differenze, in una parola i rapportitipologici in precedenza discussi in dettaglio.
La riorganizzazione delle serie monetali si avvantaggia dell’attenta osservazione dei rapporti ti-pologici e stilistici tra i nominali indicatori di cronologia relativa, e del riconoscimento di gruppi dimani di artefici (un segno di maggior prudenza rispetto alle «mani» di Sellwood), che sono taloradiversi tra recto e verso di una stessa moneta. Valorizzando ogni piccolo dettaglio tecnico e icono-
chiaro dal confronto con il panneggio delle maniche che co-prono le braccia del re, e il dato è correttamente registrato intutti i disegni relativi.
Il peplo in ogni caso è una veste arcaica da tempo cadutain disuso, e in età ellenistica interessa semmai l’arte arcaistica.Accade tuttavia che il termine sia talora impiegato più in ge-nerale e con valore convenzionale nel senso di tunica, in luo-go del corretto chitone, in particolare, anche in questo caso,nella letteratura di lingua inglese. La dea in questione invece,che in nulla differisce dalle colleghe delle scene analoghe, in-dossa la veste comune composta da chitone (o tunica) e hi-mation (o manto), e la indossa nel modo che è canonico nel-
l’arte ellenistica e che è in uso anche nell’Asia ellenizzata. Latunica senza maniche (o con maniche) è cinta alla vita, legambe sono coperte dalle pieghe più o meno oblique delmanto, che è trattenuto dalla mano o dall’avambraccio, inmodo da scoprire le pieghe verticali della tunica in vista sottola cintura e al di sopra dei piedi.
5 Sinisi 2008, 231-248.6 Ibidem, 235, fig. 2; Idem 2012, 282, fig. 15:4.7 Su entrambe queste raffigurazioni eccezionali di Tyche
vedi Invernizzi in prep.
Sulla Sylloge Nummorum Parthicorum da Vologese I a Pacoro II 79grafico, l’analisi porta a risultati documentati, attendibili o plausibili, subordinatamente alla rico-nosciuta impossibilità di disporre, in molti casi, di irrefutabili motivazioni oggettive, in conseguen-za in primis della saltuaria presenza di date sulle monete.
Le proposte dell’A. hanno importanti riflessi sul quadro ricostruttivo globale della monetazionedel periodo, e in particolare sull’interpretazione degli eventi storici contemporanei. Talora si trat-ta di conferme su aspetti di politica interna, come il rapporto tra il re (Vologese I) e Seleucia al Ti-gri, caratterizzato da contrasti con importanti conseguenze, come la fondazione di Vologesocerta(pp. 17, 21, 150).
L’assegnazione delle prime dramme di Vologese I al termine del 362 e.s. (pp. 145-147) lascia even-tualmente spazio a quelle emesse da Vonone II nel suo breve regno tra Gotarze II e Vologese I. Inseguito, la collocazione del pretendente che si ribella a Vologese I battendo moneta negli anni 366-369 e.s. (c. 55-58 d.C.), e che Sellwood aveva chiamato Vardane II, viene assicurata in dettaglio. Que-sto personaggio resta più prudentemente anonimo, e per esso viene adottata la denominazione di«son of Vardanes», già entrata nell’uso, in linea con quella di Tacito, «filius Vardanis» (p. 143, tab. 49).Ancora, l’inesistenza di un Vologese II presunto regnante negli anni 389-390 e.s. e l’attribuzione aVologese I delle emissioni con la tiara S72, ormai comunemente accettate, escono rafforzate da va-lide osservazioni sulle caratteristiche dei dettagli delle monete.
Fatto del tutto nuovo e originale è invece l’interpretazione della sequenza dinastica tra i sovraniche hanno detenuto il potere in questo periodo: Vologese I, Pacoro II e Artabano III. Nel discuterela relazione tra questi tre sovrani, attivi in parte contemporaneamente nella zecca di Seleucia (inparticolare pp. 171-183), l’A. scarta l’ipotesi tradizionalmente invocata della conflittualità tra preten-denti al trono del re dei re, una situazione che in effetti ha spesso condizionato gli eventi nella sto-ria arsacide. Al più comune cliché di ribellioni e di lotte intestine per l’acquisto del trono è invece so-stituito il tranquillo quadro di una successione pacifica mediante la reggenza, un istituto al quale siè fatto ricorso anche in altri periodi della storia partica.
Punto di partenza e base delle argomentazioni è la crescita in età di Pacoro II, registrata fedel-mente dall’evoluzione iconografia del suo ritratto in tre tappe (volto imberbe, poi con corta bar-ba, infine con barba più lunga). Queste tappe sono confermate anche dalle date eventualmente ri-portate dalle monete e costituiscono dunque un dato certo oltre che logico. Il principio dellacorrispondenza tra età e viso imberbe o barbato è di costante applicazione nell’arte antico-orien-tale, e in determinati contesti può riflettere anche una diversificazione di grado nello stato socia-le. Non sorprende che questo principio sopravviva fino all’età partica, tanto più che trova saltua-ria applicazione anche nella monetazione dei Seleucidi, in particolare, per fare un nome, nellemonete di Demetrio II (146/145-140/139, 129-125 a.C.), un re che con gli Arsacidi ha avuto strettis-simi rapporti. I ritratti dei re seleucidi sono fisionomici e realistici, ma quelli dei re arsacidi, purcostruiti su tipi convenzionali, corrispondono ugualmente bene da questo punto di vista a quellidei predecessori.
Secondo il calcolo del progredire in età elaborato dall’A. sulla base dell’evoluzione iconografica,Pacoro avrebbe avuto 7-9 anni nel 385/386-387/388 e.s. al momento dell’associazione al trono di Vo-logese I e delle prime emissioni a viso imberbe; 12-13 anni e quindi ancora una età minorile alla mor-te del padre nel 390; 17-18 anni, vista la barba incipiente, nel 396, quando si trova ad essere solo so-vrano al termine del periodo di monetazione di Artabano e al raggiungimento della maggiore età(pp. 176-177). Indipendentemente dal richiamo ad altri precedenti, la coreggenza Vologese-Pacoro èresa plausibile proprio dal ritratto poco più che infantile, anche se mancano emissioni con il dop-pio ritratto dei due sovrani come quelle di Fraatace e Musa, coniate per altro in una situazione benpiù complessa. La contemporanea assunzione della tiara da parte di Vologese, rispetto al diademadel figlioletto, esprime visivamente uno stato di primus inter duos pares per motivi anagrafici e pa-rentali, che implica evidentemente un più ampio e concreto potere effettivo.
Il corso degli eventi presenta tuttavia aspetti incerti e non privi di ambiguità, in mancanza di fon-ti storiche più dirette. Nella linea interpretativa dell’A., alla morte di Vologese non ci sarebbe stataalcuna ribellione, ma l’età ancora adolescenziale di Pacoro avrebbe richiesto la nomina di un reg-gente fedele alla famiglia del defunto re, al fine di salvaguardare la successione del fanciullo Paco-
80 Antonio Invernizzi
ro non solo designato ma già attivo nel ruolo. Sarebbe stato scelto Artabano, appunto, che dal ruo-lo di usurpatore passa quindi a quello di lealista. Egli potrebbe essere stato forse fratello di Vologe-se, e potrebbe aver manifestato il suo impegno legittimistico nell’accogliere sulle proprie monetealcuni tratti di quelle del predecessore (p. 178). Un argomento, questo, a doppio taglio, perché con-veniente anche a un pretendente alla successione comunque in possesso di motivazioni più o me-no valide di parentela o altro. Certo l’ipotesi dell’accordo, rispetto a quella della rivalità, meglio spie-gherebbe anni di quasi contemporaneità nell’uso della zecca di Seleucia, tuttavia non è supportatada prove veramente documentarie.
Il dato sicuro qui è nella sequenza delle serie monetali: alle prime di Pacoro II – che vengonoemesse dal distros 389 e.s. (febbraio 78 d.C.) a un mese indeterminato del 391 e.s. (p. 171) in con-temporanea con le ultime di Vologese I – seguono i tetradrammi di Artabano III, che pone il pro-prio nome sui tetradrammi emessi dal gorpiaios 391 e.s. (agosto 80 d.C.) a un mese non definitodell’estate 393 e.s. (82 d.C.). In questo periodo, e segnatamente nell’anno centrale 392 e.s., man-cano monete di Pacoro con indicazione della data (pp. 172-173, tab. 53). L’emissione di suoi nuovitetradrammi è attestata solo a partire dall’hyperberetaios 393 e.s. (pp. 175-176). Questo silenzio ver-rebbe però interrotto dall’assegnazione delle serie di dramme non datate allo stesso periodo del-la monetazione di Artabano, fatto che viene spiegato con l’ipotesi dell’esistenza di due «produc-tion units» al lavoro fianco a fianco per l’uno e per l’altro sovrano (p. 183), mentre altre serie diPacoro rimangono di non facile collocazione (pp. 179-183, fig. 14). Questa ricostruzione ripristine-rebbe dunque la continuità della monetazione del giovane Pacoro, ma resta una possibilità, e perdisporre di dati oggettivi occorre attendere i suoi tetradrammi con corta barba come solo sovra-no nel 393 e.s.
In questa ricostruzione storica di pacifica trasmissione del potere da Artabano a Pacoro, un ar-gomento fondamentale è fornito dall’insolito attributo che la dea tende al re in trono sul verso deitetradrammi di Artabano III (Fig. 2), attributo che nel 393 e.s. ritorna sul verso dei primi tetra-drammi di Pacoro II solo sovrano (tipo ii:2), nelle mani però di una figura maschile in vesti irani-che stante alle spalle della dea che porge la propria corona (Fig. 3). Questa figura è infatti tradizio-nalmente interpretata come lo stesso Artabano.
Tra le proposte identificative avanzate per questo attributo dalla forma stretta e allungata – dia-dema sciolto, cintura, gorytos con arco – l’A. sceglie quella di diadema sciolto (pp. 96-97, 175), e laillustra con un dettaglio ingrandito da due tetradrammi di Pacoro (p. 178, fig. 12) (Fig. 4a-b). L’ipo-tesi di un arco con il suo gorytos risulta difficilmente sostenibile, perché la figura così sottile e al-lungata dell’attributo diverge da quella più larga e compatta che ci si può aspettare da un gorytos.
Fig. 2. Omaggio divino sui tetradrammi di Artabano III.
Sulla Sylloge Nummorum Parthicorum da Vologese I a Pacoro II 81
L’immagine è comunque molto lontana dalla fa-retra che nei secoli a.C. compare tra altri simbo-li della regalità arsacide sulle metope di Nisa.Quanto alla cintura, è un oggetto indubbiamen-te adatto a essere raffigurato nel modo illustra-to dalle monete e dai disegni. Ma, diversamentedall’arco e gorytos, mancano del tutto appigliper affermare che l’offerta di una cintura possafar parte delle azioni simboliche di riconosci-mento dello stato regale o simili.
Comunque si interpretino le figure del re introno e dell’arciere sul verso delle monete (per quest’ultimo vedi la discussione a pp. 49-50), co-me rappresentazione genericamente della rega-lità arsacide, o più specificamente dello stato re-gale del re titolare dell’emissione, resta però lastranezza dell’offerta da parte della dea di undiadema sciolto, che rispetto al diadema/coronaannodato ad anello è passibile di un significato divalore restrittivo, come in effetti è interpretato.Questo presunto atteggiamento di modestia però, limitativo del proprio stato regale, e a for-tiori della stessa regalità arsacide visto il significato generale della figura del re in trono, contrastacon la proclamazione dello stato di re dei re espressa da Artabano III nell’epigrafe che incornicia lascena di omaggio.
Consapevole dell’ovvia obiezione, l’A. anticipa le sue riserve sul valore in questo specifico casodella titolatura, dal momento che il titolo completo di re dei re accompagna i coreggenti più giovani, i quali per la loro età «were clearly still not full kings», e che pertanto «had the status ofyounger co-ruler» (p. 177, nota 630). La differenza di età implica certo una distinzione fra i coreg-genti, ma si devono distinguere due diversi livelli. L’anzianità del ruolo conferisce priorità nell’esercizio del potere regale, ma solo sul piano pratico della gestione di questo potere, non giàper quanto riguarda la dignità del ruolo. «Not full king» potrà essere definito l’erede al trono nominato ma non incoronato, certo non il giovane già associato alla dignità del trono, il quale, su
Fig. 3. Omaggio al re cavaliere sui tetradrammi di Pacoro II.
Fig. 4a-b. Omaggio al re cavalieresui tetradrammi di Pacoro II (dettagli).
82 Antonio Invernizzi
attestazione della legenda, è pienamente in possesso del diritto regale a tutti gli effetti giuridici. Egliè sicuramente «full king», ha il capo cinto dallo stesso diadema del re anziano e ne condivide in pieno il ruolo di legittimo re. Solo nell’esercizio delle direttive e delle decisioni del governo, nellagestione cioè degli affari dello stato, possiamo logicamente attribuire al giovane re, di pur pari di-gnità, una posizione subordinata a quella del re anziano. Nel caso specifico poi è poco verosimileche Artabano, reggente sì ma anziano, abbia gestito le concrete attività di governo in posizione su-bordinata al giovane nipote.
Il fatto principale però nell’iconografia dell’omaggio della dea ad Artabano è che un diademasciolto resta un’incongruenza in entrambe le ipotesi, di reggente e di ribelle. Ora, il diadema sullafronte del re o la corona nelle mani della dea appaiono di norma lisci. Sulle monete di Artabano IIIl’oggetto in questione è invece segnato da una fitta successione di piccole tacche o dischetti. Pro-prio questo trattamento è stato alla base dell’interpretazione dell’oggetto come cintura, ma si de-ve osservare che esso è del tutto simile al modo di rendere il trono e altri dettagli iconografici del-la scena. Non potrebbe allora rappresentare uno scettro rigido, ma di struttura diversa da quelloellenistico – sempre liscio e lungo – tenuto dalla dea e da molti sovrani partici in più antiche età, ades. da Fraate III (S39) (Fig. 5) e da Orode II (S45)? Dopo Fraate IV (S54) e l’usurpatore Tiridate (S55),che hanno anch’essi uno scettro in mano, questo simbolo ellenistico del potere divino e regale sem-bra abbandonato dall’iconografia monetale.
Sulle monete di Artabano III (Fig. 2) e di Pacoro II (Fig. 3) l’oggetto è lungo fino a terra o quasi,la mano che lo tiene all’estremità superiore ne lascia libero il terminale. A giudicare soprattutto daidisegni, questo si ripiega un poco in fuori (Artabano) o verso l’alto in forma di linguetta ondulataliscia (Pacoro), in modo forse poco realistico per il molle laccio all’estremità di una corona/diade-ma. Ma richiama alla memoria l’effettivo uso nella corte arsacide di scettri con terminali di diversaforma, non ellenistica, attestato dall’alabarda d’argento rinvenuta negli scavi della Casa Quadratadi Nisa8 (Fig. 6). Questo oggetto era montato su un bastone o manico che non si è conservato, erappresenta evidentemente il terminale di uno scettro, poiché la sua struttura, il taglio smussatodella lama, il materiale prezioso e le dimensioni ridotte (11 cm di altezza, 25 di lunghezza totale) neescludono l’uso pratico come arma, e suggeriscono invece che l’oggetto sia stato parte dei regalia,un’insegna di comando impiegata dai re arsacidi in determinate cerimonie ufficiali, forse in paratemilitari più che civili.
Il terminale ha forma un po’ diversa sulle monete dei due sovrani, ma si tratta certamente dellostesso oggetto. Esso non sembra corrispondere alla forma del documento niseno, perché il termi-nale in forma di alabarda sporgeva ad angolo retto dal manico perduto. Tuttavia la fattura dell’at-
8 Invernizzi 1999, 129-138, tav. H:a-b.
Fig. 5. Tyche sui tetradrammi di Fraate III (S39).
Sulla Sylloge Nummorum Parthicorum da Vologese I a Pacoro II 83
tributo e la sua funzione simbolica sulle monete di Artabano co-me su quelle di Pacoro rendono sostenibile un suo inquadra-mento tra i regalia arsacidi come scettro. Scettri di diversa foggiasono d’altronde attestati nel mondo partico: lo prova quello co-stituito da un semplice bastone tenuto in mano dalla dea Nanaraffigurata in una scultura a tutto tondo di Hatra9 (Fig. 7). L’even-tuale ricorso a uno scettro da parte di Artabano III in luogo dellanormale corona per l’omaggio della dea, ma uno scettro di for-ma diversa da quella dello scettro tenuto dai re in trono di età el-lenistica, uno scettro ‘arsacide’ dunque e non ellenistico, avrebbepiù senso che non un diadema stranamente sciolto nelle manidella dea offerente, e si accorderebbe con la pienezza del potereespressa dalla titolatura di Artabano.
Che sia uno scettro o un diadema slegato, l’identità dell’og-getto come simbolo di potere e insegna regale non modifica so-stanzialmente il senso dell’omaggio divino e non sminuisce laqualifica del re in trono che lo riceve e il suo rango. Artabano III,dopo averlo ricevuto dalla dea, vuoi come reggente vuoi comepretendente, lo trasmette o lo consegna al successore a confermao della sua legittima ma temporanea difesa della continuità dina-stica, oppure della sua definitiva resa al vincitore di una contesa.Quest’ultima è l’interpretazione tradizionale, che risale a Newelle Sellwood, e di cui l’A. muta ora il senso dell’azione. Per Sell-wood la comparsa di Artabano sulla moneta di Pacoro rappre-sentava addirittura un atto di «unusual irony», vista la sconfitta ela resa al giovane re; per l’A. è invece atto devoto di omaggio conla restituzione del diadema regale, già ricevuto sciolto, al termi-ne degli anni di reggenza. Il rango, comunque regale, di Artaba-no è ulteriormente confermato dal suo apparire armato di unacorta spada alla presenza del re dei re suo nipote. Ma sarebbe or-
9 Safar, Mustafa 1974, 183, n. 176; Ambos 2003, 240, fig. 3; Invernizzi 2009a, 374-375, add. 5; Idem 2009b, 64, fig. 2:21.
Fig. 6. Nisa, terminale di insegna da parata.
Fig. 7. Hatra, Nanaia con polose scettro corto.
84 Antonio Invernizzi
mai un «half-king» che «voluntarily returns his power» ponendo termine alla reggenza di propriavolontà (pp. 176-178).
L’ipotesi pacifista proposta dall’A. è certo molto attraente, e la sostituzione dello scettro ‘arsaci-de’ alla corona ellenistica, in sé, potrebbe accordarsi bene con la situazione particolare e il presun-to stato di reggente di Artabano ma, nella nostra completa ignoranza degli specifici accadimentistorici del periodo, l’ipotesi non scioglie i dubbi sulle ragioni alla base di questi tipi monetali dei duesovrani e dei relativi sorprendenti dettagli. È forse più verosimile che altre più cogenti ragioni stia-no dietro l’adozione del nuovo simbolo, motivazioni però imponderabili per difetto delle nostre co-noscenze, connesse con lo stato di Artabano, con la sua provenienza o con le specifiche ignote cir-costanze storiche della sua ascesa al trono.
Per Artabano III, tanta modestia da parte di un sovrano, seppur reggente, non è immediatamentecomprensibile in rapporto a quanto ci è noto dell’esercizio del potere regale nel mondo antico, incui i re avanzano pretese di vittoria o piena autorità che sono contestabili. D’altra parte, dal puntodi vista di Pacoro II, l’omaggio resogli dal re dei re uscente al termine dell’esercizio del suo ufficionon sembra essere un riconoscimento di fedeltà, quasi un inusitato ringraziamento, quanto piut-tosto un modo per proclamare con fermezza la differenza del rispettivo stato. L’omaggio avrebbeben altro peso politico se fosse stato consigliato da ragioni di opportunità nella situazione, impos-sibile a definirsi, di una successione affatto priva di contrasti.
Naturalmente, sempre che il personaggio in questione sia proprio l’ex reggente (o ribelle) Arta-bano III, visto che per il resto gli attori della scena di omaggio al re sulle monete arsacidi sono tut-ti divini, anzi visto che vi compare la sola dea greca. D’altronde risulta difficile pensare a una divi-nità iranica per questa figura in vesti iraniche ma priva di attributi come l’aureola o la corona diraggi che accompagnano gli dei orientali dalla Commagene a Hatra.
Né sono immediatamente apparenti le ragioni per cui Pacoro, dopo i trascorsi della sua coreg-genza con Vologese I e della reggenza da parte di Artabano III, inizia il suo regno da solo facendo-si rappresentare a cavallo e non in trono, scartando cioè il tipo consacrato dall’ormai lunga praticaseguita da tanti re prima di lui, usurpatori compresi. Per la sua definitiva proclamazione a solo redei re una ripresa del motivo ufficiale già adottato dai suoi primi tetradrammi negli anni di coreg-genza con Vologese avrebbe più logicamente sottolineato la continuità del suo proprio stato rega-le dopo l’apparente assenza di nuovi tetradrammi emessi nel periodo della reggenza di Artabano.L’adozione di un nuovo tipo monetale corrisponde alla proclamazione di un nuovo corso, ma chela motivazione sia semplicemente il raggiungimento della maggiore età (peraltro già annunciatosul recto dalla corta barba), festeggiato in relazione al significato del cavallo per l’aristocrazia par-tica appare poco convincente (pp. 185-186).
Il confronto con l’analoga iconografia di altre monete arsacidi può invece portare un contributoa una interpretazione più tradizionale. L’eccezionalità della sostituzione del re in trono con il re ca-
Fig. 8. Omaggio della dea sui tetradrammi di Artabano II (S63).
Sulla Sylloge Nummorum Parthicorum da Vologese I a Pacoro II 85
valiere corrisponde bene all’eccezionalità dell’offerta dello scettro (o diadema sciolto). Entrambiquesti aspetti eccezionali suggeriscono l’esistenza in quegli anni di una situazione eccezionale. Nonper questo il background storico risulta meglio definito, ma di ciò è sola causa la nostra ignoranzadegli eventi, e si potrà solo speculare su altri più validi motivi di politica interna, dipendenti o nodai rapporti di parentela tra Pacoro e il predecessore, pur suggeriti dalle relazioni iconografiche traArtabano III e Pacoro II.
In particolare, si potrà soprattutto pensare a una situazione in cui le province nord-orientali ab-biano avuto un ruolo determinante. Queste province sembrano chiamate in qualche modo in cau-sa proprio dal cavaliere, che è un soggetto monetale caratteristico del mondo centroasiatico. Fattispecifici, interni e/o esterni, impossibili da definire ma in condizioni generali dello stato arsacidein sostanza non molto dissimili, possono aver spinto Pacoro a riprendere intenzionalmente il nonlontano precedente di Artabano II, il quale riuscì a consolidare definitivamente il suo trono propriocon il sostegno dell’Iran Nord-Orientale.10 Non è forse un caso che il nuovo tipo iconografico delcavaliere che inaugura il regno di Pacoro II unico re abbia in tutta la monetazione arsacide un soloprecedente con Artabano II, e non per uno ma sotto due aspetti: la sostituzione del re in trono conil re a cavallo e l’aggiunta di un secondo personaggio all’atto di omaggio.
Entrambi questi aspetti sono anticipati unicamente dai tetradrammi di Artabano II, dal tipo S63per la raffigurazione a cavallo del sovrano (Fig. 8) e dal tipo S62 per l’omaggio di un personaggioin vesti iraniche in aggiunta a quello della dea (Fig. 9). L’A. li richiama rispettivamente a p. 97 e nel-la nota 632 a p. 177. Se questi tetradrammi di Artabano II, che regnò in tempi non molto lontani (ca.10-38 d.C.), costituiscono l’unica analoga occorrenza, è verosimile che la ripresa dei due singolarimotivi da parte di Pacoro II nell’82 d.C. non sia stata casuale, tanto più nel suo nuovo momentoinaugurale di regno dopo una reggenza (gradita?, subita?) o dopo l’insorgenza e il placarsi di più im-portanti contrasti. La presenza di una terza figura in vesti iraniche sulle sole monete di Artabano IIe di Pacoro II sembra riflettere situazioni per certi versi analoghe negli eventi, nella gestione del po-tere regale, o nei rapporti tra i due sovrani, tali da raccomandare il preciso richiamo al primo daparte del secondo.
Certo il senso del motivo è più esplicito nel caso di Artabano II, il cui regno è noto essere statosegnato dall’alternanza di sconfitte e vittorie, e i cui tetradrammi della serie S62 celebrano il supe-ramento delle avverse vicende e il momento di massimo successo con l’aggiunta della figura in ve-sti iraniche inginocchiata al di sotto della palma di vittoria che la dea tende al re in trono, la stessapalma che il re riceve a cavallo sulla serie S63. Le prerogative della dea di Artabano II sembrano unpo’ sminuite dalla mancanza dello scettro, benché non al punto della Tyche di Seleucia, che tende
10 Olbrycht 1998, 138-157 e, in particolare, 155 per il decisivo aiuto militare assicuratogli dai Dahi e Saka contro l’usurpa-tore Tiridate.
Fig. 9. Omaggio della dea sui tetradramma di Artabano II (S62).
86 Antonio Invernizzi
la mano priva della corona in un gesto di rispetto paragonabile probabilmente a quello delle statuedei devoti nel santuario di Hatra. Essa si inginocchia, con un evidente rovesciamento di rango, da-vanti a Orode II (S45) (Fig. 10) e a Fraate IV (S53), assumendo dunque la stessa posizione che ha lafigura in vesti iraniche di fronte a Artabano II.
La celebrazione della conferma o del ristabilimento dell’autorità regale di Pacoro non segue glischemi trionfali della prassi artistica comune dall’antico Oriente fino ai Sasanidi, con l’avversariovinto calpestato. Il motivo di questo trionfo militare manca all’arte monumentale partica, e la ce-lebrazione arsacide non corrisponde a quella dei rilievi rupestri sasanidi. Ma il fatto è che di vinti evincitori si tratta qui solo per sottinteso. Le scene di Artabano II e di Pacoro II infatti non rappre-sentano direttamente alcun evento vittorioso ma, come altri documenti figurati,11 celebrano con-cetti quali il saluto, l’omaggio, il rispetto, il riconoscimento del rango, la sottomissione. Il perso-naggio in ginocchio di fronte ad Artabano II, così come la dea di fronte a Orode, non chiede lagrazia nei termini del vinto imperatore romano di fronte a Shapur I, ma rende un omaggio intesocome ‘volontario’, ‘spontaneo’. Si può meglio parlare di celebrazione della pace o del raggiunto ac-cordo tra avversari con il prevalere non assoluto di uno di essi, poiché il perdente dell’eventuale con-tesa non ne esce schiacciato ma conserva la propria dignità nella sua resa o sottomissione ad Arta-bano II, e Artabano III addirittura il suo rango speciale, l’arma al fianco.
Alla lettera, entrambe le scene e quelle analoghe dell’arte partica raffigurano lo stato di un per-sonaggio subordinato, in ginocchio o in piedi, sottomesso al re dei re in trono o a cavallo, in un at-teggiamento cioè che esprime il riconoscimento della superiore autorità di questi. Nell’interpreta-zione dubitativa ma senza valide alternative di Sellwood, il personaggio inginocchiato sulle monetedi Artabano II potrebbe infatti essere Vonone I, suo grande rivale. La rappresentazione di Artaba-no III sulle monete di Pacoro II si pone su un piano figurativo analogo, ed ha quindi lo stesso si-gnificato del rivale che cede di fronte all’avversario riconoscendone il superiore stato regale, Arta-bano III ora nei confronti di Pacoro come prima Vonone nei confronti di Artabano II. Per entrambil’atto di omaggio implica evidentemente precedenti lotte e contrasti più o meno gravi ma supera-ti. Che nel tendere l’insegna regale, sia corona o sia scettro, Artabano III resti in piedi e Vonone siainginocchiato non costituisce una differenzia sostanziale per quanto concerne il senso dell’azionee lo stato del personaggio, ma suggerisce per il primo condizioni di sottomissione o resa più favo-revoli e una sorte migliore rispetto al secondo, nel momento del superamento della rivalità, del ri-stabilimento della pace e del riconoscimento dell’autorità del vincitore.
Naturalmente qualunque interpretazione di queste scene sulle monete di Artabano III e di Pa-coro II urta contro difficoltà rese oggi insuperabili dalla mancanza di fonti storiche dirette sulla si-
11 L’A. stesso cita alcune opere (p. 97, note 385-386): il rilie-vo rupestre di Sar-e Pol-e Zohab, per cui vedi Kawami 1987,45-48, 162-164, tav. 6; Mathiesen 1992, ii, 176, n. 97); e le im-
pronte di sigilli di Nisa, per le quali vedi Nikitin 1993-1994, 74e 79, nn. 42, 46; Mollo 2001, 197-198, nn. 42, 45, 46.
Fig. 10. Omaggio della Tyche di Seleucia a Orode II (S45).
Sulla Sylloge Nummorum Parthicorum da Vologese I a Pacoro II 87tuazione in cui si inquadrano, sia per quanto riguarda i rapporti interni alla casata arsacide sia perquelli tra il re dei re e l’Iran Nord-Orientale. Ma tutto considerato, gli aspetti iconologici conferi-scono un maggior grado di verosimiglianza all’ipotesi di contrasti risoltisi, eccezionalmente, con lavittoria non schiacciante del vincitore e il ‘salvataggio’ del perdente, e con la conseguente compo-sizione, parimente eccezionale, della scena di omaggio sulle monete.
Nella seconda parte del volume trova ampio spazio il catalogo vero e proprio delle monete (pp. 207-412). Esso inizia con la ripresa di tutti i tipi dei nominali in schede sintetiche accompagnate dalla ri-petizione dei relativi disegni e dall’indicazione dei riferimenti alle tavole specifiche (pp. 213-246). Se-guono 71 tavole in b/n che riproducono in scala tutte le monete in catalogo, accompagnate nellepagine a fronte dall’indicazione telegrafica dei dati di ogni esemplare, con l’eventuale aggiunta innota dell’indicazione del materiale supplementare. E non basta. Seguono altre tavole con i sincro-nogrammi in b/n delle dramme di Vologese I e di Pacoro II (tavv. 72-73), con i grafici delle legende(tavv. 74-78), con i disegni dei tipi del recto e verso (79-87) e, infine, con disegni molto utili per for-nire controlli di massima chiarezza nella lettura di monete consunte, in cui i ritratti del recto e le fi-gure del re al verso dei tetradrammi sono anneriti risparmiando volta per volta i diademi, le vesti,i collari, i troni (tavv. 88-94).
Bibliografia (pp. 413-426) e indici (pp. 427-431) chiudono il volume. Tanta ricchezza illustrativa echiarezza nella struttura generale rappresentano un modello esemplare per l’evidenza fornita al ri-gore delle argomentazioni dell’A. Non si saprebbe immaginare un aiuto più efficace alle ricerche de-gli utilizzatori. Difficile perdersi in tanto profluvio di immagini. Solo, si sarebbe forse potuto ag-giungere ancora ai riquadri con i disegni dei tipi via via descritti nella prima sezione della prima parteil richiamo ai numeri di catalogo delle monete riprodotte nelle tavole e, ancor meglio, l’indicazionedelle pagine in cui questi tipi vengono discussi nella seconda sezione, nel cui testo non sono evi-denziati in neretto i numeri dei tipi in discussione, ma quelli di catalogo delle monete menzionate.
Insomma, un volume insostituibile per la discussione di tante questioni riguardanti l’impero par-tico, quali quelle sopra esemplificate, un volume che solleva grandi aspettative per la prosecuzionedel progetto della silloge, nella quale ci auguriamo che il volume vii possa trovarsi presto in altret-tanto buona compagnia.
Bibliografia
Ambos C.– 2003, Nanaja – eine ikonographische Studie zur Darstellung einer altorientalischen Göttin in hellenistisch-parthi-
scher Zeit, «Zeitschrift für Assyriologie», 93, 231-272.Finzi I.– 1931, s.v. Casacca, in Enciclopedia Italiana, ix, Roma, 277.Invernizzi A.– 1999, Sculture di metallo da Nisa. Cultura greca e cultura iranica in Partia («Acta Iranica», 3e série, xxi), Lova-
nii.– 2009a, s.v. Nanai, in Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae. Supplementum, Düsseldorf, 374-378.– 2009b, Nisa Partica. Le sculture ellenistiche («Monografie di Mesopotamia», xi), Firenze.– in prep., Due immagini polivalenti di Tyche Arsacide.Kawami T.– 1987, Monumental Art of the Parthian Period in Iran («Acta Iranica», 3e série, xiii), Leiden.Mathiesen H. E.– 1992, Sculpture in the Parthian Empire. A Study in Chronology, 2 vols., Aarhus.Mollo P.– 2001, Le sigillature di Nisa Vecchia, «Parthica», 3, 159-210.Nikitin A. B.– 1993/1994, Parthian Bullae from Nisa, «Silk Road Art and Archaeology», 3, 71-79.Olbrycht M. J.– 1998, Parthia et ulteriores gentes. Die politischen Beziehungen zwischen dem arsakidischen Iran und den Nomaden
der eurasischen Steppen, München.
88 Antonio InvernizziSafar F., Mustafa M. A.– 1974, Hatra, the City of the Sun, Baghdad.Sellwood D.– 1980, An Introduction to the Coinage of Parthia, 2nd edn., London.Sinisi F.– 2008, Tyche in Parthia: the Image of the Goddess on Arsacid Tetradrachms, «Numismatische Zeitschrift», 116-
117, Festschrift für Günther Dembski, 231-248.– 2012, The Coinage of the Parthians, in W. E. Metcalf (ed.), The Oxford Handbuch of Greek and Roman Coinage,
Oxford, 275-294.
composto in carattere dante monotype dallafabriz io serra editore, p i sa · roma.
stampato e r ilegato nellatipo grafia di agnano, agnano p i sano (p i sa) .
*
Aprile 2014(cz 2 · fg 21)
Amministrazione e abbonamenti / Administration & Subscriptions
Fabrizio Serra editore®, Pisa · RomaCasella postale n. 1, Succursale n. 8, i 56123 Pisa, [email protected]
I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o Online sono consultabilipresso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net.
Print and/or Online official subscription rates are availableat Publisher’s website www.libraweb.net.
I pagamenti possono essere effettuati tramite versamento su c.c.p. n. 17154550o tramite carta di credito (American Express, Visa, Eurocard, Mastercard, Carta Si).
Uffici di Pisa: Via Santa Bibbiana 28, i 56127 Pisa,tel. +39 050 542332, fax +39 050 574888, [email protected]
Uffici di Roma: Via Carlo Emanuele I 48, i 00185 Roma,tel. +39 06 70493456, fax +39 06 70476605, [email protected]
www.libraweb.net
*
Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l’adattamento, anche parziale o per estratti, perqualsiasi uso e con qualsiasi mezzo effettuati, compresi la copia fotostatica, il microfilm, la memorizzazione
elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazione scritta della Fabrizio Serra editore®, Pisa · Roma.Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.
All forms of reproduction, translation, adaptation, whether partial or for offprints, for any use whatsoeverand carried out by any means whatsoever, including photostatic copies, microfilms, recording, electronic
memoriza tion or any other informations storage system, etc., are strictly forbidden, unless prior permissionis obtained in writing from the Fabrizio Serra editore®, Pisa · Roma.
Any breach of the law will be dealt with according to the legislation in force.
*
Proprietà riservata · All rights reserved© Copyright 2014 by Fabrizio Serra editore®, Pisa · Roma.
Fabrizio Serra editore incorporates the Imprints Accademia editoriale,Edizioni dell’Ateneo, Fabrizio Serra editore, Giardini editori e stampatori in Pisa,
Gruppo editoriale internazionale and Istituti editoriali e poligrafici internazionali.
Stampato in Italia · Printed in Italy
*
issn 1128-6342issn elettronico 1724-1928
SOMMARIO
Rachel Mairs, Waiting for the barbarians: the ‘fall’ of Greek Bactria 9Omar Coloru, L’Hyrcanie arsacide à l’époque hellénistique. Un commentaire à Strabon, 11.7.1-5 31Leonardo Gregoratti, The Journey East of the Great King: East and West in the Parthian
kingdom 43Edward Dąbrowa, The Parthian Aristocracy: its social position and political activity 53Marek Jan Olbrycht, The titulature of Arsaces I, king of Parthia 63Antonio Invernizzi, Sulla Sylloge Nummorum Parthicorum. Da Vologese I a Pacoro II 75Carlo Lippolis, Old Nisa. Excavations in the south-western Area. Second preliminary report
(2008-2012) 89Sergey Yatsenko, Some notes on Parthian costume studies 117Ladislav Stan©o, Late antique fine ware dishes with indented rim in Bactria. Diffusion or evolution? 127Kazim Abdullaev, The Buddhist culture of ancient Termez in old and recent finds 157
Gli autori di questo numero 189