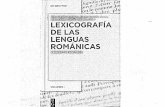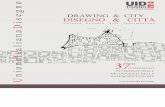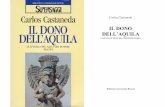Progettazione grafica della mostra “Il dono di Dioniso. Storia, produzione e consumo del vino nel...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Progettazione grafica della mostra “Il dono di Dioniso. Storia, produzione e consumo del vino nel...
Dioniso
Il dono di Dioniso Storia, produzione e consumo del vino nel mondo antico
I
Coppa di Exekias con Dioniso su imbarcazione Exekias 540-530 a.C. Monaco, Staatliche Antikensammlungen
Moneta con Dioniso ubriaco Mende, 510-480 a.C.
Cratere a volute, attico a figure rosse. Zeus affida il piccolo Dioniso ad una ninfa del monte Nisa Pittore di Altamura 470-60 a.C. Ferrara, Museo Archeologico Nazionale
Coppa a figure nere con Dioniso e Semele Pittore di Callis (attr.) VI sec. a.C. Napoli, Museo Archeologico Nazionale
Cratere a campana, attico a figure rosse. Dioniso seduto su un trono sostiene sulle ginocchia Oinopion, nudo e coronato di edera, che gli porge un kantharos Pittore di Altamura 460 a.C. Ferrara, Museo Archeologico Nazionale
Hydria attica a figure rosse. Dioniso tende un kantharos ad un personaggio femminile Pittore dei Niobidi 460 a.C. Ferrara, Museo Archeologico Nazionale
ioniso era venerato presso i Greci come dio del vino e dell’estasi. Numerose leggende riguardano la sua nascita, l’origine e la diffusione del suo culto, i caratteri contraddittori della sua personalità divina.
La più nota narra che Dioniso nacque da Zeus e da una donna mortale, Semele, figlia del re di Tebe, che morì folgorata prima di darlo alla luce per aver chiesto a Zeus di mostrarsi a lei in tutto il suo splendore, circondato cioè da lampi e fulmini. Ma Zeus salvò Dioniso cucendoselo nella coscia per il tempo restante della gestazione. Poi, per evitare le insidie della gelosa moglie Era, lo fece consegnare da Ermes alle Ninfe del monte Nisa (sinonimo per i Greci di luogo fertile per eccellenza, in Arcadia, ma identificato anche con varie località), che lo nascosero in una grotta e lo nutrirono con miele (Apollodoro, III, 4, 3). Dioniso divenne di singolare bellezza e forza, abile nelle arti e capace di inventare ogni cosa utile. Proprio sul monte Nisa, ancora ragazzo, scoprì il vino spremendo i grappoli della vite che lì cresceva spontaneamente. Riconosciuto da Era che lo fece impazzire per vendicarsi di Zeus, Dioniso iniziò così a vagare per il mondo accompagnato dal suo tutore, Sileno, e da un gruppo di Satiri e Menadi, diffondendo tra i mortali la coltivazione della vite, l’uso e la conservazione del vino, provocando estasi nei seguaci e terrore in quanti gli si opponevano. Molte città dapprima si sarebbero rifiutate di accoglierlo al loro interno, per il turbamento dell’ordine sociale che comportava diventarne seguaci, ma poi gli riconobbero il merito di aver civilizzato la terra diffondendo la coltivazione della vite e lo onorarono al pari degli altri dei. A seconda delle località in cui si radicò il suo culto, Dioniso fu venerato con appellativi vari (Eliano, Storie varie, II, 41).
Ma Bacco fu l’epiteto più popolare del dio, da cui i suoi seguaci erano detti baccanti, e questo nome venne prevalentemente usato nel mondo romano per designarlo.
Le tappe delle sue peregrinazioni, dall’Egitto all’India, alla Frigia, alla Tracia, alla Beozia, alle varie isole dell’Egeo e città della Grecia, coincidono con luoghi di produzione di rinomate qualità di vini. Risulta così evidente che la vicenda mitica di Dioniso è la metafora del diffondersi della coltivazione della vite in Europa, Asia ed Africa settentrionale, e il trionfo di Dioniso espressione della superiorità riconosciuta al vino su ogni altra bevanda inebriante.
Nell’iconografia classica Dioniso è rappresentato ora come grazioso giovinetto avvolto in una pelle di pantera e incoronato con foglie di vite e grappoli d’uva, ora come vecchio barbuto, grasso e avvinazzato, per significare appunto la doppia condizione di inebriante euforia e di molesta ubriachezza che il vino produce.
Dionysus
Dionysus was worshipped by the Greeks as the god of wine and ecstasy. A lot of tales tell about his birth, his origin, the spread of his worship and the contradictory qualities of his divine personality. The most famous tale tells that Dionysus was born from Zeus and a mortal woman, Semele, daughter of Thebes’s king, who died struck before giving birth because she asked Zeus to show himself totally shining, that is, crowned by lightning and flashes; but Zeus saved Dionysus sewing him in his thigh for the remaining time of gestation.
After Zeus ordered Hermes to deliver him to the Nymphae
of Nisa mountain (that was considered by Greeks above all a fertile area in Arcady but identified with different localities) to avoid his jealous wife Hera’s snares. Nymphae hid him in a cave and nourished him with honey (Apollodorus, III, 43). Dionysus became very beautiful and strong, clever at arts and able to invent all sorts of useful things. On Nisa mountain when he was still a boy, he got to know the wine by squeezing the bunches of grapes that spontaneously grew there.
Hera recognized him and drove him crazy to get her re-
venge against Zeus; Dionysus begun to walk around the world with his guardian, Silenus, and with a group of Satyrs and Maenads, spreading among men wine’s cultivation, usage and conservation and causing ecstasy in his disciples and fear in those who opposed him. Several towns initially refused to re-ceive him, since to become his follower was tantamount to cause social disorder, but then they ascribed him the merit of earth’s civilization and worshipped him like the other Olympic gods. Dionysus was called with different epithets according to the locality in which his worship spread (Helianus, Variae His-toriae, II, 41), but ‘Bacchus’ was the most famous one and from this name his followers were called ‘Bacchants’; this was also the name of the god during Roman period.
The places where he travelled (Egypt, India, Phrygia,
Thrace, Beotia, various Aegean islands and cities of Greece) overlap the most famous places of wine’s production. From this coincidence it is clear that Dionysus’s tale is a metaphor about vine’s cultivation in Europe, Asia and Northern Africa and Dionysus’s triumph is a symbol of the superiority of the wine over every other intoxicating beverage.
In classical iconography Dionysus’s is depicted like a nice
boy enveloped in a panther’s skin, crowned by bunches of grapes and sometimes like an old, bearded, fat and drunken man, in order to represent the double effect of wine that is in-toxicating euphoria and bothersome drunkenness.
CENTRO HERAKLES per il turismo culturale
Il dono di Dioniso Storia, produzione e consumo del vino nel mondo antico
Per una storia del vino nell’antichità
a produzione del vino risale ad epoca antichissima, avviata verso la fine del Neolitico da una fortuita fermentazione di grappoli d’uva di vite selvatica, come dimostra il racconto biblico dell’approdo di Noè dopo il diluvio sul
monte Ararat (Armenia) e della sua casuale scoperta della bevanda inebriante che si poteva ricavare dai grappoli di viti che crescevano spontanee su quelle vallate. Del resto in alcuni insediamenti umani preistorici sono stati ritrovati semi di Vitis silvestris.
La vite selvatica cresceva spontaneamente anche in altre regioni e comunque nel corso dell’età del bronzo la coltivazione si diffuse nella penisola anatolica e lungo le coste settentrionali e meridionali del Mediterraneo. Scene di vinificazione raffigurate su monumenti mesopotamici e dell’antico Egitto attestano la pratica della viticultura fin dal III millennio a.C.
La viticoltura risulta già praticata a Creta dall’inizio del II millennio a.C. e ampiamente diffusa in Grecia in età micenea. La maggior serie di informazioni sulla coltivazione della vite e sull’utilizzo e l’importanza del vino nella Grecia arcaica si ricava dalle opere di due grandi poeti, Omero ed Esiodo. Dall’Iliade e soprattutto dall’Odissea risulta che il possesso di ampi vigneti, in aggiunta ai campi coltivati a grano – oltre che privilegio degli dei nei terreni destinati al loro culto – era prerogativa di re e di esponenti dell’aristocrazia, i soli che potessero permettersi i costi d’impianto di un vigneto, i lunghi tempi necessari a ricavarne frutto (dai cinque ai quindici anni), le attrezzature occorrenti per la vinificazione e la conservazione del prodotto. Perciò il vino era considerato un bene di lusso, simbolo di prestigio, oggetto di offerte alla divinità o di dono ospitale negli scambi tra capi di comunità diverse. Particolarmente forte era la sua caratterizzazione sacrale e sociale: era immancabile nelle libagioni sacre che precedevano ogni attività comunitaria; nei sacrifici pubblici che si concludevano, nel banchetto comune, con un’equa distribuzione di porzioni di carne degli animali sacrificati e di coppe di vino fra tutti i partecipanti; nei simposi degli aristocratici.
Esiodo, che col poemetto Opere e Giorni intese anche dare consigli sulla coltivazione della terra al piccolo agricoltore, accenna solo alla raccolta, all’essiccazione ed alla conservazione dell’uva (vv. 609-614), non alla coltivazione di un vigneto ed alla vinificazione, a conferma della pertinenza aristocratica delle colture specializzate di vigneti ed oliveti nella Grecia arcaica.
Esistevano numerose varietà di vitigni, dai quali – anche in ragione delle proprietà chimiche del terreno – si produceva vino con caratteristiche diverse di gusto, aroma, gradazione alcolica e capacità di invecchiamento; esso prendeva il nome dal luogo di provenienza o dal principale luogo di produzione. Tra i più antichi e rinomati, basti ricordare il “vino biblino” (Esiodo, Op., v. 589), tratto da una vite rampicante, introdotta a Siracusa per primo dal re argivo Pollide (Ippi di Reggio, F. 4).
Molto apprezzati in Grecia rimasero sempre i vini di Pramno (nell’isola di Lesbo), di Chio, di Taso; in età ellenistica si impose su larga scala nel commercio mediterraneo del vino quello di Rodi.
Quanto ai sistemi di viticoltura d’età greca, dalle raffigurazioni sulla ceramica risultano praticati tanto il sistema a pergola, diffuso soprattutto in Egitto e poi in Italia, in cui il sostegno era costituito da alberi o lunghe pertiche, quanto quello a terra, con pali bassi di sostegno. La vendemmia aveva luogo intorno alla metà di settembre “quando Orione e Sirio giungono in mezzo al cielo” (Esiodo, Op., v. 609).
La pigiatura dei grappoli veniva fatta in tinozze di legno o in vasche in muratura, poste più in alto rispetto al piano di calpestio per far defluire il mosto in grandi vasi di terracotta cosparsi all’esterno di resina e pece, nei quali, profondamente interrati, avveniva la fermentazione. A tempo debito si procedeva al travaso del vino in anfore di terracotta o in otri, pronti per l’uso o per l’invecchiamento.
La colonizzazione greca dell’Italia Meridionale e della Sicilia dall’VIII secolo a.C. in poi diede un impulso decisivo alla estensione della coltivazione della vite in Italia. Allora si diffuse anche tra le popolazioni italiche in contatto con le città greche la pratica dell’innesto per ottenere uve pregiate e vini di qualità.
Per le favorevoli condizioni climatiche e la ottima qualità dei suoli, in Magna Grecia si ebbe uno sviluppo precoce della viticoltura nei terreni tanto delle città greche quanto di alcuni centri enotri.
Scena di vendemmia 540 a.C. Parigi, Museo del Louvre
Scena di pigiatura 460 a.C. Ferrara, Museo Archeologico Nazionale
Kylix attica a figure nere con scena di vendemmia VI sec. a.C. Parigi, Cabinet des Médailles
II
Wine’s history in the Ancient world
Wine-production goes back to a very ancient period, begin-ning towards the end of the Neolithic era, by fortuitous fer-mentation of bunches of grapes of wild vine, as evidenced by the biblical tale about Noah’s landing after the Deluge on Ara-rat mountain (Armenia) and his fortuitous discovery of intoxi-cating beverage obtained from bunches of vines spontaneously growing on those valleys. In some prehistoric human settle-ments seeds of Vitis silvestris were actually found.
Wild vine, spontaneously growing also in other places and
anyway during Bronze Age cultivations, spread in Anatolian peninsula and along Mediterranean Northern coasts.
Wine-production depictions on Mesopotamian monuments
and in Ancient Egypt attest viticultural activity since the third millennium b.C. Viticulture is attested in Crete since the be-ginning of the second millennium b.C. and it was largely dif-fused in Greece during Mycenaean period.
The main corpus of information about viticulture, use and
value of wine in archaic Greece can be extrapolated from Homer and Hesiod’s works. The Iliad and most of all the Od-yssey attest that possession of large vineyards in addition to cultivated cornfields – besides being a privilege of gods in the lots of land destined to their cult – was a privilege of kings and of aristocracy, who were the only ones rich enough to bear the cost of vineyard’s cultivation and the long-term investment (from five to fifteen years), as well as the equipments for wine-production and conservation. Therefore, wine was judged a luxury good, a status symbol, an offer to the god or a gift for guests in the exchanges among the leaders of different com-munities. Its holy and social value was very strong: it was al-ways present in libations preceding every activity of the com-munity; in public sacrifices ending in a banquet with an equal distribution of portions of sacrificed animals’ meat and of wine among the participants; in symposia of aristocracy.
Hesiod, whose Works and Days counselled the little farmer
about cultivation of fields, mentions only in passing the collec-tion, drying process and conservation of grapes (vv. 609-614), but does not talk about vineyard’s cultivation and wine-production: this fact confirms therefore that specialized culti-vations of vineyards and olive groves in archaic Greece were typical of aristocracy.
There were several species of vines and these, also on the
basis of chemical properties of each soil, produced wine with different qualities of taste, aroma, alcoholic content and aging capability; it was named after its place of origin or after its main place of production.
Among the most famous and ancient wines we may mention
“bibline wine”’ (Hesiod, Op., v. 589) that was produced by a creeping vine brought in Syracuse for the first time by Argive king Pollides (Ippi from Reghion, F. 4). In Greece the wines of Pramnos (in the island of Lesbos), Chios and Thasos were always appreciated wines; in the Hellenistic period Rhodi’s wine spread on a large scale in Mediterranean trade.
As far as viticultural systems in Greek period are con-
cerned, depictions on pottery show that they used both per-gola (system used above all in Egypt and in Italy, that is formed of trees or long perches) and the ground-system, with short stakes. Vintage took place around the middle of Sep-tember when “Orion and Syrios get in the middle to the sky” (Hesiod, Works and Days, v. 609). Wine-pressing was made in wooden tubs or in masonry tanks, higher than the floor so that to let the must flow in earthen-wares strewn with resin and pitch, and in those wares, deeply buried, fermenta-tion began. At the right moment they decanted wine in am-phora of clay or in wineskins to be used or aged.
Greek colonization of South Italy and of Sicily, from VIII
b.C. on, boosted the spread of vine’s cultivation in Italy. At that time grafting system to obtain precious grapes and wines spread in Italic populations who were in touch with Greek towns. Because of favourable climatic conditions and the ex-cellent quality of soils, in Magna Graecia there was a preco-cious development of viticulture both in Greek towns and in some Oenotrian towns.
CENTRO HERAKLES per il turismo culturale
Il dono di Dioniso Storia, produzione e consumo del vino nel mondo antico
Le “leggi” sul vino
l vino rientrava nell’alimentazione abituale dell’uomo greco benestante e figurava in tutti i pasti della giornata, che lo scrittore ellenistico Filemone distingueva così: colazione (acràtisma), in cui si poteva consumare vino puro intingendovi pezzetti
di pane; pranzo di mezzogiorno (àriston); pasto serale (hespérisma) e cena (déipnon) (Ateneo, I). L’uso del vino era rigorosamente regolamentato in tutti i sistemi legislativi noti, che recepivano la preoccupazione diffusa e presente già in Omero di permetterne l’uso con grande moderazione. Se ne fa efficace interprete Platone, quando discute sulle leggi migliori per il suo stato ideale:
“Emaneremo anzitutto una legge per cui i giovinetti che ancora non abbiano compiuto i diciotto anni, non debbono assolutamente gustare il vino, insegnando che non bisogna versare fuoco sul fuoco del corpo e dell’anima, prima di essere stati avviati a sopportare la fatica, per porre un freno alle esuberanti tendenze proprie della giovinezza. Poi, fino a trent’anni, gustino pure il vino, ma con misura, ché un giovane deve assolutamente astenersi dall’ebbrezza e dall’abuso di quella bevanda. Quando in seguito l’uomo abbia raggiunto la quarantina, pranzi in sissizii, invochi tutti gli dèi e inviti anche Dioniso a questo, che, ad un tempo, è sacro rito d’iniziazione e gioiosa festa dei vecchi, sacro rito di cui lo stesso dio fece dono agli uomini quale aiuto e rimedio alla grave austerità della vecchiaia” (Platone, Leggi, 666 a-b).
Il consumo di vino puro era di solito consentito solo ai malati a fini terapeutici. Il più antico legislatore della Magna Grecia, però, il severo Zaleuco di Locri (VII secolo a.C.), – forse per stroncare qualche abuso di malattie fittizie invocate per eludere il divieto – vietava ai malati l’uso della bevanda senza prescrizione medica. Infatti stabilì che “se un cittadino di Locri Epizefiri, quando era malato, beveva del vino puro senza che il medico glielo avesse prescritto, anche se guariva era prevista per lui la pena di morte, perché aveva bevuto qualcosa che non gli era stato ordinato” (Eliano, Storie varie, II, 37). Per consuetudine il vino era poi vietato alle donne di qualunque età, perché secondo la mentalità comune ne avrebbe messo a rischio le virtù. In qualche città c’era stato bisogno di una legge per ribadirlo con forza; tra queste sono espressamente indicate la focea Massalia (odierna Marsiglia) e Mileto, come dire da una capo all’altro del Mediterraneo! A Roma, poi, era legge rigorosamente rispettata che nessuna donna, né libera né schiava, bevesse vino e neppure i giovani di buona casata, con meno di trentacinque anni, potevano farlo (Eliano, Storie varie, II, 38).
Senatusconsultum de Bacchanalibus su lamina in bronzo 186 a.C. Vienna, Kunsthistorisches Museum Il testo epigrafico, ritrovato nel 1640 a Tiriolo (Cz) durante gli scavi di fondazione del palazzo del principe Cigala, contiene la disposizione del senato romano che vietava lo svolgimento dei bacchanalia, festvità rituali dedicate a Bacco, che per il loro carattere orgiastico, e probabilmente per l’eccessivo uso di vino, costituivano una minaccia per l’ordine pubblico.
III
“Laws” of the wine
Wine was an element of the alimentation of the rich Greek man and it was present in all meals of the day divided by the Hellenistic writer Philemone in this partition: breakfast (acràtisma), in which one can drink neat wine dipping in little pieces of bread; lunch at midday (àriston); evening meal (hespérisma) and dinner (déipnon) (Athenaeus, I).
Usage of the wine, however, was ruled in all known legisla-
tive systems that received the common worry (already present in Homer) of allowing only moderate consumption. Plato (Laws, 666 a-b) speaks about it when he discuss about the better laws for his ideal state: “First of all we will publish a law according to which people younger than eighteen should not taste of wine, teaching that one should not add fire on the fire of body and soul, before having been accustomed to en-dure toils, and to limit the excessive trends of youth. Then, until the age of thirty, they may taste of wine but moderately, since young people must restrain themselves from drunken-ness and from excess of that drink. When people reach the age of forty, that they take their meals in syssitia, invoking all the gods and inviting Dionysus as well, to what is at the same time a sacred ritual of initiation and a joyous feast of the old, a sacred ritual, Dionysus’s gift to the men as help and remedy for heaviness of old age”.
Neat wine’s consumption was usually possible only for ill
people with therapeutic aims. The most ancient lawgiver of Magna Graecia, however, the strict Zaleucus of Locris (VII b.C.) – maybe to avoid some abuse relate to illness fabricated to shun the prohibition – forbade ill people the consumption of the beverage without a prescription. He actually established that “if a citizen of Locri Epizephyrii when he was ill drunk neat wine without prescription, also if he recovered, death penalty was established for him because he had drunk some-thing that had not been prescribed to him” (Helianus, Variae Historiae, II, 37).
According to the custom, the wine was forbidden to the
women of all ages because it would have risked their virtue. In some towns there was the necessity of a law that would stress this fact; between those towns there are the Phocean Massalia (today Marseille) and Miletus, from one to the other pole of the Mediterranean Sea! In Rome a law established that any woman, either free or slave, drunk wine and also aristocratic youth less the 35 years old could drink it (Helianus, Variae Historiae, II, 38).
CENTRO HERAKLES per il turismo culturale
Il dono di Dioniso Storia, produzione e consumo del vino nel mondo antico
Il vino e il simposio
“Bevi con me, suona con me, porta con me la corona; quando son pazzo, siilo anche tu con me e quando son savio sii savio anche tu”
(Carmina Convivalia, in Ateneo, XV, 695 d)
l simposio (da syn pìnein, bere insieme), rappresenta nel mondo greco (come poi in quello romano) un importante fenomeno sociale. Si tratta di una riunione quasi sempre di soli uomini dopo il pasto serale, per bere insieme: durante il suo
svolgimento che in ogni fase conserva una forte valenza comunitaria, persone della medesima estrazione sociale alta (ma non della stessa età) e appartenenti di solito ad una determinata cerchia culturale si scambiano idee ed opinioni riguardo ai temi più cari al cittadino greco, dall’amore alla politica, dalle gesta degli antenati alle leggi patrie, ed esercitano le arti della poesia, della musica, del canto, della rappresentazione teatrale, della seduzione amorosa o del divertimento giocoso cimentandosi direttamente o godendo della prestazione altrui.
Tra un sorso o una coppa di vino e l’altra, il simposio costituisce una palestra di sapienza, il luogo privilegiato di trasmissione da una generazione all’altra di regole di comportamento e memorie del passato, di elaborazione dialogica di nuovi percorsi di conoscenza, di creazione poetica.
Ciò che meglio lo caratterizza è la ricerca ora gioiosa ora pensosa del godimento, raramente volgare, del corpo e dello spirito, che è dono delle Muse e di Dioniso, e che si nutre però anche di scherzi, lazzi, sfide, giochi.
L’anima del simposio è appunto il vino, che accende la sensibilità e la voglia di vivere, e, come dice Platone, è “il dono che lo stesso Dioniso fece agli uomini quale aiuto e rimedio alla grave austerità della vecchiaia, sì che la nostra gioventù riviva e l’anima nostra ormai indurita, obliando la sua freddezza, si faccia più tenera come ferro nel fuoco, divenendo così più malleabile” (Platone, Leggi, 666 b-c).
Per questo l’atto preliminare a ciascun simposio era una “libagione”, una formale offerta agli dei del vino che sarebbe stato consumato. Venivano consacrati alle divinità tre crateri: il primo a Zeus e a tutti gli dei dell’Olimpo, il secondo agli eroi, il terzo al Zeus Sotér (salvatore). Dioniso costituiva l’oggetto stesso della libagione, era cioè rappresentato dal vino dei tre crateri, da cui appunto si attingeva il vino per la libagione riempiendo una coppa a ciascuno dei partecipanti al simposio.
Scena di taglio del vino
Cratere a calice apulo a figure rosse con scena di banchetto IV sec. a.C. Ruvo di Puglia, Museo Archeologico Nazionale
Cratere a campana a figure rosse con scena di banchetto 360-330 a.C. Napoli, Museo Archeologico Nazionale
Olpe a figure rosse con scena di banchetto Seconda metà del IV sec. a.C. Napoli, Museo Archeologico Nazionale
Cratere a campana a figure rosse con scena di simposio 400-380 a.C. Napoli, Museo Archeologico Nazionale
IV
Wine and Symposium
“Drink with me, play with me, wear a crown with me; when I’m crazy, let’s be crazy with me and when I’m wise let’s be wise with me” (Carmina Convivalia, in Athenaeus, XV, 695 d)
Symposium (word comes from syn pìnein, drink together)
represents in the Greek world (and then in the Roman world) an important social phenomenon. It is almost always a meet-ing of men after supper to drink together: during the sympo-sium, that has a strong value for community, people from the same high social class (but not coevals) and usually from a precise cultural circle exchange ideas and opinions about sub-jects of outmost interest for Greek citizen (love, policy, ances-tors’ deeds, laws).
They attend to poetry, music, singing, theatre, loving se-
duction or playful amusement, either actively of watching oth-ers’ performances. Between a sip or a cup of wine, sympo-sium was a practice of wisdom, the privileged place of trans-mission of behaviour’s rules, history, of dialogic elaboration of knowledge, and of poetry. Its main feature is the now happy and now thoughtful, but rarely vulgar quest for enjoyment of the body and soul; this enjoyment is a gift from the Muses and Dionysus and feeds on jokes, challenges and games as well.
Wine is exactly symposium’s soul that inflames sensitivity
and lust for life and, as Plato says, is “Dionysus’s gift to the men as help and remedy for heaviness of old age in such a way as our youth lives again and our hardened soul, forgetting its coldness, becomes more tender like iron in fire becoming like-wise more malleable” (Plato, Laws, 666 b-c).
Because of this fact a libation was made before every sym-
posium, an offering to the gods by wine that was to be con-sumed. Three craters were devoted to the gods: the first to Zeus and all the other gods of Olympus; the second to the he-roes and the third to Zeus Sotér (the Saver). Dionysus was the object of libation, he was symbolized by wine in the cra-ters, that contained wine for libation filling a cup for every guest of the symposium.
CENTRO HERAKLES per il turismo culturale
Il dono di Dioniso Storia, produzione e consumo del vino nel mondo antico
Lo spazio del simposio
ttraverso l’evidenza archeologica, le fonti letterarie e le raffigurazioni presenti per lo più sulle forme vascolari è possibile ricostruire e comprendere le modalità e lo spazio in cui si svolgeva il simposio. Esso aveva inizio dopo il
pasto serale (deìpnon) e si protraeva fino a tarda notte; quando, tolte le “prime tavole”, lavate le mani e spazzato il pavimento, venivano portate le “seconde tavole”. Dal simposio erano del tutto escluse le donne, eccetto le etère o le flautiste e le danzatrici, per lo più di condizione servile o comunque non legate da vincoli matrimoniali legittimi.
L’inizio del simposio avveniva dopo un’abluzione (lavaggio delle mani) e una libagione, che consisteva nel sorseggiare vino puro, pronunciare una preghiera e fare un’offerta. I convitati si presentavano al simposio con vesti eleganti e leggere e con il capo cinto da bende di lana colorata e corone di fiori. Esso si svolgeva in un ambiente preciso della casa (andròn) lungo le pareti del quale venivano sistemati i letti (klìnai), che potevano variare da 7 a 15, in base alla dimensione della stanza.
Sui letti si giaceva in posizione semisdraiata, appoggiandosi col braccio sinistro su cuscini, ed ogni letto poteva ospitare due o tre convitati. Ciascuno era disposto in modo tale da poter vedere tutti gli altri ed essere sempre in condizione di eguaglianza con tutti i suoi compagni, a portata di voce e di sguardo, affinché si potesse colloquiare senza difficoltà. Davanti a ciascun letto venivano disposti piccoli e bassi tavolini (tràpezai) su cui era collocata la suppellettile da tavola che serviva per contenere, oltre al vino, anche noci, fichi secchi ed altre varietà di piatti stuzzicanti con i quali si accompagnava la bevanda del simposio. I convitati eleggevano quindi un simposiarca (il re del banchetto) al quale spettava decidere le regole del simposio: dalle modalità del bere alle altre attività da svolgere durante la serata. Disobbedire al simposiarca significava essere esclusi dai simposi e messi ai margini della vita sociale.
La regola principale nel simposio era la condivisione del cibo, che veniva distribuito in parti uguali secondo il rispetto del principio dell’uguaglianza, e la condivisione del vino: non si doveva mai bere da soli ma in gruppo. Il simposiarca stabiliva quale dovesse essere la miscela tra acqua e vino: da Plutarco si ricavano le proporzioni di due parti di vino su tre di acqua o di tre su cinque (Plutarco, Questioni conviviali, 3-9; Ateneo, X, 426 c). Altre regole dettate dal simposiarca erano relative alla tipologia di coppe da usare, alla quantità di vino da bere (tre coppe erano la giusta misura) ed al modo in cui dovesse essere bevuto; di solito si comandava di berlo in una volta, senza cioè riprendere fiato e senza chiudere le labbra. Spesso il simposiarca costringeva a bere grandi quantità di vino: è il bere per costrizione, a comando (pros bìan), contrario al bere per piacere (pros edonèn).
Il poeta greco Senofane in una sua elegia espone le norme che regolano il buon simposio, l’ideale era quello di rimanere sempre sobri, in equilibrio sul crinale che divideva i vantaggi e gli svantaggi che il vino offriva: “[…] si deve lodare chi dà prova di un nobile carattere dopo aver bevuto, e chi usa la sua memoria e la sua forza per fini morali” (Senofane, fr. B I West in Ateneo, XI, 462 c-f).
Il simposio in molti casi terminava con un corteo (kòmos) che si svolgeva fuori dalla casa e poteva assumere un andamento sfrenato, il cui clima si può intuire dalle raffigurazioni di frenetiche danze di convitati accompagnati da menadi e satiri presenti sui vasi.
Ricostruzione di un andròn
Scena di simposio: particolare della Tomba del Tuffatore 480-470 a.C. Paestum, Museo Archeologico Nazionale
Cratere a campana con scena di banchetto Metà del IV sec. a.C. Napoli, Museo Archeologico Nazionale
V
The space of the symposium
Thanks to archaeological evidence, literature and especially vase painting it is possible to reconstruct and understand the ways and the places of the symposium. It started short after supper (deìpnon) and it lasted until dead of night; after having cleared the ‘first tables’, washed one’s hands and cleaned the floor, the ‘second tables’ were brought. Women were totally excluded from the symposium, except hetaerae or flautists and dancers, mainly slaves or anyway those who were not officially married.
The beginning of symposium took place after an ablution
(washing of the hands) and a libation performed by sipping neat wine, praying and making votive offerings. Guests ap-peared for symposium elegantly and lightly dressed, with their heads surrounded by dyed bandages and wreaths of flowers. It took place in a precise place of the house (andròn) along whose walls they put beds (klìnai) varying from 7 to 15 ac-cording to the size of the room. People layed down in these beds, leaning on cushions and each bed could host from two to three guests.
Everyone stayed in such a way as to see all the other guests
and to be equal to all their companions, so that they could look at each other and converse with ease. In front of every bed they put small and short tables (tràpezai) on which they put vessels that contained, in addition to wine, also walnuts, dried figs and different types of appetizers that they ate with the drink of symposium.
Guests chose a symposiarch (the king of he symposium)
and his role was to establish the rules of the symposium, the way of drinking and other activities to be done during the night. Disobeying the symposiarch was tantamount to being left out of symposia and excluded from social life. The main rule of the symposium was sharing the food, that was equita-bly assigned, according to the principle of equality, and shar-ing the wine: one never had to drink one one’s own but always in group. The symposiarch established the mixture of water and wine: Plutarch says that the proportion of water and wine was 2:3 or 3:5 (Plutarch, Quaestiones conviviales, 3-9; Athe-naeus, X, 426 c). He also established the type of drinking glasses to be used, the quantity of wine to be drunk (the exact quantity was three glasses) and the way of drinking (usually they drink all in one), without breathing and closing the mouth.
Symposiarch often forced to drink a lot of wine: this type of
drinking was drinking under compulsion (pros bìan) different from drinking with pleasure (pros edonèn). The Greek poet Xenophan describes in an elegy the rules for a good sympo-sium, optimum was to always be sober, in between the advan-tages and the disadvantages offered by the wine: “[…] praise must be given to those who show a noble character after hav-ing drunk and use their memory and strength for moral ends” (Xenophan, fr. B I West in Athenaeus, XI, 462 c-f).
Symposium usually finished in a revel (kòmos) that took
place outside the house and it could be unbridled, as we can imagine through the images of guests (with maenads and sa-tyrs) frenetic dances in vase paintings.
CENTRO HERAKLES per il turismo culturale
Il dono di Dioniso Storia, produzione e consumo del vino nel mondo antico
Gli instrumenta del simposio
dati archeologici recuperati in contesti sia rurali che urbani, insieme ai dati iconografici offrono indicazioni significative per l’individuazione degli strumenti e degli utensili che nel mondo greco e magnogreco erano destinati alla mescita e al
consumo del vino. Nei simposi venivano adoperati diversi contenitori ceramici, ognuno dei quali aveva una specifica funzione e destinazione d’uso in base alla forma ed alla dimensione. Essi potevano essere artisticamente decorati con soggetti che rimandavano alla cultura condivisa dei simposiasti e che ne caratterizzava il loro status sociale.
Nel ricco repertorio vascolare, sia di produzione locale che di importazione greca, si possono individuare le forme chiuse, utilizzate per versare, e le forme aperte impiegate per mescere o per bere.
L’elemento centrale del simposio è il cratere, il vaso consacrato a Dioniso, nel quale il vino puro si mescolava con l’acqua, secondo una consuetudine tipicamente greca originata dal bisogno di controllare gli effetti conseguenti all’uso del vino puro, ad alta gradazione alcolica. Il cratere è un contenitore monumentale, dotato di una imboccatura dal diametro assai ampio e provvisto di due anse verticali, impostate sulla spalla per facilitarne la presa.
Accanto al cratere sono presenti altri vasi, sempre collocati al centro della tavola e atti a contenere il vino, quali lo stámnos e il dèinos. Il primo per la forma è molto simile ad un cratere, ma presenta una bocca più stretta ed è provvisto, in alcuni casi, di coperchio; il secondo, privo di anse, è di forma sferoidale e necessitava di un apposito sostegno, generalmente alto e lavorato.
Tra i contenitori di dimensioni grandi bisogna ricordarne uno simile ad un fiasco con una larga pancia (psyktèr) che, colmo di vino ed inserito in un cratere riempito di neve, serviva per refrigerare il vino.
La bevanda ottenuta dalla mescita veniva attinta dai grandi contenitori con una sorta di mestolo (kýathos), una coppa con un’ansa alta, e travasata nelle brocche di varia foggia, con le quali veniva servito ai commensali. In questa categoria rientrano le brocche a bocca trilobata (oinochóai), le grandi brocche a bocca tonda (òlpai) e i piccoli otri (askòi).
Il vino si sorseggiava in piccoli recipienti, caratterizzati da due manici e da vasche di varie fogge, tra le quali quelle più ricorrenti sono: una coppa con grandi anse vistosamente esorbitanti dall’orlo (kántharos), un bicchiere (skýphos), una larga coppa (kỳlix) e una tazza (kotỳle).
Concludono il repertorio del simposio una coppa a forma di corno, configurata a testa di animale (rhytòn) e un piatto (phiale) ombelicato, ossia con una sporgenza al centro per facilitare la presa, utilizzato per le libagioni.
Corredo funerario con vasellame da simposio Necropoli di Banzi, loc. Piano Carbone V sec. a.C. Melfi, Museo Archeologico del Melfese
Cratere Stámnos Dèinos Psyktèr Kýathos Oinochóe Olpe
Kỳlix Skýphos Kàntharos Askòs Phiale Rhytòn
VI
Instrumenta of symposium
In addition to iconographic data, archaeological evidence, collected both in rural and urban contexts, provide important information for identification of means and tools that were used to pour wine and for consumption of wine.
A lot of pottery containers were used in the symposia and
everyone had a different usage and function according to its size and shape. They could be artistically decorated with sub-jects coming from guests’ common culture and that character-ized their social status.
Among the types of vase painting, both from local produc-
tion and Greek importation, closed shapes (used to pour out) and open shapes (used to pour or to drink) can be individu-ated.
The crater was a central element of the symposium, a vase
consecrated to Dionysus, in which neat wine was mixed with water, according to a specific Greek custom born from the ne-cessity of controlling the effects of neat wine with high alco-holic content. The crater was an impressive container, with a very large mouth and with two vertical handles on its shoulder to make the handling easy.
In addition to the crater there are other types of vase,
placed at the centre of the table to contain the wine, such as the stamnos and the déinos. The first is very similar to a crater in its shape, but has a tighter mouth and sometimes a lid; the second, without handles, is spherical in shape and had to have a special support that was high and elaborate.
Among containers we have to mention a type similar to a
flask with a large belly (psykter) that, once full of wine and placed in a crater full of snow, which was used to refresh the wine.
The beverage obtained from the pouring off was drawn
from big containers with a ladle (kyathos), a cup with a high handle and decanted in different types of jug by which it was served to the guests.
The jugs with trilobate mouth (oinochoai), the big jugs with
a round mouth (olpai) and the little wineskins (askoi) entry this category.
The wine was sipped in little containers with two handles
and various cups and the most common were: a cup with big handles jutting out from edge (kantharos), a glass (skyphos), a large bowl (kylix) and a cup (kotyle).
Finally in the inventory of the symposium entry a cup with
the shape of a horn, like an animal’s head, (rhyton) and a um-belicate dish (phiale) that is, with a protrusion at the centre to facilitate gripping, used for libations.
CENTRO HERAKLES per il turismo culturale
Il dono di Dioniso Storia, produzione e consumo del vino nel mondo antico
I poeti lirici e il vino
Portami un orcio, ragazzo / ch’io tracanni d’un fiato / mescimi dieci misure / d’acqua e cinque di vino / perché di nuovo io celebri / senza violenza Dioniso […] / Suvvia non più, di nuovo / fra urla e clamori / beviamo, com’usano gli Sciti / ma sorseggiando fra bei canti.
(Anacreonte, fr. 43 Diehl, trad. B. Gentili)
a musica e il canto accompagnavano la consumazione del vino durante il simposio, sicché nacque un genere di lirica nota come poesia simposiale. Sorto a Lesbo nel VII secolo a.C., il canto conviviale (skòlion) godette in Grecia di
una lunga fioritura ed ebbe tra i suoi maggiori rappresentanti Alceo, Anacreonte, Archiloco. Della poesia simposiale fiorita in Magna Grecia nulla rimane, nonostante la presenza
di poeti celebri; di Cleante di Taranto, che durante i simposi era solito recitare versi, non si sa neppure se ne avesse composti di suoi o recitasse quelli di più noti ed antichi poeti. Tuttavia le numerose raffigurazioni vascolari italiote di scene di simposio dimostrano che anche in Magna Grecia il canto veniva esercitato soprattutto nell’ambito del simposio: collettivo all’inizio, con la preghiera agli dèi, individuale negli scolia (canti obliqui) e nell’elegia. Gli scolia erano canti iniziati da un convitato e proseguiti da altri man mano che un ramo di mirto passava, come testimone, da uno all’altro, ma senza una successione ordinata (per questo erano detti “obliqui”).
Questi canti potevano essere accompagnati da uno strumento a corda, come la lira, mentre per i canti in distici elegiaci si preferiva l’aulòs (strumento a fiato simile al flauto). Accanto agli scolia vi erano anche canti conviviali improvvisati di volta in volta su temi particolari. Alcuni vennero riuniti in vere e proprie raccolte ed Ateneo ne conserva qualcuna di autori anonimi.
Nel vino come nel canto l’animo si placa, si stemperano le passioni, si fa largo il sentimento amoroso: è giusto allora nel simposio scegliere temi opportuni per il canto e bere con misura:
Non amo chi bevendo presso un cratere colmo / narra tumulti risse e lacrimose guerre /
ma chi, mescendo delle Muse e d’Afrodite / gli splendidi doni, canta l’amabile gioia. (Anacreonte, fr. 56, trad. B. Gentili)
Il vino bevuto smodatamente è un male; / se lo si beve moderatamente non è un male ma
un bene. / il bere può arrecare ai deboli mortali due terribili pericoli: / quello della sete inestinguibile e quello dell’opprimente ebbrezza. / Ma io mi terrò nel mezzo tra questi due eccessi / e tu non riuscirai a convincermi / né a smettere di bere né ad ubriacarmi smodatamente.
(Teognide, vv. 509-510; 837-841) Ma se il cuore è infiammato dalla passione politica, ed esplode la gioia per la rovina
dell’avversario, persino nel simposio non c’è più spazio per la moderazione: Ora conviene ubriacarsi e che ciascuno anche con forza / beva, poiché ormai Mirsilo è
morto. (Alceo, fr. 332 Lobel-Page)
Altro tema ricorrente nella poesia simposiaca è l’amore, tra erotismo e ricerca
dialettica di conoscenza. Gli effetti del vino sono spesso paragonati a quelli provocati dall’amore e dalla poesia: estasi, smarrimento, gioia e dolore. E Dioniso rimane sempre la cura più efficace:
Vino, ragazzo caro, e verità
(Anacreonte, fr. 366 Lobel-Page) Gònfiati di vino: già l’astro / che segna l’estate dal giro / celeste ritorna, / tutto è arso di
sete, / e l’aria fumica per la calura. / Acuta tra le foglie degli alberi / la dolce cicala di sotto le ali / fitto vibra il suo canto, quando / il sole a picco sgretola la terra. / Solo il cardo è in fiore: / le femmine hanno avido il sesso, / i maschi poco vigore, ora che Sirio / il capo dissecca e le ginocchia.
(Alceo, fr. 347 Lobel-Page, trad. S. Quasimodo) Beviamo, perché aspettare le lucerne? Breve il tempo. / O amato fanciullo, prendi le
grandi tazze variopinte, / perché il figlio di Zeus e Sémele / diede agli uomini il vino / per dimenticare i dolori. / Versa due parti di acqua e una di vino; / e colma le tazze fino all’orlo: / e l’una segua subito l’altra.
(Alceo, fr. 346 Lobel-Page, trad. S. Quasimodo)
Canto di un convitato e suonatore di aulòs V sec. a.C. Monaco, Staatliche Antikensammlungen
Canto di un convitato che suona il barbiton
Canto di un convitato
VII
Lyric poets and wine
Boy, bring me a jar to drink it all in one, pour out for me ten measures of water and five of wine to celebrate again Dio-nysus without violence […]. Come on, again let us drink no longer with shouts and clamours, like Scythians, but sipping with beautiful songs.
(Anacreon, fr. 43 Diehl) Music and songs were the companions to wine during the
symposium and a type of lyric poetry was born known as ‘symposial poetry’. Born in the island of Lesbos in the VII b.C., convivial song (skòlion) blossomed for a long time in Greece and its main representatives were Alcaeus, Anacreon, Archilocus.
We haven’t any evidence of symposial poetry blossomed in
Magna Graecia, despite the presence of famous poets; we don’t know if Cleantes from Taranto, who usually recited verses during symposia, composed his own verses or recited those of more famous and ancient poets. Anyway some sym-posium’s scenes on Italic vase paintings show that also in Magna Graecia songs were performed above all during the symposium: collectively at the beginning, with the prayer to the gods, and then individually in the skolia (oblique songs) and in the elegy.
One of the guests began to sing the skolia and the other
guests carried on singing as soon as a brunch of myrtle was handed down from one guest to the other, like a witness, but without a precise order (because of this fact they were called ‘oblique’).
These songs could be accompanied by a stringed instru-
ments, like lyre; while songs composed in elegiac distiches were performed with the aulòs (a wind instrument similar to the flute). In every occasion convivial songs were improvised about peculiar subjects in addition to the skolia. Some were collected in veritable collections and Athenaeus preserves some of them from anonymous authors.
Both wine and song appease the soul, passions melt, love blossoms: it is therefore correct in symposium to choose the right subjects for songs and to drink moderately:
I don’t love the man who drinks a full crater and tells riots,
brawls and tearful wars, but the one who, mixing the splendid gifts of the Muses and Aphrodite, sings the lovely joy.
(Anacreon, fr. 56) Wine immoderately drunk is a bad thing; when drunk with
moderation it is not a bad thing but a good one. Drinking can bring two terrible dangers to weak mortals: unquenchable thirst and gruesome drunkenness. But I will stay in the middle of these extremes and you will not be able to persuade me to quite drinking nor to get immoderately drunk.
(Theognis, vv. 509-510; 837-841) But if the heart is inflamed by political passion and happi-
ness for enemy’s defeat spread, even in the symposium there is not space for moderation:
Now we have to get drunk and that everyone drink thor-
oughly because Mirsilus is dead. (Alcaeus, fr. 332 Lobel-Page)
Love is another theme usually present in symposial poetry,
between eroticism and dialectic research of knowledge. The effects of wine are usually compared with those caused by love and poetry: ecstasy, bewilderment, happiness and sorrow. Dionysus remains the most efficacious remedy:
Wine, dear boy, and truth.
(Anacreon, fr. 366 Lobel-Page) Wet you lungs with wine: the star is coming round, the sea-
son is harsh, everything is thirsty under the heat, the cicada sings sweetly from the leaves… the artichoke is in flower; now are women most pestilential, but men are feeble, since Sirius parches their heads and knees.
(Alcaeus fr. 347 Lobel-Page) Let us drink! Why do we wait for the lamps? There is only
an inch of day left. Friend, take down the large decorated cups. The son of Semele and Zeus gave men wine to make them forget their sorrows: mix one part of water to two of wine, pour it in brimful, and let one cup jostle another.
(Alcaeus, fr. 346 Lobel-Page)
CENTRO HERAKLES per il turismo culturale
Il dono di Dioniso Storia, produzione e consumo del vino nel mondo antico
I giochi del simposio
giochi erano un complemento essenziale per una buona riuscita del banchetto. Potevano essere giochi di società, come enigmi, sciarade e imitazioni, o giochi di abilità e di equilibrio. Solo se l’ospite era abbastanza ricco assoldava una troupe di
artisti, nella maggior parte dei casi i convitati si divertivano a minor prezzo, coi propri mezzi.
Il vino diventava strumento di gioco ed i vasi diventavano giocattoli, corpi da maneggiare che, distolti dalla loro funzione primaria, venivano impiegati in svariati giochi di destrezza e di equilibrio. I più praticati erano il gioco dell’askoliasmòs e quello del kòttabos.
Il gioco dell’otre consisteva nello stare in equilibrio e mantenere la propria stabilità con un piede su un otre piena di vino; abilità questa resa particolarmente difficile dal fatto che l’oggetto di cuoio, dalla forma quasi sferica, veniva cosparso di grasso. Si creava dunque una specie di trasferimento di funzioni: non era il vino a far vacillare il bevitore, ma il contenitore che in qualche modo simulava l’effetto del vino.
Il cottabo, tra i giochi del simposio, era quello più conosciuto; molti scrittori parlano di questo gioco come istigatore d’ubriacature, poiché quanto più si sbagliava, tanto più si doveva bere (Ateneo, XV, 666).
Nato in Sicilia e successivamente introdotto in Etruria ed in Grecia, il gioco consisteva nel lanciare, rimanendo sdraiati sul fianco sinistro, le ultime gocce di vino rimaste nella coppa in un bacile di metallo posto al centro della stanza. Tale gioco, infatti, prendeva il nome dal rumore che le gocce producevano cadendo nel bacile.
Talvolta il giocatore, apprestandosi al lancio, pronunciava il nome della persona amata, la qualità del suono prodotto dalla caduta del liquido nel recipiente era indice di un amore corrisposto o meno.
Un’altra versione del gioco prevedeva di colpire ed affondare, con le gocce di vino lanciate, piccoli piatti di terracotta che galleggiavano nel bacino pieno d’acqua.
Altri passatempi consistevano nel riuscire a mantenere in equilibrio vasi o coppe in modo inconsueto, senza cioè tenerli con le mani.
Scena di simposio con gioco del cottabo: particolare della Tomba del Tuffatore 480-470 a.C. Paestum, Museo Archeologico Nazionale
Scena di gioco di equilibrio con coppa
Scena di gioco di equilibrio su otre (askoliasmòs)
Kylix attica a figure rosse con gioco del kòttabos 510 a.C. Parigi, Museo del Louvre
Kylix attica a figure rosse con scena di komasta che tiene in equlibrio un'anfora 510 a.C. Parigi, Museo del Louvre
VIII
The games of the symposium
Games are an important complement for a good success of the banquet. They could be parlour games, like riddles, cha-rades and imitations, or games of skilfulness or balance. Only if the host was rich enough he would engage a troupe of artists but in most cases guests enjoyed themselves unexpensively through their means.
The wine became an instrument of game and the vases be-
came games themselves, objects to knead that, outside their primary function, were used in games of skilfulness or bal-ance. The most played were askoliasmòs and kòttabos game.
The wineskin-game consisted in keeping the balance and
maintaining one’s stability on a foot above a wine’s full wine-skin; this capability was very difficult because the almost spherical object of leather had been spread all over with fat. Therefore there was a type of transfer of functions: the wine did not make totter the drinker, but the container somehow simulated wine’s effect.
Among the games of the symposium the kòttabos game
was the most famous; a lot of writers describe this game as in-stigating intoxication, since the more one missed, the more one had to drink (Athenaeus, XV, 666).
The game was born in Sicily and then brought in Etruria
and Greece and it consisted in throwing the latest drops of wine in a basin of metal placed in the centre of the room, lay-ing down on the left side. The game was named from the sound that the drops produced falling in the basin. Sometimes the player, before throwing, pronounced the name’s of his be-loved and the type of the sound produced by wine’s falling could be a sign or a denial of mutual love.
Another version of the game consisted in knocking and
sinking little dishes of clay floating in the basin full of water by throwing drops of wine.
Other pastimes consisted in keeping the balance of vases or
cups in an unusual way, that is without holding them with the hands.
CENTRO HERAKLES per il turismo culturale
Il dono di Dioniso Storia, produzione e consumo del vino nel mondo antico
Il vino e la medicina
l vino era considerato un medicamento dalle qualità terapeutiche eccezionali, un vero e proprio farmaco che come tale doveva però essere assunto in dosi minime e sotto controllo, per evitare che il suo dolce sapore inducesse a farne abuso. Come dimostrano i trattati di medicina di famosi medici greci, quali Ippocrate e
Galeno, in Grecia il vino trovava impiego in vari modi nella cura di specifiche malattie, utilizzato sia solo che associato ad erbe aromatiche o a piante medicinali, freddo o caldo: il vino caldo era considerato capace di apportare più afflusso di sangue, quello freddo di rinforzare. Agli anziani era prescritto per favorire la diuresi e per smuovere i calcoli renali; era considerato adatto a stimolare la digestione; diluito con eguale porzione di acqua era consigliato contro l’ansia, la paura; con l’aggiunta di poca acqua era invece un ottimo rimedio contro l’insonnia. Ad alcuni vini, in base alla provenienza, venivano attribuiti specifici effetti, quali ad esempio di provocare l’aborto, rendere feconde le donne o determinare l’impotenza degli uomini.
Esistono numerose testimonianze epigrafiche che attestano l’uso medicinale del vino in contesti religiosi, connessi al culto di Asclepio: è il dio che decide come curare il malato per raccoglierne i meriti. Le terapie prescritte utilizzano il vino associato ad altre erbe: vino pepato italico per curare la tubercolosi (SIG3 1171), vino vecchio e farina d’orzo per la cura della scrofola e dell’infiammazione alla spalla. Il vino impastato con cenere si era rivelato un toccasana contro la pleurite:
“A Lucio, pleuritico e spacciato da ognuno, il dio ordinò per oracolo di andare, prendere dal trobimos della cenere e di impastarla con vino e di applicarla al torace. E fu salvato e pubblicamente rese grazie al cielo, e il popolo si rallegrò con lui” (SIG3 1173, trad. M. Girone).
IX
Wine and medicine
Wine was considered a remedy with excellent therapeutic qualities, a real drug that one had to assume in small doses and under control so that its sweet taste did not induce to abuse.
Greek doctors’ treatises on medicine, like Hippocrates and
Galen, show that in Greece wine was used in different ways to treat specific illnesses, it was used on its own or in association with aromatic or medicinal herbs, cold or hot: hot wine was thought to be able to increase blood’s flux, cold wine, on the other hand, to strengthen people. They prescribed it to old people to favour diuresis and to remove calculi; they thought that wine stimulated digestion; if one mixed it with an equal dose of water it was a good remedy against anxiety and fear; if one mixed it, on the contrary, with a small dose of water it was an excellent remedy against sleeplessness. They thought that some wines, according to their provenance, had specific effects, like causing abortion, making women fertile or men impotent.
A lot of epigraphic sources attested a therapeutic usage of
wine in religious contexts, particularly connected with Ascle-pius’s worship: the god decides the treatment for the ill and gets the merit for the cure. Prescribed therapies use wine in association with other herbs: Italic spiced wine was used to treat tuberculosis (SIG3 1171), aged wine and barley meal for scrofula and inflammation of shoulder. Wine and ash was a powerful remedy against pleurisy: “The god ordained by ora-cle to the pleuritic and donefor Lucius to go and get some ash from trobimos and to mix it with wine and to smear it on the chest. He was saved and publicly thanked heaven and people enjoyed with him” (SIG3 1173).
CENTRO HERAKLES per il turismo culturale
Il dono di Dioniso Storia, produzione e consumo del vino nel mondo antico
Omero e il vino
ttraverso i poemi omerici si possono ricavare le prime testimonianze letterarie su usi e consuetudini legate al vino. I versi di Omero, pur riportando ad un sostrato mitico e culturale in cui non si è ancora realizzata
l’istituzionalizzazione del culto di Dioniso come “padre del vino”, sottolineano il forte valore conviviale che il vino ha già assunto tra le classi aristocratiche e che conserverà nei secoli successivi anche sotto la “giurisdizione” di Dioniso.
Oltre all’aspetto conviviale sono attestati diversi usi del vino: terapeutico e anestetizzante, e nutrizionale e saziante quando è accompagnato dal cibo; ci sono anche riferimenti agli effetti negativi della bevanda “che scioglie le forze e indebolisce le membra” quando si eccede nell’uso.
Omero, infatti, invita sempre ad un consumo moderato e giovevole. Non a caso gli episodi più conosciuti dei due poemi, il cavallo di Troia per l’Iliade e l’accecamento di Polifemo per l’Odissea, sono legati ad un uso smodato della bevanda che turba la mente e allontana da un comportamento vigile e saggio.
Nel primo caso infatti i Troiani avevano banchettato fino a tarda ora e bevuto in eccesso, cosicché quando furono attaccati dai Greci fuoriusciti dall’ingannevole dono dedicato ad Atena, il noto cavallo di legno, non ebbero la forza di resistere all’invasione e furono sconfitti. Nel secondo caso l’astuzia di Ulisse meditò la possibilità di fuga dalla caverna facendo ubriacare Polifemo che, completamente indebolito dagli effetti del vino, non ebbe la forza di reagire all’accecamento, come è chiaro anche da tutta l’iconografia sviluppatasi a partire dalla diffusione del mito di Ulisse. L’invito ad un uso moderato e sano del vino, presente nei versi di Omero, sembra essere disatteso dalla prima testimonianza scritta e legata al vino recuperata in Magna Grecia:
Sono la coppa di Nestore, piacevole per bere. Chiunque da questa beva, subito lo coglierà
il desiderio di Afrodite dalla bella corona
Si tratta di un’iscrizione graffita sulla cosiddetta coppa di Nestore, una kotyle di un corredo di sepoltura rinvenuto nell’isola di Ischia e databile alla metà dell’VIII sec. a.C. L’oggetto nella forma rinvia alla pratica conviviale, e nel testo, invece, lascia supporre una buona conoscenza del testo omerico sia per la forma metrica che per il confronto istituito con la coppa di Nestore.
Nei versi infatti, con tono quasi canzonatorio, la semplice coppa di argilla viene paragonata alla preziosa coppa d’oro di Nestore dettagliatamente descritta da Omero (Il., XI, vv. 632-637), non certamente per esaltarne il valore artistico o materiale, ma piuttosto per sottolineare nella funzione delle coppa il carattere regale legato alla possibilità di contenere il liquido inebriante che suscita il desiderio della passione amorosa.
Accecamento di Polifemo: particolare dell’Anfora di Eleusi 660 a.C. Eleusi, Museo Archeologico
Coppa di Nestore Seconda metà dell’VIII sec. a.C. Lacco Ameno (Ischia), Museo Archeologico di Pithecusae
Cratere a calice attico a figure rosse con scena di accecamento di Polifemo Ultimo quarto del V sec.a.C. Londra, British Museum
Kylix attica a figure rosse Atena che prepara il cavallo di Troia V sec. a.C. Firenze, Museo Archeologico Nazionale
Anfora con particolare del cavallo di Troia VII sec. a.C. Mikonos, Museo Archeologico
X
Homer and the wine
Homeric poems give the first literary evidence about usages and customs related to the wine. Although referring to a mythical and cultural substratum in which the cult of Dionysus as ‘father of wine’ was not yet institutionalized, Homeric verses stress the high convivial value that wine had already ac-quired for the aristocracy and that maintained during the fol-lowing centuries also under Dionysus’s ‘jurisdiction’.
In addition to its convivial value, different usages of wine
are attested: therapeutic, anaesthetical, nutritional and satisfy-ing if accompanied to food; there are also references about negative effects of wine ‘that debilitates and weakens limbs’ if one exceeds in drinking.
Therefore Homer always invites to moderate and reason-
able consumption. The most famous episodes of the Homeric poems (Troy’s horse in the Trojan Cycle and Polyphemus’s blinding in the Odyssey) are related, and for a purpose, to an immoderate consumption of this beverage that disturbs the mind and hinders a watchful and wise behaviour.
In the first case, the Trojans banqueted until dead of night
and immoderately drunk, so when Greeks came out of the de-ceitful present dedicated to Athena, the famous wooden horse, and attacked them, they were not able to defend themselves and they were defeated.
In the second case, Ulysses’s shrewdness plotted the es-
cape from the cavern getting Polyphemus drunk who, weak-ened by the wine, was not able to react to the blinding, as it is attested also by the iconography based on Ulysses’s myth.
The Homeric invitation to a moderate and healthy con-
sumption of wine does not seem to be applied in the first writ-ten source about wine found in Magna Graecia:
I’m Nestor’s cup, pleasant to drink.
Whoever drinks from me, immediately will be taken by the desire Aphrodite of the beautiful crown
This is an inscription written on the so-called Nestor’s cup,
a kotyle from funerary vessels found in Ischia island and dat-able back to the middle of VIII b.C.
The shape of the cup refers to banquet, and the inscription,
on the other hand, suggests the knowledge of the Homeric text both for metrical scheme and for the comparison with Nestor’s cup.
As a matter of fact in these verses the cup of clay is com-
pared with the precious Nestor’s golden cup described in great detail by Homer (Il., XI, vv. 632-637) with an almost mocking tone, not to highlight its artistic or material value, but to stress a regal quality in the function of the cup, connected to its capability of containing the intoxicating beverage that provokes love’s desire.
CENTRO HERAKLES per il turismo culturale
Il dono di Dioniso Storia, produzione e consumo del vino nel mondo antico
L’Enotria cara a Bacco
“Oh Bacco, che proteggi l’illustre Italia...” (Sofocle, Antigone, v. 1118)
“Oenotria dicta est a vino optimo quod in Italia nascitur” (Varrone in Servio, Commento a Virgilio, Eneide I, 532)
“Pisandro nel XIII libro dice che l’Enotria (Oinotrìa) veniva così chiamata dall’uso del vino (oinos)”
(Stefano Bizantino, s.v. Oinotrìa)
ltri sostenevano che l’Enotria prese il nome da oinòtron, sinonimo di carax, che significa palo di vite (Esichio, s.v. Oinotrìa). I Greci, quando vollero indicare l’origine del nome della regione d’Italia in cui in età arcaica erano
andati a fondare alcune dello loro più famose colonie, la ricondussero al nome greco del vino o del palo di sostegno della vite e dei tralci.
È stato accertato, del resto, che la coltura della vite (come quella dell’ulivo) in Italia meridionale precede l’arrivo dei Greci, e l’uso di produrre e consumare vino faceva già parte dell’attività economica e delle consuetudini sociali delle tribù degli Enotri che vi abitavano da secoli.
Ad una “vite avvinghiata ad un fico” alludeva l’oracolo di Apollo che ordinò ai Calcidesi di fondare Reggio alla foce del sacro fiume Apsia, dove avessero trovato un maschio maritato ad una femmina (Diodoro Siculo, VIII, 23, 2).
Aristotele (Politica, VII, 1329 b) attribuisce all’antichissimo re Italo la trasformazione degli Enotri da pastori in agricoltori e l’introduzione dei “sissizi”, i pasti in comune (poi caratteristici della società spartana). In essi il vino era la bevanda di rito, equamente distribuita nelle coppe a ciascun commensale, attingendolo da un grande cratere.
Le necropoli di molti centri enotri di età protostorica, come Francavilla Marittima e Tortora, hanno restituito recipienti e tazze per la conservazione ed il consumo del vino. In alcune tombe di età arcaica figurano interi “servizi” per il consumo del vino, prova evidente della diffusione anche in ambito indigeno della pratica del simposio.
Necropoli di loc. S. Brancato, Tortora (CS) Tomba 4
Cratere enotrio a decorazione geometrica VI sec. a.C. Tortora (CS), Antiquarium
Statua di Bacco Copia romana di originale greco IV sec. a.C. Napoli, Museo Archeologico Nazionale
XI
Oenotria dear to Bacchus
“Bacchus who protects famous Italy” (Sophocles, Antigone, v. 1118)
“Oenotria dicta est a vino optimo quod in Italia nascitur”
(Varrone in Servius, Comment on Vergil, Aeneid I, 532) “Pisandros in the XIII book says that Oenotria (Oinotria) was so called from the use of wine”
(Stephanus Bizantinus, s.v. Oinotria) Other authors told that Oenotria was named from oinotròn,
synonymous of carax, that means stakes of vine (Esichius, s.v. Oinotria).
When Greeks wanted to look for the origin of the name of
the Italian region in which they had built some of their most fa-mous colonies thought to find it in the Greek name of the wine or of the pole that buttressed the vine.
It is certain that wine cultivation (like olive groves) in the
South of Italy preceded Greek’s arrival and the habit to pro-duce and to consume wine was important for the trade and customs of Oenotrian’s tribe who lived there for ages.
Apollo’s oracle made a mention of “vine clasped to a fig-
tree” and commanded Chalcidians to build Reghion at holy Apsia’s outfall in the place where they would find a male mar-ried to a female (Diodorus Siculus, VIII, 23, 2).
Aristotle (Politics, VII, 1329 b) ascribes to the very old
king Italus Oenotrians’ transformation from shepherds to countrymen and the introduction of ‘syssitia’ that is common meals (typical of Spartan society). Wine was a ritual beverage for Oenotrians, equitably distributed in cups to every guest, and drawn from a big crater.
Necropolis of a lot of Oenotrian proto-historical towns, like
Francavilla Marittima and Tortora, have supplied vessels and cups for wine’s usage and conservation. Some complete ser-vices for wine have been found in graves of archaic period and this is an evident proof of symposium spreading also in indige-nous contexts.
CENTRO HERAKLES per il turismo culturale
Il dono di Dioniso Storia, produzione e consumo del vino nel mondo antico
Il commercio del vino in Calabria
e anfore rappresentano un prezioso strumento di conoscenza, soprattutto per risalire alle zone dove esse venivano prodotte, alla loro cronologia, al prodotto in esse contenuto e ai mercati dove venivano vendute. Esse rappresentano
un’eccezionale testimonianza delle economie produttive, delle modalità degli scambi e delle antiche rotte commerciali delle navi mercantili. Informazioni interessanti si ricavano dallo studio delle caratteristiche strutturali delle anfore, quali, soprattutto, la forma, che cambiava a seconda del luogo di produzione, il tipo di argilla usata nell’impasto e i bolli, che riportano i nomi dei proprietari o dei luoghi di produzione del vino.
Le anfore sono contenitori di terracotta, provvisti di due anse verticali all’altezza del collo ed aventi l’imboccatura dal diametro più piccolo rispetto a quello della pancia. Esse venivano utilizzate anche per la conservazione e il trasporto del vino e, grazie alla loro terminazione a punta, erano facilmente trasportabili e adatte ad essere infilate, per mezzo di adeguati sostegni, nelle stive delle navi. Interi carichi di anfore si rinvengono normalmente nei relitti di navi affondate in vicinanza delle coste, e che testimoniano un uso prettamente commerciale e pratico di questo tipo di contenitore, anche se non mancano le anfore appositamente realizzate per i corredi di sepoltura, che sono in genere quelle meglio conservate.
La tipologia di anfore rinvenute nel bacino del Mediterraneo è assai varia ed è stato possibile effettuare una classificazione sulla base della loro provenienza geografica. E così si distinguono le anfore di Corinto, le anfore ionico-massaliote, le anfore chiote riconoscibili per il collo fortemente rigonfio e quelle magnogreche e siceliote ritrovate, soprattutto, nell’Italia meridionale, dove certamente la viticoltura rappresentò una delle attività agricole di maggiore redditività economica.
Le produzioni che interessano la Magna Grecia nel periodo compreso tra la fine del V e il III secolo a.C. sono rappresentate da 6 tipologie, anche se già dalla metà del VI secolo a.C. a Sibari è attestata una produzione di anfore vinarie.
La attiva circolazione attestata dai contenitori da trasporto è ulteriormente confermata dall’utilizzo di un’anfora come tipo o simbolo monetale, che rappresenta un sicuro indizio di una fiorente attività di produzione e commercio del vino da parte della città emittente: con questo tipo sono infatti attestate monete degli inizi del V sec. a.C. a Sibari, del IV sec. a.C. a Laos, Ipponio e Locri, del III sec. a.C. quelle dei Brettii.
Le anfore vinarie magnogreche per esigenze di trasporto erano sigillate a tenuta stagna con la pece ricavata dalle foreste della Sila, che continuò ad essere utilizzata anche in età romana, come testimoniano Plinio e Strabone, i quali non mancano di sottolinearne l’eccellente qualità e il suo indispensabile impiego nella fabbricazione dei recipienti destinati a contenere il vino.
Vari tipi di anfore da trasporto Ricostruzione di una nave da carico con anfore Anfora greco-italica IV-III sec. a.C. Vibo Valentia, Museo Archeologico Nazionale
XII
Wine-trade in Calabria
Analysis of amphoras represent a way to gather pieces of information about areas of production, chronology, products they contained and the markets where they were sold. They are an excellent proof of productive economies, of the ways of exchanging and of ancient cargos’ commercial courses. It is possible to obtain interesting information by structural quali-ties of amphoras such as shape, that changed according to the places of production, type of clay used in the mixture and the seals with owners’ names or places of wine production.
Amphoras are clay-made containers with two vertical han-
dles at neck-height and with the mouthpiece smaller than the belly. They were also used to preserve and transport wine and, thanks to their pointed end, it was easy to transport them and to adapt them into ships’ holds with adequate supports. In ships sunk near the coasts complete amphoras’ cargo are usu-ally found and they attest the commercial and practical usage of this type of container; in addition, it is possible to fine am-phoras created for funerary vessels as well, that are usually the best preserved ones.
The type of amphoras that have been found in Mediterra-
nean basin is very various and it has been possible to classify them according to their provenance. So, there are Corinthos, ionian-massalian amphoras, chiote (recognizable because of their very inflated neck), magno-graecae and siceliot that have been found especially in southern Italy where viticulture was surely one of the agricultural activities of major economic im-pact.
Between the end of the V and the III b.C. Magna Graecia’s
production is represented by 6 types, even if from the half of VI b.C. wine’s amphoras production is already attested in Sybaris.
The active circulation attested by containers for transporta-
tion is ulteriorly confirmed by the representation of an am-phora for coinage or as a symbol, that represents a certain in-dication of a blossoming wine-production and trade from the town of origin: coins of the beginning of V b.C. in Sybaris, of IV b.C. in Laos, Hipponion and Locri, of III b.C. between Brettii, have been found bearing the amphora-type.
Because of the odds of transportation, wine-amphoras of
Magna Graecia were sealed with watertight pitch coming from Sila’s forests that was still in use in the Roman period, as Pliny and Strabo attest, stressing its excellent quality and the necessary usage in the production of wine containers.
CENTRO HERAKLES per il turismo culturale
Il dono di Dioniso Storia, produzione e consumo del vino nel mondo antico
La produzione vinicola nella Calabria settentrionale
primi vitigni ad essere acclimatati in Magna Grecia furono il Byblinos, originario dell’Egeo orientale ma destinato a svilupparsi principalmente in Sicilia, e l’Aminaios, proveniente dalla Tessaglia e impiantato sul litorale ionico
settentrionale della Calabria. Il vitigno Aminaios era assai rinomato perché produceva un ottimo vino, dal sapore aspro ma soggetto a lungo invecchiamento.
La sua denominazione potrebbe essere messa in relazione con la popolazione degli Aminaioi, stanziata forse nel tratto di territorio compreso tra Sibari e Crotone e nota attraverso una serie monetale incusa recante la legenda AMI.
Nell’età arcaica, a seguito dell’importazione di vitigni greci, incominciano a delinearsi quelle che sarebbero diventate le principali aree di produzione vinicola della Calabria settentrionale.
Sul versante ionico, l’area di Sibari/Thurii rappresentava il principale polo vinicolo con uno sfruttamento intensivo delle fertili colline del suo entroterra e la conseguente distribuzione commerciale del prodotto agricolo. Nella città magnogreca sono stati identificati quartieri dedicati alla produzione e conservazione del vino e fattorie dislocate nelle campagne, la cui attività prevalente era la produzione del vino, da destinare non solo alla sussistenza del nucleo familiare ma, soprattutto, alla vendita.
Plinio nella sua Naturalis Historia (XIV, 69) fa una classificazione dei vini più famosi della Magna Grecia e, dopo aver menzionato i vini lucani, passa a quelli del Bruzio, citando il Thourinos e il Lagaritanos, quindi le produzioni vinarie più recenti di IV e III secolo a.C. attestate nell’area in cui sorgeva a suo tempo la città di Tempsa, da localizzare probabilmente nella bassa valle del fiume Savuto, e di Consentia, l’antica metropolis dei Brettii situata lungo la vallata del Crati.
Del vino Lagaritanos si trova menzione anche in Strabone (VI, 1, 14) che lo ricollega all’antica Lagaria, città fondata da Epeo, il mitico costruttore del cavallo di Troia, nel tratto ionico compreso tra Thurii ed Herakleia. Un vino quello “lagaritano” che risultava al palato degli intenditori assai dolce (glykùs) e amabile (apalòs) ma che era apprezzato anche dai medici in virtù delle sue qualità terapeutiche.
Ai vigneti dell’area sibarita, regione portatrice di frutti come la definisce Ateneo nella sua opera “I sapienti a banchetto” (o “Deipnosofisti”), facevano da pendant sul litorale tirrenico i vigneti gestiti dalla popolazione dei Serdaioi, che la ricerca archeologica è concorde nel localizzare in quel settore compreso tra Laos (nei pressi dell’attuale Santa Maria del Cedro) e Pissunte/Buxentum, in cui è attestata in età romana la produzione di un vino rinomato, noto anche ad Ateneo (I, 27 a) con la denominazione di Buxentinon.
Thourinos
Buxentinos
Consentia
Tempsa ?
Lagaritanos ?
XIII
Wine industry in Northern Calabria
The first species of vine acclimatized in Magna Graecia were the Byblinos, indigenous to the East Aegean Sea and which was mainly to be developed in Sicily, and Aminaios, in-digenous to Thessaly and particularly cultivated on Calabrian Northern Coast. Aminaios was well-known as it produced a very good wine, with a bitter taste and aged for a long time. Its name could be related with the Aminaioi population, probably settled between Sybaris and Kroton, and known through by the coin engraving ‘AMI’.
In the archaic period, following Greek vines importation,
the main areas of wine production in Northern Calabria started to emerge. On the Ionian coast, Sybaris/Thurii was the main pole of wine-production with an intensive exploita-tion of fertile inland’s hills and with the ensuing commercial distribution of the agricultural products. In the town of Magna Graecia, quarters for wine production, conservation and coun-try farms have been identified; their main activity was wine production not only for domestic subsistence but also for sell-ing purposes.
In Naturalis Historia (XIV, 69), Pliny classifies the most fa-
mous wines of Magna Graecia and, after Lucania’s wines, he places the wines of Bruzio, mentioning Thourinos and Lagari-tanos and then later wine production (IV-III. b.C.) like those of Tempsa, town to be localized in Savuto low valley, and those of Consentia, the ancient Brettii’s metropolis laying on Crati’s valley.
Also Strabo (VI, 1, 14) talks about Lagaritanos wine relat-
ing it to ancient Lagaria, a town founded by Epeus, the mythi-cal constructor of Troy’s horse; the town was located between Thurii and Herakleia. Lagaritanos wine was not only very sweet (glykùs) and pleasant (apalòs) to the experts but also appreciated by doctors because of its therapeutic qualities.
Vineyards on Tyrrhenian coast were the companion to
those of Sybaritic area, fruit-bearer region as Athenaeus de-fines it in his Deipnosophistai. Tyrrhenian vineyards were managed by Serdaioi population that archaeological research agrees in locating it between Laos (on the outskirts of today’s Santa Maria del Cedro) and Pissunte/Buxentum, where in Roman age the production of the famous Buxentinon wine is attested, known to Athenaeus (I, 27 a) as well.
CENTRO HERAKLES per il turismo culturale
Il dono di Dioniso Storia, produzione e consumo del vino nel mondo antico
Dioniso e i “Serdaioi”. La viticoltura nell’area del fiume Lao
questa una delle più antiche serie monetali della Magna Grecia e tra le più antiche del mondo greco su cui compaia al diritto Dioniso chiaramente raffigurato come dio del vino.
Reso a figura intera, nudo, risulta riconoscibile per i due attributi tipici, la coppa a due manici (kàntharos) nella mano destra e un vistoso tralcio di vite sulle spalle. Il turgido grappolo d’uva che pende da un tralcio raffigurato sul rovescio aggiunge al significato religioso del tipo del diritto, il rimando al principale prodotto dell’economia della comunità politica titolare della zecca monetaria, indicata dalla legenda SER - SERD.
Per molto tempo non si è potuto attribuire ad un popolo specifico le rare serie monetali in argento a doppio rilievo contraddistinte da tipologia dionisiaca e da questa legenda, note in appena 9 esemplari, 2 stateri, 2 dioboli, 1 obolo e 4 emioboli, di cui solo uno da ripostiglio di provenienza calabrese.
Nel 1961 è stata rinvenuta in Grecia, negli scavi del santuario panellenico di Zeus ad Olimpia, una lamina bronzea che reca inciso, in caratteri arcaici ed alfabeto acheo, il testo epigrafico di un trattato di amicizia perenne stipulato dai Sibariti e dai loro alleati col popolo dei Serdaioi:
“Si sono accordati i Sibariti coi i loro alleati ed i Serdaioi per un’amicizia eterna, fedele e senza inganno. Testimoni Zeus, Apollo e gli altri dei e la polis di Poseidonia”.
Nonostante le incertezze sulla identificazione dei Serdaioi menzionati in questa epigrafe e sulla loro esatta localizzazione, è ormai opinione della maggior parte degli studiosi che si tratti di una delle tribù enotrie stanziate sulla costa settentrionale tirrenica della Calabria, area in cui sorgevano diversi centri indigeni che altre serie monetali rivelano economicamente legati a Sibari (Sirino, Pissunte, Palinuro, Molpa, Sontia, ecc.) e diventata per di più sede della colonia sibarita di Laos, rifugio dei profughi Sibariti dopo la rovinosa sconfitta del 510 a.C.
Conquistata dai Lucani alla fine del V secolo a.C., Laos conservò la propria prosperità e rimase fino ad età romana il loro più meridionale centro urbano sul Tirreno (i resti sono stati trovati in anni recenti in località Marcellina di Santa Maria del Cedro).
Anche la serie monetale della Laos lucana (seconda metà del IV sec. a.C.) presenta come tipo del diritto la testa di Dioniso coronata di edera, a conferma della persistenza nell’area di una fiorente produzione vinaria e del culto dionisiaco.
XIV
Dionysus and the ‘Serdaioi’. Viticulture next river Lao’s region
This is one of the most ancient coins’ series of Magna
Graecia and one of most ancient of the Greek world in which Dionysus appears on the recto clearly depicted like the god of the wine. The entire figure of Dionysus is depicted, he is na-ked and recognizable because of his two typical attributes: the cup with two handles (kàntharos) in the right hand and a big wine-shoot on his shoulder. On the verso a turgid bunch of grapes hanging on a wine-shoot adds to the religious meaning of the recto the reference to the main economic product of the society titular of the mint signalled by SER-SERD writing.
For a long time it has been impossible to ascribe the un-
common coin silver series with double relief to a precise popu-lation, characterized by dyonisiac features and by this writing, known by just 9 items, 2 staters, 2 dioboli, 1 obolus e 4 hemioboli and of whom only one comes from Calabrian store-room.
In 1961 during the excavations of Pan-Hellenic Zeus’s
sanctuary in Olympia one bronze thin plate was found with a writing that shows one epigraphic text about a perennial treaty of friendship between Sybaris and its allies with Serdaioi population in archaic handwritings and Achaean alphabet:
“Sybarites agreed with their allies and with Serdaioi for an eternal and truthful friendship.Witnesses Zeus, Apollo and the other gods and the polis of Poseidonia”.
Despite the doubts about the identification of Serdaioi
mentioned in this epigraph and their precise localization, most scholars think that they were one of the tribes settled on the Tyrrhenian Northern coast of Calabria. In this area there were many indigenous towns economically related to Sybaris as some coin series show (Sirino, Pissunte, Palinuro, Molpa, Sontia); it also became the seat of the Sybaritic colony of Laos, a place of refuge for the Sybaritic fugitives after the ter-rible defeat of 510 b.C. by Kroton’s army.
Laos was conquered by Lucans at the end of V century
b.C.; it maintained its richness and it was the southernmost town on Tyrrhenian coast until the Roman age (as recently found rests in Marcellina, towards Santa Maria del Cedro, at-test).
Silver series of Lucania’s Laos also presents in the recto
the type of Dionysus’s head crowned with ivy and this con-firms the persistence of a blossoming wine production and dionysian worship in the area.
Lamina bronzea 550-525 a.C. Olimpia, Museo Archeologico
Statere dei Serdaioi D/: Dioniso stante con kàntharos e viticcio; legenda SER R/: tralcio di vite con grappolo d’uva 480 a.C. circa Parigi, Bibliothèque Nationale de France
D R Diobolo dei Serdaioi D/: testa di Dioniso a destra; legenda SER R/: grappolo d’uva 500-475 a.C. circa SF Collection, USA (collezione privata)
D R
CENTRO HERAKLES per il turismo culturale
Il dono di Dioniso Storia, produzione e consumo del vino nel mondo antico
Sibari opulenta e trasgressiva
ibari fu la colonia della Magna Grecia che in appena due secoli di vita (720 circa-510 a.C.) dimostrò una capacità eccezionale di intessere relazioni con vari popoli ed esercitare un controllo politico o anche solo economico su un territorio vastissimo,
esteso dallo Ionio al Tirreno; raggiunse così una tale prosperità, da restare ineguagliata. Lo stile di vita dei Sibariti divenne e resta ancora proverbiale per la ricerca di ogni lusso
ed ogni “comfort” e per la mollezza dei costumi (tryphè). Si formò perfino un vero e proprio genere letterario per illustrarlo, le “novelle sibaritiche” (logoi sybaritikoi); alcune sono riportate nell’opera “I sapienti a banchetto” di Ateneo di Naucrati, una piccola miniera di notizie e pettegolezzi su usi, costumi e amenità varie messe in bocca ai commensali fra una pietanza e l’altra, tra uno stuzzichino e un sorso di vino.
Produzione e commercio del vino Proprio da tale opera apprendiamo che una delle principali risorse economiche dei
Sibariti era appunto il vino, tant’è che nel territorio erano state create varie “infrastrutture” per favorirne la produzione e facilitarne la commercializzazione.
Anzitutto, un reticolo di strade, molte delle quali persino ombreggiate ad arte, consentiva ai grandi proprietari terrieri di raggiungere comodamente in carrozza le loro terre, impiegando talvolta persino tre giorni di viaggio, con più soste lungo il percorso, per raggiungere quelle più lontane.
A coltivarle per loro c’erano migliaia di contadini, liberi o servi, e capitava che qualche Sibarita si lamentasse di sentirsi tutte le ossa rotte al solo guardarli lavorare piegati, intenti a “scalzare” le piante.
La produzione era perciò molto abbondante, tanto che era stato creato un complicato sistema di canali, una sorta di “enodotto”, per fare scorrere il vino dai palmenti in campagna fino alle cantine costruite vicino al mare:
“La maggior parte dei Sibariti possedeva cantine vicino al mare, nelle quali il vino veniva portato dai campi per mezzo di canali, da dove in parte era venduto fuori dal territorio, in parte era portato in città con navi da carico” (Ateneo, XII, 519 d).
Probabilmente era in queste cantine che il mosto subiva il processo della fermentazione e tutti i trattamenti successivi sino all’“imbottigliamento” in grandi anfore da trasporto. A quel punto il vino era pronto per essere venduto ad altre città (dunque esportato), ma almeno una parte veniva trasportato con navi da carico in città per il fabbisogno interno.
Lo scalo navale fu archeologicamente individuato da Paola Zancani Montuoro in località “Casa Bianca”, dove l’archeologa rinvenne anche bolli ovali di anfore turine, a riprova della prosecuzione dell’attività di trasporto e commercializzazione del vino anche quando al posto di Sibari era ormai subentrata la città di Thurii.
Il consumo interno, tra banchetti e simposi Ai piaceri della tavola i Sibariti non sapevano proprio resistere! I banchetti pubblici, allestiti in occasione delle feste, erano particolarmente frequenti, e
davano occasione agli aristocratici di fare sfoggio di liberalità nell’assumersene l’onere senza badare a spese ed ai cuochi di stupire i commensali con piatti prelibati e ricette sempre nuove.
L’apprezzamento per i primi era espresso onorandoli con corone d’oro e facendone pubblicamente proclamare l’elogio ad opera di araldi durante i sacrifici pubblici e le gare, non per la loro dirittura morale, ma per la loro generosità; per i cuochi era d’uso premiare con corone quelli che più si fossero distinti per la loro particolare abilità e riconoscere il brevetto alle migliori ricette, col diritto di conservarne l’esclusiva per un anno (Ateneo, XII, 519-521): “In queste feste incoronavano anche fra i cuochi coloro che avevano preparato le migliori pietanze”.
Durante i banchetti era modica la quantità di vino che accompagnava la consumazione dei cibi. Non così durante i simposi, che a Sibari si prolungavano per gran parte della notte e spesso si concludevano con una ubriacatura generale.
Aristofane in qualche commedia doveva aver ironizzato sul fatto che i Sibariti più raffinati e dal palato sofisticato non si accontentassero di far servire l’ottimo vino delle proprie terre, ma riservavano ai propri ospiti il rinomatissimo vino di Chio (Ateneo, XI, 484 f; XII, 527 c).
A detta di Ateneo i Sibariti erano stati i primi ad allietare il banchetto introducendo nani e cagnolini e ad ammettervi la partecipazione di donne (alla maniera degli Etruschi) invitandole con un anno di anticipo, perché avessero il tempo di prepararsi le vesti e gli ornamenti.
Cratere a volute attico a figure nere (particolare) 500-480 a.C. Taranto, Museo Archeologico Nazionale
Sibari/Copia L’emiciclo-teatro di Parco del Cavallo
Kylix a figure rosse con scena di simposio 480 a.C. Berlino, Antikensammlung
XV
Opulent and luxurious Sybaris
Sybaris was the Magna Graecia’s colony that scarcely in two centuries (towards 720-510 b.C.) showed a strong ca-pacity of creating relationships with different populations and controlling politically (or economically) a very vast territory, from the Ionian to the Tyrrhenian Sea; in this way Sybaris be-came so opulent to remain unrivalled.
The way of life of Sybaris’ inhabitants became and still re-mains proverbial because of the unrelenting quest for luxury and comfort and because of their lasciviousness (tryphè). A literary genre was even born to illustrate it, ‘sybaritic tales’ (logoi sybaritikoi); some are present in Athenaeus from Naucratis ‘Deipnosophistai’, a little mine of information about different usages, customs and pleasantness uttered by the guests among appetizers, various dishes and a sip of wine.
Wine-production and trade Athenaeus tells that one of the main economical resources
of Sybaris was indeed wine and in the territory several struc-tures were built to improve wine production and marketing.
First of all a network of roads, many of whom also shaded on purpose, allowed rich landowners to comfortably reach by carriage their fields, who sometimes employed three days to travel, stopping during the journey more than once, to get to the farthest ones.
Thousands of countrymen cultivated soils for them, free men or slaves, and some inhabitants of Sybaris reported that one could feel one’s bones broken only by watching these peo-ple toiling and bending on the vines.
Production was very wide, and a complex system of canals was created, like a ‘wineduct’, to transfer wine from mill-stones in the country to the cellars built next to sea: “Most of the inhabitants of Sybaris had cellars next to the sea, in which they brought wine from fields by means of canals, then they sold outside their territory and in part it was brought in the town with cargo ships” (Athenaeus, XII, 519 d).
In these cellars probably must underwent fermentation and all later stages until it was bottled in big amphoras to be trans-ported. At that moment wine was ready to be sold in other towns (that is to be exported), but at least one part was brought in town by cargo ships for domestic consumption.
The Italian archaeologist Paola Zancani Montuoro indi-viduated the place where ships moored: ‘Casa Bianca’ where she also found oval seals of amphoras from Thurii, a proof to the fact that this port was still in use for conveying and trading even when Thurii took over Sybaris.
The internal consumption between banquets and symposia Sybarites could not resist the pleasures of the table! Public banquets, in times of celebration, were very frequent
and they were a chance to show off their richness and to take upon themselves the burden of expenses for the aristocracy and at the same time it was a chance for the cooks to surprise the guests with appetizers and new recipes.
They expressed favourable opinions for the hosts with golden crowns and heralds who pronounced eulogies in public during sacrifices and competitions not for their probity but for their liberality; for the cooks they usually gave crowns as a prize to those who distinguished themselves for their clever-ness and they usually gave the patent to the best recipes and the possibility to have the exclusive right for a year: “In these celebrations they crowned also those cooks who prepared the best dishes” (Athenaeus, XII, 519-521).
The quantity of wine present in the banquets with the food was very small. That was quite different from the symposia in Sybaris that lasted for the major part of the night and often ended on a general intoxication. Aristophanes was probably ironic about the fact that the most refined and delicate Syba-rites were not satisfied with the wine of their vineyards but of-fered to the guests the very famous wine of Chios (Athenaeus, XI, 484 f; XII, 527, c).
According to Athenaeus the Sybarites were the first to en-joy the banquet and introduced dwarves and doggies and to allow women’s participation (like Etruscan custom), inviting them one year before, so that they had time to prepare dresses and ornaments.
CENTRO HERAKLES per il turismo culturale
Il dono di Dioniso Storia, produzione e consumo del vino nel mondo antico
Le villae romane in Magna Grecia e il vino
Romani furono particolarmente attenti alle tecniche agricole. Numerosi autori latini si cimentarono nella composizione di trattati sull’agricoltura o componimenti in cui largo spazio era destinato all’illustrazione della vita dei campi: basti pensare,
per citare i più noti, a Catone, a Varrone, a Virgilio, a Columella, a Plinio il Vecchio. Questo loro interesse contribuì notevolmente a perfezionare le tecniche di
coltivazione delle viti ed a privilegiare la produzione del vino (e dell’olio) rispetto ad altre colture meno redditizie anche nei loro possedimenti in Italia meridionale. In quelle grandi aziende vitivinicole che erano le villae romane, grande era la varietà degli attrezzi e degli ambienti utilizzati per la produzione del vino: esistevano locali attrezzati per la pigiatura e per la torchiatura delle uve (i nostri palmenti), quelli destinati alla fermentazione ed al travaso del vino, infine le cantine idonee al suo invecchiamento. Esse erano di solito ubicate su colline costiere o lungo vallate fluviali, da cui fosse poi agevole convogliare il vino prodotto, attraverso piccoli scali, verso i mercati principali.
Man mano che si allargano le ricerche archeologiche in Calabria, si scopre un fitto reticolo di ville nelle aree più idonee alla produzione vinicola, che coincidono con le aree accertate di produzione di vini in età antica, e non casualmente con i più rinomati vigneti attuali.
Mosaico con scena di raccolta e trasporto dell’uva Inizi del IV sec d.C. Roma, Mausoleo di Santa Costanza
Mosaico con scena di trasporto e pigiatura dell’uva Inizi del IV sec d.C. Roma, Mausoleo di Santa Costanza
Pianta della pars rustica della villa romana di Pian delle Vigne Il Settore A, pavimentato in opus spicatum, era destinato alla produzione del vino, come testimoniato dalla presenza di tre basi dei torchi (arae), due per il vino rosso (A2, 4-5) e una per il vino bianco (A3, 3), relative ad altrettanti ambienti dei torchi vinari (torcularia). Sulle arae venivano spremute le vinacce, dopo che l’uva era stata pigiata nel forus vinarium o cal-catorium (6): il mosto veniva convogliato nel forus attraverso delle canalette (7, 8, 9). Fine del I sec. a.C. - IV sec. d.C. Loc. Pian delle Vigne, Falerna (CZ)
XVI
Roman villae in Magna Graecia and the wine
Romans took a great interest in agricultural techniques. A
lot of Latin authors wrote about agriculture or they wrote lit-erary works diffusely telling about bucolic life: e.g. Cato, Varro, Virgil, Columella and Pliny the Elder to quote the most important ones.
Their interest in the countryside contributed towards im-
proving viticultural techniques and preferring wine and oil pro-duction, rather than other types of cultivations less profitable, also in their estates in South of Italy. In Roman villae, big wine-farms, there was a big variety of tools and places of wine-production: some places were supplied with tools for wine-pressing (that we call ‘millstone’), others for wine fer-mentation and decanting, finally wine cellars for aging. They were usually placed on hillsides or fluvial valleys so that it was easy to convoy wine in the main markets through intermediate stops along the way.
Going deeper in archaeological researches in Calabria, we
discover a close network of villae in places more suitable for wine production that coincide with places of wine production in the Ancient world and, not by chance, with the most famous places of wine production today.
Terracotta decorata a rilievo con scena di vendemmia Fine del I sec. a.C. Firenze, Museo Archeologico Nazionale
CENTRO HERAKLES per il turismo culturale
Il dono di Dioniso Storia, produzione e consumo del vino nel mondo antico
Aree DOC e centri di produzione antica in Calabria: tra continuità e cambiamento
XVII
l tema del vino si presta ad iniziative di promozione culturale che si vogliono radicare sul territorio recuperando il valore storico, culturale e simbolico che esso possiede, attraverso una lettura diacronica dei processi di occupazione e di acculturazione delle diverse popolazioni che su esso si sono stanziate. Lo studio e l’analisi storica del vino offrono la possibilità di riscoprire le specificità del mondo antico analizzando miti, fonti storiche, epigrafiche, iconografi-
che e oggetti che consentono di ricostruire consuetudini, tradizioni, processi produttivi, economie del passato. Ma questa analisi storica permette anche di cogliere la continuità o diversità di produzioni, di modalità operative, di pratiche agricole che in molti casi si sono mantenute, in forma tradizionale e rituale, dal passato ad oggi.
Il vino offre la possibilità di legare il presente al passato per una consapevole interpretazione dei territori e della loro storicità, che in molti casi hanno mante-nuto nel tempo una tradizione di produzione, dimostrando di essere stati sempre vocati per caratteristiche climatiche e ambientali alla coltivazione della vite.
Da più parti lo sviluppo del turismo enogastronomico è stato individuato come nuovo fattore trainante per lo sviluppo delle economie ecocompatibili dei terri-tori ad elevata qualità paesaggistica e culturale, ricchi di produzioni agricole ed enogastronomiche di qualità e di rilevanti testimonianze storico-architettoniche.
La costruzione di itinerari di conoscenza che mettano insieme questi elementi si propone come importante strumento di promozione e valorizzazione dei ter-ritori in cui la natura, gli usi, la riscoperta di antichi sapori, la valorizzazione di aree di interesse storico-archeologico e architettonico diventano catalizzatori di una domanda turistica che oggi sempre più si caratterizza come culturale e per la quale bisogna creare un sistema di offerta integrato.
Colline del Crati
Esaro
Condoleo
CENTRO HERAKLES per il turismo culturale