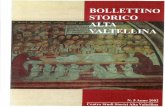Il capitale sociale in Italia, ovvero dell'incommensurabilità dei paradigmi
«quel popolo hora tuto catholico». Nuovi dati sulla valtellina tra Cinquecento e Seicento: anime,...
Transcript of «quel popolo hora tuto catholico». Nuovi dati sulla valtellina tra Cinquecento e Seicento: anime,...
«QUEL POPOLO HORA TUTO CATHOLICO»NUOVI DATI SULLA VALTELLINA TRA CINQUECENTO E SEICENTO:
ANIME, FUOCHI E PARADIGMI DI COMPATIBILITÀ
Giorgio Spini ormai più di un decennio fa, discutendo di Figure e movi-menti del protestantesimo di lingua italiana nella Svizzera tra Cinquecento eNovecento (1) si domandava come mai non solo nessuno avesse mai preso inconsiderazione l’influenza culturale e teologico-filosofica che gli esuli italianihanno esercitato sulla riforma e sulla cultura svizzera, ma anche come mai nes-suno si fosse posto il problema d’indagare, per esempio, la componente pla-tonica del pensiero calvinista e ficiniano. Tanto meno, ulteriore corollario,nessuno ha mai davvero fatto ricerche sulla presenza lucchese e senese inValtellina e nei Grigioni, da Vermigli a Sante Pagnini, i quali, per la propriastatura culturale hanno sicuramente fatto da tramite tra il platonismo degliambienti fiorentini e la teologia riformata. Per tacere della presenza cremo-nese a Teglio e di quella senese e toscana in genere, con tutto il carico di pro-blematiche letterarie, teologiche e filosofiche che erano alla base della loro appar-tenenza geografica. Su queste basi, allora, si pongono diversi spunti, a lorovolta frammentati in ulteriori momenti, non ultimo il principio focalizzatoproprio dallo studioso nel suo stesso intervento, di una geografia culturale dellariforma che scavalca i confini delle Orobie e della Rezia (2).
(1) G. SPINI, Figure e movimenti del protestantesimo di lingua italiana nella Svizzera traCinquecento e Novecento, in Il protestantesimo di lingua italiana nella Svizzera. Figure e movi-menti tra Cinquecento e Ottocento, a cura di E. Campi e G. La Torre, Atti del convegno distudi, Bondo, Val Bregaglia, 3-4 luglio 1997, Torino, Claudiana, 2000, pp. 7-9.
(2) Tale ricerca trova le proprie origini anche nelle posizioni espresse, ormai da più di unquarantennio, da Alessandro Pastore (Riforma e società nei Grigioni. Valtellina e Valchiavennatra ’500 e ’600, a cura di A. Pastore, Milano, Franco Angeli, 1991, ma soprattutto, per gli stessitemi: A. PASTORE, Nella Valtellina del tardo Cinquecento: fede, cultura, società, Milano, SugarcoEdizioni, 1975), il quale, discutendo di esuli, libri e frequentazioni culturali in Valtellina dopoil 1526, non solo si chiedeva quale apporto, in un territorio lontano dai centri culturali, avreb-bero potuto dare le idee riformate e le forme dell’umanesimo italiano di cui gli esuli si face-
Note e documenti324
Il paradigma di compatibilità di cui qui discutiamo interessa quindi l’ef-fettiva quantificazione della popolazione riformata (i cui dati relativi a primadel 1575 sono praticamente inesistenti), l’assegnazione dei luoghi di culto(fondamentale per capire gli equilibri politici e di forza numerica esistenti tracattolici e riformati nelle singole realtà vallive), la quantificazione della popo-lazione valliva fino al Sacro Macello, il numero dei morti verificatisi nell’epi-sodio poiché, se è vero che «[...] per tuta la Valtelina s’amazava tuti li lute-rani a istanza di Santa Chiesa», è anche vero che i motivi che originaronol’insurrezione furono tutt’altro che religiosi. Lo conferma proprio il compor-tamento della componente che prende il potere all’indomani del 1620: larestaurazione di una supremazia sociopolitica nelle comunità del partito cat-tolico e filo-spagnolo, autentica «restaurazione aristocratica» e non rivolu-zione, dimostra la volontà di liberarsi certamente dal giogo Grigione, ma soloper ripristinare privilegi e poteri persi nel 1512. La stessa organizzazione ter-ritoriale e di governo non è un modello di rappresentanza democratica, masemplice coordinamento cooptativo, molto più simile all’oligarchia delle classisociali veneziane che non a un modello politicamente nuovo e coerente congli sviluppi sino allora avutisi nella politica valtellinese. Non solo: in appenaotto anni gli spazi democratici, già abbastanza ristretti, si chiudono del tuttoquando verrà cacciato Gian Francesco Schenardi, uno dei fondatori del gruppodirigente rivoluzionario originario e a Chiavenna si firmeranno accordi diriequilibrio del governo del territorio tra patrizi e vicini che squilibrerannofortemente i rapporti politici, sociali ed economici a danno dei secondi. Questoaccadde anche perché la rivolta fu un fatto essenzialmente valtellinese, cui ilchiavennasco fu costretto suo malgrado a partecipare o perché territorio dipassaggio delle truppe Grigioni (il contado) o perché travagliato dalla neces-
vano portatori, ma anche, segnalando alcuni titoli in particolare, dava adito a una nostra primariflessione sui libri antichi e sulle proprietà librarie in Valtellina tra Cinquecento e Seicento dallaquale è possibile ipotizzare, anche scavando nei cataloghi di altri fondi antichi presenti in pro-vincia di Sondrio e nei Grigioni (una volta risaliti alle proprietà effettive), una serie di percorsi,identificabili anch’essi come paradigmi di compatibilità, atti a ricostruire rapporti economici,apporti umanistici, vicissitudini ed effettiva condizione della società valtellinese e chiavennascatra riforma e controriforma, equilibri politici sul territorio e tra gruppi di potere, peso del con-trollo inquisitorio sulla cultura religiosa della regione (G. TALLINI, Incunaboli, Cinquecentine eSeicentine della biblioteca “Grazioli – Della Vedova” del Liceo “Piazzi – Lena Perpenti” di Sondrio,in «Gutenberg Jahrbuch», 2010, pp. 287-319). Sulla penetrazione in Valtellina delle idee lute-rane e sui modi di reprimerla da parte dell’inquisizione cfr. F. PALAZZI TRIVELLI, Sentenze e pro-cessi contro streghe e stregoni in Sondrio nelle carte del notaio Antonio Rusca (1523), in «Bollettinodella Società Storica Valtellinese», 59, 2006, pp. 175-226.
Note e documenti 325
sità di schierarsi con l’una o con l’altra fazione (il borgo). Il patriottismo dicasta che la parte valtellinese portò alla ribalta della rivoluzione territoriale del1620 fu il principale fattore di debolezza, in un contesto sociale in cui granditensioni religiose tra le parti, almeno fino al 1585, non ve ne furono, anchequando a Morbegno era inquisitore Ghislieri. Del resto, lo ammise ancheGian Giacomo Paribelli che la «presente atione sia stata incaminata ad istan-tia di sua Maestà Catholica sotto finti pretesti di religione» (3).
Affermata con forza la natura politica e sociale e non religiosa dei motidel 1572 e del 1620, è evidente che le ragioni del nostro studio conducononecessariamente in direzione proprio degli equilibri (numerici, economici e poli-tici) determinatisi nei singoli paesi e perciò accertare il numero dei riformatinon è un semplice esercizio statistico, ma operazione fondamentale da cui discen-dono tutte le altre. Ancora, la matrice sociale dei moti smentisce anche unodegli assiomi tuttora resistenti e riguardante la cattolicità dei valligiani. Anchein questo caso, molteplici sono i segni di un dominio consociato (chiesa cat-tolica e gruppi sociali abbienti) delle classi sociali più povere, costrette in unacondizione di quasi totale povertà che ben corrisponde all’etichetta con cui lepopolazioni valtellinesi in questo periodo sono indicate: «popoli pieghevoli allabuona disciplina» (4).
2. Per questi motivi, scelta delle fonti e adozione dei dati emergenti dallevisite pastorali dei vescovi comaschi, sono necessari e imprescindibili, soprat-tutto se pensiamo che in termini di catasto civile e/o di repertori fiscali, i primidati certi rimontano solo al 1575, né sono attendibili i pochi libri animarumo gli altrettanto scarni dati fiscali precedenti quella data; lo stesso catastoGrigione (1531) è da questo punto di vista perfettamente inutile. In partico-lare, l’evento che più incide sulla realtà riformata in valle è la visita pastorale
(3) A. RUFER, Johann Baptista von Tscharner. Eine biographie im Rahmen der Zeitgeschichte,Chur, Bischofberger, 1963, pp. 11-27. Per la situazione cfr. anche G. SCARAMELLINI, La fine deldominio grigione in Valtellina e Contadi nel 1797. Rapporti economici, socio-economici: dalla col-laborazione alla rottura, in La fine del governo Grigione in Valtellina e nei Contadi di Chiavennae Bormio nel 1797, a cura di G. Jäger e G. Scaramellini, Atti del convegno La fine del governogrigione in Valtellina e Contadi: presupposti, modi ed effetti, Sondrio, Chiavenna - Tirano, 26-27-28 settembre 1997, Sondrio, Polaris, 2001, pp. 7-8.
(4) Archivio Storico Diocesano di Como, Visite pastorali, b. XCVI, fasc. 1, p. 569; S. XERES,«Popoli pieghevoli alla buona disciplina». Mentalità religiosa tradizionale e normalizzazione tri-dentina in Valtellina, Chiavenna e Bormio tra Sei e Settecento, in Economia e Società in Valtellinae nei contadi nell’età moderna, a cura di G. Scaramellini e D. Zoia, Sondrio, Fondazione CreditoValtellinese, 2006, 2 voll. e 1 CD-ROM, II, pp. 45-169).
Note e documenti326
effettuata dal morbegnese vescovo di Como Feliciano Ninguarda (1589) cheelenca per ogni paese il numero delle famiglie riformate e compie un’attentaricognizione delle stesse condizioni in cui versa il clero cattolico locale e igno-rante, spesso neppure ordinato e sempre più lontano dalle classi sociali menoabbienti.
Altra visita determinante è quella del 1624 compiuta da monsignor SistoCarcano, utile per avere un quadro ravvicinato dei cambiamenti intercorsiappena dopo il Sacro Macello (5). In ultimo, è utile confrontare quanto emersodalle fonti prima citate con i risultati degli studi di Enrico Besta (6) e con quellisegnalati dalla visita pastorale di monsignor Carofino (1631), dai quali emergeuna geografia della Riforma nelle valli diversa dalla realtà cartografica e terri-toriale. Infatti, le descrizioni non prendono in considerazione Bormio e il suoterritorio, cattolico e con penetrazione riformata inesistente e di converso sioccupano di descrivere numericamente la Valchiavenna, Traona e Morbegno,Sondrio e Tirano.
In particolare è il territorio di Sondrio (SO1) con le sue frazioni (SO2) ela quadra di Traona con Caspano e Dazio ad avere un numero di famiglieriformate residenti abbastanza consistente. A Mossini, Aschieri, Ronchi all’im-bocco della Valmalenco la popolazione è in gran parte riformata e anzi, aMossini, per diretta ammissione del vescovo di Como Ninguarda, sono tuttiriformati. A SO1 la chiesa dei SS. Felice e Naborre è data in gestione ai rifor-mati e ciò provoca malumori cattolici piuttosto forti e duraturi. A Traona eCaspano, è probabile che fosse istallata addirittura una stamperia riformatasul modello di quella di Landolfo Dolfino a Poschiavo, poi smantellata e quasisicuramente trasferita a Chiavenna già sul finire del 1555.
I moti del 1572 e del 1620, dunque, s’incuneano in una situazione socialecaratterizzata da attriti religiosi, in gran parte fomentati con eguale irrespon-sabilità dall’una e dall’altra fazione e per i motivi più futili. Le vere ragionidei moti (vessazioni economiche delle classi subalterne, ricavi incontrollatidalle tassazioni imposte dai Beccaria, vassalli del vescovo di Como) disegnano,infatti, una realtà politicamente equilibrata, con fratture e stridii, ma non pro-blematica e sull’orlo di un crollo definitivo che delinea il profilo di una verae propria guerra di classe, vissuta all’ombra della cattolicità spagnola e con-
(5) L. ODESCALCHI, 1624 – Nota della visita di Valtellina fatta da monsignor Sisto Carcano,a cura di G. Perotti, in «Bollettino della Società Storica Valtellinese», 45, 1992, pp. 123-150.
(6) E. BESTA, Le valli dell’Adda e della Mera nel corso dei secoli, 2 voll., II, Il dominio Grigione,Milano, Giuffré, 1964.
Note e documenti 327
vinta che la dominazione svizzera sarebbe stata spazzata via dalle grandipotenze europee; ciò non solo non avvenne, ma comportò la fine di un equi-librio religioso unico nel panorama di guerre e massacri che caratterizzò l’in-tero continente fino al 1648.
3. La presenza di esuli e la vicinanza ai territori riformati permette l’in-sediamento nei centri vallivi e favorisce il rafforzamento e la diffusione delleidee riformate. Per forza di cose, allora, è necessario ricostruire correttamenteil catalogo delle città e della popolazione riformata basandosi soprattutto sullericognizioni pastorali effettuate dai vescovi di Como durante il periodo 1536-1624 e su alcuni tra gli studi specifici interessanti il territorio, la corrispon-denza epistolare tra personaggi principali e studi sui singoli autori ed episodi.In particolare, alcune fonti documentali descrivono nei minimi particolari lasituazione e la quantità di nuclei familiari cattolici e riformati, non rinunciandoa dare, di fronte all’elenco dei pastori, un eguale catalogo di sacerdoti, segna-lati soprattutto perché in grado di contrastare l’espandersi dell’eterodossia, siateologicamente che in punta di diritto quando i riformati cominceranno a chie-dere luoghi di culto per le proprie funzioni. Spesso, infatti, le chiese sarannoope legis equamente utilizzate e divise tra i due fronti.
Sul versante dei numeri, soprattutto per Teglio, centro riformato tra i piùpopolati e attivi tra quelli dell’epoca, se è vero che non è possibile avere daticerti, pure, stando solo alle fonti storiche e documentali, è possibile ipotiz-zarne una consistenza minima che noi fissiamo all’incirca intorno alle trecentounità, tenendo conto sia della consistenza della popolazione tellina all’epocasia della grandezza e importanza del suo contado.
Per le contrade di Mossini, Ronchi e Aschieri (SO2) ipoteticamente sti-miamo in circa un centinaio di persone la popolazione riformata poiché, standoalle fonti, non solo risulta che quasi tutta la popolazione fosse eterodossa, mala vicinanza alla Valmalenco, anche qui piuttosto consistente e da noi previ-sta in circa centocinquanta-duecento persone di diversa estrazione socio-eco-nomica, ci induce a pensare a trasferimenti continui e ravvicinati (Tabella 1:popolazione riformata nelle fonti).
Tabella 1: popolazione riformata nelle fonti
Dubino 10 Caspano 50
Mello 10 Piuro 50
Mese 10 SO2 100
Prata 10 Valmalenco 150
Note e documenti328
Grosotto 20 Tirano 150-200
Villa Di Chiavenna 30 Chiavenna 200
Berbenno 40 Traona 200
Boalzo 40 SO1 250
Morbegno 40-50 Teglio 300
1660-1720
Indicativamente, dunque, stando allo spoglio fin qui effettuato, siamo inpresenza di una minima oscillazione del 3,48% e cioè tra 1660 e 1720 indi-vidui riformati, con ciò intendendo in quel numero, il complesso delle per-sone (adulti, anziani e bambini) con una certa sicurezza eterodosse nelle duevalli; circa 322-344 fuochi, stando anche ai dati emergenti dal lavoro condottoda K. J. Beloch nel 1961 (7). Facciamo notare però, che nella tabella prece-dente i dati di Sondrio sono stati divisi tra la città e le frazioni intorno; se cispostiamo da questo dato e arretriamo di un quindicennio, già abbiamo perla sola Sondrio dati completamente diversi. La stessa cosa avviene per tuttele realtà antropizzate in altitudine, le quali, essendo soggette (vedi Traona eCaspano) a spostamenti di transumanza e nomadismi stagionali, non possonogarantire sempre lo stesso numero di abitanti. Tentare, quindi, un confrontotra le visite pastorali e i dati in esse certificate, è altamente indicativo, utilesolo per avere dati di riferimento da comparare con le fonti precedenti e suc-cessive. Ne sia esempio Bormio dove si segnalano ca. 1800 fuochi, numero datutti considerato eccessivo e da ridurre del 50%, per un totale di 4500 per-sone (900 fuochi).
Come per Bormio, così anche per altre zone, i calcoli relativi alle popo-lazioni dislocate in altura, che Scaramellini e Zoia hanno così bene docu-mentato nelle loro ricerche, per il nostro studio si sono rivelati, se non inu-tili, inapplicabili poiché, zone come Mello, Caspano, Teglio, Mossini, poste aquote rilevanti rispetto agli altri centri e fondamentali per poter determinare
(7) K. J. BELOCH, Bevölkerungsgeschichte italiens, Berlin - Leipzig, Walter De Gruyter &Co., 1937-1961, 3 voll., III, Die Bevolkerung der Republik Venedig, des Herzogtums Mailand,Piemonts, Genuas, Coriscas und Sardiniens, die Gesamtbevolkerung italiens, Berlin, Walter DeGruyter & Co., 1961, pp. 261 ss. In parte, i dati sono implicitamente confermati dalle analisicondotte da Diego Zoia sugli estimi catastali delle proprietà Grigioni nelle due valli, le quali,a fronte di cifre precedenti spropositate (oscillazioni comprese tra il 30 e il 50%), non avreb-bero invece raggiunto che il 5% del totale (Documenti, a cura di D. Zoia, CD-ROM allegatoa Economia e Società in Valtellina e nei contadi nell’età moderna, a cura di G. Scaramellini eD. Zoia, cit.).
Note e documenti 329
la consistenza della popolazione riformata, risulterebbero, come nuclei abitati,maggiormente popolati rispetto ai grandi centri della pianura. Tali numeri, infatti,sarebbero direttamente proporzionali all’altitudine, cosa al momento non docu-mentabile, anche se a favore di questa affermazione si potrebbero addurre motividi lavoro in quota che al momento non sembrano emergere dai documenti(Tabella 2: dati desumibili dalle fonti principali).
Tabella 2: dati desumibili dalle fonti principali
Besta 1964 Fuochi Beloch 1961 Fuochi
Terziere Inferiore 0 0 20015 4003
Terziere Di Mezzo 39 8 27215 5443
Terziere Superiore 11 2 23050 4610
Tirano 340 68 0 0
Bormio 8 2 9000 1800
Teglio 11 2 0 0
Chiavenna 2600 520 8287 1657
Morbegno 22 4 0 0
Traona 22 4 0 0
So1 e So 2 900 180 0 0
3953 790 87567 17513
Nella prima colonna, risalente agli studi condotti da Enrico Besta, sonoindicate le presenze riformate nei singoli comuni, mentre la terza, estrapolatadai dati pubblicati da Beloch, mostra cifre nettamente maggiori, diversificatie basati sul complesso della popolazione valliva. Per Besta, se accostiamo isuoi dati a quelli della popolazione citati da Beloch, abbiamo una popolazioneriformata che è il 4.51% del totale delle anime; lo stesso Besta poi, riconduceal 3.80% ca. la popolazione riformata rispetto alla cattolica, una variazione diappena lo 0.84% che significa una variazione di 33-34 persone, cioè all’in-circa 6 fuochi. Tale variante però, deve essere rapportata anche ai piccoli cen-tri e qui il dato potrebbe diventare influente poiché, in un centro come Tiranoper esempio, 33-34 persone rappresentano il 10% netto dell’intera presenzariformata; altrove, ragionando in termini di fuochi, l’intera rappresentanza delTerziere di Mezzo si ridurrebbe del 75%.
Un primo dato che possiamo ricavare dalla tabella precedente riguarda ilcalcolo della popolazione cattolica che, a questo punto, sottraendo i riformatial totale della popolazione generale, somma 83614 anime (16723 fuochi); a
Note e documenti330
loro volta, a tale risultato, bisognerà sottrarre i 351 riformati di Tirano eTeglio che non risultano nei conteggi della popolazione effettuati da Belochscendendo così a 83263 (16653 fuochi).
Sommando gli abitanti dei tre Terzieri si raggiungono le 70277 (14055 fuo-chi), 78564 (15713 fuochi) se aggiungiamo Chiavenna e 87567 unità se siaggiunge anche Bormio (17513 fuochi; i dati per comodità di calcolo sono statiarrotondati quando superiori a 0,5 all’intero più vicino), cifra che è di pocosuperiore agli 85.000 calcolati da Sandro Massera e Tarcisio Salice nel 1971 (8).
Sorvolando sulla mancanza di risultati (in Beloch) per Tirano, il TerziereInferiore e Teglio, Morbegno, Traona e Sondrio con il suo circondario (doveinvece Besta segnala per sicura la presenza in massa di riformati, basta vederei numeri di SO1 e SO2), possiamo lo stesso registrare alcuni dati di fatto rela-tivi alle altre zone geografiche che sembrano confermare una netta diminu-zione dei riformati nella parte bassa della valle a ridosso del lago e del fortedi Fuentes e un numero progressivamente crescente procedendo verso il capo-luogo e nel circondario di Chiavenna. Se, infatti, si sommano i dati del Terzieredi Sotto con gli altri terzieri, inglobando in essi quelli degli abitanti nelle sin-gole città e paesi, si ottengono dati che dimostrano lo sbilanciamento urbanoe territoriale verso l’interno e verso altitudini più elevate, anche rispetto al cir-condario di Chiavenna. Tutte le fonti, a fronte di differenze numeriche ancheconsistenti, dimostrano la tendenza a stabilirsi verso l’interno e il centro dellavalle, luogo non solo più sicuro e lontano da Como e Milano, ma soprattuttoal centro di linee di comunicazione sicure con Venezia o la Svizzera riformata.
Anche nel caso dei residenti valchiavennaschi, la scelta di stabilirsi nel capo-luogo di valle, a Ponteggia, Piuro e valle Bregaglia, non solo risponde a pre-cise istanze di sicurezza, ma anche a condizioni economiche che proiettanoscambi e traffici direttamente verso il nord Europa. Anzi, nel caso dellaValchiavenna, a fronte di una forbice troppo ampia tra i dati disponibili(rispetto ai quali calcoliamo una media all’incirca di 802 anime), possiamo notarecome nell’unica fonte disponibile (la relazione Archinti), si evidenzi il progressivo
(8) S. MASSERA - T. SALICE, Brevi cenni di storia valtellinese, in L’ambiente naturale e umanodella provincia di Sondrio, a cura di S. Massera - T. Salice - M. Gianasso, Lecco, BPS, 1971,pp. 23-24. Se, dunque, confrontiamo il numero della popolazione riformata a quello totale, perzona, emergono dati discontinui certamente, ma prossimi alla realtà. Per esempio, sono verisi-mili i dati relativi a Bormio, dove tutte le fonti danno per quasi inesistente la presenza rifor-mata e a Chiavenna, dove, al contrario, tutte le visite pastorali danno per certa la maggioranzadi riformati rispetto ai cattolici. Lo stesso vale per Sondrio e circondario e per Tirano dove iriformati erano abbastanza numerosi rispetto ai cattolici.
Note e documenti 331
avvicinamento dal lago al confine naturale tra Svizzera e Italia (Tabella 3: datidella popolazione riformata per zone).
Tabella 3: dati della popolazione riformata per zone
Città Grigioni Ninguarda Archinti Truog Media
Terziere Inferiore 0 Caspano 0 50 0 0 12,5
Dubino 0 0 10 10 5
Mello 0 0 10 0 2,5
Morbegno 22 40 40 0 25,5
Traona 22 200 0 0 55,5
totali 0 44 290 60 10 101
Terziere di mezzo 39 Berbenno 0 40 0 0 10
so1 0 250 0 0 62,5
so2 0 0 100 0 25
So1/so2 900 0 0 0 225
Valmalenco 0 150 0 150 75
totali 39 900 440 100 150 397,5
Terziere di sopra 11 Grosotto 0 20 0 0 5
Tirano 340 0 150 150 160
Teglio 11 300 0 0 77,75
Boalzo 0 40 0 0 10
totali 11 351 360 150 150 252,75
Valchiavenna 0 Chiavenna 2600 0 200 0 700
Mese 0 0 10 0 2,5
Piuro 0 0 50 0 12,5
Prata 0 0 10 0 2,5
Villa di Ch. 0 0 30 0 7,5
totali 0 2600 0 300 0 725
totali 50 2995 1090 510 310 1226,25
Nei dati di Enrico Besta abbiamo 2995 anime riformate nei singoli paesi(comprensivi del chiavennasco e delle quarantaquattro persone riformate abi-tanti nel Terziere inferiore). Il dato in questione è più convincente se confrontatocon i 1090 riformati della visita pastorale effettuata dal vescovo Ninguarda (chenon comprendono Chiavenna) e dai 510 del Vescovo Archinti. Diversamente,
Note e documenti332
invece, i dati espressi da altre fonti non sono completamente accettabili poi-ché non solo sono assenti quelli riferibili a Chiavenna, Sondrio, Traona eCaspano (che sappiamo essere autentici perni della riforma nelle valli), ma ancheperché mancano riferimenti quantitativi al Terziere superiore, zona che sap-piamo essere popolata da riformati in diversi centri da Teglio a Tirano.
Colpisce la mancanza di dati certi e documentati interessanti la Valmalenco.Nel numero indicato, infatti, ben l’86.81% è rappresentato dai riformati chia-vennaschi, all’interno dei quali devono comprendersi anche gli abitanti del cir-condario (Mese, Piuro e Villa), mentre il 30.05% è costituito dagli abitantiriformati di Sondrio e del suo circondario compresa la Valmalenco stessa: èevidente che sono dati non corretti e perciò non utilizzabili se non ricalcolati.
Al di là dell’assenza di dati relativi alle famiglie cattoliche residenti nellequadre di Traona e Morbegno, rapportando la ricognizione effettuata dai duevescovi Ninguarda (1589, cioè all’epoca del periodo di massima diffidenza traoccupanti e vescovi comaschi e tra le due componenti religiose e all’inizio delleprime diatribe religiose interne alle comunità riformate vallive) e Carcano(1624, cioè dopo il Sacro Macello) con i dati già presentati nelle tabelle pre-cedenti (e tendendo anche presente che i dati di parte cattolica, per ovvimotivi politici, potrebbero essere stati volutamente ridimensionati rispetto allecifre reali già all’epoca), emergono alcune novità che vanno considerate conuna certa importanza poiché incidono sulla differenza numerica esistente tracattolici e riformati. Innanzitutto, è evidente la diversità di valutazione tra idati della visita compiuta dal vescovo Ninguarda e quella della relazioneArchinti. Il 4.51% della popolazione valtellinese riformata, si è ridotta nel 1624(quattro anni dopo il Sacro Macello) del 46.78%, da 1090 dichiarati daNinguarda a 510 in soli trentacinque anni (-580 anime). Se guardiamo al datodella sola Chiavenna (2600) dichiarato da Besta, notiamo una riduzione ancoramaggiore (300): l’11.53%, ovvero -2300 persone. Questo significa che in tren-tacinque anni sono scomparse o emigrate 2850 anime. Se a queste sommiamole altre differenze registrate nello stesso periodo, abbiamo un totale di -3660,un numero abbastanza basso che non sembra far presagire chissà quali stragio emigrazioni forzate negli anni precedenti. Non si dimentichi che le stimefinora riscontrate parlano, sulla scorta di quanto scritto da Cesare Cantù, dicirca 400 morti nel solo Sacro Macello, più o meno il 10% di tutti i morti oespatriati verificatisi in trentacinque anni.
4. Se, dunque, i dati sulla popolazione riformata sono ridimensionatirispetto alle precedenti stime, è anche vero che dallo stesso dato emerge uncalo numerico della popolazione tutta, riformata e non. Infatti, per cause non
Note e documenti 333
solo legate alla religione e alle problematiche politiche che vi sono connesse,la popolazione è drasticamente calata a partire dal 1575, anno del censimentodella popolazione di Sondrio e rimarrà su valori piuttosto bassi fino alla finedel Seicento. È appena il caso di citare proprio il numero degli abitanti delcapoluogo (con le frazioni) per rendersene conto: 3010 abitanti nel 1575, 1815cento anni dopo (nel 1670) e solo 3573 nel 1696, con una variazione, tra 1575e 1670 di -1195 (60.29% della popolazione in meno rispetto al 1575) e di+563 nei ventisei anni successivi (il 18.70% in più rispetto al primo dato, maappena il 15.75% rispetto alla popolazione del 1575). La stessa cosa si regi-stra per Bormio e in ambiti cronologici ben più ristretti, tra 1625 e 1681, econ ogni probabilità, anche se non abbiamo dati disponibili, lo stesso accadea Chiavenna, nel suo contado e nella vicina Val Bregaglia. Solo nel periodo1575-1624 (stando ai censimenti effettuati nel 1575, ai dati ricavabili dalla visitaNinguarda, alle stime relative al periodo 1599-1603 effettuate da Beloch, allevalutazioni ascrivibili allo stesso 1624) emerge un calo della popolazione diben 9380 unità nei soli 13 anni che passano dal 1575 al 1589, quindi un aumentoconsistente di 5535 anime dieci/quattordici anni dopo (il 59%) e 2325 per-sone ancora nel 1624 (il 24.78%).
Sondrio, censimento 1575 74125
Valtellina, visita pastorale Ninguarda 1589 64745
Beloch 1599-1603 70280
Valtellina, visita pastorale Carcano 1624 67955
In meno di cinquanta anni la popolazione è calata di 6170 unità, ovveroil 65.77% del calo iniziale e l’8.32% della popolazione esistente nel 1575 conun picco negativo di 9380 unità ben prima del Sacro Macello e nel periodoiniziale delle lotte religiose antecedenti. Questo dimostra ancora una voltache la religione era solo un espediente con cui giustificare situazioni che nullaavevano a che vedere con essa e con la sua professione, in un campo comenell’altro. Oltretutto, come vedremo più avanti, proprio il dato relativo al1624 è scorretto e sottostimato, almeno stando ai dati delle anime indicati nellarelazione della visita pastorale di quell’anno. Risultano, infatti, da quel censi-mento ben 78172 anime, cioè 10217 persone in meno (il 13,06% in meno).Delle due, l’una: se si parla di 2/3 della popolazione, beninteso solo nei ter-ritori intorno a Sondrio e Chiavenna, già saremmo largamente oltre ogni pre-visione intorno alla diffusione e conversione alla riforma da parte dei valli-giani e questo, è chiaro, rimette in discussione anche il numero dei morti nelSacro Macello.
Note e documenti334
È un dato di fatto che relativamente al calcolo della popolazione nelle suediverse componenti religiose, alcuni luoghi sono completamente ignorati; è ilcaso dei dati relativi a Castello dell’Acqua, che mancano del tutto anche dopoche 88 capifamiglia (su un totale di 130, più dei 2/3 dei residenti) decidonodi staccarsi da Chiuro (140 fuochi) e Castionetto (60 fuochi) per erigersi acomunità indipendente il 4 febbraio 1536. Dagli estimi notiamo che la richie-sta era più che legittima visto che i beni di pertinenza della frazione erano digran lunga più ricchi delle altre due componenti, sfiorando il 50% dell’interoterritorio di competenza delle tre quadre; non solo, ma gran parte delle per-tinenze di Chiuro (che complessivamente ammontavano a 13.668 lire annue)era in effetti posta nel territorio di Castello. I capifamiglia rivendicano 6834lire annue che divise per il numero di fuochi (130) fa 52.56 lire annue a fami-glia (12614,4 denari annui) (9).
Il dato di Chiuro-Castello-Castionetto è importante perché se riuniamotutti i fuochi residenti nelle tre quadre, abbiamo un nucleo di ca. 1650 abi-tanti (330 fuochi complessivi) in gran parte dislocati sul versante orobico, piùpopolato anche a diverse altitudini. Se, quindi, alla tabella iniziale della popo-lazione aggiungiamo anche i dati relativi a Chiuro e le sue quadre, anche senon abbiamo dati sui soli eterodossi, almeno possiamo avere un quadro ancorapiù preciso della popolazione valtellinese che per le sole quadre chiurasche eil Terziere mediano ammonta 28865 anime (5773 fuochi) (10).
Il totale della popolazione, allo stato della questione, risulta nuovamentedisegnato secondo dati che, comunque, sono del tutto provvisori poiché man-cano quelli di Morbegno, Teglio, Traona, Sondrio con le sue pertinenze, Tiranoe molti altri comuni compresi nei terzieri proprio per individuare nuove fonticredibili, altrimenti non si potrà mai avere un risultato certo e soprattutto mai
(9) D. ZOIA, Castello dell’Acqua e la sua comunità, in «Bollettino della Società StoricaValtellinese», 61, 2008, pp. 157-179. P. MIOTTI, Chiuro nel secolo XVII. Una comunità valtelli-nese agli inizi della seconda dominazione Grigione, Milano, tesi di laurea, facoltà di Magistero,Università Cattolica del Sacro Cuore, 1980/1981.
(10) Solo poco meno del 6% della popolazione dell’intero Terziere di Mezzo risiede a pochichilometri dal capoluogo. Questo già ci dice che forse la popolazione riformata dei dintorni diSondrio non era dislocata solo a SO1 e SO2, ma molto più probabilmente si distribuiva equa-mente nella piana e sul versante orobico, soprattutto verso le frazioni oltre Piateda alta (soprat-tutto Agneda verso il lago di Scais all’incirca tra il 700 e 1200 m. di quota) e poi verso le fra-zioni alte di pertinenza proprio di Castello (Bratte soprattutto, ancora coltivata a campo intornoai 1000 metri). Archivio Storico del Comune di Chiuro, Misurazione e valutazione dei terreni(4 giugno 1526), b. 9, fasc. 103.
Note e documenti 335
sarà possibile distinguere esattamente i dati relativi agli eterodossi da quelliortodossi (Tabella 4: anime e fuochi).
Tabella 4: anime e fuochi
Siti Anime % Fuochi %
Terziere Inferiore 20015 22,43 4003 22,43
Terziere di Mezzo e Quadre Chiuro 28265 32,25 5773 32,35
Terziere Superiore 23050 25,84 4610 25,84
totale 71330 80,62 14386 80,62
Bormio 9000 10,08 1800 10,08
Chiavenna 8287 9,29 1657 9,29
Teglio 0 0 0 0
Morbegno 0 0 0 0
Traona 0 0 0 0
Tirano 0 0 0 0
Sondrio 0 0 0 0
totale 88617 17843
Il 19.37% della popolazione (per quanto il dato di Bormio potrebbe nonessere credibile) abita a Bormio e Chiavenna mentre il restante 80% è distri-buito più o meno equamente nei Terzieri. Se per ipotesi assegniamo alle cittàdi cui necessitano dati, un numero di ca. 2000 abitanti per sito, dobbiamoaggiungere almeno altre 10000 anime (per circa 2000 fuochi complessivi) equindi raggiungiamo, sempre ipoteticamente, la ragguardevole cifra di 99217abitanti, quantità che però potrebbe oscillare ulteriormente superando la cifradei 100000 abitanti perché Sondrio, Morbegno, Tirano e Teglio (più cheTraona) avevano diverse frazioni tra le loro pertinenze e abbastanza popolate.Si noti, per questo, il fatto che Boalzo, che pure è pertinenza del comune diTeglio, da sola conta nel proprio territorio 40 riformati (come Piuro e Scilanoa ridosso della disastrosa frana del 1618), la stessa Teglio ne censisce 300 eTirano arriva a 340; nel solo Terziere Superiore (escludendo Grosotto), dun-que, abbiamo complessivamente 680 riformati, i quali, rapportati al numerodi fuochi danno 136: più o meno l’intera popolazione della quadra di Castellodell’Acqua. Questo ci induce a pensare che anche le città di cui non abbiamodati sulla popolazione dovrebbero lo stesso avere un numero di fuochi supe-riore a 130-140, soprattutto se teniamo conto del fatto che quei centri sonofondamentali per la vita economica dell’intera provincia. Per questo, il valore
Note e documenti336
da noi ipoteticamente espresso (2000 fuochi), potrebbe anche essere totalmenteinsufficiente. Unica certezza allora, resta il conteggio effettivo delle anime (ete-rodosse) ricavabili dalle fonti, mentre per il calcolo generale della popolazioneè necessario ricorrere ai dati disponibili per epoca limitando il periodo di ricercaal 1589-1624 e analizzando i numeri paese per paese, quadra per quadra(naturalmente ove disponibili).
5. In questo senso, un primo caso, per certi versi molto simile a quellodi Castello dell’Acqua è rappresentato da Berbenno e dalle sue pertinenze(Postalesio, Valmadre, Cedrasco, Colorina, Fusine, Pedemonte, Monastero,Valle, Rodolo). La pieve, nel 1589 dotata di 21 chiese (cui sommando lediverse cappelle e chiesette sparse sul territorio, raggiungeva il ragguarde-vole numero 43 edifici per il culto), all’epoca della visita Ninguarda avevauna popolazione di 6348 anime (ca. 1269 fuochi) calata di quasi il 60% nel1634 (causa le ondate di peste che si successero tra il 1629 e il 1636) e convistose punte dell’80% di media a Colorina e Postalesio. Nel solo 1630-1631 a Talamona morirono 650 persone e cinque anni più tardi a Caspanometà della popolazione (600 anime) e 200 soldati francesi fecero la stessafine.
Ninguarda Fuochi Carcano Fuochi Diff. Anime Diff. Fuochi %
Berbenno 2730 546 1379 275 -1351 -271 50,51
Cedrasco 840 168 480 96 -360 -72 57,14
Colorina 618 123 510 102 -108 -21 82,52
Fusine 1380 276 760 152 -620 -124 55,07
Postalesio 780 156 610 122 -170 -34 78,2
Totale 6348 1269 3739 747 -2609 -522 58,9
La visita Ninguarda assegna a Fusine 200 famiglie cattoliche e segnala solodue famiglie riformate di origine svizzera: quella di Salis e quella del poschia-vino Paolo Paganino. È evidente che c’è una sottovalutazione voluta del feno-meno eterodosso perché, se tutta la popolazione di Fusine è indicata in 1380anime, sottraendo i 200 fuochi cattolici (1000 anime), le due famiglie rifor-mate dovrebbero avere 380 anime.
La popolazione di Berbenno e delle pertinenze assomma sul fronte cat-tolico a 3795 anime (759 fuochi). Alle famiglie cattoliche bisogna poi som-mare quelle registrate dalle visite pastorali Ninguarda e Carcano (1624), i cuidati, essendo espressi in anime, sono stati da noi ricondotti ai soli fuochi.
Note e documenti 337
Ninguarda Carcano Cattolici Fuochi Anime TuanaNinguarda riformati riformate
Berbenno 455 275 450 5 25
Cedrasco 140 28 140 0 0
Colorina 109 20 109 0 0
Fusine 230 46 200 30 150
Postalesio 130 26 130 0 0
1064 395 1029 35 175 750
Dai calcoli rileviamo che nel 1589, a fronte di 1029 fuochi cattolici residentinella sola pieve di Berbenno (3795 anime), si registrano 35 riformati (175 anime)per un totale della popolazione residente di 1064 fuochi (5320 anime) (11).
6. Altra operazione consimile riguarda la popolazione di Chiavenna chenel 1633-1634, all’epoca della visita pastorale del vescovo Carafino e standoallo Status animarum del 1633, ne dichiara 1816 (12).
Stando ai risultati della visita pastorale Carafino, se nel 1633 in tutto ilcontado vivevano 8287 persone, è pur vero che nel solo borgo di Chiavennadimoravano, stando sempre alla stessa fonte, 1816 persone, dato consideratoda altri sospetto e che invece sembrerebbe allo stato attuale del tutto credi-bile (13). Infatti, se sommiamo ai 1816 abitanti censiti (di cui non abbiamo
(11) Intorno alla metà del Seicento la popolazione di Berbenno è stimata in 750 anime «essen-done morti tant’altri per la peste» (cioè 1500 persone). Il dato è nettamente superiore a quellodella visita Carcano e è probabile che lo storico seicentesco Giovanni Tuana intenda invece lapopolazione di tutta la pieve; in questo caso la popolazione complessiva (1975 anime) dal 1624sarebbe diminuita (causa la peste più che il Sacro Macello) di circa 475 anime, più o meno unquarto della popolazione vivente nell’intero territorio di Berbenno un quarto di secolo prima(G. TUANA, De rebus Vallistellinae, a cura di T. Salice, trad. dal latino di A. Levi, Sondrio, SocietàStorica Valtellinese, 1998).
(12) Archivio Capitolare Laurenziano di Chiavenna, Archivio Vecchio, b. 1, fasc. Statid’Anime, secoli XVII-XVIII, atti del 1633, 1642, 1679 e 1709. Nel borgo e nel contado chiaven-naschi, intorno al 1650, sono registrati anche all’incirca 100 riformati (di cui quasi un terzorisiede nel borgo), nello stesso periodo a Piuro-Scilano sono presenti 40 eterodossi e 70 a Mese(G. SCARAMELLINI, Protestanti a Chiavenna nel Settecento. Prime indagini demografiche, econo-miche e sociali, in «Clavenna», XXXIII, 1994, pp. 151-219).
(13) G. SCARAMELLINI, «Der pündter London»: commercio, finanza e manifattura nel borgo enel contado di Chiavenna (XVI-XIX), in Sulle tracce dei Grigioni in Valchiavenna, a cura di M. Balatti- G. Giorgetta - G. Scaramellini - G. Scaramellini - D. Zoia, Atti della giornata di studi in occa-sione della mostra allestita al Palazzo Sertoli Salis di Chiavenna, 23 maggio - 20 settembre 1998,Chiavenna, Museo della Valchiavenna, 1998 (Elementi per una ricerca, 5), pp. 13-15.
Note e documenti338
controprove che possano dimostrare che il dato è gonfiato) i morti per pestedi due anni prima (all’incirca un terzo della popolazione, cioè 605 residenti),abbiamo 2421 anime e 484 fuochi (più o meno), dati che sembrano essere inlinea con i 2010 abitanti registrati nel 1642 (14). Se nel 1633 la popolazioneammonta a 1816, nel 1624 circa invece, sottraendovi il numero dei morti dipeste prima segnalati (15), ammonterebbe a circa 1211 abitanti, numero chepossiamo ritenere valido con una certa approssimazione (16).
Il dato chiavennasco relativo al 1589 però, può essere lo stesso ricavatoda altre fonti, meno precise sicuramente, ma lo stesso indicative e accettabili.Ci stiamo riferendo in particolare alla relazione in latino stesa dall’esule par-mense Broccardo Borroni (17). In essa, il cronista parla di una popolazioneminima di 5000 persone e di almeno 800 riformati (cioè il 16% del dato com-plessivo). Questo dato, valido per i cattolici del borgo e del contado e forsesottostimato (ma probabilmente giusto per gli eterodossi che in questo casosono il totale della popolazione riformata di Chiavenna, Piuro, Ponteggia-Villae Mese), ci permette di determinare anche il numero dei riformati chiaven-naschi che ammonterebbe per il solo borgo di Chiavenna, sottratti gli 800 citatida Borroni, a 650 riformati (18).
(14) È probabile che fino al 1633, nonostante la peste e le guerre di Valtellina, non sia cre-sciuta la popolazione “patrizia” quanto i “vicini”, persone cioè nate nella città ma non origi-narie del paese, immigrate per motivi soprattutto economici dovuti in grandissima parte allacrescita sociale e commerciale, all’imprenditoria legata ai transiti e alla penetrazione economicae sociale che gli stessi Grigioni esercitarono tra 1630 e 1787 (Ivi, pp. 14-31).
(15) G. SCARAMELLINI, La peste del 1629-1631 in Valchiavenna e Valtellina, prima parte: InValchiavenna, in «Notiziario della Banca Popolare di Sondrio», XI, 1983, 31, p. 40.
(16) G. SCARAMELLINI, «Der pündter London»: commercio, finanza e manifattura nel borgoe nel contado di Chiavenna (XVI-XIX), cit., p. 14.
(17) B. BORRONI, Informatione dello Stato e del Governo delli Signori Grisoni, in A. GIUSSANI,Il forte di Fuentes. Episodi e documenti di una lotta secolare per il dominio della Valtellina, Como,Ostinelli, 1905.
(18) Gli Status animarum del 1633 e i dati della visita Carofino (1634) danno poi altri numeri:7434 per il primo e 8287 per il secondo (naturalmente, i numeri intendono la totalità dellapopolazione del borgo e del contado). Ora, se nel 1633 la sola popolazione chiavennascaammontava a 1816 persone, è evidente che nel resto della valle la popolazione non poteva esseresuperiore alle 5168 unità (1123 fuochi). Ancora, se l’anno successivo il vescovo Carafino segnalainvece più di 8000 persone, allora, la popolazione (utilizzando lo stesso dato) ammonterebbea 6471 con 1294 fuochi. È evidente che il dato sovrastimato è quello di Carafino, sicuramenteinteressato a favorire numericamente la fazione cattolica; è infatti impossibile che in un soloanno la popolazione aumenti di 853 elementi (170 fuochi per un differenziale di quasi il 9%)e tutti tra borgo e contado. È altresì evidente che il censimento Borroni non si allontana moltodalla verità poiché il suo macro-dato complessivo è vicino a quello segnalato dallo stato delleanime del 1633.
Note e documenti 339
7. All’altro capo della valle, la pieve di Mazzo presenta analoghi problemidi distribuzione e riorganizzazione dello Status animarum relativo a un terri-torio piuttosto ampio che va da Lovero a Grosio e fino alle pendici delMortirolo. Tale territorio è importante non tanto per la comunità riformata,residente a Grosotto (a Grosio e Mazzo non se ne conservano tracce), quantoper la popolazione nel suo complesso, dato che esso andrebbe a sommarsi aquello di Bormio (9000 anime), a lungo sopravvalutato.
Il territorio del solo comune di Mazzo, formato da quattro quadre (Nobili,Albertelli, Monti verso il Mortirolo e Vione), nel corso del Cinquecento havisto una costante immigrazione nei propri confini, sia da fuori provincia cheda altre zone della stessa Valtellina e in particolare dalle zone di Sondrio eAlbosaggia. Così, stando alla solita visita pastorale di Feliciano Ninguarda, nel1589 si rilevavano 300 famiglie con 800 anime, mentre nel 1620 si contavano230 fuochi paganti il focatico.
La popolazione del comune, in soli trentacinque anni (dal 1589 al 1620e poi fino al 1624, nell’arco dunque delle sole visite pastorali citate), ha oscil-lato in media intorno ai 1050 abitanti e con un aumento progressivo di quasila metà dei fuochi nel solo periodo 1589-1620. Nonostante la situazione poli-tica generatasi in quello stesso anno, sembrerebbe che la popolazione siaaumentata costantemente, per poi bruscamente calare per la peste. Stando alcalcolo dei morti per peste, infatti, Mazzo è stata particolarmente martoriatapoiché le ondate di peste si susseguirono non solo tra 1629 e 1631 (il numerodei morti però non ci è pervenuto), ma anche nel 1634 (59 morti), 1635 (148morti), 1636 (297 morti) e 1637 (18 morti) per un totale, in soli sei anni, di586 persone. Così, se teniamo per buoni i 1150 abitanti del 1620, sottraen-dovi i morti per peste, abbiamo 564 abitanti (112 fuochi), numero che puòbenissimo essere risalito in centocinquant’anni ai 930 del 1766 (186 fuochi)anche questo non molto lontano dai 145 fuochi di quattordici anni più tardi(1780). È interessante notare che poi, in un secolo, la popolazione risalga aldoppio del censimento precedente, segno di una ritrovata sicurezza economicae sociale.
Nello stesso 1630-1635 la peste a Grosotto falcia più di 500 persone; così,anche sommando i soli dati di Mazzo e Grosotto, abbiamo 1086 persone, piùo meno un terzo dell’intera popolazione della pieve in quello stesso periodo.All’incirca, infatti, tutta la popolazione della pieve potrebbe assommare nelperiodo indicato a 3258 persone con un 3-4% di popolazione riformata resi-dente a Grosotto (circa un centinaio di persone secondo Ninguarda che segnalala presenza, nel 1589, di 20 famiglie riformate).
Note e documenti340
8. I dati prima esplicati conducono all’ennesimo conteggio della popola-zione valtellinese. Infatti, se aggiungiamo i dati ricavati sinora al quadro ini-ziale e li confrontiamo con quelli raccolti da Beloch (che peraltro adotta pro-prio i dati della visita Carofino, che potrebbero essere gonfiati nella parte relativaai cattolici) otteniamo altri numeri. La possibilità di avere un quadro certodella popolazione ci è offerta allora, almeno per il 1624, dal vescovo Carcano,che allega alla relazione della propria ricognizione pastorale un dettagliato elencodella popolazione che qui riportiamo raggruppando per aree di pertinenza cittàe paesi più importanti.
Popolazione Riformati %
A1 Morbegno 9869 50 0,5
A2 Berbenno 3739 40 1,06
A3 Sondrio 8744 350 4
A4 Valmalenco 2383 150 6,29
A5 Montagna 2790 60 2,16
A6 Ponte in Valtellina 3900 84 1
A7 Piateda 1248 27 2,16
A8 Chiuro 1770 37 2,16
A9 Poschiavo 4500 97 2,16
A10 Bormio 5717 0 0
A11 Mazzo di Valtellina 9804 20 0,2
A12 Tirano 7154 200 2,79
A13 Teglio 6204 340 5,48
A14 Ardenno 2602 56 2,16
A15 Caspano 7818 270 3,45
Totale aree 78242 1781 2.27
Chiavenna 1211 300 24,77
Poschiavo -4500 -97 2,16
Totale popolazione 74953 1984 2,64
Ricordiamo che Beloch 1961 si riferisce al periodo 1599-1603 e quindipossiamo considerare i dati sopra citati all’interno di una curva di crescita. Lamedia della popolazione in Valtellina tra 1575 e 1624 oscilla allora tra i 74125e i 78242, con una media di 76152.25 e con una variazione, rispetto ai datiBeloch 1961, di 11414.75 anime (il 14.98% calcolato sulla media) e al 1624
Note e documenti 341
di 9485 abitanti (il 12.45% calcolato sempre sulla media ponderata). Tra i dueè evidente che il differenziale più basso (quello del 1624) è il più realistico,vuoi perché si avvicina ai risultati indicati in altre fonti, vuoi perché la diffe-renza calcolata, distribuita sulle 15 aree individuate fa 632.33 anime per zona,più o meno la popolazione di uno solo dei paesi presi in considerazione. Lamedia dei residenti però deve sottrarre l’area 9 (Poschiavo, 4500 anime), percui la media effettiva sale a 887,61 con uno scollamento dello 0.71% rispettoalla precedente (con una popolazione per area, escluse sempre Poschiavo eBrusio, in media di 4911.46 residenti, il 6.66% del totale al 1624). È evidente,altresì, che mancano i dati di Chiavenna del 1624, calcolati in 1211 unità chesommati ai dati già raccolti fa 74833 abitanti (79383 contando Poschiavo eBrusio) con una media abitativa per area (senza l’area svizzera) di 4680.18 resi-denti e 891.46 anime per comune (1.19% rispetto ai soli abitanti registrati daSisto Carcano nei tre Terzieri e Bormio, 1.12% contando anche l’area 9).
Il dato di media della popolazione è, dunque, quello più vicino alla mediadell’epoca e soprattutto ben al di sotto di quelli dichiarati dalle fonti che sisono interessate alla questione. Non solo, ma la consistenza ridotta della popo-lazione riduce in percentuale anche il numero dei morti perché direttamenteproporzionale alla base di calcolo.
Il nuovo dato sulla popolazione (79383 comprese Chiavenna, Poschiavoe Brusio) ci riconduce all’effettiva consistenza della popolazione riformata chea questo punto può essere desunta in maniera più agevole escludendo dai datigenerali quelli relativi ai comuni dove è certificata la presenza riformata. Inquesto modo, fermo restando che la popolazione riformata di Montagna,Ponte, Piateda, Chiuro, Poschiavo, Ardenno non è indicata altrove e che aBormio le fonti danno per scontata la totale assenza di riformati, si è proce-duto ad assegnare un valore minimo di media alle popolazioni non indicate,corrispondente al 2.16% dei dati noti rispetto al rapporto in totale tra rifor-mati e cattolici. Il valore, approssimativamente, corrisponde a 97 anime perPoschiavo, 84 per Ponte, 27 per Piateda, 60 per Montagna e 56 per Ardennoper un totale di 1781 riformati in Valtellina e 2081 in tutto il territorio (19).
(19) Assodato che il valore relativo alla popolazione valtellinese e valchiavennasca tra 1575e 1624 è di 74883 anime (senza Poschiavo e Brusio e con una densità abitativa per area di4992 abitanti) è possibile ora analizzare altri dati, successivi al 1624 e a esso strettamente legatipoiché permette di osservare le variazioni dovute a eventi endemici come la peste. Altro valore,dunque, è quello dei morti per peste che, pur intervenendo solo dopo il 1620, hanno lo stessocreato problemi poiché spesso sono stati registrati sommariamente. Altrove, non esistendo uncontrollo demografico efficace e valido per tutte le parrocchie, non è neppure possibile indi-
Note e documenti342
9. Il numero dei morti e dei rifugiati all’estero dopo il 1620 porta a risul-tati diversi da quelli prospettati sinora dalle fonti. Se si sommano i presunti400 morti dati da Cesare Cantù ai 250 rifugiati a Zurigo (20), già abbiamo unnumero di riformati nettamente più alto di quello stimato (450-500 al mas-simo nelle valli). Tenendo presente che non solo a Zurigo ci sono stati esuli,ma anche in altre città svizzere e persino a Lione, è chiaro che il numero vameglio determinato. In base ai nostri calcoli, se la popolazione intera, nel periodo1589-1624 assommava a 74883 anime e se i dati estrapolati dalle fonti nonmentono, abbiamo all’incirca un migliaio di riformati in tutte e due le valli,con punte di più del 63.72% in Valchiavenna. Il dato della visita Archinti èa questo punto da scartare perché fortemente alterato in quanto più basso deisoli riformati presenti nel contado chiavennasco. Se lo si esclude dal computoritorniamo alla media da noi individuata all’inizio di circa 1020 persone.
Feliciano Ninguarda non aveva sbagliato le sue stime o per lo meno leinformazioni raccolte erano nettamente più precise che in altre situazioni, delresto la missione del morbegnese aveva come scopo preciso proprio quello dideterminare la situazione sul territorio, a cominciare dalla consistenza dellafazione eterodossa. È evidente che lo stesso Ninguarda non ha considerato validii dati raccolti dal suo predecessore visto che la media da noi calcolata e ildato del morbegnese coincidono quasi alla perfezione.
Il differenziale tra cattolici e riformati tra 1589 e 1620 è dunque all’in-circa l’1.45% della popolazione intera. Calcolando che in 250 si rifugiano aZurigo, 311 sono i morti citati da Romegialli (compresi i 27 poschiaviniuccisi) (21), 200 sono i rifugiati in altri luoghi della Svizzera, 10 quelli lasciatiliberi dal pretore tiranese (22) e 73 gli esuli fuggiti attraverso il passo delMuretto, abbiamo 844 riformati a diverso titolo coinvolti: 311 morti e 533 fuo-riusciti, rispettivamente il 36.84% e il 63.15%. Su 1089 eterodossi presenti inValtellina, quindi, secondo la nostra elaborazione sottraendo tutti gli 844 coin-
viduare le variazioni di popolazione sicuramente verificatesi prima e dopo il passaggio dellapeste (lo stato delle anime della pieve di Mazzo, per esempio, comincia solo dal 1579 per ibattesimi, dal 1654 per le cresime, dal 1625 per i matrimoni e dal 1626 per i morti, mentre ilcensimento della popolazione vivente solo dal 1766; si veda infatti: Archivio Capitolare eParrocchiale di Mazzo di Valtellina, Serie XIII, anagrafe, in Archivi Storici Ecclesiastici di Grosio,Grosotto, Mazzo, a cura di G. Antonioli, Sondrio, Società Storica Valtellinese, 1990, pp. 351-360).
(20) V. PARAVICINO, Vera narrazione del massacro di Valtellina, 1621.(21) G. ROMEGIALLI, Storia della Valtellina e della già contee di Bormio e Chiavenna, Sondrio,
co’ tipi di Giovanni Battista della Cagnoletta, 1834, pp. 222-266.(22) Ivi, p. 238.
Note e documenti 343
volti, cioè morti e fuoriusciti, rimangono 245 individui, lo 0.32% dell’interapopolazione delle due valli. È evidente che il dato è nettamente più basso esicuramente più plausibile, nell’ottica della popolazione intera e nella sola per-cezione del dato riformato, fermo restando che, sia pure di un 50% ca. piùbasso rispetto alle fonti, esso è comunque terribile poiché il 48,94% della popo-lazione riformata (1089) ha dovuto comunque abbandonare tutto, il 28.55%è stato ucciso e 245 (22.49%) sono probabilmente rimasti nelle valli o si sonorifugiati temporaneamente oltre confine o nel Milanese o nel chiavennasco perpoi ritornare molto più tardi ai luoghi d’origine.
Va rilevato però, che se si usa il dato da noi stimato di 2081 riformatiresidenti nelle valli tra 1589 e 1620 (che però non divide i Valtellinesi dallealtre nazioni), abbiamo un numero di morti tra la popolazione eterodossa chesi aggira tra i 1237 e i 1187 (con una media di 1212) che va rapportatacomunque ai quarant’anni di intervallo considerati. La stima ci permette diavere oscillazioni che tengano anche conto dei semplici decessi e non solo deidefunti nel Sacro Macello. Se applichiamo, infatti, ai numeri fin qui ricavatila media di 21 morti eterodossi (all’incirca l’1% dei 2081 riformati da noi riscon-trati) e la moltiplichiamo per il periodo preso in considerazione, abbiamo 840morti i quali, sottratti al valore di partenza (2081), danno 1241 anime rifor-mate; a loro volta, sottratti i numeri derivati dalle fonti e già dichiarati in pre-cedenza, abbiamo un’oscillazione tra i 347 e 397 morti, questo sì in linea conle fonti (tra lo 0.46% e lo 0.53% della popolazione nel suo complesso).Evidentemente, chi ha conteggiato la popolazione in precedenza ha messo nelconto anche i morti naturali intercorsi nei quant’anni dalla visita Ninguardaa Carafino.
10. Il catalogo delle città e dei luoghi di culto, unito a quello dei pastoririformati permette di tracciare un quadro diverso della riforma in Valtellina eValchiavenna e permette di poter meglio analizzare tali presenze. Anzi, ilrifiuto Grigione a procedere alla costruzione di nuovi edifici di culto, deveessere letto proprio in chiave di conservazione della pace sociale, visto che inmolti nuclei familiari esistevano persone di religione diversa. Soprattutto inalcune zone, l’uso comune dello stesso edificio, infatti, è probabile fosse statoconcesso proprio per evidenti motivi di ordine pubblico. Ciò avviene perchéla presenza riformata e la rappresentanza pastorale erano particolarmente evi-denti sul territorio e nel complesso della città o dei singoli villaggi.
Al di là, infatti, dell’effettiva consistenza numerica della popolazione ete-rodossa, in alcuni centri si assiste alla contemporanea presenza di più pastori(o di un numero elevato di essi), indice di un ricambio continuo e di un tes-
Note e documenti344
suto sociale forte e coeso che va oltre l’assegnazione di un luogo di culto ido-neo e conforme al proprio rito. È proprio questa presenza, testimonianza diuna forza territoriale politica, sociale, economica e familiare, che incute sog-gezione nei cattolici e in quella parte del gruppo dirigente ortodosso che vedequotidianamente diminuire il proprio potere e la propria forza, acquisita e raf-forzata nei secoli. Se si scorre l’elenco dei luoghi, delle chiese e dei riformatipresenti e lo si raffronta con il numero dei predicatori attivi, tutto ciò è evi-dente e incontestabile.
Città Periodo Pastore Chiesa Pastori
Berbenno 1557-1620 A. Pozzi; B. da Casale; S. Abbondio, 6S. Tarracchia; G. B. S. AntonioParavicini; B. Clauschrist;G. Jenatsch
Boalzo === === S. Giorgio 0
Caspano 1542-1620 C. Renato; R. Paravicini; 6A. Riva; G. A. Paravicini; A. Basso; G. Resta; M. Paravicini
Chiavenna (23) 1531-1619 F. Negri; Ag. Mainardi; S. Maria del 5Ger. Zanchi; Scip. Pattarino,Lentolo; Ottaviano Mei S. Pietro,
S. Maria diBorgonuovo
(23) All’elenco chiavennasco vanno aggiunti i pastori dissidenti: Simone Fiorillo (1556-1597),Bartolomeo Silvio e Camillo Renato (cfr. A. ROTONDÒ, Esuli italiani nella Valtellina delCinquecento, in Studi di storia ereticale del Cinquecento, Firenze, Olschki, 2008, 2 voll., II, pp.403-442, in origine recensione a A. PASTORE, Nella Valtellina del Tardo Cinquecento: fede, cul-tura, società, cit., in «Rivista Storica Italiana», LXXXVIII, 1976, 4, pp. 756-791). Se si analizza ilnumero di luoghi di culto presenti in ogni singolo comune, è evidente anche il rapporto esi-stente tra protestanti e cattolici. Se poi teniamo conto che in tre paesi (Dubino, Grosotto, Mello)non è stato ancora identificato un luogo di preghiera riformato o in uso alla comunità nata nelterritorio di competenza e che diversi luoghi avevano chiese in comune, allora, è evidente che,se non si può parlare di grandi numeri, pure non possiamo escludere un coinvolgimento ampiodella popolazione stessa, anche rispetto al dato statistico relativo alla popolazione valliva nelsuo complesso. Non a caso ben tre chiese sono presenti a Chiavenna, importante quanto Coriae sede di diverse famiglie riformate, mentre altrove non si va oltre un solo luogo, spesso con-diviso.
Note e documenti 345
Dubino 1558-1620 P. Antignatensis; 6G. Chiesa [?]; G. Torti; A. Da Macerata;M. Mortellito; G.B. Calandrino; A. Bugliotta; G. D. Rascher; A. Basso; W. Vedrosi
Mello 1572-1620 L. Gaio Da Soncino; 9G. Chiesa;C. Gaffori; G. Da Verona; G. Grass; M. A. Alba; U. Janutt Ballestin; S. Andreoscia
Mese 1561-1582 Ger. Tifernas; G. Zonca; S. Mamete 3A. Bugliotta
Morbegno 1558-1618 Fr. Cellario; S. Pietro 11U. Martinengo; Sc. Calandrino; A. Andreoscia; G.B. Thei; G. Torti; E. Poggi;M. Mortellito; G. Nuot Andreola; Muz. Paravicini; Bonav. Toutsch
Piuro 1561-1607 Ger. Torriani; 4M. Mortellito;M. A. Alba; M. Mortellito 4
Prata 1564-1618 G. Martino; G. Marra S. Cristofaro 2
SO1 1555-1620 A. Conradi; B. Silvio; Ss. Nabore e 5Sc. Calandrino; G. Betscha; FeliceG. Alessio
SO2 1566-1620 Sc. Lentolo; Sc. Calandrino; Sine Titulo 7B. Silvio; G. Averrario; Luigi Fracatius; Nicola Kesel; Bart. Marlianici
Teglio 1555-1620 Paolo Gaddi; B. Silvio; S. Orsola 4Ottaviano Mei; G. P. Danzio
Note e documenti346
Tirano 1551-1620 C. Martinengo; S. Maria 7G. Da Milano; Fr. Negri; Del CastelloA. Pozzi; G. Da Milano; Seb. Segni; A. Andreoscia;Antonio Basso
Traona 1545-1620 C.Renato; A. Pozzi; SS. Trinità 7C. Gaffori; R. Paravicini; G. Da Verona;A. Martinengo; L. DonatoA. Blech
Valmalenco 1580-1606 Bart. Chiesa; M. A. Alba S. Giacomo 2G. Chiesa [Ep]
Villa di 1579-1620 G. Torrioni; A. Bugliotta; Capp. Di S. 5Chiavenna G. A. Marchion; Rocco [ann.(Ponteggia) E. Poggi; T. Casella Chiesa Parr.]
Mello e Morbegno sono i luoghi dove maggiormente si sono succeduti ipastori (rispettivamente 9 e 11, in media il 10% circa dei 92 registrati), men-tre la media per territorio è di 5 pastori per luogo. Così, Morbegno, a frontedi ben 11 pastori che si succedono alla carica, mantiene una sola chiesa, men-tre a Chiavenna 5 pastori amministrano 3 chiese. Tutto ciò dipende dalla forzapolitica ed economica che i riformati avevano nei luoghi in cui abitavano: Traonaper esempio, pure in presenza di 7 pastori, conserva sempre e solo una chiesaper la forte opposizione della comunità cattolica e nonostante il numero deiriformati. Diverso il caso di Berbenno che conserva due chiese e un solopastore, quel Benedetto da Casale Monferrato, ex domenicano chiamato dallefamiglie riformate Sebregondi, Paravicini, Piatti e Capello e stipendiato dal-l’intera comunità.
Un altro dato interessante riguarda la distribuzione numerica dei pastoristessi; infatti, se dividiamo i 93 pastori complessivi per la popolazione valtel-linese e chiavennasca da noi determinata in precedenza (74883 anime, di cui1984 riformate), otteniamo un pastore ogni 21 eterodossi (il 4.68% della stessapopolazione riformata) e un pastore ogni 814 persone. È evidente che si veri-ficano situazioni per cui, a fronte di un numero davvero esiguo di riformati,la percezione che se ne ricava è invece completamente diversa al punto chesembrano esserci quasi più pastori che eterodossi; questo ci induce a credereche, almeno in parte, i capi della fazione cattolica avessero ragione a temere,
Note e documenti 347
più che una recrudescenza del governo Grigione all’indomani dei processi diThusis, un vero e proprio colpo di mano da parte riformata (24).
Se rapportiamo la media dei pastori calcolata (5 per luogo) alla media dellapopolazione per ognuna delle 15 aree individuate (la cui media della popola-zione assomma a ca. 632 anime tra orto ed eterodosse), abbiamo un pastoreriformato ogni 126 persone (lo 0.79% della popolazione in ogni area); ora,tenendo presente che lo stato dei sacerdoti cattolici in Valtellina era piuttostobasso, tanto che ogni visita pastorale ha deplorato le condizioni minime delclero (spesso dedito all’ubriachezza, all’usura o in molti casi addirittura nem-meno consacrati secondo le regole), è chiaro che anche un solo pastore rifor-mato (ben preparato, spesso giovane e socialmente espressione dei ceti alti dellasocietà, consapevole della propria forza evangelizzatrice e cosciente della pro-pria capacità di studio e riflessione quotidiana sul Libro), sia pure a capo diuna piccolissima comunità, pur non avendo necessariamente alle spalle ilgoverno Grigione, poteva lo stesso essere un problema e non solo per l’operadi conversione, ma soprattutto perché sin da subito entrava a far parte di uncircolo teologico-dottrinale, economico, sociale e politico a cui l’antica aristo-crazia cattolica di valle si guardava bene dal partecipare. Non a caso, è a Teglio,Traona e Caspano che si registrano le famiglie riformate socialmente più affer-mate, luoghi dove, al di là della ricchezza economica delle loro quadre e per-tinenze e dell’antica nobiltà valliva che ivi risiedeva, si era sviluppata, lungoil corso del Trecento e del Quattrocento, tutta una filiera mercantile che avevaesportato i propri commerci verso il nord Europa, aprendosi alla novità e impo-nendo nuovi modelli di scambio e di pensiero che andavano oltre la ristrettamentalità delle decime e della sovranità vescovile sul territorio stesso. Se solosi confrontano le opere dei Besta e quelle dei Beccaria proprio alla fine delCinquecento, si noterà tale differenza, palese persino nei palazzi e negli arredidelle proprie dimore.
(24) Sui processi di Thusis e la figura di Niccolò Rusca e per la questione relativa ai rap-porti tra riformati e cattolici, rimandiamo a F. VALENTI, Le dispute teologiche tra cattolici e rifor-mati nella Rezia del tardo Cinquecento. Primato del papa, divinità di Cristo, sacrificio della messa,Sondrio, Galleria del Credito Valtellinese - Palazzo Sertoli, 2010; A. WENDLAND, Ai confini del-l’eresia. Le frontiere religiose ed ecclesiastiche in Valtellina (1550-1640), in La Valtellina croceviadell’Europa. Politica e religione nell’età della Guerra dei Trent’anni, a cura di A. Borromeo, Milano,Mondadori, 1998, pp. 163-197; S. MASA, Fra curati cattolici e ministri riformati. Niccolò Ruscae il rinnovamento tridentino in Valmalenco, Sondrio, Fondazione Gruppo Credito Valtellinese,2011.
Note e documenti348
Ognuno dei 93 pastori individuati ha curato una stessa comunità almenouna volta e più volte invece è ritornato a occupare cariche già in precedenzaassegnatigli. In una topografia valliva della residenza dei pastori riformati,quindi, si possono riconoscere, per la gran parte almeno, alcune appartenenzeche dimostrano anche come la circolarità delle idee (e dei libri) avvenisse attra-verso percorsi sicuri, ben garantiti e partecipati.
Nome Sede
Mortellito Michele Morbegno 1593-1596; Dubino 1596-1597; Piuro 1597-1603;Piuro 1606-1607;
Alba Marco Antonio Piuro 1603-06; Mello 1606-08; Chiesa 1608-20;
Basso Antonio Caspano 1597-1598; Grosotto 1598-1607; Tirano 1608-1620;
Bugliotta A[ndrea] Mese 1579-1582; Villa Di Chiav. 1579-1582; Grosotto 1587-1589;
Calandrino Scipione SO2 1566-1568; Morbegno 1569-1583; SO1 1589-1607;
Pozzi Agostino Berbenno 1557-1561; Tirano 1561-1578; Traona 1578-1588;
Silvio Bartolomeo SO2 1568-1572; Teglio 1572-1580; SO1 1580-1583;
Andreoscia Antonio Morbegno 1583-1585; Tirano 1593-1608;
Chiesa Giacomo Dubino 1576-1584; Mello 1578-1585;
Gaffori Cesare Mello 1588-1591; Traona 1588-1591;
Gaio da Soncino L. Mello 1572-1578; Mello 1585-1588;
Giulio Da Milano Tirano 1552-1555; Tirano 1578-1581;
Giulio Da Verona Traona 1591-1592; Mello 1592-1601;
Lentolo Scipione SO2 1566-1568; Chiavenna 1568-1597;
Mei Ottaviano Teglio 1580-1597; Chiavenna 1597-1619;
Negri Francesco Chiavenna 1531-1539; Tirano 1555-1559;
Paravicini Raffaele Morbegno 1606-1615; Caspano 1615-1619;
Poggi Ercole Morbegno 1590-1593; Villa Di Chiavenna 1585-1588;
Torti Gerardo Dubino 1584-1588; Morbegno 1588-1593;
Benedetto da Casale Berbenno 1589;
Alessio Giuseppe SO1 1617-1620;
Andreoscia Samuele Mello 1617-1620;
Antignatensis Paolo Dubino 1558-1576;
Ant. Da Macerata Dubino 1589-1596;
Averrario Gabriele SO2 1582-1586;
Note e documenti 349
Betscha Giuseppe Sondrio1 1607-1616;
Blech Alessandro Traona 1616-1620;
Calandrino Gio. Batt. Dubino 1604-1620;
Camillo Renato Traona 1545-1546;
Casella Tommaso Villa Di Chiavenna 1588-1620;
Cellario Francesco Morbegno 1558-1568;
Chiesa Bartolomeo Chiesa V. 1580-1606;
Chiesa Giovanni Chiesa V. 1580-1606;
Clauschrist Bald. Berbenno 1612-1618;
Conradi Alfonso SO1 1555-1580;
Danzio Giov. Pietro Teglio 1601-1620;
Donato Luca Traona 1596-1615;
Fracatius Luigi SO2 1576-1593;
Gaddi Paolo Teglio 1555-1572;
Grass Giovanni Mello 1602-1606;
Janutt Ballestin Ulr. Mello 1608-1617;
Jenatsch Giorgio Berbenno 1618-1620;
Kesel Nicola SO2 1593-1616;
Mainardi Agostino Chiavenna 1541-1563;
Marchion Giov. Ant. Villa Di Chiavenna 1582-1585;
Marlianici Bart. SO2 1616-1620;
Marra Giovanni Prata 1594-1618;
Martinengo A. Traona 1593-1596;
Martinengo Celso Tirano 1551-1552;
Martinengo Ulisse Morbegno 1568-1569;
Martino Giovanni Prata 1564-1594;
Nuot Andreola Giov. Morbegno 1596-1600;
Paravicini Gio. Bat. Berbenno 1605-1607;
Paravicini Raffaele Traona 1588-1589;
Paravicini Gio. And. Caspano 1588-1589;
Paravicini Muzio Caspano 1547-1558;
Piacentino Cesare Traona 1589;
Rascher Giov. Dom. Grosotto 1589-1598;
Resta Giosuè Caspano 1598-1615;
Note e documenti350
Riva Angelo Caspano 1558;
Segni Sebastiano Tirano 1581-1593;
Tarracchia Seb. Berbenno 1572-1593;
Thei Giov. Batt. Morbegno 1585-1587;
Tifernas Gerolamo Mese 1561-1572;
Torriani Girolamo Villa Di Chiavenna 1579-1582;
Toutsch Bonaventura Morbegno 1615-1618;
Vedrosi Wolfgang Grosotto 1609-1615;
Zanchi Gerolamo Chiavenna 1563-1567;
Zonca Guido Mese 1572-1579;
Dai movimenti analizzati sembra evidente che le comunità riformate ten-dono a chiamare i pastori che risiedono nelle vicinanze o in comunità vicine.Tranne che in qualche raro caso in cui si chiamano pastori residenti dall’altraparte della valle, quasi sempre si ricorre al sistema di reclutamento più ovvio,quello cioè basato sulla vicinanza territoriale (la cosiddetta “linea di valle”) esugli interessi delle famiglie (25).
Pastore Luogo Permanenza Pastore Luogo Permanenza
Martino Prata 30 Calandrino SO1 17
Chiesa Bartolomeo Chiesa V. 26 Pozzi Tirano 17
Chiesa Giovanni Chiesa V. 26 Fracatius SO2 17
Conradi SO1 25 Andreoscia Tirano 15
Kesel SO2 23 Marra Prata 14
Mei Chiavenna 22 Alba Chiesa V. 12
Mainardi Chiavenna 21 Basso Tirano 12
(25) È il caso proprio di Michele Mortellito richiamato a Piuro dopo la triennale parentesidi Marco Antonio Alba proprio per i contatti stretti con i Vertemate Franchi e la comunità diScilano. Stessa situazione si verifica per Scipione Calandrino, a distanza di vent’anni richiamatoa Sondrio capoluogo dopo la parentesi tellina proprio per i buoni rapporti stretti con le comu-nità riformate del capoluogo nella sua prima residenza come pastore delle contrade di Mossinie Aschieri. Altrettanto può dirsi per Agostino Pozzi, i cui contatti con il notaio sondrieseMartino Pozzi e le famiglie più in vista della città, gli hanno sicuramente permesso di accederea comunità piuttosto ricche e ben poste socialmente quali potevano essere non tanto i rifor-mati di Berbenno quanto quelli di Tirano (come predecessore del secondo mandato di Giulioda Milano) e Traona. In entrambi i casi, la sua permanenza è stata molto lunga: diciassette annia Tirano e dieci a Traona, mentre Silvio Bartolomeo, per esempio, pur occupando cariche pasto-rali in centri importanti come Sondrio e Teglio, non conserva la stessa longevità professionale.
Note e documenti 351
Tarracchia Berbenno 21 Casella Vil. di Ch.12
Lentolo Chiavenna 19 Paravicini M. Caspano 11
Danzio Teglio 19 Silvio Teglio 8
Donato Traona 19 Mortellito Piuro 7
Janutt Ballestin Mello 19 A. da Macerata Dubino 7
Antignatensis Dubino 18
Sorprende che il più longevo dal punto di vista della permanenza in ser-vizio pastorale attivo sia Giovanni Martino, ininterrottamente pastore dellacomunità di Prata per trent’anni. Dietro di lui abbiamo solo Giovanni eBartolomeo Chiesa, espressione di una delle famiglie più in vista della valle epastori riformati in Valmalenco per ventisei anni ciascuno. Anche AlfonsoConradi mantiene una posizione preminente con il suo quarto di secolo diattività a Sondrio, e poi Mei, Lentolo e Mainardi a Chiavenna dimostrano chequeste comunità erano forti proprio perché lunga e durevole era la presenzadi pastori addestrati e ben addentro alle cose teologiche. Spiccano anche lelunghe permanenze di Calandrino a Sondrio, quella di Pozzi a Tirano e quelladi Muzio Paravicini a Caspano. Resta da sottolineare che dei 26 pastori presiin considerazione, 13 risiedono nel Terziere Inferiore e nel chiavennasco, 10nel Terziere di Mezzo e 3 nel Terziere Superiore.
Nel primo gruppo preponderante è la residenza chiavennasca (8 dellaValchiavenna contro 5 della quadra di Traona e nessuno di Morbegno), nelsecondo gruppo ben 7 sono di Sondrio e della Valmalenco, 2 soltanto di Teglioe 1 di Berbenno e nel terzo tutti di Tirano. Questo dimostra che la distri-buzione delle cariche pastorali, appunto, non dipendeva solo (o in gran parte)dai bisogni religiosi delle comunità rimaste senza pastore, ma dagli equilibrie scelte delle comunità più influenti. In altre parole, i rapporti di forza cheregolavano gli equilibri economici, sociali e politici tra i centri delle valli, dopol’arrivo della riforma, non sono mutati, ma si sono adeguati ai nuovi stan-dard politico-economici instaurando sistemi di gestione e controllo che nonsolo non differivano dai precedenti usi, ma anzi si erano rafforzati ulterior-mente in chiave religiosa e socio-economica. Così Agostino Pozzi si spostada Berbenno a Tirano e poi a Traona andando a occupare a Tirano il postolasciato nel 1559 da Francesco Negri (la sede è così occupata di nuovo daun «ortodosso» dopo due anni di vacanza) e a Traona dove inaugura la seriedei pastori locali; fino ad allora, infatti, stando al quadro cronologico di cuisopra, non si rintracciano curatele di anime riformate se non a Mello eCaspano.
Note e documenti352
Scipione Lentolo si sposta dalle frazioni sopra Sondrio a Chiavenna cer-tamente grazie ai buoni risultati ottenuti nel rafforzare le comunità di Aschieri,Ronchi e Mossini. Gli succede a Chiavenna Ottaviano Mei proveniente daTeglio, altro gruppo al centro d’interscambi continui con i confratelli di Traona,Morbegno e la stessa Chiavenna. A Teglio Mei aveva trovato una comunitàrafforzata e ben organizzata intorno al nucleo dell’Ecclesia cremonensis e alcarisma di Paolo Gaddi, perno della penetrazione riformata nel Terziere diMezzo. Analoga situazione la riscontriamo a Morbegno e Caspano per il magi-stero di Raffaele Paravicini, Silvio Bartolomeo e Antonio Andreoscia il quale,succeduto a Scipione Calandrino proprio in quel di Morbegno, passa nel 1593a Tirano a sostituire Sebastiano Segni, probabilmente lo stesso che fa da testein un contratto di compravendita di terreni a Baruffini, una contrada nei din-torni di Tirano, cui presenziano anche lo stesso Antonio Andreoscia e altriTiranesi. Ultimo caso è quello rappresentato dalla successione dei pastori aMello e Traona dove, quando non si sono unificate le chiese per brevi periodi,si assiste a veri e propri passaggi da una comunità all’altra (26).
(26) Soprattutto dopo il 1572 le comunità riformate di Mello e Traona decidono di ser-virsi degli stessi capi, sia per una maggiore sicurezza organizzativa che per la temporanea scar-sità di predicanti. Così Giacomo Chiesa nel biennio 1584-1585, pur essendo reggente a Mello,prende sotto la sua protezione anche Dubino e lo stesso si registra a proposito del servizio diGiulio da Verona che nel 1592 regge insieme Traona e Mello. Costui succede a Traona a CesareGaffori, a sua volta rettore, dal 1588 al 1591, proprio delle due comunità insieme. Prima ancora,proprio a partire dal 1572, Lorenzo Gaio da Soncino si alterna con Giacomo Chiesa nel gui-dare i riformati di Mello, i quali, dopo Giulio da Verona, sceglieranno due non Italiani: JohannGrass, che reggerà la comunità tra il 1602 e il 1606 e Ulrich Janutt Ballestin che prenderàpossesso della comunità nel 1608 tenendola fino al 1617 (gli succederà il poschiavino AndreosciaSamuele figlio di Antonio già pastore a Tirano fino al 1608). Come Mello, anche Traona sidoterà di pastori protestanti tra 1616 e 1620 scegliendo Alessandro Blech, probabilmenteposchiavino anche lui. Sono dunque i rapporti interpersonali e sociali (oltre che le convenienzesocio-economiche e la rete di protezioni costruite tra persone provenienti dalle stesse zone diorigine) a determinare la scelta e la destinazione dei pastori, fenomeno accentuatosi dopo il1572-1575, periodo in cui cominciano a giungere in Valtellina sacerdoti formatisi al CollegioElvetico, più attenti alla predicazione e alla rievangelizzazione. Questo ha spinto le comunitàriformate e i relativi gruppi dirigenti a chiamare personale in grado di discutere teologicamentee controbattere in dispute pubbliche i teologi cattolici, ecco perché nelle comunità più fortie anche più a rischio di scontro con la fazione controriformista, giungono pastori di prove-nienza svizzera o in genere non italiana. Quasi sicuramente, costoro davano maggiori garan-zie di solidità dottrinale e fedeltà alla causa riformata degli Italiani, nel frattempo ormai quasitutti trasferitisi dalla Valtellina a Ginevra o a Basilea. Non dimentichiamo, infatti, che gli esulireligionis causa arrivati nelle valli alla metà degli anni Quaranta sono ora alla seconda gene-razione e già da almeno un decennio (intorno agli anni Sessanta del Cinquecento) hanno tra-sferito beni e famiglie in Svizzera, pur mantenendo contatti economici e proprietà soprattuttoa Chiavenna e nel suo contado.
Note e documenti 353
11. Ben 69 pastori (su 93) in soli cento anni sono dislocati in un territo-rio piuttosto ristretto, comprendente quasi sempre il solo Terziere di Mezzo.Infatti, se si calcolano le presenze in chiave esclusivamente topografica, abbiamoun quadro così distribuito: Terziere inferiore 39, di mezzo 24, Superiore 11,Chiavenna 19; solo il Terziere Inferiore e Chiavenna raccolgono il 62.36% ditutti i predicatori disponibili nelle valli. Se li raggruppiamo per aree notiamoaltri risultati, più interessanti dei precedenti se confrontati con la parallela dis-locazione dei sacerdoti data da Carcano.
Pastori Sacerdoti
Area 1 Morbegno 3 18
Area 10 Bormio 0 13
Area 11 Mazzo 2 13
Area 15 Caspano 10 12
Area 3 Sondrio 5 10
Area 2 Berbenno 4 8
Area 6 Ponte in Valtellina 0 8
Area 13 Teglio 1 5
Area 4 Valmalenco 2 4
Area 8 Chiuro 0 4
Area 9 Poschiavo 0 4
Area 14 Ardenno 0 4
Area 5 Montagna 0 3
Area 7 Piateda 0 3
Area 12 Tirano 2 3
Area 16 Chiavenna e contado 5 0
totale 34 112
Dal prospetto, fatta salva la mancanza di dati relativi ai sacerdoti chia-vennaschi e ai pastori di Bormio, Chiuro, Poschiavo, Ardenno, Montagna,Piateda e Ponte, è evidente che i vescovi comaschi avevano pienamente ragionea chiedere ai parroci valtellinesi più attenzione nel controllo dei riformati eancora più salda cultura teologica nella cura delle anime cattoliche esortan-doli ad abbandonare i comportamenti controproducenti e dottrinariamente scon-venienti. Solo Caspano, tra tutti, registra un numero quasi uguale di predi-canti e sacerdoti: bisogna tener conto però del fatto che tutta la zona avevafama di essere totalmente intrisa di riformati, mentre invece, come abbiamovisto, non superavano il 3.95% dei più di 7000 residenti.
Note e documenti354
Il diverso numero dei pastori e quello dei sacerdoti, tra 1600 e 1624, dimo-stra che fu mal gestita proprio la presenza cattolica sul territorio. Infatti, ben66 sacerdoti (più del 50% dei padri censiti da monsignor Carcano) sono con-centrati in sole cinque zone (Morbegno, Sondrio, Bormio, pieve di Mazzo,Caspano); ora, se calcoliamo la popolazione di quelle sole aree, abbiamo 41952anime e 690 eterodossi: un sacerdote ogni 10 riformati circa e uno ogni 625cattolici (che in totale sono 41262). Analoga situazione si verifica nella pievedi Mazzo, dove avendo solo 20 riformati a Grosotto abbiamo 13 preti (unoogni 754 cattolici) e nel territorio di Morbegno dove il caso è più eclatantepoiché, a fronte di soli 50 riformati, abbiamo 18 sacerdoti (uno ogni tre) chedevono servire 9819 anime (uno ogni 545 cattolici). A Tirano di fronte adAntonio Andreoscia e Antonio Basso (uno ogni 100 anime eterodosse, più omeno la media dell’intera valle), abbiamo solo 3 sacerdoti: uno ogni 67 rifor-mati e uno ogni 2318 cattolici, un numero incontrollabile e soprattutto diffi-cilmente gestibile con oculatezza (27).
La presenza di chiese di proprietà della comunità è determinante perchépermette di individuare anche i passaggi dei singoli pastori e la loro ricorrentepresenza presso una stessa comunità. Così a Morbegno ricorre ben 4 volte ilpastore Mortellito, mentre in altri luoghi la permanenza è minore, fattoredovuto alla capacità di difendere e conservare il territorio attraverso proseli-tismo e dispute e alla necessità di avere un luogo sicuro e visibile. Infatti, lad-dove le chiese sono state divise a metà tra le due comunità o laddove più stri-denti erano i contatti tra le parti, maggiore è il ricambio di pastori, la cuiprovenienza, peraltro, è in gran parte italica, con 16 lombardi, 9 valtellinesi,5 piemontesi, 5 toscani, 2 veneti, 2 emiliano-romagnoli, 2 campani, 1 calabrese;
(27) Solo Sondrio e Caspano mantengono un numero adeguato di pastori in percentualepiuttosto alta rispetto alla popolazione riformata, segno evidente di una volontà evangelizza-trice forte e ben organizzata. Per questo non devono meravigliare gli 11 pastori presenti in soli24 anni nel territorio del capoluogo e delle sue vicinanze, né deve meravigliare la superioritànumerica dei pastori a Caspano rispetto ai sacerdoti dello stesso luogo. È evidente che la dis-locazione dei sacerdoti né favoriva il mantenimento di posizioni cattoliche in luoghi eterodossi,né permetteva di gestire adeguatamente l’inquisizione e il neoproselitismo di gesuiti e sacerdotiusciti dal Collegio Elvetico. Anzi, proprio nella pieve di Mazzo stupisce la numerosa presenzadi prevosti, sacerdoti e altre figure, in un territorio dove il numero dei riformati non supera i4 fuochi, fatto certamente dovuto al sistema delle rendite provenienti dalle diverse cappelle,chiese e pievi. Proprio tra gli atti della pieve di Mazzo si registra, infatti, un numero altissimodi cause e ricorsi al vescovo di Como per l’assegnazione di ogni singola dipendenza che dimo-stra l’appetibilità delle prebende previste, in barba a ogni cura animarum (si veda Archivi StoriciEcclesiastici di Grosio, Grosotto, Mazzo, a cura di G. Antonioli, cit.).
Note e documenti 355
8 sono svizzeri, 21 sono i pastori di cui non si è riusciti a risalire alla prove-nienza e 5 di cui si ipotizza la provenienza. Per molti di loro è stato arduoricostruirne la provenienza data la scarsità di documenti. Di fronte a 25 lom-bardi, qualora si dovesse in futuro confermare la provenienza svizzera ancheper i 4 probabili, il gruppo più numeroso sarebbe proprio quello transalpino.In totale gli Svizzeri sarebbero 38 pastori su 76 (il 50%) mentre il primo gruppotra gli Italiani sarebbe quello di provenienza toscana.
12. Ulteriore dato di analisi storica è costituito dai documenti originaliconservati nell’Archivio Paribelli nel quale una gran parte è costituita propriodagli autografi del maggior protagonista della rivolta del 1620 e cioè GianGiacomo Paribelli, capo della fazione cattolica, successivamente ambasciatoredella causa valtellinese presso le diete di Lucerna, presso la corte spagnola epapale alfine di redimere a favore dei rivoltosi la questione valtellinese ricon-ducendola in seno alla Spagna, staccandola dalle leghe svizzere protestanti ese necessario anche riunendola agli Svizzeri cattolici come quattordicesimo can-tone. Il giureconsulto valtellinese ci ha lasciato documenti importantissimi, rac-colti in diversi quaderni (tutti in formato cm 16 x 21) e narranti le vicendestoriche e gli equilibri politici cui ha partecipato in prima persona come legatodesignato dal governo rivoluzionario auto-designatosi all’indomani del SacroMacello.
I. Acta Legationis Hispanicae, diario della legazione presso il Re di Spagna,narra gli avvenimenti accaduti tra il 23 agosto e il 30 novembre 1622;
II. Acta Legationis Mediolanensis, narra i fatti svoltisi tra il 17 dicembre 1622e il 26 marzo 1623;
III. Cronaca 1620-1622, il manoscritto, mutilo all’inizio e senza titolo, riguardagli avvenimenti accaduti nel triennio 1620-1622 (la titolazione è nostra);
IV. Iter Mediolanense ad Rheticam tractationem; è il diario dettagliato degliavvenimenti accaduti tra il 28 marzo e la fine di maggio del 1630. Purnarrando separatamente gli eventi accaduti nella primavera del 1630.
V. Iter Romanum, dal 12 marzo 1625 al 20 marzo 1626;VI. Libellus rerum quotidianorum inceptus a me Jo. Jacobo Paribello I.V.D., anno
Domini 1628 in mense septembris, diario personale del condottiero val-tellinese comprendente i fatti dal 04/09/1628 al maggio 1635 con un’am-pia lacuna dal 09 luglio 1630 al 01 settembre 1631.
Ai manoscritti qui indicati si sommano le lettere (anch’esse conservatenell’Archivio Paribelli di Albosaggia) che lo stesso Paribelli ha scritto lungotutto il periodo 1620-1635 a diversi personaggi coinvolti a più livelli nella que-
Note e documenti356
stione valtellinese. Tutti i documenti qui citati sono stati parzialmente pub-blicati (ma senza un’analisi precisa dei diversi fili che li collegavano) da SandroMassera in una monografia sull’avvocato valtellinese edita ormai da più di unquarantennio (28). Ora, sulla scorta di nuove e più approfondite e miratericerche, ne diamo una nuova lettura.
Ciò che subito risalta in maniera interessante dalla lettura dei documentiparibelliani, è proprio la posizione politica da lui espressa all’indomani del-l’estate 1620. Ci riferiamo in particolare al tentativo di mascherare sotto la vestereligiosa quelli che furono essenzialmente moti filo-spagnoli, giustificati dallapresenza di agenti spagnoli tra le fila dei cattolici e dall’interesse geopoliticoche la stessa Valtellina rivestiva come territorio di transito. Le stesse motiva-zioni addotte da Paribelli suonano come iniziale e strategica opposizione a quelleche sembravano mosse esclusivamente politiche e non religiose. Infatti, già inun documento manoscritto risalente proprio all’indomani del Sacro Macello,l’avvocato valtellinese, ricordando i motivi che spinsero la fazione cattolica adifendersi, segnala la supposta prossima presenza sul territorio di un grossocontingente olandese, autorizzata dai Grigioni e sollecitata dai pastori calvi-nisti dopo il patto firmato il 31 dicembre 1619 tra Venezia e le Provincie Unite.
[...] Queste cose avvennero nel tempo che il conte Palatino [FedericoV Elettore Paltino] co’ suoi adherenti haveva ridotto in tanta angustia l’im-peratore che pareva che fosse per restare libero padrone di tutto l’imperioe, disdegnando egli di far passaggio in Italia, trattò con Grigioni stretta ami-citia. Nel medesmo tempo si concluse la lega fra Venetia et Stati d’Olandaper quale, sendo passato l’ambasciatore de gli Olandesi per ‘l paese de’Grigioni et Valtelina, considerata l’opportunità di quel passo, trattò co’ prin-cipali Grigioni, capi dela fattione vinitiana, di mettere grosso presidio di sol-datesca olandese nella Valtelina a’ confini dello stato di Milano, quale pre-sidio doveva mantenersi a comuni spese di Venetiani et Olandesi e di tuttal’unione del Palatino. Il fin (per quanto s’è cavato da lettere trovate nellacancelleria anhaltina e da altre scritture ritrovate presso gl’heretici valtelini,uno de’ quali, sendo in propria persona intervenuto a detti trattati, fatto dopoqueste rivolutioni cattolico ha dato intiero conto di tutte le particolarità) fuprima per chiuder a Spagna ogni via di mandar soccorsi all’Imperatore e dicorrispondersi gli aiuti di casa ar intiero compimento al loro antico pensierod’estinguer affatto la religione catholica e i suoi professori in Valtelina e percolorire la loro malvagità pigliando il pretesto di sospetto et gelosia di stato,
(28) S. MASSERA, Un diplomatico valtellinese del secolo XVII: Gian Giacomo Paribelli (1588-1635), Sondrio, Società Storica Valtellinese, 1970, pp. 119-243.
Note e documenti 357
al che tiravano tutte le diligenze et officij tatti da’ cattolici per riparo de’pregiudicij della religione, formati varij processi ne’ quali havevano perinserto tutto d’Austria d’Italia in Germania e vice versa; secondo per tenersila porta aperta da poter, superate che fossero le oppositioni in Germania,far passare l’esercito dell’unione palatina in Italia et haver di qua da montila Valtelina per far ivi la massa de le genti d’armi. Li predicanti, consape-voli di tutti questi trattati e disegni, pensorno di esser questa l’occasione oppor-tuna di dal paese. E come di già molti de’ principali Valtelini, considerandoli gravi pericoli che dalle machinationi continue de’ predicanti si vedevanodil clero e la nobiltà, pensando ch’estinti questi, la plebe priva de’ capi sisarebbe ridutta ad abbracciar la loro religione, stabilito havevano con l’in-troduttione di detto presidio, di repartirlo in aloggiamento per le case de’processati et in giorno determinato farli tagliar tutti a pezzi, quasi che pervia ordinaria di giiustitia non si potesse proceder contro di tanti per il peri-colo d’una general sollevatione. Favorì Dio che questo crudel pensiero daalcuni calvinisti Grigioni, a’ quali non soffriva l’animo d’acconsentir ad unatanta strage, fosse palesato a suoi amici particolari Valtelini acciò almeno essifugissero il pericolo, fra quali io ero di pensierio per ciò di partir soprastare,erano molto tempo inanti andati pensando alli rimedij, fatti hora consape-voli del sudetto aviso, come negl’estremi pericoli si suol appigliarsi ad estremirisolutioni, non hebbero difficoltà di tirar ciascuno di loro li suoi più con-fidenti in parere di tentar con l’armi l’ultimo sforzo per liberarsi dal pre-sente pericolo et insieme dall’heresia et tirannia de’ Grigioni. E per ciò, pre-vedendo pochi giorni prima che il presidio olandese doveva entrar nella Valle,tagliorno a pezzi tutti li heretici et Grigioni che si trovavano in essa (29).
Dalle parole del rivoluzionario valtellinese emergono i punti focali dellarivolta: liberarsi della Riforma, della tirannia grigione e scongiurare ogni peri-colo d’invasione, trame che però non avevano ragione di essere perché nonc’erano le condizioni che potevano favorire un tale quadro politico, date lastretta trama di parentele, i profitti economici e i rapporti di consanguineità
(29) Archivio Paribelli (AP) – Cronaca 1620-1622, cc. 1-10. La versione di Gian GiacomoParibelli non trova però riscontro in altre cronache coeve. Infatti, già Fortunato Sprecher(Historia Raetica, p. 110) alla fine del Seicento, sia pure non negando i contatti diretti tra l’u-nione e i Grigioni (cit., p. 159) aveva considerato poco più che invenzioni di parte cattolica lapossibilità che un contingente riformato entrasse stabilmente in Valtellina con la complicità diVenezia. È pur vero, però, che contatti tra l’unione evangelica tedesca e il Beitag di Coira perpermettere che un proprio contingente militare potesse stanziarsi nelle valli erano stati avan-zati davvero (il 10 giugno 1620); anzi, stando ai documenti pubblicati, fu anche inoltrata larichiesta ai comuni retici a esprimersi in proposito (A. GIUSSANI, La rivoluzione valtellinese del19 luglio 1620, Milano, Giuffrè, 1940, p. 166, doc. VI).
Note e documenti358
esistenti tra le due fazioni. Il fattore religioso, allora, non era minimamentedeterminante, né particolarmente sentito. Anzi, è probabile, viste le numerosetestimonianze in proposito, che le personalità più avvertite nei due campiabbiano compreso i risvolti più pericolosi, se avesse dovuto manifestarsi, comepoi in effetti accadde, un qualunque atto criminale contro la comunità rifor-mata.
Liberarsi della tirannia, parimenti, sempre ammettendo che si trattasse anchedi questo, per gli stessi capi della rivolta era un problema non da poco, vistoche molti di loro erano parte attiva della stessa burocrazia svizzera (sia pureoccupando posti non di primissimo piano): non a caso, instaurando il nuovoregime, essi confermeranno le stesse strutture amministrative territoriali dimo-strando così che la rivolta fu essenzialmente solo una vendetta per i fatti diThusis e un tentativo, riuscito, di riprendersi prebende e privilegi antichi conil consenso di una plebe adusa «alla buona disciplina», per la gran parte anal-fabeta e ridotta in forme di servitù in gran parte ancora feudali. In questocaso anzi, «li professori» e le famiglie cattoliche più importanti formano unnuovo tessuto connettivo proprio per il ripristino di forme politiche del governoterritoriale precedenti il 1512. Sull’invasione presunta invece, tutto si basa suopportune informazioni fatte filtrare da Casati e Della Torre con il preciso obiet-tivo di creare una situazione difensiva che giustificasse la rivolta una volta chefosse scoppiata.
Al di là delle giustificate paure cattoliche, nate a seguito della repressionee dei processi del 1618, la cronaca paribelliana ci offre un punto di vista inte-ressante sul clima di odio e sospetto che regnava nelle valli dopo le sentenzedi Thusis, soprattutto se confrontata con i resoconti di Cantù e Romegialli (30).
(30) «[...] Anche in Valtellina si ha per costante che i Riformati si fossero giurati a fare unvespro siciliano, e ridurre alla nuova religione la valle, non lasciando razza né generazione deiCattolici. Questo fatto potrebbe, se non giustificare, scusare almeno l’estremità dei Valtellinesi:ma è egli altrettanto vero, quanto asseverantemente ripetuto? Il Ballarini, il Tuana e altri scrit-tori cattolici lo affermano; e che il governatore di Sondrio si fosse lasciato sfuggire di bocca,non andrebbe molto che sarebbero tutti di una fede. Nelle suppliche sporte dal clero e dalpopolo di Valtellina al re cattolico e al cristianissimo si asserisce questa congiura. Possibile ardis-sero mentire così sfrontatamente in faccia a quelle corone? Parrebbe anzi che unissero alle sup-pliche l’atto di quella congiura. Ma perché, mentre si conservarono le suppliche perì tal docu-mento? Come, fra tanti fasci di carte, che ad altri e a me non parve fatica rovistare, questa nonsi rinvenne? Ben si ragiona di qualche lettera, e il Bajacca asserisce nel 1619 esserne caduta inmano dei Cattolici una, di non si sa qual predicante, che si leggeva “Dio vi salvi, fratelli. Nonpotendo la patria conservarsi in altra guisa che col levare di mezzo i dissidenti, si conchiuseche vengano dalle fondamenta tolte la città e il vescovo di Coira, poi la Rezia tutta per riguardoai papisti”. Ne recitano pure un’altra lunga latina, che suona in questo tenore: “Fratelli, il dado
Note e documenti 359
Dopo i fatti del 19-21 luglio 1620, proprio Gian Giacomo Paribelli funominato dal consiglio reggente ambasciatore presso i cantoni cattolici per illu-strare la posizione del popolo valtellinese e le motivazioni della rivolta controi Grigioni, poiché, già per il 3 agosto era stata indetta la dieta generale deitredici cantoni su richiesta di Berna e Zurigo (spalleggiate da Venezia) col finedi chiamare a raccolta le bandiere svizzere in aiuto delle Tre Leghe. Il 29 luglioParibelli parte a cavallo per Baden, dove arriverà a ridosso del 3 agosto. Uncosì lungo tempo di viaggio è giustificato dal fatto che prima si era recato aSorico per incontrare monsignor Giulio della Torre – da cui riceve una let-tera di presentazione per l’ambasciatore spagnolo a Lucerna Alfonso Casati –e poi a Castione di Bellinzona, per incontrare alcuni fuoriusciti di Mesolcinae Val Calanca ai quali aveva consegnato un messaggio per i comuni cattolicidella Lega Grigia scritto da Robustelli (31).
è gittato... usiamo prestezza: non diamo agli avversarii tempo a respirare... I papisti non si devonoridurre alla disperazione se non si possono insieme prendere e uccidere, poiché spesso la dispe-razione è causa di vittoria. Mentre dunque il ferro è caldo, battiamo: di poi l’occasione saràcalva: moviam loro liti, molestiamoli citando, disputando, mormorando: calunniamoli, finchélice quanto piace; quelli d’alto ingegno irretiamo colle astuzie: allontaniamo così qualunque peri-colo possa alle cervici nostre sovrastare; tronchiamo le più alte: prima il vescovo, gli abati, iprelati, i ministri avversi prendiamo, poi gli ispanizzanti; rissiamo gli altri fra loro affinché siconsumino: questi cacciamo, quelli abbattiamo: se non taglieremo, saremo tagliati: oppressi quelli,nulla è a temere... E ch’io lo dica in una parola: coll’esilio e la morte di 300 uomini saremosicuri”» (C. CANTÙ, Il Sacro Macello di Valtellina, Milano, Sonzogno, 1885, p. 35; G. ROMEGIALLI,Storia della Valtellina e della già contee di Bormio e Chiavenna, cit., pp. 205-314). Sulla que-stione dei rapporti tra Stato veneziano, Olandesi e Spagnoli, cfr. G. N. PARKER, The army ofFlanders and the Spanish road (1567-1659), Cambridge, Cambridge University Press, 1972, men-tre, per ciò che concerne la rete dei contatti esistenti tra le chiese calviniste svizzere e italiane,si veda O. P. GRELL, Brethen in Christ. A Calvinist network in reformation Europe, Cambridge,Cambridge University Press, 2012.
(31) «L’agente valtelino in passando vicino alla valle Mesolcina, abboccatosi con alcuni prin-cipali cattolici della Lega Grisa, fece loro conoscere l’interesse comune che dalla mossa de’ Valteliniera per risultar a tutti i cattolici, tanto delle leghe quanto della Valle, e restò perciò con essiin concerto che per la causa comune tutti unitamente prendessero l’armi contra gl’heretici. Ondeincontinente si fecero fermare 2000 di loro, quali di già marciavano per unirsi con gli stessiheretici a danno de’ Valtelini, e ritornati adietro presero posto nella terra di Jant, loco murato,benché heretico, et occuporno altri passi stretti co’ quali potessero impedir l’ingresso a’ nemicinelle valli loro» (AP – Cronaca 1620-1622, cc. 2v-3r). Paribelli, tornò da Lucerna il 7 settem-bre e pochi giorni dopo la battaglia di Tirano, stando alla cronaca di Sprecher, suo fratelloOrazio, probabilmente per vendetta, «sclopetto transverberavit» (Historia raetica, p. 172); il Libermortuorum della parrocchia di Albosaggia riporta soltanto la data di sepoltura senza ulterioriaggiunte («D.nus Horatius filius exc. D.ni Laurentii Paribelli sepultus fuit die 17 septembris1620», cit. in S. MASSERA, Un diplomatico valtellinese del secolo XVII: Gian Giacomo Paribelli(1588-1635), cit., p. 21).
Note e documenti360
In questo periodo diversi progetti sul destino politico delle valli si acca-vallano l’un l’altro senza che vi siano chiari intendimenti nel procedere in unsenso piuttosto che in un altro. Sembrava prendere il sopravvento sull’idea,certamente più abbordabile, di un’aggregazione alla Lombardia spagnola,soprattutto la possibilità che la Valtellina diventasse uno Stato vassallo del pon-tefice, così da togliere di mezzo in un sol colpo le mire di Venezia, dell’Impero,della Spagna e dei Francesi (oltre che scongiurare ogni ritorno ai Grigioni).A sostegno di tale ipotesi c’erano gli indubbi vantaggi economici e la difesaconsistente dei propri possedimenti. In tal senso la pensavano anche GianGiacomo Paribelli e diversi rappresentanti delle comunità vallive, le quali, inun documento risalente al settembre 1620 dichiarano la propria volontà di voleressere suddite della Spagna (32).
Le comunità di Sondrio, Postalesio, Montagna e Albosaggia, stando aquanto citato nel documento, già pochi mesi dopo il Sacro Macello si schie-rano apertamente per la soluzione spagnola. È evidente che quanto riportatoè una forzatura probabilmente orchestrata dallo stesso partito filo-spagnolo,poiché tra i firmatari figurano Lorenzo Paribelli, padre di Gian Giacomo etra i capi della rivolta del 20 luglio, e Luigi Lavizzari decano di Sondrio, men-tre poco chiara è la presenza del decano di Postalesio, comunità non facenteparte del territorio del capoluogo perché parte di Berbenno.
13. Un altro punto da sviluppare, all’interno delle diverse linee proposi-tive individuate per la storia delle valli nel periodo da noi studiato, è costi-tuito dal fondo degli atti notarili conservati nell’Archivio di Stato di Sondrio
(32) «Noi infrascritti agenti, decani et altri in nome delle infrascritte Comunità con le qualihabbiamo a pieno partecipato, di loro ordine e commissione protestiamo et si dichiariamo dinon voler altri superiori temporali che Sua Maestà Catholica re di Spagna, con quelle capitu-lationi et privilegi che si degnerà per gratia sua concederci con partecipatione delli agenti divalle d’esser sopra deputati, a fin che il paese conosca il grande avantaggio che ha da sentirea differentia delli tempi passati. Io Alvisio Lavizaro decano della comunità di Sondrio affermoet protesto come di sopra et per fede mi son sottoscritto et sigillato con il proprio sigillo[...]Io Gio. Batta. S. Benedetto per comissione e a nome de messer Gian Zola decano dellaComunità di Montagna per non saper lui scrivere, affermo et protesto come di sopra et in fedemi son sottoscritto et sigillato con il proprio sigillo. [...] Io Lorenzo Paribello dottor di leggedi comissione di messer Battista Motta decano d’Albosaggia et d’espresso ordine di detta comu-nità et della Comunità del Faedo con le quali ho a pieno partecipato affermo come di soprae per fede mi son sottoscritto et col proprio sigillo confermato. [...] Io Nicolò Artenza dePostalesio in nome di ser Stefano de [...] decano della comunità de Postalesio afermo quantodi sopra si contiene et per fede mi sono sottoscritto» (AP – Cronaca 1620-1622, c. 5r).
Note e documenti 361
(ASSo), ricco e tuttora non completamente esplorato. Alessandro Pastore avevacitato nei suoi lavori un buon numero di testimonianze che oggi però, a tren-t’anni dalla loro pubblicazione, per quanto ancora importanti, sono comun-que insufficienti, soprattutto perché sono cambiati gli orizzonti storici analiz-zati; diversi episodi hanno avuto letture differenti e completamente nuove, glistessi studi sui personaggi e sulle questioni fondanti dell’epoca sono cambiatidando altre notizie. Ne sia esempio per tutti la questione relativa ai processiper stregoneria del 1523 svoltisi a Sondrio per cura dell’inquisitore vicentinoVincenzo Scrofeo, finora intesi come processi stregoneschi e invece oggi riletticontra hæreticos (33).
Una prima ricognizione degli atti notarili conservati in ASSo non può nonprescindere da quelli stipulati dal notaio Martino Pozzi, estensore degli attiriguardanti Francesco Negri (34) e l’Ecclesia cremonesis di Teglio (35). Il notaio,anch’egli quasi sicuramente riformato, parente del pastore Agostino Pozzi(attivo a Berbenno tra il 1556 e il 1561), sembra circondarsi quasi sempre deglistessi testimoni, tra i quali spiccano i nomi di diversi appartenenti al gruppodei cremonesi exules religionis causa stabilitisi a Teglio dopo il 1550, dai fra-telli Fogliata (Giovanni Niccolò e Francesco, parte del gruppo dei ventidueprocessati a Cremona per eresia) a Giuseppe Fossa (in casa del quale si eranorifugiati i due benedettini mantovani all’origine dell’inchiesta cremonese), daGiacomo Antonio Baruffini ad Andrea Roncadello (36).
I. Vol. 763, notaio Giovanni Andrea Mascaranico: il 02/01/1539 fitta a F.Negri una casa in Chiavenna in qualità di «scolarium rector in terraClavenne» (c. 1r). Nella miscellanea di atti notarili firmati da Mascaranicocompaiono altri atti riguardanti Negri, per fitti e pagamenti contratti conChiavennaschi, per l’istruzione di alcuni figli della nobile famiglia chia-vennasca dei Pestalozzi o per interventi come mundualdo (37).
(33) F. PALAZZI TRIVELLI, Sentenze e processi, cit., pp. 175-226.(34) G. GIORGETTA, Francesco Negri a Chiavenna. Note critiche, in «Clavenna», XIV, 1975,
pp. 38-46.(35) A. PASTORE, Nella Valtellina del tardo Cinquecento: fede, cultura, società, cit.(36) S. CAPONNETTO, La riforma protestante nell’Italia del Cinquecento, Torino, Claudiana,
1992, pp. 273-274. Un documento interessante la questione valtellinese a ridosso dei fatti del1620 è anche narrato nel Discorso politico del naturalista Giulio Cesare d’Eugenio Braccini (cfr.A. TORTORA, Considerazioni in margine al Discorso politico intorno alle preparazioni che si fannodi guerra per occasione della Valtellina, in «Nuova Rivista Storica», XCV, 2011, 2, pp. 523-546).
(37) Un repertorio preciso e documentato di tali atti è in G. GIORGETTA, Francesco Negria Chiavenna. Note critiche, cit., pp. 39-40.
Note e documenti362
II. Altri atti su Francesco Negri, sono presenti nelle imbreviature dei notaiPaolo Peverelli (ASSo 1813), Carlo Stampa (ASSo 2101) e Vincenzo Oldradi(ASSo 1015). La scuola istituita dall’eretico bassanese era così importanteche a essa si iscrivevano anche i rampolli delle nobili famiglie cattoliche,non ultimo un figlio di Giacomo Travers, virtuoso esempio di nicodemitae cugino del vescovo di Coira Tommaso Planta (38).
III. Vol. 891, notaio Girolamo Rumo: Il 05/03/1549 Negri è intestatario di unmandato per la vendita di libri da parte di Pietro Loso de Scilano di Piuroche lo incarica di ricavarne cento fiorini. Qualora i libri dovessero andarepersi o bruciati («igne vel bello») nulla sarà addebitato a Negri (39).
IV. Vol. 1010, notaio Vincenzo Oldradi: Atti riguardanti il pagamento di fitti.V. Vol. 1093, notaio Giovanni Oldradi: il 05/06/1538 la moglie Cunegonda
Fessi nomina proprio procuratore il marito Francesco Negri.
Che i libri affidati a Negri fossero pericolosi è più che evidente e non-ostante ciò il bassanese svolge il compito affidatogli con tranquillità e capa-cità, al di là delle funzioni solite del semplice libraio ambulante, di cui pure,la valle era piena. Anzi, proprio il compito affidatogli ci induce a pensare chefare il corriere librario, attraverso i centri riformati vallivi, fosse una vera epropria attività, ben remunerata, protetta e fondamentale per la diffusione delleidee riformatrici. Se si guarda una carta topografica della valle, si noterà,osservando la dislocazione dei centri riformati, come da Chiavenna a Tirano
(38) La testimonianza è tratta da uno scritto di Vincenzo Quadrio in cui si afferma cheTravers «[...] mantiene un suo figliolo “a la schola di Francesco Niger luterano in Clavenna”»e sulla sua professione di fede aggiunge: «[...] Adesso non so se fusse catolico, si lo facesse[...]» (N. SALIS-SOGLIO, Die familie von Salis Gedenkblätter aus der geschikte des ehemaligenFreistaates der drei bünde in Hohenrhätien (Graubünden), Lindau, 1891, p. 69).
(39) Il terzo documento è più interessante poiché, almeno sulla base di quanto espresso, isuoi contenuti ci spingono legittimamente a ipotizzare che i libri fossero sospetti poiché, primadi tutto, si sa già quale somma ricavarne (e quindi qualcuno ha stabilito in precedenza un prezzocon un anonimo compratore); non solo, ma a corollario della prima ipotesi se ne delinea un’al-tra, ancora più importante: si stabilisce infatti, anticipatamente, che nulla deve accadere al ven-ditore, segno che il rischio di arresto e/o di sequestro del libro era alto. In ultimo, dalla datadell’atto, possiamo pure ipotizzare dove Negri portasse i libri, poiché proprio alla metà di marzo,a Tirano, si svolgeva annualmente una fiera che richiamava mercanti anche dai paesi tedeschi,oltre che dalla Svizzera, dal milanese e dal veneziano. Questo ci induce a considerare il bassa-nese come un vero e proprio corriere librario ambulante attraverso la Valtellina, da Chiavennaa Tirano e viceversa, cosa che peraltro, facevano un po’ tutti, da Pietro Paolo Vergerio aFrancesco da Milano.
Note e documenti 363
e viceversa, un libraio ambulante attivo e ben rifornito, potesse toccare tuttii centri in meno di una giornata di viaggio, raggiungere la Svizzera per rifor-nirsi e ricominciare il proprio commercio appena possibile. Le grandi fiere poi,richiamando merci da tutta Europa, facevano il resto offrendo la possibilitàdi reperire libri provenienti dalle tipografie francesi, svizzere e tedesche, dismerciarli o scambiarli con altri e poi riprendere il girovagare interno.
Una terza condizione permette di individuare e circoscrivere un vero eproprio circolo Pozzi, in cui interagiscono (pensiamo non solo economicamente,ma anche culturalmente) Negri, Niccolò Fogliata, Giuseppe Fossa, Sermondie tanti altri personaggi che non sono solo semplici testimoni per gli atti sti-pulati, ma la prova di un’integrazione economica e non solo religiosa tra inte-ressi comuni.
L’atto in questione, dunque, permette d’indagare non solo il mercatolibrario e le provenienze nordeuropee di gran parte dei libri circolanti nellevalli e ancora oggi presenti nelle biblioteche provinciali, ma ci permette anchedi avvalorare nuove ipotesi riguardo alla presenza di stamperie, non solo aPoschiavo (Dolfino Landolfi), ma anche in altri centri riformati quali Traonae Chiavenna. Atti in merito non se ne sono ancora trovati, però, una tale fio-ritura di scambi librari e la presenza di diversi inventari contenenti elenchi dilibri, permettono la costruzione di un paradigma di compatibilità tra la cir-colazione libraria (riformata) e la loro presenza in biblioteche private (rifor-mate e cattoliche). Ciò prova che gli scambi librari e commerciali non seguis-sero le regole degli opposti schieramenti, ma che invece, fossero il fattoreintegrante di tutta la comunità a prescindere dalla religione professata.
La presenza di cattolici alla scuola di Negri e la presenza di testimoni rifor-mati in atti stesi da notai cattolici e viceversa dimostrano, dunque, una paritàdi rapporti e scambi che è già una certezza. Pertanto, anche in quest’ottica,non deve meravigliare se, sul territorio, fossero attive più stamperie, magaricon una funzione più di vendita che non di stampa dato che non era difficileprocurarsi oltre confine (in particolare in territorio veneziano) i libri fascico-lati e poi ricomposti direttamente prima che fossero venduti. Il sistema deilibrai ambulanti, quindi, funzionava da raccoglitore di prenotazioni e distri-butore finale: solo così si giustificano le cifre elevate pattuite, la mancanza dielenchi dei volumi ricercati, comprati e venduti e la totale assenza di dati deicompratori. In questo modo, l’operazione rimaneva segreta e ciò permettevadi non dover neppure giustificare le somme incassate.
Quanto ipotizzato giustifica anche la mancanza di documentazioni sulloscambio librario e sulla presenza di botteghe a stampa. Infatti, di fronte allasola certificata presenza della stamperia Landolfi di Poschiavo (attiva alla metà
Note e documenti364
del Cinquecento e parte importantissima nella diffusione della polemica lute-rana a opera di Pietro Paolo Vergerio) e alla presunta tipografia di Traona nel1555 (e di cui non si trovano tracce documentali), nelle valli null’altro è testi-moniato. Al contrario, mentre sono documentati diversi sequestri di libri, arre-sti e processi a corrieri, nulla si sa della presenza di librarie vere e proprie(stanziali intendiamo) o di altre stamperie che non fossero quelle milanesi.Tantomeno, sono presenti tracce consistenti di libri “pericolosi”, né sono rima-ste tracce evidenti dell’uso e della diffusione di fogli volanti e placards (40).Eppure la circolazione dei testi a stampa, tra 1530 e 1560, è estremamentevitale. Lo dimostrano le continue bolle dei vescovi comaschi e milanesi e ilpoliziesco controllo delle piazze mercantili più importanti esercitato dagliinquisitori.
Le stesse testimonianze librarie esistenti si fermano alla ricognizione delfondo Sermondi, al nostro già citato fondo antico da poco documentato, allaraccolta di testi antichi conservata nella biblioteca della famiglia Venosta e allaraccolta di libri medicali esistente nella biblioteca comunale di Bormio (41).In essi, però, le tracce reali di una tradizione riformata e davvero eretica neicontenuti e nelle scritture sono labili e non determinanti per la ricostruzionestorica e bibliografica. Per esempio, è rintracciabile un gran numero di edi-tori svizzeri, ma è anche vero che fanno da contraltare a tale presenza opereteologiche cattolicamente ineccepibili; anzi, il tenore dei volumi è retorico, lin-guistico, storico o letterario e scarsamente teologico, segno di un interesse didat-tico e non religioso dell’eventuale compratore che ha fatto pensare a una pro-venienza da biblioteche di istituti gesuiti.
Personalmente riteniamo, invece, che la provenienza dei volumi e la pro-prietà siano vallive e rigorosamente laiche. Infatti, almeno gli incunaboli dellaBiblioteca «Grazioli – Della Vedova» (proprietà del liceo «Piazzi - LenaPerpenti» di Sondrio) e diverse cinquecentine nello stesso istituto conservatesono proprietà del notaio Giovanni Bernardo Colombera. Lo dimostra una sortadi ex libris presente su diverse carte interne degli incunaboli e replicato al ter-mine dei propri atti dallo stesso notaio (FIGURA 1).
(40) U. ROZZO, La strage ignorata: i fogli volanti a stampa nell’Italia dei secoli XV e XVI, Udine,Forum Editrice, 2008.
(41) Per la ricognizione del fondo Sermondi, risalente al 1575, cfr. A. PASTORE, NellaValtellina del tardo Cinquecento, cit., 1975; per la ricognizione del fondo antico del Liceo diSondrio, cfr. G. TALLINI, Incunaboli, Cinquecentine e Seicentine, cit., pp. 139-155.
Note e documenti 365
FIGURA 1: ex libris del notaio G. B. Colombera (mm. 72x37 ca.)
Il disegno riconduce a simboli e concetti religiosi, poiché è sin troppo evi-dente che il serpente si arrampica sull’albero di Jesse a sua volta poggiante sutre gobbe, identificabili con le tre virtù teologali: fede, speranza e carità, argo-menti che tornano ossessivamente nelle glosse che Colombera aggiunge allaSumma Theologica di s. Antonino edita da Jenson alla fine del Quattrocentoe di proprietà del notaio valtellinese.
14. Connesse alle questioni librarie e alla loro diffusione rientrano anchele problematiche relative alla morte di Ludovico Castelvetro e alla sua biblio-teca. A tal proposito, restano interessantissimi gli atti del notaio Lupi (ASSO
1545), comprendente il «codicillus» del testamento chiavennasco del letteratomodenese. Tra i nomi dei testimoni compare il vicentino Alessandro Trissino,riparato proprio a Chiavenna il 31 maggio 1564 dopo essere sfuggito al pro-cesso e al carcere e con una condanna per eresia (7 marzo 1564) e interces-sore, quattro anni più tardi, presso la comunità riformata chiavennasca diGiovanni Bergomozzi, fuoriuscito modenese rifugiato a Piuro che era stato allon-tanato dal collegio dei pastori per aver professato idee anabattiste e aver accu-sato lo stesso collegio di comportarsi come papisti e inquisitori (42). È curiosoche, per proteggere la propria persona, il vicentino utilizzi spesso lo pseudo-
(42) Cfr. la voce a cura di A. Rotondò in «Dizionario Biografico degli Italiani», IX, pp. 96-98.
Note e documenti366
nimo di Andrea Pallanza, personaggio realmente esistito e scomparso nel 1579,di cui si conservano due testamenti, uno del 24 maggio 1573 e l’altro, per oraancora inedito, del 1579 (ASSo 1804, notaio Carlo Stampa del fu Paolo) (43).
A proposito del testamento di Castelvetro, c’è anche da segnalare che ilproprietario della casa in cui egli muore, il bresciano Marco Zobia, è coin-volto, con Simone Fiorillo in alcune testimonianze per eredità riformate (ASSo1813, notaio Paolo Peverelli, 01/03/1566 e ASSo 2099, notaio Carlo Stampadel fu Giovanni Angelo, 21/05/1571).
Radunando per religione professata i notai, possiamo renderci conto dicome la professione di fede, di fronte a quella notarile, scomparisse del tutto;anzi: nel caso dei notai Pozzi e Rusca (quest’ultimo estensore, suo malgrado,dei processi inquisitori del 1523), il primo riformato e il secondo cattolico,scorrendo l’elenco dei testimoni da loro iscritti agli atti, si nota, da un lato,la totale assenza di remore nello scegliere testimoni dell’uno o dell’altro frontee, dall’altro, la presenza di testi spesso imparentati con l’uno o l’altro fronteo con tutti e due nello stesso tempo. Lo stesso si evidenzia per altri notai:Lupi, Paravicini, Rumo, Quadrio e Stampa (tutti cattolici, ma con ricca clien-tela protestante), Pestalozzi, Peverelli, Malacrida, Marlianici, Lavizzari (prote-stanti, ma con ampi agganci tra i cattolici).
Se si guardano le date in cui gli atti sono stipulati, notiamo che la mas-sima concentrazione avviene tra il 1550 e il 1567, proprio gli anni in cui, daSiena, Lucca, Cremona e altre città italiane aumenta il flusso di esuli e s’in-crementa anche la possibilità che, in funzione di un successivo trasferimentoa Ginevra e Basilea, si gettino basi economiche per un primo consolidamentodelle proprie realtà familiari (44).
(43) Per l’atto del 24/05/1573 cfr. A. PASTORE, Nella Valtellina del tardo Cinquecento, cit.,pp. 189-193. Sulla biografia e le opere di Alessandro Trissino, si veda A. OLIVIERI, AlessandroTrissino e il movimento calvinista vicentino nel Cinquecento, in «Rivista di Storia della Chiesain Italia», XXI, 1967, 1, pp. 54-117.
(44) In particolare il nucleo centrale dell’ecclesia Cremonensis, che usa la Valtellina propriocome base di lancio per un definitivo trasferimento in Svizzera, mostra questa particolare ten-denza, segno che lo stabilirsi in valle, non era definitivo, ma solo dettato dalla necessità delmomento. Lo stesso avviene per gli altri nuclei di rifugiati; anzi, analizzando meglio i flussi migra-tori religionis causa si scopre che sono ben pochi quelli che vi si stabiliscono definitivamente.Al contrario, mentre gli esuli italiani, dopo un iniziale ambientamento (che comprende il rin-saldarsi della propria condizione economica e il ripristino dei traffici svolti nella terra di ori-gine), trovano normale espandersi e trasferirsi in Svizzera, altrettanto non è per gli Svizzeri, iquali ben presto, attirati anche dalle prebende offerte dal governo grigione, si trasferiscono soprat-tutto nel chiavennasco e qui si stabiliscono definitivamente.
Note e documenti 367
Le questioni offerte dai documenti notarili conservati in ASSo, permettonodi studiare la formazione delle librarie private e l’utilizzo del libro nella societàvaltellinese del tempo, come uso e come merce di scambio. Solo per rimanereal periodo osservato infatti, la realtà culturale delle due valli e del contadobormiese si caratterizza per la doppia funzione cui la socializzazione del librorisponde: la prima interessa lo studio e è legato all’educazione o alle profes-sioni (è il caso dei molteplici libri medicali presenti diffusamente nelle biblio-teche della provincia, delle grammatiche, dei vocabolari e dei testi teologici),la seconda, invece, interessa l’utilizzo privato del libro, il mantenimento dellafunzione educativa e la possibilità di circolare come merce di scambio pro-prio perché preminente la prima condizione. In questo caso, il libro ad argo-mento storico, scientifico o filosofico ha più probabilità di circolare e di esserebarattato con testi appartenenti alla prima funzione. Gli atti riguardanti benilibrari confermano tale condizione e determinano, per i testi così caratteriz-zati, una sorta di borsino di scambio che ne determina l’importanza e il valore.Così facendo, mentre le grammatiche e i vocabolari confermano la propria iden-tità di testi scolastici, non altrettanto si può dire per i libri medicali o per lemolteplici Descriptiones che, per esempio, affollano oggi la biblioteca di Grosioe il ricchissimo Fondo Visconti Venosta.
Il libro è dunque usato come merce di scambio per arricchire non solola propria formazione culturale, ma anche per acquistare prestigio di frontealle altre famiglie della valle. È, dunque, prima di tutto una funzione politicae poi culturale quella che interessa la fruibilità del libro antico in Valtellina equesto costringe a separare rigidamente gli interessi culturali dal semplice col-lezionismo incidendo fortemente sulla stessa distribuzione libraria. Infatti, purnon esistendo che una stamperia documentata (quella landolfiana a Poschiavo)e ancor meno librerie, assume particolare importanza la figura del venditoreambulante, capace di attraversare le valli per scambiare libri con altri, ven-derne a un buon prezzo o trasferirne diversi a sud o nord delle Alpi, magarianche importando libri ereticali di contrabbando. In questo caso le vie eranomolteplici e i sequestri altrettanti (45).
La rigida separazione degli ambiti organizzativi della distribuzione libra-ria conduce allora verso l’altrettanto rigida classificazione degli argomenti utilia tale tipo di mercato e alla determinazione di canali obbligati della distribu-
(45) M. BUNDI, Frühe Beziehungen zwischen Graubünden und Venedig (XV-XVI jh.), Quellenun forshungen zur Bündener geschichte, b. II, herausgegeben vom Staatsarchiv Graubünden,Chur, Gasser A. G., 1988, pp. 111-119 e 142-150.
Note e documenti368
zione stessa. A tale proposito, si individuano due fattori: il primo, distribu-tivo, a diffusione orizzontale e in ambiti ermeneutici ristretti, interessante cate-gorie sociali ben precise (alta borghesia, alto clero, nobili) e un secondo, quan-titativo, a diffusione verticale e in ambiti ermeneutici più ampi (scholae,formazione culturale individuale e personale in ambito medio-alto, precettori,sacerdoti). Tali categorie non hanno mai utilizzato il libro secondo funzioni escopi effettivi, ma solo come esercizio di potere e comunicazione culturale-educativa (grammatiche, catechismo, medicina) interna alla famiglia o al grupposociale di appartenenza. È l’arrivo della Riforma a spingere il libro fuori dellecategorie sociali solite e a imporre modalità di consumo culturale diverse, avolte originatesi direttamente tra le classi sociali più basse e soprattutto, nelcaso almeno di testi teologici e biblici, addirittura individuali e non più legatial tramite interpretativo di altri. In particolare nel caso dei libri della biblio-teca di Grosio, se guardiamo alle cinquecentine e agli incunaboli ivi deposi-tati, troviamo idonei riscontri a quanto in precedenza affermato.
Incunaboli Cinquecentine
aforismi 0 aforismi 1
antichità 0 antichità 6
astronomia 0 astronomia 1
diritto 1 diritto 9
emblemi 0 emblemi 1
filosofia 10 filosofia 21
geografia 0 geografia 1
Gram. latine 0 Gram. latine 3
letteratura 13 letteratura 30
medicina 0 medicina 4
orazioni 0 orazioni 2
pittura 0 pittura 7
religione 2 religione 29
storia 0 storia 5
vocabolari 0 vocabolari 2
Totale 26 Totale 122
Totale complessivo 148
Di fronte ai 26 incunaboli, contrassegnati solo da opere letterarie, testi difilosofia e religione, le 122 cinquecentine sono contrassegnate dalla presenza
Note e documenti 369
non solo degli stessi argomenti, ma anche di opere di astronomia, geografia,vocabolari latini, testi diversi di teologia e religione, orazioni, medicina, dirittoe soprattutto pittura e letteratura (tra essi spicca anche una rara edizione dellaCivil conversazione del Guazzo). Come si vede gli antichi proprietari non ave-vano raccolto tali volumi per scopi diffusivi della cultura, ma solo per colle-zionismo ed esibizione di potere. La stessa comunicazione culturale ed edu-cativa rimane confinata all’utilizzo familiare e alla funzione di archivio personale.Così, possono tranquillamente convivere vocabolari e grammatiche latine conopere di medicina e testi sulla pittura, mentre il fondo letterario, spaziandoda Cicerone a Guazzo, segnala, da un lato, la propria inadeguatezza culturalee dall’altro la quotidianità e provvisorietà della stessa raccolta, bene non neces-sario e alla bisogna anche facilmente alienabile (46).
15. Un ultimo punto da studiare, partendo dal libro e dalle testimonianzedocumentali conservate nell’archivio di Stato sondriese, interessa i notai e laloro attività a margine del Sacro Macello. Dal quadro dei notai attivi soprat-tutto nell’ultima parte del secolo XVI e fino al 1620 possiamo ricavare, infatti,dalla data d’interruzione della loro attività professionale e dall’appartenenzafamiliare, l’inserimento nel fronte eterodosso. Molti di loro, oltre che appar-tenere alle famiglie riformate più in vista in diversi centri grandi e piccoli, sem-brano aver interrotto la propria attività più o meno simultaneamente intornoal 18 di luglio del 1620 (il 20 era domenica) e soprattutto non si registranonegli anni successivi riprese in altri luoghi delle proprie scritture, segno chequalcosa (che presumiamo possa essere stato il Sacro Macello) è accaduto impe-dendo ogni ripresa delle attività.
(46) La sproporzione tra testi letterari, orazioni, grammatiche e vocabolari, storia, aforismi,antichità (49, il 72.52% del totale dei volumi) e testi filosofici e teologici (50, il 74%) e poiscientifici (6, l’8.88%) dimostra che i proprietari, al di là della formazione umanistica ricevutain gioventù, altri interessi non coltivavano, né avevano interesse a farlo con inevitabili ricaduteanche sulle professioni svolte: non abbiamo, infatti, docenti, storici o altre professioni legatealla diffusione culturale, ma solo giureconsulti, teologi, prevosti, possidenti, mercanti. Anzi, aguardare le date di edizione di molti dei volumi editi negli ultimi venti anni del Cinquecento(periodo a cui probabilmente risale il nucleo centrale della raccolta, visto che rappresentano il75% dei volumi), è evidente che essi sono stati raccolti alla rinfusa, senza nessun obiettivo spe-cifico. Ciò rende ancora più importante il mercato ambulante di libri poiché, a fronte di unafunzione essenzialmente rappresentativa dell’oggetto libro, con la Riforma si sviluppa una con-sapevolezza culturale diversa, aperta e capace di rinnovare il clima culturale vallivo mettendolodirettamente in contatto con i grandi centri italiani ed europei.
Note e documenti370
Dei 923 notai censiti presso l’archivio di stato di Sondrio dal 1294 al 1665,339 sono attivi dal 1564 al 1620 (36.72%) e 35 (10.32%) hanno interrotto lapropria attività nel luglio del 1620.
Luogo Num. ASSO Volume ASSO
Stampa Carlo Chiavenna 584 2118
Grosini Romerio Bormio 651 2467
Paravicini–Bedoglio G. A. Caspano 661 2500
Rusca Celso Morbegno 681 2712
Oldrado Orazio Chiavenna 666 2537
Casolari Giovanni Bormio 687 2743
Pozzi Andrea Teglio 688 2748
Girardoni And. fu Giorgio Sondrio 711 2877
Marlianici Francesco Sondrio 713 2909
Sanfedele Liberto Dubino 720 2924
Moroni G. St. fu Filippo Castione 722 2931
Crotti Buonomo Carona 734 3003
Gatti Claudio Teglio 778 3198
Crivelli Rodolfo Montagna 785 3214
Curti Giov. Matteo Delebio 838 3546
Malacrida Giov. Pietro Caspano 842 3556
Malacrida Celio Caspano 844 3561
Interiostoli Giov. Giacomo Sondrio 858 3652
Monaci Giov. Pietro Sondrio 869 3702-3703
Malacrida Orazio Caspano 880 3743
Malacrida G. B. fu Bartolo Caspano 892 3784
Moroni Carlo Castione 893 3785
Paravicini Tomaso Berbenno 894 3786
Alardi Benedetto Sondrio 904 3851
Imeldi Gaspare Bormio 905 3852
Tutti agiscono in luoghi nei quali la presenza eterodossa era forte econo-micamente e socialmente e gli stessi atti da loro composti evidenziano un buonequilibrio dei rapporti sociali ed economici tra le due fazioni, smentendo la
Note e documenti 371
progressiva radicalizzazione dello scontro che invece le fonti successive sem-brano continuamente richiamare e avallare (47).
La doppia condizione sociale dimostra che i rapporti tra i due frontierano forti e ben organizzati al punto da tendere, attraverso l’esogamia dif-fusa (intendendo con ciò il prender moglie di osservanza diversa dalla pro-pria), da un lato alla minor evangelizzazione, ma dall’altro al mantenimentodei contatti economici e alla crescita demografica (giustificata dai nostri dati),ottimi sistemi entrambi per far circolare beni e proprietà all’interno della pro-pria comunità garantendone così la sopravvivenza (48).
Analizzando una selezione di notai operanti in Valtellina tra 1589 e 1620è possibile notare tale condizione economica chiusa, limitata alle famiglie ealle persone della comunità in cui si vive o si è vissuto, che ha condotto, daun lato, al restringimento dell’esercizio della professione notarile a poche per-
(47) Dall’elenco risaltano nomi e persone che ritroviamo nelle pagine dell’arida cronaca sto-rica: è il caso di Buonomo Crotti, parente di Antonio Crotti di Schio, con la propria moglieAnna di Liba uccisi durante il Sacro Macello; Claudio Gatti, massacrato con i suoi due fratellie la moglie Maddalena Gilardoni; Rodolfo Crivelli, ucciso con Vincenzo Bruno e GiovanniAntonio Merlo; Giovanni Pietro Monaci, ucciso con i nipoti e il fratello Teofilo de Mossini,che fu fatto esplodere con una mina in bocca perché, pur colpito a morte, tardava a trapas-sare; Giovanni Stefano Moroni con suo figlio, sorpresi sulla via della val Masino e suo fratelloCarlo, anch’egli notaio, ma cattolico, ucciso da Stefano Perari mentre con costui si disputavaparte del bottino ottenuto con il saccheggio delle case riformate. A costoro vanno aggiunti itre Chiesa, tutti pastori e contemporaneamente notai: Bartolomeo, il capostipite, già parrocodi Chiesa Valmalenco e notaio, passato alla Riforma grazie all’influenza esercitata su di lui daPietro Paolo Vergerio quando questi risedeva a Mossini (1552) e i suoi figli, anch’essi notai econtemporaneamente predicanti, Giacomo e Giovanni. Scipione Besta, notaio di Teglio cui futrucidato, «in braccio alla moglie» secondo Giuseppe Romegialli, il figlio Antonio; AnselmoGatti, cancelliere del comune e notaio. Ancora a Teglio, Giovanni Antonio Federici, giurecon-sulto e notaio (dei cui atti, però, in ASSO nulla si conserva) è ucciso per mano del canonicoAntonio Piatti come vendetta per la condanna inferta al fratello Biagio nei processi di Thusis.Per ultimo, Paravicino Paravicini, notaio in Dazio (numero di catalogo 706, si conservano attida lui controfirmati fino al 1615) e fratello di Prospero con cui ripara a Zurigo, è da identifi-carsi con uno dei due figli di Petronio Paravicini assassinato con altri sulla via della Valmasinomentre cercavano di sfuggire ai massacri. Sempre a Caspano sono probabilmente uccisi anchei quattro componenti della famiglia Malacrida di cui rimangono nell’Archivio di Stato di Sondriodiversi volumi di atti, tutti interrotti sempre alla data del luglio 1620.
(48) Un caso simile è quello documentato, ma solo per gli scambi economici e la produ-zione locale posta in rapporto all’esistenza stessa del gruppo sociale stanziale che la produce ene usufruisce, da Robert Netting per Törpel nel canton Vallese, secondo cui, alla forte emi-grazione dei residenti non corrispose mai un’altrettanto forte immigrazione eppure, la comu-nità continuò a vivere e a produrre conservando la propria centralità all’interno del territoriodi competenza (R. NETTING, In equilibrio sopra un’alpe, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1996,pp. 137-150).
Note e documenti372
sone, spesso parenti o addirittura padre e figlio e dall’altro ha fatto sì che lestesse proprietà e beni rimanessero all’interno della comunità, anche quandogli atti sono scritti fuori delle valli.
Così mentre a Chiavenna e Morbegno le famiglie notarili non sembranoavere il monopolio degli atti, tanto da segnalare solo due cognomi uguali aChiavenna (Oldrado Pietro Antonio [n. 532 del catalogo dei notai censiti inASSo] e Orazio [666] su otto notai) e Morbegno (Castelli – Sannazaro Artuchinofu Maino, 678, e Castelli – Sannazaro Ludovico, 700, su un totale di 14 uffi-ciali). Registriamo la stessa situazione a Sondrio, dove, a fronte di 11 notaiattivi, abbiamo i soli Malacrida Bartolomeo (521) e il di lui figlio Bartolomeofu Bartolomeo (553) e a Tirano, dove su quattro notai attivi due apparten-gono alla stessa famiglia e sono Lorenzo Manfredotti (606) e il figlio Gregorio(679). Non eguale situazione si registra nei centri più piccoli e mano a manoche si sale in altitudine; così, del tutto opposti sono i casi di Mello, dove inotai appartenenti alla famiglia Greco sono ben 3 su quattro attivi (Matteo[502], Godenzo [532], Achille [673]); Civo, dove su 6 notai attivi 3 appar-tengono alla famiglia Paravicini (Giovanni Pietro fu Giovanni Battista [507],Raffaele [654], Prospero [748]) e 3 agli Asinago e ai suoi rami collaterali(Giovanni Currado [529], Giovanni Angelo del Curado [612], Giovanni Pietrodel Curado [753]); Bormio, con 2 Sermondi (Zaccaria [480] e Leoprando [636])e 2 Romano (Giovan Battista [555] e Giovanni Antonio [699]) su sei com-plessivi; Caspano, dove i soli notai attivi appartengono a diversi rami deiParavicini (Paravicini Bedoglio Giovanni Antonio [661], Paravicini della DonnaBartolomeo [707], Paravicini Giovanni Antonio [443] e Bartolomeo fuPellegrino [607]) e alla famiglia Malacrida (Valentino [534], Francesco fuAntonio [614], Giovanni Battista fu Giovanni Antonio [617]; Battista fuGiovanni Pietro); Teglio, con Gatti Anselmo (625) e Claudio fu GiovanniAntonio (765); Ponte, con diversi rami dei Quadrio (de Maria, Martinaccia,Ascendino) e dei Guicciardi; Berbenno, con ancora gli onnipresenti Paravicini,Odescalchi, Malacrida; Mazzo, dove sono attivi i Crotti padre, figlio e nipote.
Raccogliendo per terzieri e contadi notiamo come 96 notai su 121 (77.68%)siano attivi tra Delebio e Boalzo, cioè nei due terzieri inferiore e di mezzo esolo 13 nel rimanente terziere e quasi lo stesso numero nei due contadi.
Ciò avvalora l’idea che la rivolta abbia trovato forte incentivazione nellezone più agricole (appunto il terziere superiore), meno coinvolte nei commercie meno aperte agli scambi e alle novità (comprese quelle religiose). Poco piùdel 15% del totale dei notai è attivo nelle contrade del terziere superiore edel contado bormino, dato in totale sintonia con la scarsa presenza riformatae inversamente proporzionale alla quantità delle rivendicazioni avanzate da parte
Note e documenti 373
ribelle. Laddove è meno presente la componente riformata, maggiori infattisono state le accuse e maggiore è stata la diffusa sensazione di sopraffazionesentita dai cattolici, anche laddove la presenza riformata non era così forte edeconomicamente potente: basti rivedere i dati della popolazione della Pievedi Mazzo, per rendersene conto senza difficoltà. Infatti, analizzando il numerodei notai impegnati nelle due sole pievi di Mazzo e Berbenno e nel territoriodi Traona e Caspano e raffrontandoli alla popolazione di quegli stessi luoghi,potremo notare con facilità la quantità di atti e di conseguenza l’elevatonumero di scambi e contrattazioni.
Popolazione Notai Notai riformati Rapporto pop.
pieve di Berbenno 3739 9 0 415,44
pieve di Mazzo 9804 10 0 980,4
Caspano 7818 23 0 339,91
Totale popolazione 21361 42 0 508,59
Morbegno 9869 14 1 704,92
Sondrio 8744 11 7 794,9
Chiavenna 8287 8 3 1035,87
Tirano 7154 4 0 1788,5
Teglio 6204 4 4 1551
Totale popolazione 40258 41 15 2603,86
Tot. complessivo 61619 82 15 4107,93
Media 1413,175
Il rapporto tra notai e popolazione è lo stesso, più o meno, del rapportoesistente tra riformati e cattolici: nella pieve di Berbenno i 9 notai servonociascuno ca. 415 persone, mentre nella pieve di Mazzo, con quasi lo stessonumero di notai, il numero dei potenziali clienti sale a più del doppio, perridursi drasticamente a Caspano, dove un numero più elevato di notai fa sìche sia di un terzo inferiore il numero dei clienti (una media per notaio di561 persone). Le percentuali non cambiano se applichiamo gli stessi calcolialle città più grandi; si ricorda anche che il dato relativo a Chiavenna inte-ressa l’intera popolazione del contado e non solo della città.
Per le città mandamento possiamo anche indicare, sulla base delle fonti,il numero di notai sicuramente riformati; ciò che però è interessante è il rap-porto tra notai e popolazione, solo in due casi inferiore al migliaio e natural-mente in città dal forte orientamento economico e commerciale quali erano
Note e documenti374
Sondrio e Morbegno. La media della popolazione servita è di circa 1175anime, con punte di 1788 persone a Teglio e di poco più di 700 a Morbegno.
I dati raccolti, sia pure indicativi di alcune situazioni e non di tutte lerealtà sociali ed economiche della regione, sono lo stesso indice della vitalitàdegli scambi e delle transazioni e confermano, da un lato, la necessità di man-tenere all’interno delle comunità di appartenenza i beni e le proprietà e dal-l’altro provano che lo stesso tessuto sociale permetteva tali rapporti, causa, primadi tutto, non solo l’esogamia, ma soprattutto i ristretti gradi di parentela esi-stenti tra riformati e cattolici. Non è solo un problema di mogli e formazionee conservazione di nuclei familiari, ma soprattutto di rapporti di parentelacostruiti attraverso la rete di scambi economici e non viceversa. Tanto è veroche se calcoliamo la media di abitanti per notaio, ci accorgiamo che i rapportisono all’incirca gli stessi di quello tra sacerdoti e popolazione, cioè poco piùdi 600 persone per notaio (618.86).
GENNARO TALLINI
Università degli Studi di Verona
The essay compares some data and documents interesting the real numberof reformed people in Valtellina and Valchiavenna between XVI and XVIICentury until the Sacro Macello. Data, recovered from many sources and docu-ments never compared, show as the number of reformed killed during the revo-lution of 1618 was less than Catholic and Reformation sources always have affir-med.
KEYWORDS
WaldesiansValtellinaSacro Macello