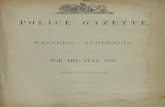Pittura vascolare e politica ad Atene e in Occidente: vecchie teorie e nuove concezioni, in M....
Transcript of Pittura vascolare e politica ad Atene e in Occidente: vecchie teorie e nuove concezioni, in M....
Monica de Cesare
PITTURA VASCOLARE E POLITICA AD ATENE E IN OCCIDENTE:
VECCHIE TEORIE E NUOVE RIFLESSIONI
Estratto da
Arte-Potere
Forme artistiche, istituzioni, paradigmi interpretativi Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 A cura di Marianna Castiglione e Alessandro Poggio
Milano, LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2012
ISBN 978-88-7916-503-7
Copyright 2012
Via Cervignano 4 - 20137 MilanoCatalogo: www.lededizioni.com
I diritti di riproduzione, memorizzazione elettronica e pubblicazionecon qualsiasi mezzo analogico o digitale(comprese le copie fotostatiche e l’inserimento in banche dati)e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parzialesono riservati per tutti i paesi.
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.
Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possonoessere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da:AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108 - 20122 MilanoE-mail [email protected] <mailto:[email protected]>sito web www.aidro.org <http://www.aidro.org/>
Videoimpaginazione e redazione: Paola MignanegoStampa: Arti Grafiche Bianca & Volta
Pubblicato con il contributo di
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Scuola Normale Superiore, Pisa
Banca Monte dei Paschi di Siena
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
5
SOMMARIO
Introduzione 7
Il re e la comunicazione del potere nell’arte siro-ittita (XI-X sec. a.C.) 11Stefania Mazzoni
Scrittura e potere nella Grecia arcaica: il caso di Creta e Cipro 33Albio Cesare Cassio
Bacchiads, Cypselids and Archaic Isthmia 45K.W. Arafat
I signori di Corinto e l’arte della città. La formazione della polis 57sotto le dinastie bacchiade e cipselideRachele Dubbini
Observations on feminity and power in early Greece 77Alan Johnston
Myth and images on the Acropolis of Athens in the Archaic period 87Fabrizio Santi
Pittura vascolare e politica ad Atene e in Occidente: vecchie teorie e nuove riflessioni 97Monica de Cesare
Società, architettura e immagini all’origine dell’arte romana 129Gabriele Cifani
Oligarchie al potere: gnorimoi e politeia a Taranto 147Enzo Lippolis
Art and power in Archaic Greek Sicily. Investigating the economic substratum 173Franco De Angelis
Greek choral lyric poetry and the symbols of power 185Herwig Maehler
Altari e potere 195Clemente Marconi
L’artista alla sbarra: il processo a Fidia. Distorsioni storiche, invenzioni letterarie 207Eva Falaschi
Immagini venatorie e monumenti dinastici: l’Impero Persiano tra centro e periferia 227Alessandro Poggio
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
6
SOMMARIO
Lycian dynast, Greek art: the two small friezes of the Nereid Monument at Xanthos 243Francis Prost
Skopas alla corte macedone? Motivi stilistici skopadei tra Grecia e Macedonia 259Gianfranco Adornato
Immagini e potere alla corte dei Tolemei 273Elena Ghisellini
La tomba dei Giulii a Glanum (St. Rémy-de-Provence) in Gallia Narbonensis.Le ambizioni politiche del programma iconografico 301Maurizio Paoletti
Modelli urbani per forme di autorappresentazione locale. Il monumento funerariodi un eques pompeianus a Porta di Nocera 325Marianna Castiglione
L’arte augustea negli studi attuali: una nota 339Eugenio Polito
Ercole: l’immagine del potere (da Traiano ai Severi) 347Michela De Bernardin
Signa come segni. Riletture dell’antico per i Barberini 361Lucia Faedo
Referenze fotografiche e iconografiche 381
Elenco degli autori 387
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
97
PITTURA VASCOLARE E POLITICA AD ATENE E IN OCCIDENTE: VECCHIE TEORIE E NUOVE RIFLESSIONIMonica de Cesare
Il dibattito acceso da John Boardman alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso 1 sul rapporto tra pittura vascolare e politica nell’Atene di età arcaica e classica, variamente sfuma-to nell’insidiosa marca di propaganda politica, appare oggi suscitare nuovi quesiti e rinnovate questioni, alla luce delle più recenti metodiche di approccio alla lettura delle immagini nella Grecia antica.
La questione in realtà precede Boardman, che come è noto ha incentrato la sua disa-mina principalmente – ma non solo – su Eracle e sui Pisistratidi, e vede invece coinvolta in prima istanza la saga di Teseo, il famoso «eroe della democrazia ateniese»; ciò accade già con Edmond Pottier, agli inizi del Novecento 2, e qualche decennio più tardi con Karl Schefold 3, che, attingendo anche alla documentazione vascolare, attribuisce a Clistene la responsabilità della creazione di Teseo come eroe nazionale.
L’ingresso dirompente, seppur cauto, di Boardman nella formulazione del riconoscimen-to di un ruolo della pittura vascolare nella «manipolazione politica del mito» 4, con il suo arti-colo del 1957 nel Journal of Hellenic Studies, a firma doppia con Parke 5, sancisce una nuova linea anglosassone di approccio allo studio delle immagini sui vasi, garantita dalla autorevolez-za dello studioso inglese.
Centrale inoltre per la definizione e sanzione di un tale tipo di approccio appare il Sympo-sium tenutosi ad Amsterdam nel 1984 (Ancient Greek and related pottery) 6, nel quale un’intera sezione del Convegno è dedicata ai Political and sociological factors as reflected in iconography,
1 Parke - Boardman 1957. 2 Pottier 1901, in parallelo con Eracle. Ma si veda ancor prima Helbig 1897, a proposito della figurazione di una coppa di Londra del Pittore di Lysippides, riconnessa con la vicenda pisistratea di Pallene (sui cui, più di recente, Williams 1983, 135-136; 1986; Angiolillo 1997, 116 nota 54). 3 Schefold 1946; analogamente Jacoby 1949, 394 nota 23. Secondo Schefold (1946, 65), gli Alcmeonidi avrebbero commissionato un poema, perduto, che doveva narrare le nuove avventure dell’eroe, ispirando la pit-tura vascolare: si veda Neer 2002, 154. Si ricordi inoltre il tentativo di Smith 1929 (ripreso e discusso in Shapiro 1980 e 1989, 16) di classificare come pro-Alcmeonidi i pittori della cerchia di Andokides e come pro-Pisistratide la bottega di Epiktetos, proposizione subito liquidata da Beazley come «an ingenious flight of fancy» (Beazley 1931b, 120); l’assunto di Smith anticipa in qualche modo l’idea di Boardman di Exekias supporter degli Alcmeoni-di. Sul rapporto tra produzione ceramica e Pisistratidi si veda poi Kluwe 1967. 4 L’espressione è in Boardman 1975, 12; si vedano anche Boardman 1989a, 158; 1996, 19; Osborne 1983-1984. 5 Supra, nota 1. 6 Brijder 1984.
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
98
Monica de cesare
aperta naturalmente da Boardman 7. Lo studioso in questa sede introduce possibili connessioni dell’iconografia di Eracle, oltre che con i Pisistratidi, anche con altri esponenti dell’aristocrazia ateniese, come gli Alcmeonidi, trasformando l’associazione Atena-Eracle in un’immagine poli-tica in senso più lato.
Partendo da analisi statistiche sulla distribuzione cronologica e quantitativa delle pitture vascolari, nonché dalla registrazione delle varianti iconografiche introdotte nella raffigurazione di un mito, lo studioso testa le fonti storiche relative alle vicende politiche dell’Atene arcaica, connettendo la popolarità del tema figurativo della lotta tra Apollo ed Eracle per il possesso del tripode nella seconda metà del VI sec. a.C. con la prima guerra sacra 8, e passando poi, a partire dal suo articolo del 1972, Herakles, Peisistratos and sons 9, a enucleare le strette inter-connessioni tra Eracle e i Pisistratidi 10. Sono proposte in tal modo interpretazioni in chiave politica di variazioni o innovazioni del repertorio iconografico, quali la sostituzione di Tritone a Nereo come antagonista di Eracle a partire dalla metà circa del VI sec. a.C., collegata con la vittoria di Pisistrato su Megara 11, la nascita e diffusione del tema dell’ingresso di Eracle al l’Olimpo su carro, accompagnato da Atena, ancora alla metà circa del secolo, connesse con il trionfale ritorno del tiranno dopo il primo esilio (Fig. 1) 12; e ancora, l’affermarsi dell’Eracle mousikos a partire dal 530 ca. a.C., ricondotto alla regolamentazione degli agoni rapsodici nelle Panatenee 13, la sparizione di ogni indicazione di violenza nell’episodio della cattura di Cerbero e l’ingresso di Trittolemo nell’iconografia vascolare a partire dal 540-530 ca. a.C., messi in relazione con il rapporto dei Pisistratidi con l’ambiente eleusinio (Fig. 2) 14. Si arrivano quindi a sondare altri eroi (Aiace in primis) e saghe epiche dipinte sui vasi e del tutto estranee alla tradi-zione letteraria, quali in primo luogo l’episodio di Achille e Aiace giocatori di dadi, introdotto, come è noto, nel repertorio iconografico da Exekias (Fig. 3) 15 e letto come allusione in chiave anti-tirannica alla vittoria di Pisistrato a Pallene e al suo ritorno ad Atene, secondo il racconto di Erodoto 16.
Tale impostazione metodologica, mantenuta da Boardman nei dovuti toni cauti 17 ma spinta faziosamente in alcuni casi verso etichette più estreme sia da oppositori che da soste-
7 Boardman 1984. 8 Parke - Boardman 1957; Boardman 1978c; Boardman et al. 1990, 141. 9 Boardman 1972 e, più di recente, 1989a. 10 Una sintesi delle tappe di tale percorso critico in Rosati 2002; per un bilancio di tale approccio: Brandt 1997. Si veda anche l’intervento di F. Santi in questo volume. 11 Si vedano anche Boardman 1989b e 1991, 91; inoltre Glynn 1981; Ahlberg-Cornell 1984, 103; Pipili 1992, 835; Angiolillo 1997, 138; Icard-Gianolio 1997, 72; Nadal 2008, 42-43; Mackay 2010, 140-141 e 383-384. 12 Hdt. 1.60.4-5. Si vedano Boardman 1972, 61 ss.; 1991, 87-88; infra. Si consideri, inoltre, da ultimo, An-giolillo 2009 (con disamina della bibliografia); Mackay 2010, 183 ss. sull’anfora Faina da Orvieto di Exekias (si-gnificativa la titolatura data alla scena dipinta sul lato B del vaso: «Chariot scene (perhaps Peisistratos)»). Sull’in-troduzione poi del motivo del gorgoneion sullo scudo e sull’egida di Atena alla metà del VI secolo, interpretata alla luce del legame tra la dea e Pisistrato: Halm-Tisserant 1986. 13 Boardman 1972, 69; 1975, 10-11; Boardman - Palagia - Woodford 1988, 810 ss., in particolare 816; si vedano anche Schauenburg 1979; Angiolillo 1997, 140. Inoltre, da ultimo, con nuovi spunti esegetici, Berlinzani 2002. 14 Boardman 1975 e 1991, 91. Si vedano anche Hayashi 1992, 8 ss.; Angiolillo 1997, 139. 15 Infra, nota 83. 16 Hdt. 1.63.1. Si veda Boardman 1978a; infra. A sostegno della sua tesi Boardman valuta anche l’associa-zione del tema di Achille e Aiace con quello del ritorno dei Dioscuri, dipinto sul lato B dell’anfora del Vaticano (come su un’altra anfora frammentaria di Exekias: infra, nota 83). I Dioscuri, di origine spartana in quanto figli di Tindaro, non potevano che avere, secondo Boardman, un significato politico anti-tirannico: di lì a pochi anni infatti i Pisistratidi sarebbero stati cacciati dagli Spartani alleati degli Alcmeonidi. Di segno opposto l’interpreta-zione di Hermary (1978), che, leggendo la scena come l’introduzione dei Dioscuri all’Olimpo e constatando che le raffigurazioni di apoteosi di Castore e Polluce nella ceramica attica si datano tra il 540 e il 510 a.C., interpreta la coppia divina come immagine simbolica dei figli di Pisistrato (così Angiolillo 1997, 131), richiamando anche il di-scusso caso del cavaliere Rampin (su cui peraltro anche Boardman 1978b, fig. 114). Mommsen 1980 e 1988 pensa, più acutamente, a nostro avviso, a un parallelo tra i gemelli divini e Achille e Aiace, sostenendo che l’intento del pittore era quello di rappresentare Aiace come di pari grandezza ad Achille e dunque di celebrare il Salaminio co-me eroe attico; così, ma con qualche correttivo, Mackay 2010, 348, che riconduce l’associazione a uno dei poemi del ciclo epico. 17 Numerosi sono i richiami alla cautela nei suoi scritti; da ultimo, Boardman 2001, 208-209.
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
99
Pittura vascolare e Politica ad atene e in occidente
nitori (che hanno trasformato variamente la marca di riflesso o valenza politica nella pittura vascolare in quella di propaganda e manifesto ideologico), ha suggellato di fatto una procedura che, portata all’estremo, fa di certe figure mitiche una diretta ipostasi di personaggi politici ateniesi e di alcune generiche scene dipinte sui vasi una vera e propria trasposizione metaforica o riecheggiamento diretto di puntuali episodi politici a noi noti dalle fonti. È esemplare al riguardo il caso della lettura proposta da Boardman della famosa anfora di Oxford del Pitto-re di Priamo, da Cerveteri (Fig. 1) 18, con il tema di Eracle su carro accompagnato da Atena, che riporta nello spazio tra i volti dei due personaggi l’iscrizione Herakleous kore, intesa dallo studioso come epiteto della dea, «figlia di Eracle», sottintendendo, in uno stretto intersecarsi del piano mitologico con quello metaforico, un rimando a Phye, nuora di Pisistrato, la donna che, secondo il racconto di Erodoto, si sarebbe travestita da Atena guidando il carro sul quale Pisistrato, novello Eracle (secondo Boardman), avrebbe fatto ritorno ad Atene dopo il primo esilio 19.
Non starò in questa sede a ripercorrere le diverse e articolate argomentazioni addotte da Boardman in una serie di articoli pubblicati tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso e più di recente ancora in The history of Greek vases 20, né proverò a riassumere le nette riserve e le serrate critiche apportate ad alcuni aspetti o all’intera impostazione metodologica dello studioso inglese da alcuni colleghi 21 – a cominciare da Bažant, Osborne, Moon, Cook e Block, e poi, più di recente, Brandt e Rosati 22 –, o infine le integrazioni, correzioni o varianti inter-pretative più o meno efficaci o felici proposte da altri studiosi su una più o meno comune linea metodologica con Boardman – penso in primo luogo ai diversi contributi di Shapiro 23, ma anche a Williams 24 e, per l’ambiente italiano, alla Angiolillo 25. Proverò soltanto a riformulare il problema, non partendo da una confutazione, ma aprendo all’Occidente e cercando di abbrac-ciare un’ottica non unicamente incentrata sui produttori delle immagini, ma anche sui fruitori e i possibili destinatari di esse.
Per poter avviare tale riformulazione, è tuttavia necessario precisare e ricordare che, ac-canto al gruppo di documenti sinora illustrato e fatto oggetto di analisi da parte di Boardman, ovvero la serie di iconografie mitiche con possibili impliciti rimandi alla più o meno contem-poranea realtà politica, nelle quali accanto a Eracle e ad Aiace un ruolo primario svolgono anche le tematiche teseiche 26, vi sono poi quei pochi documenti vascolari (le rare scenes di
18 Beazley 1931a, tavv. 7.9, 8.5-6, 9.3; ABV, 331, n. 5; Boardman - Palagia - Woodford 1988, 809, n. 1423, tav. 538; Beazley Addenda2, 90 (con ulteriore bibliografia). 19 Boardman 1972, 64 ss.; 1996, 29-30, con esegesi in chiave ‘politica’ anche dell’iscrizione kalos Munichos che compare sul vaso insieme all’altra; inoltre, in sintesi, Angiolillo 1997, 136-137, con illustrazione e discussione delle diverse esegesi del vaso. Beazley (1931a) leggeva invece la didascalia come frutto dell’erronea contrazione di due differenti espressioni: Herakleous (al genitivo, sottintendendo «immagine di»), e Dios kore, epiteto ricorrente in riferimento ad Atena. Moon (1983b, 106) pensa invece che l’espressione vada letta come «aiutante di Eracle» (per il significato di kore su un vaso di Napoli dello stesso Pittore di Priamo, infra, nota 66); similmente Angiolillo (1997, 136), che a ragione interpreta «Atena (protettrice) di Eracle». 20 Boardman 2001, 202 ss. 21 Per alcuni richiami specifici, note supra e infra. 22 Bažant 1982; Osborne 1983-1984; Moon 1983b; Cook 1987; Blok 1990; Brandt 1997; Rosati 2002; si aggiunga inoltre, da ultimo, Santi 2010, 330 ss. 23 In particolare nello studio dei rapporti tra iconografia vascolare e attività di culto ad Atene sotto i ti-ranni (ma con presa di distanza, in alcune sedi, rispetto a un’idea della pittura vascolare come strumento diretto di propaganda politica): Shapiro 1980; 1981a; 1981b; 1982; 1983; 1984; 1989, 16-17 e passim; 1991; 1992; 1993; 1994; 1996; 1998. 24 Williams 1983, in cui gli Alcmeonidi sono considerati responsabili della diffusione di certi miti eraclidi come simboli politici sia prima dei Pisistratidi che dopo la caduta della tirannide; inoltre Williams 1986 e 2009. 25 Angiolillo 1997, 115 ss.; 2009. 26 Si vedano al riguardo, dopo Schefold 1946, Kardara 1951; Fink 1960; Shefton 1962; Friis Johansen 1969; Webster 1972, 82 ss., 252 ss.; Gauer 1980, in particolare 129 ss.; Boardman 1982; Shapiro 1982; Laurens 1986; Neils 1987, 148-151; Pollitt 1987; Shapiro 1989, 143 ss.; 1991; 1992; 1994; Neer 2002, 154 ss.; Servadei 2005, 202 ss.; Nadal 2007, 162 ss. Si vedano inoltre miti di minore popolarità, quali quello di Borea e Orizia, la cui diffusione sui vasi a partire dal 480-470 a.C. è stata messa in relazione con il presunto intervento di Borea in favo-re degli Ateniesi nella battaglia di Capo Artemisio (in sintesi Neer 2002, 164 ss., con bibliografia di riferimento a nota 101; inoltre Arafat 2002, 109-110; Massa-Pairault 2007, che interpreta il soggetto come un tema funzionale
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
100
Monica de cesare
Webster) 27, nei quali il collegamento con temi politici risulta forse più esplicito e immediato, almeno all’apparenza, come il piccolo gruppo di raffigurazioni dei tirannicidi (Figg. 9-11) 28 e anche la singolare immagine di Creso sulla pira dell’anfora del Louvre di Myson (500-490 a.C.; Fig. 16) 29. Inoltre, a completamento del quadro, che è necessario ricomporre, è opportuno aggiungere quella serie di testimonianze nelle quali la scrittura, le iscrizioni, hanno indirizzato verso un’interpretazione storicizzante della figurazione. Penso ad esempio all’oinochoe di Am-burgo della maniera del Pittore di Trittolemo, con la raffigurazione di un Greco che si appresta a sodomizzare un Persiano, al quale si associa l’iscrizione kubade esteka Eurumedon eimi («sto chinato, sono Eurimedonte»; 460 ca. a.C.; Fig. 4) 30, con rimando alla nota vittoria di Cimone, come espressione del trionfo sui barbari 31, o al caso ben più problematico dell’anfora del Pitto-re di Copenhagen (480-470 a.C.) 32, con la personificazione dello Strimone, insieme a Okeanos e Nilo nell’ambito della rappresentazione di Eracle nel Giardino delle Esperidi – collegata da Tiverios alla politica espansionistica dell’Atene cimoniana 33 –, o a quei vasi con iscrizioni che riportano nomi riconducibili a uomini politici noti dalle fonti, come per esempio la famosa pisside del 540-530 a.C. da Merenda con il nome di Stesagoras 34 (Fig. 5), il vincitore olimpico figlio di Cimone, secondo Immerwahr, Mommsen e Mackay 35. Quanto al piatto di Paseas da Chiusi conservato a Oxford (520 a.C.; Fig. 6), con arciere in costume orientale su cavallo e l’iscrizione Miltiades kalos 36, questo costituisce un caso ancora diverso, legandosi al problema del kalos (e dunque alle aristocratiche pratiche simpotiche) e considerando che non necessaria-mente il nome debba associarsi alla figura dipinta dal ceramografo 37, come anche l’iscrizione Hippokrates kalos su tre vasi del penultimo decennio del VI sec. a.C. (Fig. 7) 38.
all’interesse dei Filaidi nel Nord Egeo, ricordandone però la connessione anche con gli Eumolpidai); o ancora il tema dell’inseguimento di Egina da parte di zeus, la cui fioritura sui vasi attici (490-450/440 a.C.) è stata rappor-tata alle relazioni tra Atene e Egina (Arafat 1990, 78 ss.; 2002, 110 ss.). 27 Webster 1972, 74 ss. 28 Si tratta di nove vasi in tutto (infra), già al centro dell’attenzione di Beazley 1948 e su cui, da ultimo, si sono soffermati Oenbrink 2004 e Schmidt 2009. 29 ARV 2, 238, n. 1; Devambez 1954; Beazley Addenda2, 201; Laurens 1989; Denoyelle 1994, 120-121 e 193, n. 55 (con ulteriore bibliografia); Arafat 2002, 107-108. 30 Schauenburg 1975; Pinney 1984. 31 Neer 2002, 164 ss., che parla per la figurazione di tale vaso di immagine che esprime i valori caratteri-stici del V sec. a.C., riassumibili nell’anti-Medismo e nei privilegi maschili, oltre che nell’autoctonia; lo studioso cita a tal proposito anche la famosa coppa del Pittore di Oxford-Brygos, con la raffigurazione della lotta tra Greci e Persiani, da lui identificati con i combattenti nella battaglia di Platea. Si vedano inoltre Arafat 2002, 101-104; Kilmer 2002, 135 ss.; Giuman 2007, 128-129 a proposito dell’immagine del barbaro nell’Atene del secondo quar-to del V sec. a.C.; Cohen 2010, 168-169. 32 Cahn 1988; Tiverios 1991; Cahn 1994, 32, n. 4, tav. 22; Weiss 1994, 815, n. 1, tav. 577 (con rimandi interni). 33 Tiverios 1991; si vedano anche Cromey 1991, 166 nota 6; Shapiro 1992, 32. 34 Già attribuita a Exekias (ARV 2, 1699 e con più cautela Beazley Para., 61), è stata ora espunta dalla produzione di tale ceramografo: Mackay 2010, 347 nota 148, e 353, n. X3, tav. 80 (con bibliografia). 35 Sulla discussa identificazione di tale personaggio: Immerwahr 1972, 184, che parla di «gift to a member of the Philaid family»; Moore 1980, 433 nota 128, con menzione di Hdt. 6.103; 1986, 114 nota 55; Shapiro 1981b, 174; 1989, 157, che la considera una «special commission»; Mommsen 2002, 32-38; Mackay 2010, 353. Analo-go l’indirizzo interpretativo esercitato sull’anfora di Monaco dall’Italia meridionale, con la raffigurazione di un auriga denominato Alkmeon, ricollegato all’Alkmeone, figlio di Megacle che per primo vinse la corsa dei carri a Olimpia nel 592 a.C.: ABV, 401, n. 6; Cromey 1991, 166 nota 6. 36 Beazley 1927, tav. I.5; ARV 2, 1061; Beazley Para., 337; Beazley Addenda2, 182; Cromey 1991, 166 nota 6; Neer 2009, 206-207. 37 Così Neer 2009, 206. 38 Anfora di Psiax con Eracle su carro: ABV, 294, n. 23; Lullies 1956, tavv. 153.1-2, 154.1-4, 188.1; Beazley Addenda2, 77; anfora del Gruppo delle Tre linee con Eracle su carro: ABV, 321, n. 9; Beazley Addenda2, 86; hydria della maniera del Pittore di Lysippides con donne alla fontana (Fig. 7): Walters 1931, III He, tavv. 88.3 e 91.1; ABV, 261, n. 41, e 667; Beazley Addenda2, 68. Sulla interpretazione delle iscrizioni su tale gruppo di vasi: Webster 1972, 61-62; Shapiro 1980; Immerwahr 1990, nn. 144 e 1169; si veda anche Boardman 1972, 66. Sui problemi poi di cronologia dell’Onetorides kalos che compare su tre vasi di Exekias (tra cui sull’anfora del Vaticano con Achille e Aiace giocatori di dadi), da ultimo, Mackay 2010, 384-386, con richiamo alla tesi di Slater 1999 sul kalos come strumento di pubblicità per un membro di una famiglia cliente e protettrice di una bottega. Si veda infine, sul-l’Hipparchos kalos, da ultimo, Neer 2009.
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
101
Pittura vascolare e Politica ad atene e in occidente
La prima precisazione da fare, a mio avviso, per affrontare correttamente tutta questa massa di documentazione, è quella di focalizzare i termini della questione e gli interlocutori del mondo delle immagini veicolato dai vasi: ci sono gli artigiani attici, i pittori e i vasai, ci sono gli acquirenti dei vasi, Ateniesi e non, ci sono gli oggetti, i vasi con i loro aspetti funzionali valorizzati nei diversi contesti, ci sono le immagini dipinte con i loro meccanismi di produzione e il linguaggio delle immagini condiviso con altri media, e c’è il politico in senso lato che rifun-zionalizza il mito per costruire messaggi ideologici identitari legando la sfera politica a quella religiosa, cultuale, artistica.
Per quanto riguarda gli artigiani, è opportuno chiedersi se è possibile ipotizzare un dialo-go di essi con il politico 39, aspetto che necessariamente richiede una definizione dello statuto dell’artigiano nell’Atene del VI e V sec. a.C., un annoso problema ancora di fatto irrisolto, che si associa, tra gli altri, a quello delle firme apposte sui vasi, sempre più interpretate in relazione anche alla clientela oltre che in rapporto a ceramisti e ceramografi 40. Sullo status sociale degli artigiani di recente la critica si è orientata in direzione di una rivalutazione di esso 41, sino a postulare l’ipotesi limite della presenza di aristocratici nel Kerameikos ateniese 42. Tale stretto contatto tra artigiani e aristocrazie potrebbe essere anche supportato dai diversi potter-portraits su vasi dei Pionieri 43, che ritraggono se stessi in contesti aristocratici di simposi; tali immagini ambigue potrebbero rimandare piuttosto, secondo la recente ben argomentata ipotesi di Neer, a «fantasy-image for elites within the drinking group», rispecchiando aspirazioni ‘sovversive’ di un gruppo di artigiani di chiara fama esplicitate in un «imaginary symposium of equals» 44, o forse preferibilmente rappresentare un’immagine di promozione non solo del proprio status, ma anche della propria ‘arte’ e del ruolo di essa nel contesto aristocratico del simposio, sempre comunque configurandosi non come proiezioni di una realtà, bensì come costruzioni fanta-stiche, concettuali, al pari dell’immagine della bottega di ceramisti incoronati da Atena sulla kalpis del Pittore di Leningrado 45, dove però la techne è più esplicitamente esibita 46.
Rimane a tutt’oggi difficile dunque stabilire, sulla base della documentazione a nostra disposizione, un possibile contatto diretto tra gli artigiani e la classe politica ateniese, pur ammettendo la possibilità di special commissions 47 e riconoscendo l’inserimento di pittori e vasai all’interno di un contesto storico-politico, religioso, monumentale e culturale in senso lato riecheggiato e tangente al mondo delle immagini dipinte sui vasi; si pensi infatti che, se non l’artigiano, certo il vaso, come gli stessi Pionieri ci ricordano con i loro autoritratti, veniva comunemente in contatto con l’ambito simpotico 48, che è uno dei luoghi del ‘politico’, intera-
39 Già Moon 1983b, 97; Brandt 1997, 315. Si veda inoltre, su tale problema, Stissi 1999, 88-89. 40 Viviers 2002, 80; 2004; 2006. Già Williams 1995, 157, in cui si richiama il ‘potenziale’ degli acquirenti privati; così Laurens 1995, 163. Villard (2002, 782) ritiene che «variations que l’on peut esquisser dans la signi-fication des signatures pourraient correspondre à des variations dans la nature de la clientèle». Di contro, da ultimo, Villanueva Puig 2007. 41 Birchler Émery 2008; Williams 2009, con una rivalutazione dell’aspetto figurativo della nudità. Sul livel-lo culturale elevato poi di certi pittori, indiziato da un uso della scrittura nell’imagerie vascolare: Schmidt 2005, seppure per un contesto più tardo (Pittore di Dario). 42 Così Williams 1997 e Kreuzer 2009 sulla possibile coincidenza tra la persona del Pittore di Kleophrades e Megakles. L’ipotesi è suggerita da uno skyphos molto frammentario di tale pittore con l’iscrizione lacunosa MEGA[…] posta di fronte a una figura maschile seduta (Agamennone secondo Williams). L’iscrizione è stata interpretata da Beazley come il nome del kalos, Megacle, e invece ricondotta da Williams, per l’assenza di ogni traccia della parola kalos e per l’incongruenza cronologica con il Megakles kalos dipinto dai Pionieri (Phintias e Euthymides) e più tardi dal Pittore di Kleophon e dal Pittore di Oreste, alla firma del pittore o del vasaio, conclu-dendo che il reale nome del Pittore di Kleophrades doveva essere Megacle. 43 Neer 2002, 87 ss.; si veda anche, da ultimo, Catoni 2010, 296 ss. 44 Neer 2002, 106; analogamente, seppure con sfumature diverse, Catoni 2010, 333. Si veda anche a tal proposito, Shapiro 1981a, che ritiene che la perdita in popolarità tra il 510 e 480 di tali scene di corteggiamento rappresenti la reazione contro le classi aristocratiche in associazione con i Pisistratidi, nel contesto della nuova democrazia clistenica e specialmente durante il movimento post-persiano attraverso la democrazia radicale. 45 ARV 2, 571, n. 73; Beazley Addenda2, 261; Sena Chiesa - Arslan 2004, 120, n. 100. 46 Si veda Catoni 2010, 359-361; analogamente, a proposito dei vasi con la raffigurazione di donne alla fontana, Ferrari 2003, 49 ss. 47 Webster 1972, 42 ss.; da ultimo, sulla questione, de Cesare c.s. (con bibliografia recente di riferimento). 48 Catoni 2010, 214-215.
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
102
Monica de cesare
gendo con esso come con la pratica religioso-cultuale e rituale. L’artigiano inoltre dialoga – è oggi dato acquisito – con gli acquirenti, siano essi politai ateniesi, appartenenti a una classe o a una fazione politica locale, o anche consumatori stranieri, orientando la sua produzione sulla base della predilezione per certi temi figurativi di fasce diverse di mercato 49.
È opportuno dunque, quando si avviano analisi statistiche sulle immagini, tenere in conto il luogo (e anche il contesto, naturalmente!) di rinvenimento dell’oggetto, qualora noto, come già suggerito a suo tempo da Warren Moon 50, considerando che certamente non si può pensa-re solo a un «second-hand market» per le ceramiche attiche destinate all’esportazione 51. È da rilevare, per esempio, che praticamente tutti i vasi decorati con scene che ritraggono Eracle su carro accompagnato da Atena provengono dall’Etruria 52, in particolare da Vulci (possibilmen-te da contesti funerari); questo dato senz’altro deve essere letto anche in rapporto alla storia dei rinvenimenti dei vasi attici e alla casualità di essi, ma ugualmente stimola a interrogarci se die-tro la diffusione di tale tema, al di là delle allusioni a realtà politiche locali, non si celi anche un motivo più semplicemente connesso con il valore eroizzante (fors’anche a sfondo escatologico) del soggetto, come anche Christoph Reusser suggerisce 53.
È utile inoltre ricordare l’aspetto funzionale di questi vasi, che un’ottica unicamente in-centrata sulle immagini sembra svilire o mettere in ombra. Non è dato da trascurare infatti, a mio avviso, che la maggior parte delle scene di partenza di Eracle su carro siano dipinte su an-fore o vasi per il simposio, o che il tema delle donne alla fontana – altro soggetto ricollegato ai Pisistratidi, comparendo in pittura vascolare a partire dal 530 a.C. (Figg. 7-8) 54 – decori quasi unicamente hydriai, un tipo di vaso notoriamente di pertinenza femminile, al centro peraltro della celebrazione degli Hydrophoria, nell’ultimo giorno delle Antesterie, come ricorda Erika Simon a proposito delle hydriai decorate con questo soggetto 55; o ancora, che i ‘ritratti’ di pittori o vasai compaiano esclusivamente su vasi collegati con il simposio; o infine, che il tema dei Tirannicidi sia dipinto alla fine del V sec. a.C. su tre choes (una delle quali proveniente dal cenotafio di Dexileos; Fig. 11) 56, vasi comunemente usati nelle Antesterie, tralasciando la signi-ficativa testimonianza offerta dall’episema dello scudo di Atena dipinto su tre anfore panatenai-che del 403-402 a.C. (Fig. 12) 57, l’unico caso che, per la funzione ufficiale del vaso, potrebbe
49 Come ricorda Moon (1983b, 113), un «essential economic factor» doveva orientare l’industria ceramica ateniese. Su tale aspetto si veda de Cesare 2008. Ma già Boardman (1978a, 11-12), che precisa: «[…] the market determines the product, but the market can be conditioned and instructed». 50 Moon 1983b, 97. 51 Su tale teoria, formulata da Webster 1972, 293, 298, e discussa a più riprese, di recente, in sintesi, Reusser 2002, 10 (con bibliografia di riferimento); si veda inoltre, da ultimo, Mackay 2010, 2-3, 215-216 e 386, a proposito della testimonianza del dinos di Villa Giulia di Exekias da Cerveteri, con l’iscrizione «Epainetos mi ha donato a Charopos», per cui infra; infine, sul problema dell’uso o riuso dei vasi attici in Occidente: Catoni 2010, 119-120. 52 Un elenco delle occorrenze del tema in Brommer 1956, 94 ss. Si veda inoltre, a tal proposito, Moon 1983b, 106 e 113-114. 53 Reusser 2002, 180-181; si veda anche de La Genière 1999, 17-19, con presa di distanza dalla lettura po-litica di Boardman del tema. Alla predilezione per i cavalli e per i carri da parte dei compratori appartenenti alla classe aristocratica pensa Moon (1983b, 98), per giustificare la diffusione del soggetto; inoltre ivi, 106, sul valore eroizzante del tema. Si vedano anche Scheibler 1987, 95-96; Torelli 2007, 60-61, ripreso in Santi 2010, 334. 54 Infra, nota 61. 55 Simon 1983, 99, che riprende Diehl 1964, 128-133, con richiamo in particolare all’hydria di Londra (Fig. 8) con donne alla fontana alla presenza di Hermes e Dioniso (ABV, 333, n. 27; Beazley Addenda2, 90); si vedano inoltre Moon 1983b, 109-110; De Simone 2008. Di recente, su tale tema figurativo e in particolare sul pro-blema dell’identità sociale delle figure rappresentate, sono intervenuti anche Pfisterer-Haas 2002, 7 ss.; in sintesi (con bibliografia completa di riferimento), Iozzo 2003, richiamando anche la provenienza etrusca della maggior parte di tali vasi; Shapiro 2003; Ferrari 2003, 44 ss.; Kosso - Lawton 2009. 56 Schmidt 2009, 227 ss., figg. 9, 16 e 17 (con bibliografia di riferimento alle note 26, 48 e 49); si veda anche Oenbrink 2004, 38 ss.; l’autore osserva inoltre che le prime raffigurazioni del tema compaiono su vasi destinati al simposio connettendo l’immagine con l’ambiente aristocratico (infra, nota 72); su tale punto anche Schweizer 2006, 302. 57 de Cesare 1997, 69-70, nn. 427-429; Bentz 1998, 50 e 158, nn. 5.239, 5.244e 5.245, tavv. 95-97 (con bibliografia); Schmidt 2009, 228 nota 29 e fig. 10.
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
103
Pittura vascolare e Politica ad atene e in occidente
realmente caricarsi di più puntuali significati politici, evocando possibilmente la caduta dei Trenta Tiranni ad Atene nel 403 a.C. 58.
È pur vero che la figurazione dipinta sui vasi è frutto di meccanismi produttivi, in cui la scelta di soggetti e schemi iconografici poteva derivare anche da impulsi esterni accolti dai ceramografi, quali esperienze visive legate alla realtà monumentale ateniese, al teatro, alla vita civica (cultuale e politica) della polis in cui gli artigiani vivevano 59. Se può, per esempio, essere plausibile che nell’iconografia delle donne alla fontana l’edificio raffigurato, qualificato in due casi da iscrizioni come Ka(l)li(r)rhoe e Kalirhe krene (Fig. 7) 60, possa ritrarre la monumentale fontana della polis ateniese ricordata dalle fonti anche in rapporto ai Pisistratidi e usata peral-tro durante i riti sacri delle Antesterie, non necessariamente si deve però concludere che tali raffigurazioni, data la presenza dell’edificio e l’esplicito riferimento per esso alla Kallirrhoe, siano il frutto di un voluto «richiamo all’opera dei tiranni», così come sostenuto da Boardman e poi ancora da Eva Keuls e più di recente dall’Angiolillo 61. Un collegamento in tal caso con una realtà cultuale locale, quale quella delle Antesterie (o piuttosto con qualche altra pratica ri-tuale collettiva di tipo iniziatico?), richiamata da Erika Diehl e dalla Simon, e ripresa di recente con nuovi argomenti da Ferdinando De Simone 62, ci sembra senz’altro più plausibile e meno contorto.
I recenti orientamenti del dibattito sul linguaggio per immagini, sviluppatosi dalla vec-chia disamina del rapporto tra pittura vascolare e produzione letteraria, hanno poi chiarito che dietro la tradizione figurativa vi è un sottofondo nutrito di oralità e formule visive, alla base anche della meccanica della comunicazione teatrale come delle ritualità religiose 63. A tal proposito quindi ci potremmo chiedere se il famoso rientro trionfale ad Atene di Pisistrato con la mascherata di Phye nei panni di Atena, riecheggiato più o meno esplicitamente secondo Boardman sui vasi dipinti con Eracle su carro accompagnato da Atena, non debba interpretarsi all’inverso come l’appropriazione da parte del tiranno di un linguaggio visuale ben compren-sibile agli Ateniesi, usi a personificazioni rituali di dei nei cerimoniali religiosi e nelle perfor-mances rituali – come suggerito da Sinos 64 –, ma anche forse già avvezzi, attraverso la cultura figurativa, all’immagine e al tema di Eracle su carro con Atena – la cui posteriorità rispetto all’evento storico sembra del tutto da discutere – o semplicemente al soggetto figurativo della divinità che sale sul carro, certo ben anteriore alla vicenda pisistratea 65. Se ammettiamo tale ipotesi, il tiranno avrebbe sfruttato dunque i mezzi della comunicazione non verbale, attuando un meccanismo di evocazione di un exemplum mitico a scopo di legittimazione politica.
Quanto ai vasi, non bisogna poi dimenticare la tradizione di bottega, le convenzioni e formule figurative consolidatesi all’interno di un’officina, come ha ben dimostrato Moon a pro-posito del Pittore di Priamo, nella sua serrata e convincente confutazione di alcuni assunti del Boardman: è così che l’anfora con l’iscrizione Herakleous kore (Fig. 1), collegata macchinosa-mente con Phye, rientrerebbe semplicemente nell’uso del Pittore di Priamo di creare epiteti per i suoi personaggi dipinti, dei, uomini ed eroi 66.
58 Si rimanda al riguardo all’acuta analisi condotta di recente da Schmidt 2009; si vedano in proposito an-che Ajootian 1998, 8; Ober 2003, 226 e 239 ss.; Oenbrink 2004. Gli altri tre vasi che riportano tale soggetto sono costituiti da uno stamnos probabilmente dall’Etruria, da uno skyphos a figure rosse da Gela e da una lekythos a figure nere da Atene, tutti databili in età severa (infra), cui è poi forse da aggiungere un frammento di skyphos del Pittore di Pan da Agrigento (ARV 2, 559, n. 147); inoltre, sulle provenienze di questi vasi, Beazley 1948, 28. 59 Infra. Così già Boardman 1978a, 11. 60 Si tratta dell’hydria della maniera del Pittore di Lysippides, che riporta anche l’iscrizione Hippokrates kalos, per cui supra, nota 38, e di un’hydria di Atene (ABV, 677; Worshiping women, 310, n. 338, M. Giannoupou-lou). 61 Boardman 1974, 206; Keuls 1983, 210; Angiolillo 1997, 120-121. Si vedano anche Webster 1972, 62; Shapiro 1980; Hannestadt 1984; Pedley 1987, 76-77. 62 Supra, nota 55. 63 In sintesi, de Cesare 1997; Catoni 2005. 64 Sinos 1993. 65 Su tale punto Brandt 1997, 323-324; si vedano inoltre Angiolillo 2009, 93-94; Santi 2010, 334. 66 Kore è sinonimo di Atena su un vaso di Napoli dello stesso Pittore di Priamo (Moon 1983b, 106); supra, nota 19.
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
104
Monica de cesare
Temi e schemi figurativi, con i possibili significati politico-ideologici di cui si caricano, vanno dunque valutati in rapporto all’ambiente artigianale nel quale questi nascono e vengono impiegati e variati, oltre che in rapporto a una linea di tradizione. Emblematico, pur nella sua unicità, è il caso del tipo figurativo dei Tirranicidi, che si retrodata rispetto al gruppo scultoreo di Kritios e Nesiotes, configurandosi come il frutto di un processo di trasmissione e contamina-zione non soltanto di forme ma anche di contenuti politici, forse anche solo eroici; nel famoso gruppo statuario del 477 a.C. (Fig. 13) potrebbe riconoscersi non solamente una sorta di rifa-cimento del precedente gruppo di Antenore, ma anche una semplice e al contempo originale rielaborazione di formule o tipi preesistenti di combattenti (Eracle in primo luogo, ma anche Teseo), attestati dalla documentazione pittorica (Fig. 14) 67. Più esplicita sembra l’assimilazione Tirannicidi-Teseo sulle due coppe di Londra, l’una di Douris (480 a.C.), con Teseo contro la scrofa di Crommio e Teseo e Sini, e l’altra del Pittore di Codro, di qualche decennio più tarda (440 a.C.; Fig. 15), ancora con il ciclo di Teseo, entrambe da Vulci 68, nelle quali l’identifica-zione iconografica (e simbolica) tra Aristogitone e Teseo risulta sancita dall’identità di attributi dei due eroi e dalla ‘citazione’ della famosa opera scultorea, in un’Atene in cui i due tirannicidi erano diventati exemplum di virtù civica e simbolo dell’isonomia, pur appartenendo come ari-stoi al mondo aristocratico 69.
Eracle – l’eroe dei Pisistratidi per Boardman –, i Tirannicidi e l’eroe della nuova demo-crazia ateniese segnerebbero così, attraverso un gioco di contaminazioni formali e sostituzioni simboliche, una tradizione iconografica da un lato frutto di processi produttivi (vedi lo scor-poro e la ricomposizione dei due schemi di Armodio e Aristogitone sulle coppe succitate), dall’altro, soggetta a istanze politico-ideologiche e mitiche, recepite, forse solo in parte, o ri-funzionalizzate dall’ambiente di destinazione dei prodotti vascolari. I due tirannicidi sembrano essere assurti nell’immaginario ateniese a figure simboliche, entrando a far parte del mondo eroico 70; in questo senso dobbiamo fors’anche intendere la narrazione figurata dell’uccisione di Ipparco da parte di Armodio e Aristogitone sullo stamnos di Würzburg, del Pittore di Sy-riskos, probabilmente dall’Etruria (475 a.C.; Fig. 9) e sul frammento di skyphos di Villa Giulia (460-450 a.C.; Fig. 10), da Gela 71, precoci occorrenze del tema, in cui il fatto storico è narrato allo stesso modo in cui sono raffigurati altri eroi del mito (per esempio Oreste nell’uccisione di Egisto), sfruttando per i due tirannicidi non lo schema del gruppo statuario, ma tipi del comu-ne repertorio della pittura vascolare, e prediligendo l’aspetto narrativo e tragico dell’evento 72.
67 de Cesare 1997, 61 ss., che riprende Kardara 1951; si veda anche Shefton 1960, con menzione dell’Era-cle del cratere di Arezzo di Eufronio. Si veda infine Ermini 1997, 3 ss. 68 de Cesare 1997, 65-66, con bibliografia di riferimento alle note 125 e 126 e con menzione anche della coppa di Spina del Pittore di Pentesilea e della coppa di Madrid di Aison. 69 Shapiro 1994; Servadei 2005, 213. «Heroes of isonomia and symposium both» li definisce Neer 2002, 171, 175, e inoltre «secular heroes for the new democracy» (ivi, 180). Si veda infine, da ultimo, Jaccottet 2008, 46-49. 70 Neer (2002, 170) parla di «timeless heroic charge»; si veda anche Schweizer 2006, 298. In tale contesto sembra giustificarsi l’uso del tema sulla lekythos a fondo bianco del Pittore di Emporion (verosimilmente da un contesto funerario: de Cesare 1997, 211-212, n. 460, fig. 148, con bibliografia; Schmidt 2009, 227 nota 24); ma si veda anche infra, a proposito di una doverosa distinzione tra vasi pregevoli e prodotti seriali, con gradi differenti di consapevolezza nell’uso di temi iconografici. 71 Schmidt 2009, 221 nota 11, figg. 4 e 6, e 223 nota 18, fig. 5 (con bibliografia di riferimento). Per il fram-mento di skyphos da Agrigento, supra, nota 58. 72 Schmidt 2009, 222 ss. Di contro Neer (2002, 178) pensa che la mancata citazione o semplice rielabo-razione dell’iconografia del gruppo statuario, nonché la presenza del tiranno, omesso nel gruppo scultoreo come nelle più tarde raffigurazioni, rimuova in questo caso i tirannicidi dal mondo del mito, situandoli chiaramente all’interno della polis contemporanea e conclude: «[…] the assassination is not an isolated event, so to speak, but eminently civic: a deed performed in late Archaic Athens, before late Archaic Athenians» (ivi, 179). Si veda inoltre quanto osservato in Hölscher 1973, 87-88. Per il parallelo con l’iconografia di Oreste, si veda anche Petre 1997, in particolare 1214-1215, che ritiene lo schema dell’eroe del mito quale compare nella pittura vascolare atti-ca dei primi decenni del V sec. a.C. derivato da quello dell’Aristogitone (forse del gruppo di Antenore), ponendo l’iconografia vascolare all’interno di una riflessione sulla violenza politica. A noi sembra che Oreste abbia subito l’influsso dello schema dei Tirannicidi di Kritios e Nesiotes intorno al 470-460 a.C. (si veda il cratere di Boston del Pittore della Dokimasia) e che il nostro stamnos di Würzburg richiami piuttosto il vecchio schema dell’eroe, introdotto nella pittura vascolare attica all’inizio del V sec. a.C.: Gais 1981, 372 ss., nn. 6-13, tavv. 287-288. Su tale
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
105
Pittura vascolare e Politica ad atene e in occidente
Analogamente, sulla famosa anfora del Louvre di Myson, proveniente da una tomba di Vulci (Fig. 16) 73, il pittore, come sottolineato da Laurens 74, ha reso graficamente lo statuto speciale che possedeva Creso nell’immaginario greco, evocato anche dalle fonti letterarie 75. Immagine di sovrano quasi divinizzato, il re di Sardi, l’Orientale filelleno, che per associazione con la pira evoca l’immagine dell’apoteosi di Eracle 76, è abbinato all’eroe di Atene, Teseo (con Piritoo nel ratto dell’Amazzone Antiope, sul lato B del vaso), forse, come ragionevolmente pensa Boardman 77, a effigie della Grecia in lotta contro la Persia, in un’ottica tutta ateniese, che sembra anche collegare regalità e isonomia. Ma l’immagine può evocare anche aspettative eroizzanti e salvifiche, se dall’ambiente di produzione dell’immagine ci spostiamo a quello fu-nerario etrusco di utilizzo della stessa.
È inoltre opportuno distinguere rigorosamente tra una produzione vascolare di massa, presumibilmente frutto di procedimenti meccanici di scelta e d’uso delle immagini e di un utilizzo generalmente inconsapevole di formule iconografiche, da prodotti più ricercati e pre-gevoli, nati dalle mani di artigiani più creativi e meno prolifici, quali per esempio Exekias, e ve-rosimilmente destinati a élites più che a una middle-class maggiormente ricettiva nei confronti di prodotti più seriali 78. A questo proposito, si potrebbe osservare che alcune delle iconografie di età arcaica variamente ricollegate in letteratura a tematiche politiche derivino proprio da Exekias.
Sarebbe interessante vagliare in maniera più approfondita tutta la produzione pittorica di questo artigiano, tanto attento agli aspetti psicologici dei suoi personaggi mitici, in rapporto anche ai contesti – quelli noti – di rinvenimento dei suoi prodotti; il recentissimo volume di Anne Mackay, dal promettente titolo Tradition and originality: a study of Exekias, con un’ac-curatissima disamina di tutta la produzione figurativa di tale ceramografo, liquida a mio avviso un po’ troppo frettolosamente il problema dei contesti di rinvenimento, pensando all’Etruria come un «second-hand-trade» sulla base del dinos di Villa Giulia da Cerveteri, con l’iscrizione in alfabeto sicionio voluta dal presunto acquirente greco 79. Mi limiterò qui ad alcune osserva-zioni che derivano proprio dall’analisi di certi contesti.
È stata più volte sottolineata la predilezione di Exekias per Aiace, giustificata pensando a una provenienza del ceramografo da Salamina, patria dell’eroe, e variamente ricollegata alla guerra fra Atene e Megara per il possesso dell’isola, al tempo di Pisistrato 80, o piuttosto a un rapporto tra il pittore e i Filaidi, potente genos che vantava legami genealogici con l’eroe 81; tale predilezione si concretizza soprattutto nell’ideazione del tema del suicidio di Aiace – di recente letto da Joseph Basile come espressione degli ideali della aristocrazia messi in pericolo da una tirannide che cercò di consolidare il suo potere con il supporto popolare 82 – e soprattutto nella creazione del tema di Achille e Aiace che giocano ai dadi (Fig. 3a), del tutto estraneo alla tradizione letteraria 83. Come già ricordato, Boardman ha riconnesso l’ingresso di quest’ultimo
assimilazione si veda anche Oenbrink 2004, 384-385, in cui queste prime raffigurazioni del tema sono lette come espressione della reazione del ceto aristocratico al regime tirannico; infine Schweizer 2006, 302-303. 73 Supra, nota 29. 74 Laurens 1989, 80. 75 Duplouy 1999. 76 Devambez 1954, 116; Laurens 1989, 79 e 80-81. 77 Boardman 1982, 16 (in cui si considera il vaso una «special commission»); si veda inoltre Gauer 1980, 132. 78 Su tale aspetto, de Cesare 1997, 210-211; si veda anche Moon 1983b, a proposito del Pittore di Priamo. Inoltre, per il tema dei Tirannicidi: Ermini 1997, 1. 79 Supra, nota 51. Sul rapporto dei temi figurativi dipinti da tale pittore con la realtà politica a lui contem-poranea: Mackay 2010, 383 ss. 80 Boardman 1978a; di contro, Williams 1980. Si vedano anche Moore 1980, in particolare 433-434; 1987, 158 e 160. 81 Shapiro 1981b; 1989, 154-157. Si veda anche Angiolillo 1997, 126 ss., in cui si collega l’iconografia al-l’«avvenuta alleanza tra i Pisistratidi e il potente genos dei Filaidi» (ivi, 129). 82 Basile 1999, 21. Sull’anfora con il suicidio di Aiace, da ultimo Mackay 2010, 243 ss., n. 21, tavv. 58-59 (con bibliografia di riferimento). 83 Sulla famosa anfora del Vaticano, da ultimo, Mackay 2010, 327 ss., n. 32, tavv. I e 76c-78 (con bibliogra-fia di riferimento); il tema ricompare tra la produzione del nostro pittore, su un’anfora frammentaria proveniente
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
106
Monica de cesare
tema nel repertorio figurativo vascolare al brano di Erodoto 84 relativo alla vittoria di Pisistrato a Pallene e al suo ritorno ad Atene nel 546 a.C., in seguito alla mancata vigilanza degli Ateniesi, pensando che il soggetto dovesse rappresentare un monito a non abbassare mai la guardia contro la tirannide, secondo una lettura anti-pisistratea; sempre su una linea di esegesi politica, Difry Williams rovescia l’interpretazione pensando piuttosto a un manifesto di propaganda di Ippia e Ipparco, volto a celebrare l’astuzia del padre e a riaffermare i loro diritti alla successio-ne 85. Rifiutando in partenza simili interpretazioni ‘propagandistiche’, con rimandi troppo pun-tuali a contingenze politiche, richiamo semplicemente il valore simbolico di questi due eroi – e soprattutto di Achille, il prototipo degli eroi – come exempla di arete, espressione di società a carattere aristocratico. Ricordo anche che, a cominciare dall’anfora del Vaticano di Exekias, molti dei vasi con tale soggetto, per i quali abbiamo indicazioni circa il luogo di ritrovamento, provengono da Vulci e in generale dall’Etruria, oltre che dalla Sicilia, soprattutto da Gela e Selinunte 86. In particolare, per quanto attiene Selinunte, due vasi provengono dal santuario della Malophoros 87, cui sono da aggiungere un’anfora a profilo continuo quasi integra dall’area del tempio E (Gruppo E), oggi esposta al Museo Salinas di Palermo 88, una lekythos del Pittore di Atena 89 e fors’anche tre lekythoi (Classe di Atene 581 e bottega del Pittore della Megera) della Collezione Mormino del Banco di Sicilia di Palermo, se ammettiamo una provenienza selinuntina per la maggior parte delle ceramiche di tale collezione 90; questi vasi potrebbero richiamare – in un’ottica coloniale, ribaltata rispetto a quella ateniese, se accettiamo una va-lenza politica del mito fatta propria dalle botteghe attiche – il legame di Aiace con Salamina e Megara, la madrepatria della colonia selinuntina 91.
Il caso selinuntino testimonia la necessità di abbinare un’analisi del contesto socio-cultu-rale in cui un’iconografia è formulata e impiegata, a una lettura dell’immagine in rapporto al contesto d’uso o di destinazione del vaso 92; è opportuno dunque considerare tanto i temi di interesse degli artigiani, quanto le aspettative dei compratori e dei lettori delle immagini dipin-
dall’Italia e probabilmente con la stessa associazione figurativa con i Dioscuri, come sul lato B dell’anfora del Vaticano: ivi, 311 ss., n. 30, tav. 73 (con bibliografia); supra, nota 16. 84 Hdt. 1.63.1. 85 Supra, nota 80. 86 Kossatz-Deissmann 1981, 96-103; 2009, 6. In particolare, dalla Sicilia, da Gela: frammento di lekythos a figure nere (Beazley Para., 238); coppa della Maniera del Pittore di Haimon (Panvini 2003, 223, fig. 117); cratere del Pittore di Efesto (de Cesare 2008, 120, fig. 9, e 123 nota 59, con bibliografia); da Agrigento: due lekythoi della Classe di Atene 581 (Calderone 1985, tav. 69.3-4; Veder greco, 152, n. 34); da Vassallagi: frammento di lekythos a fondo bianco della fine del VI sec. a.C. (Griffo 1987, 264); da Lipari: lekythos della Classe di Atene 581 (Beazley Para., 238); genericamente dalla Sicilia: coppa del Leafless Group (ABV, 646, n. 200, e 653, ma con indicazione dubbia di provenienza). Per le attestazioni selinuntine, infra. Si osserva che spesso il tema di Achille e Aiace giocatori di dadi si associa sul lato B del vaso a soggetti dionisiaci e talvolta al tema del komos o del simposio: l’associazione sembra alludere al significato del vino e del gioco, attività simposiache, quali complemento ai valori guerreschi aristocratici, ovvero al valore omologo di simposio, attività agonale e guerra nell’ambito della società aristocratica; in proposito si veda anche Mackay 2010, 348 (in relazione al lato B dell’anfora del Vaticano). Più ricorrente l’associazione con il tema della guerra, nella quale si può leggere un rimando eroizzante ai modelli miti-ci. Raro risulta invece l’abbinamento con il tema di Eracle e Atena su carro e con quello delle donne alla fontana. Attestata infine, anche se in maniera sporadica, l’associazione con le imprese di Eracle. Per il tema dei Dioscuri si veda infine supra, nota 16. 87 Paoletti 1996, 133 (frammento di anfora a profilo continuo, Gruppo E); Greco - Tardo 2009, 680-681e 682 (lekythos a fondo bianco con firma Ioilos epoiesen), con richiamo anche alla valenza del mito in relazione al le-game colonia-madrepatria; si veda pure de Cesare 2003, 116, a proposito della lekythos di Palermo, già Collezione Crisafulli, del Pittore di Atena, con lotta tra Aiace e Odisseo per il possesso delle armi di Achille alla presenza di Agamennone, analoga a un esemplare della Collezione Mormino di Palermo. 88 Gullini 1983, 106 nota 17: su lato B, «Partenza dei guerrieri troiani per la battaglia, con la figura di Priamo, al centro della scena»; l’anfora è in corso di studio e di pubblicazione da parte di A. Villa. 89 Haspels 1936, 258, n. 89. 90 Giudice et al. 1992, nn. D76, D102 (Classe di Atene 581), D239 (Scuola del Pittore della Megera). 91 Supra, nota 87. 92 Già Beazley (1948, 28), a proposito dei vasi con la raffigurazione dei Tirannicidi trovati in Sicilia, os-servava: «The Agrigentine who bought the glaux by the Pan Painter, the Gelan who bought our skyphos and dedicated it to the hero-founder of the city: did they think of them merely as handsome Attic vases? or had they also Emmenids, and Deinomenids, in mind?».
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
107
Pittura vascolare e Politica ad atene e in occidente
te sui vasi, partendo dall’idea dell’esistenza di un rapporto dialettico tra produttori e consuma-tori, anche sul piano delle tematiche figurative 93. Se il contesto di produzione infatti non può dare sempre risposte certe circa gli intenti ‘ideologici’ alla base delle scelte dei temi, talvolta più espliciti risultano i dati forniti dai contesti d’uso e di fruizione, che possono in certi casi aiutare anche a capire le motivazioni alla base della diffusione di un determinato soggetto e di una particolare variante figurativa nell’ambito dell’artigianato attico.
Un caso degno di attenzione è senz’altro fornito da certi contesti etruschi, per i quali si ipotizza una sovrapposizione tra formulazioni degli artigiani ateniesi e ricezione di esse da par-te degli ambienti allogeni, un aspetto di recente indagato da Françoise-Hélène Massa-Pairault e da Cristiana zaccagnino a proposito dei messaggi ideologici esplicitati sulla ceramica espor-tata nell’area etrusca, in particolare in ambiente spinetico 94, spia di una sorta di omologazione locale ai modelli elaborati ad Atene. Un fenomeno che sembra essere testimoniato anche dalla diffusione dei temi teseici, in un processo di ‘atticizzazione’, registrabile in età classica e su cui si è fermata da ultimo Eliana Mugione 95.
Un altro caso interessante, ricco di sfumature diverse nel suo processo di elaborazione e diffusione, è rappresentato dal mito di Trittolemo (Figg. 2 e 17), carico di significati stori-co-religiosi e politici, simbolo della missione civilizzatrice di Atene e dunque funzionale alla legittimazione della politica ateniese, ma anche espressione di una cultualità demetriaca, varie-gata nei suoi aspetti ideologici e tradizionalmente sfruttata dalle tirannidi a fini politici, per il «mantenimento di strutture sociali stabili» 96, così ad Atene, nella forma di culto eleusinia, co-me nel l’Occidente, nella forma tesmoforica 97. L’analisi condotta da Anna Calderone e Alfonsa Serra sulla diffusione di tale mito in Occidente e sulle variazioni iconografiche manifestate dal tema nella ceramica attica, ha efficacemente dimostrato come le diverse aree culturali e politi-che dell’Occidente che hanno recepito il soggetto così come dipinto sui vasi hanno valorizzato alcuni aspetti rispetto ad altri della vicenda, anche in rapporto ai contesti d’uso degli oggetti 98; spingendoci oltre, si potrebbe ipotizzare che i ceramografi attici abbiano a loro volta orientato la loro produzione, creando variazioni nello schema figurativo o abbinando il soggetto a temi dif-ferenti al fine di sottolineare sfumature diverse del mito, sulla base di tali esigenze di mercato 99.
In conclusione, rifiutando un approccio che ravvisi un meccanico e diretto rapporto di filiazione del mito dipinto sui vasi da eventi reali, nonché direttive politiche alla base di certe scelte tematiche dei pittori vascolari e dell’evoluzione iconografica di un soggetto, che tra l’al-tro non rendono ragione anche degli sviluppi cronologici della vita e della fortuna di un ciclo o episodio mitico nella ceramica figurata 100, ci sembra più opportuno fermarci a un primo livello di ricezione o interpretazione ‘politica’ ovvero ‘civica’ 101 dei miti in immagine, in cui
93 Così Mugione 1997 e 2000, nel contesto di una analisi del repertorio figurativo mitico nella produzione vascolare italiota e siceliota, su cui anche Pouzadoux 2005. 94 Massa-Pairault 2007; zaccagnino 2007, a proposito del cratere del Pittore di Bologna 279 da Spina con i Sette a Tebe, ma ancora con uno schema interpretativo incentrato sul concetto di ‘propaganda’. Si vedano inoltre Massa-Pairault 1998, 150 ss.; Menichetti 2007, a proposito del mito di Thamyris. 95 Mugione 1997, in particolare 118. Ben diverso è il quadro per l’età arcaica, in cui l’introduzione dell’i-conografia di Teseo in Occidente, in particolare in Etruria, è stata interpretata piuttosto in relazione alla sua va-lenza di mito della regalità funzionale al processo di strutturazione delle poleis arcaiche (Menichetti 1994, 109 ss.; Mugione 1997, 111). 96 Calderone 1992, 38. Sul collegamento stabilito da Boardman tra l’ingresso del tema nella pittura vasco-lare attica e il legame dei Pisistratidi con il santuario eleusinio, supra, nota 14. 97 Calderone 1992, 38-39. 98 Calderone - Serra 2004, con analisi del soggetto in rapporto alla decorazione del lato B dei vasi presi in esame. Sui contesti occidentali di ricezione del tema è incentrato anche il più recente studio di Pierre 2008. 99 Si veda anche al riguardo de La Genière 1995, 1016, 1017 e 1019. Si ricordi poi che, tra le prime raf-figurazioni del mito, c’è l’anfora della maniera di Exekias, proveniente da Locri (Fig. 2): Calderone - Serra 2004, 242, n. 51 (con bibliografia di riferimento). Per quanto attiene alla Sicilia, un altro caso forse analogo è costituito dal mito di Filottete, che meriterebbe ulteriori approfondimenti: spunti in Nenci 1991, 134-135. 100 Servadei 2005, 204-205. Contro un significato propagandistico, si è espresso di recente anche Neer 2002, 181, a proposito delle raffigurazioni di Teseo e dei Tirannicidi. 101 Così Boardman 1996, 19, in cui si specifica che per «politico» si intende ciò che ha a che fare con la polis, «rather than political parties or personalities».
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
108
Monica de cesare
una figurazione o un personaggio dipinto su un vaso possa solo evocare contesti e contenuti politici e sociali dominanti, pur anche promossi da una classe o da un uomo politico, contenuti identitari di cui la polis è compenetrata e si riveste, secondo un modello canonizzato da Tonio Hölscher 102. Si tratta dello stesso rapporto di autonomia creativa che intercorre tra pittura va-scolare e tradizione letteraria, ossia un rapporto nutrito di un sottofondo comune, ma mai con-figuratosi come una filiazione diretta 103, in una convergenza di temi e valori politici e sociali, nella quale un ruolo vincente giocano la malleabilità del mito, la polivalenza dell’immagine 104 e la transizione fluida tra mito e realtà 105.
E a tal proposito, per tornare a uno dei primi anelli di questa catena esegetica in chiave simbolica che ho qui ripercorso, mi piace concludere citando una frase di Pottier, che solo agli inizi del Novecento acutamente osservava: «Au fond de Thésée, nous reconnaissons un peu de Solon, un peu de Pisistrate, beaucoup de Thémistocle et peut-être même d’Alcibiade» 106.
102 Hölscher 1997 e 1999; a proposito dell’Atene del V sec. a.C.: Hölscher 1998. Si veda inoltre quanto os-servato in Rosati 2002, 125: «Resta in effetti sullo sfondo, o va ricercato all’interno di altri filoni di ricerca, il rap-porto con una politica che non sia intesa solo nei suoi aspetti pragmatici, contingenti, come attività connessa con la conquista e la gestione del potere, o genericamente, come gestione degli affari pubblici, ma, al contrario, come elemento strutturante di quella specifica conformazione del potere che fu la polis ateniese fra VI e IV sec. a.C. […]. Il suo [scil. della politica] compito è consistito nel dare un’identità alla polis, rinnovando i propri modelli simbolici». 103 «Painting is a process, an action, not the mirror of something else (‘politics’, ‘literature’, ‘history’)» (Neer 2002, 185). 104 Si veda, per Teseo: Neer 2002, 155 e 182, sulla capacità dell’immagine di cambiare fazione. Inoltre Shapiro1989, 146; Boardman 2001, 208: «Herakles was not a ‘Peisistratid emblem’ but, with Athena, an Athenian emblem». 105 Schmidt 1997, 892; inoltre Ferrari 2003; Servadei 2005, 215, a proposito dei miti teseici. 106 Pottier 1901, 18. Si veda anche Neer 2002, 155 e ss., in cui Teseo è considerato un eroe estremamente malleabile e adattabile, punto di incontro tra la vecchia e la nuova politica, in quanto espressione di una diallage, espressione di modelli di comportamento con i quali le élites ateniesi potevano negoziare un loro ruolo o posto nella polis della isonomia.
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
109
Pittura vascolare e Politica ad atene e in occidente
Fig. 1 – Anfora attica a figure nere, Pittore di Priamo. Da Cerveteri.Oxford, Ashmolean Museum,inv. 1885.668 (V 212) (lato A).
Fig. 2 – Frammentodi anfora attica
a figure nere,maniera di Exekias.
Da Locri.Reggio Calabria,
Museo Archeologico Nazionale, inv. 4001.
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
110
Monica de cesare
Fig. 3 – Anfora attica a figure nere, Exekias.Da Vulci. Città del Vaticano,Museo Gregoriano Etrusco, inv. 16757(lato A e B).
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
111
Pittura vascolare e Politica ad atene e in occidente
Fig. 4 – Oinochoe attica a figure rosse, maniera del Pittore di Trittolemo. Amburgo, Museum für Kunst und Gewerbe, inv. 1981.173.
Fig. 5 – Pisside attica a figure nere. Da Myrrhinous. Brauron, Archaeological Museum, inv. 1591.
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
112
Monica de cesare
Fig. 6 – Piatto atticoa figure rosse, Paseas.
Da Chiusi. Oxford,Ashmolean Museum,
inv. 310.
Fig. 7 – Hydria attica a figure nere, Pittore di Priamo. Da Vulci. Londra, British Museum, inv. B 331.
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
113
Pittura vascolare e Politica ad atene e in occidente
Fig. 9 – Stamnos attico a figure rosse,Pittore di Syriskos. Würzburg,
Martin von Wagner Museum der Universität,inv. 515 (lato A e B).
Fig. 8 – Hydria attica a figure nere,maniera del Pittore di Lysippides.
Da Vulci. Londra, British Museum, inv. B 332.
Fig. 10 – Frammento di skyphos attico a figure rosse.Da Gela. Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, inv. 50321.
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
114
Monica de cesare
Fig. 11 – Chous attica a figure rosse. Da Atene,tomba di Dexileos. Boston, Museum of Fine Arts,
inv. 98.93b.
Fig. 12 – Anfora panatenaica,Kuban Group. Da Tocra.Londra, British Museum, inv. B 605.
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
115
Pittura vascolare e Politica ad atene e in occidente
Fig. 13 – I Tirannicidi di Kritios e Nesiotes (calco ricostruttivo).Università degli Studi di Roma «La Sapienza», Museo dei Gessi.
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
116
Monica de cesare
Fig. 14 – Coppa attica a figure rosse, Skythes. Da Cerveteri. Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, inv. 20760 (lato A e B).
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
117
Pittura vascolare e Politica ad atene e in occidente
Fig. 15 – Coppa attica a figure rosse, Pittore di Codro. Da Vulci. Londra, British Museum, inv. E 84.
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
118
Monica de cesare
Fig. 16 – Anfora attica a figure rosse, Myson.Da Vulci. Parigi, Musée du Louvre, inv. G 197(lato A e B).
Fig. 17 – Cratere attico a figure rosse,
Pittore di OriziaDa Agrigento.
Palermo,Museo Archeologico
Regionaleinv. 2124.
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
119
Pittura vascolare e Politica ad atene e in occidente
riferimenti bibLiografici
ABV J.D. Beazley, Attic black-figure vase-painters, Oxford 1956.Ahlberg-Cornell 1984 G. Ahlberg-Cornell, Herakles and the sea-monster in Attic black-figure
vase-painting, Stockholm 1984. Ajootian 1998 A. Ajootian, A day at the races: the Tyrannicides in the fifth-century Agora,
in K.J. Hartswick - M.C. Sturgeon (eds.), ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Studies in honor of B. Sismondo Ridgway, Philadelphia 1998, 1-13.
Angiolillo 1997 S. Angiolillo, Arte e cultura nell’Atene di Pisistrato e dei Pisistratidi, Bari 1997.
Angiolillo 2009 S. Angiolillo, «Fece spargere la voce che Atena riportava in patria Pisi-strato», in Fortunelli - Masseria 2009, 89-102.
Arafat 1990 K.W. Arafat, Classical Zeus. A study in art and literature, Oxford 1990.Arafat 2002 K.W. Arafat, State of the art - art of the state. Sexual violence and politics
in late Archaic and early Classical vase-painting, in Deacy - Pierce 2002, 97-121.
ARV 2 J.D. Beazley, Attic red-figure vase-painters, Oxford 19632, 3 voll.Basile 1999 J.J. Basile, Exekias’ «Suicide of Ajax» and the problem of socio-political
symbolism in Greek vase-painting, in S.S. Lukesh (ed.), Interpretatio rerum. Archaeological essays on objects and meaning by students of R. Ross Holloway, Providence 1999 (Archeologia Transatlantica 17), 15-22.
Bažant 1982 J. Bažant, The case of symbolism in Classical Greek art, Eirene 18 (1982), 21-33.
Beazley 1927 CVA Oxford, Ashmolean Museum, 1, 1927 (J.D. Beazley).Beazley 1931a CVA Oxford, Ashmolean Museum, 2, 1931 (J.D. Beazley).Beazley 1931b J.D. Beazley, Recensione a Smith 1929, JHS 51 (1931), 119-120.Beazley 1948 J.D. Beazley, Death of Hipparchos, JHS 68 (1948), 26-28.Beazley Addenda2 T.H. Carpenter (ed.), Beazley Addenda, Oxford 19892.Beazley Para. J.D. Beazley, Paralipomena. Additions to Attic black-figure vase-painters
and to Attic red-figure vase-painters, Oxford 19712.Bentz 1998 M. Bentz, Panathenäische Preisamphoren: eine athenische Vasengattung
und ihre Funktion vom 6.-4. Jahrhundert v. Chr., Basel 1998 (AntK Bei-heft 18).
Berlinzani 2002 F. Berlinzani, Una leggenda musicale tebana: Lino ed Eracle, in F. Cor-dano (a cura di), Giornata tebana, Milano 2002, 51-60.
Birchler Émery 2008 P. Birchler Émery, Du ‘banausos’ au ‘technites’: contribution à l’étude du type iconographique de l’artisan en Grèce archaïque, in Seifert 2008, 29-33.
Blok 1990 J. Blok, Patronage and the Pisistratidae, BABesch 65 (1990), 17-28. Boardman 1972 J. Boardman, Herakles, Peisistratos and sons, RA (1972), 57-72.Boardman 1974 J. Boardman, Athenian black figure vases. A handbook, London 1974.Boardman 1975 J. Boardman, Herakles, Peisistratos and Eleusis, JHS 95 (1975), 1-12. Boardman 1978a J. Boardman, Exekias, AJA 82 (1978), 11-25.Boardman 1978b J. Boardman, Greek sculpture. The Archaic period. A handbook, London
1978.
Boardman 1978c J. Boardman, Herakles, Delphi and Kleisthenes of Sikyon, RA (1978), 227-234.
Boardman 1982 J. Boardman, Herakles, Theseus and Amazons, in D. Kurtz - B. Sparkes (eds.), The eye of Greece: studies in the art of Athens, Cambridge - New York 1982, 1-28.
Boardman 1984 J. Boardman, Image and politics in sixth century Athens, in Brijder 1984, 239-247.
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
120
Monica de cesare
Boardman 1989a J. Boardman, Herakles, Peisistratos and unconvinced, JHS 109 (1989), 158-159.
Boardman 1989b J. Boardman, Herakles at sea, in Beiträge zur Ikonographie und Herme-neutik. Festschrift für N. Himmelmann, Mainz am Rhein 1989, 191-195.
Boardman 1991 J. Boardman, The sixth-century potters and painters of Athens and their public, in T. Rasmussen - N. Spivey (eds.), Looking at Greek vases, Cam-bridge 1991, 79-102.
Boardman 1996 J. Boardman, Iconographic signals in the work of the Priam Painter, in I vasi attici ed altre ceramiche coeve in Sicilia, Atti del Convegno inter-nazionale (Catania - Camarina - Gela - Vittoria, 1990), I, Catania 1996 (Cronache di Archeologia 29), 19-30.
Boardman 2001 J. Boardman, The history of Greek vases: potters, painters, and pictures, New York 2001.
Boardman et al. 1990 LIMC, V, 1, 1990, s.v. Herakles, 1-192 (J. Boardman et al.).Boardman - Palagia - LIMC, IV, 1, 1988, s.v. Herakles, 728-838 (J. Boardman - O. Palagia - Woodford 1988 S. Woodford).Brandt 1997 H. Brandt, Herakles und Peisistratos, oder: Mythos und Geschichte. Anmer-
kungen zur Interpretation vorklassischer Vasenbilder, Chiron 27 (1997), 315-334.
Brijder 1984 Ancient Greek and related pottery, Proceedings of the international Vase Symposium (Amsterdam, 1984), ed. by H.A.G. Brijder, Amsterdam 1984.
Brommer 1956 F. Brommer, Vasenlisten zur griechischen Heldensage, Marburg 1956.Cahn 1988 H.A. Cahn, Okeanos, Strymon und Atlas auf einer rotfigurigen Spitzam-
phora, in Christiansen - Melander 1988, 107-116. Cahn 1994 LIMC, VII, 1, 1994, s.v. Okeanos, 31-33 (H.A. Cahn).Calderone 1985 CVA Agrigento, 1, 1985 (A. Calderone).Calderone 1992 A. Calderone, Riflessi della politica ateniese in Occidente: i Sicelioti e il
mito di Trittolemo, QuadAMess 7 (1992), 33-42 (= Ostraka 6, 1, 1997, 167-178).
Calderone - Serra 2004 A. Calderone - A. Serra, Prospettive occidentali del mito di Trittolemo nel-l’«imagerie» vascolare attica, in La tradizione iconica come fonte storica, il ruolo della numismatica negli studi di iconografia, Atti del I Incontro di studio del Lexicon Iconographicum Numismaticae (Messina, 2003), a cura di M. Caccamo Caltabiano - D. Castrizio - M. Puglisi, Reggio Calabria 2004, 215-251.
Catoni 2005 M.L. Catoni, ‘Schemata’. Comunicazione non verbale nella Grecia antica, Pi sa 2005.
Catoni 2010 M.L. Catoni, Bere vino puro. Immagini del simposio, Milano 2010.de Cesare 1997 M. de Cesare, Le statue in immagine. Studi sulle raffigurazioni di statue
nel la pittura vascolare greca, Roma 1997.de Cesare 2003 M. de Cesare, Immagini greche nella Sicilia ‘elima’, in Il greco, il barbaro
e la ceramica attica. Immaginario del diverso, processi di scambio e auto-rappresentazione degli indigeni, Atti del Convegno internazionale di studi (Catania - Caltanissetta - Gela - Camarina - Vittoria - Siracusa, 2001), a cura di F. Giudice - R. Panvini, II, Roma 2003, 113-128.
de Cesare 2008 M. de Cesare, Immagini attiche in contesti greci e anellenici di Sicilia: forme della circolazione e modalità d’uso e di lettura, in Seifert 2008, 111-127.
de Cesare c.s. M. de Cesare, La ceramica figurata attica nella Sicilia arcaica: spunti di riflessione, in La Sicilia in età arcaica. Dalle apoikiai al 480 a.C., Atti del Convegno internazionale (Caltanissetta, 2008), a cura di R. Panvini - L. Sole, in corso di stampa.
Christiansen - Melander Proceedings of the 3rd Symposium on ancient Greek and related pottery 1988 (København, 1987), ed. by J. Christiansen - T. Melander, København
1988.
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
121
Pittura vascolare e Politica ad atene e in occidente
Cohen 2010 A. Cohen, Art in the era of Alexander the Great, Cambridge 2010.
Cook 1987 R.M. Cook, Pots and Pisistratan propaganda, JHS 107 (1987), 167-169.
Cromey 1991 R.D. Cromey, History and image: the Penelope Painter’s Akropolis (Louvre G372 and 480/79 BC), JHS 111 (1991), 165-174.
Deacy - Pierce 2002 S. Deacy - K.F. Pierce (eds.), Rape in antiquity, London 2002.
Denoyelle 1994 M. Denoyelle, Chefs-d’oeuvre de la céramique grecque dans les collections du Louvre, Paris 1994.
Denoyelle et al. 2005 La céramique apulienne: bilan et perspectives, Actes de la Table ronde (Napoli, 2000), éd. par M. Denoyelle et al., Napoli 2005.
De Simone 2008 G.F. De Simone, Le donne alla fontana sui vasi attici a figure nere, in Doni agli dei. Il sistema dei doni votivi nei santuari, Atti del Seminario di studi (Napoli, 2006), a cura di G. Greco - B. Ferrara, Pozzuoli 2008, 317-342.
Devambez 1954 P. Devambez, Sur l’amphore de Crésus, au Louvre, BABesch 29 (1954), 16-19.
Diehl 1964 E. Diehl, Die Hydria. Formgeschichte und Verwendung im Kult des Alter-tums, Mainz am Rhein 1964.
Dougherty - Kurke 1993 C. Dougherty - L. Kurke (eds.), Cultural poetics in Archaic Greece. Cult, performance, politics, Cambridge 1993.
Duplouy 1999 A. Duplouy, L’utilisation de la figure de Crésus dans l’idéologie aristo-cratique athénienne: Solon, Alcméon, Miltiade et le dernier roi de Lydie, AntCl 68 (1999), 1-22.
Ermini 1997 A. Ermini, Il ‘passo’ di Armodio e il ‘passo’ di Aristogitone. Echi e riprese del gruppo dei Tirannicidi nella ceramica attica, BdA 101-102 (1997), 1-24.
Ferrari 2003 G. Ferrari, Myth and genre on Athenian vases, ClAnt 22 (2003), 37-54.
Fink 1960 J. Fink, Der politische Gehalt in Darstellungen von Theseus’ Abenteuer mit Skiron, WeltGesch 20 (1960), 10-15.
Fortunelli - Masseria Ceramica attica da santuari della Grecia, della Ionia e dell’Italia, Atti del 2009 Convegno internazionale (Perugia, 2007), a cura di S. Fortunelli - C. Mas-
seria, Venosa 2009.
Friis Johansen 1969 K. Friis Johansen, Triptolemos or Theseus, MeddelGlypt 26 (1969), 15-46.
Gais 1981 LIMC, I, 1, 1981, s.v. Aigysthos, 371-379 (R.M. Gais).
Gauer 1980 W. Gauer, Das Athenerschatzhaus und die marathonischen Akrothinia in Delphi, in F. Krinzinger - B. Otto - E. Walde-Psenner (Hg.), Forschungen und Funde. Festschrift B. Neutsch, Innsbruck 1980, 127-136.
Giudice et al. 1992 F. Giudice et al., La ceramica figurata, in F. Giudice - S. Tusa - V. Tusa, La collezione archeologica del Banco di Sicilia, Palermo 1992, I, 175-355, e II, 75-216.
Giudice - Panvini 2007 Il greco, il barbaro e la ceramica attica. Immaginario del diverso, processi di scambio e autorappresentazione degli indigeni, Atti del Convegno inter-nazionale di studi (Catania - Caltanissetta - Gela - Camarina - Vittoria - Siracusa, 2001), a cura di F. Giudice - R. Panvini, IV, Roma 2007.
Giuman 2007 M. Giuman, Lo sguardo oltre il nemico. Processi percettivi e immagine del barbaro nell’Atene del secondo quarto del V sec. a.C., in Giudice - Panvini 2007, 123-134.
Glynn 1981 R. Glynn, Herakles, Nereus and Triton: a study of iconography in sixth century Athens, AJA 85 (1981), 121-132.
Greco - Tardo 2009 C. Greco - V. Tardo, Importazioni attiche nei santuari di Selinunte: inci-denza, dinamiche, prospettive, in Fortunelli - Masseria 2009, 677-692.
Griffo 1987 P. Griffo, Il Museo Archeologico Regionale di Agrigento, Roma 1987.
Gullini 1983 G. Gullini, Origini dell’architettura greca in Occidente, in Grecia, Italia e Sicilia nell’VIII e VII secolo a.C., Atti del Convegno internazionale (Athe-nai, 1979), I, Roma 1983 (ASAtene 59), 97-126.
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
122
Monica de cesare
Halm-Tisserant 1986 M. Halm-Tisserant, Le gorgonéion, emblème d’Athéna. Introduction du motif sur le bouclier et l’égide, RA (1986), 245-278.
Hannestad 1984 L. Hannestad, Slaves and the fountain house theme, in Brijder 1984, 252-255.
Haspels 1936 C.H.E. Haspels, Attic black-figured lekythoi, Paris 1936.Hayashi 1992 T. Hayashi, Bedeutung und Wandel des Triptolemosbildes vom 6.-4.
Jh. v. Chr. Religionshistorische und typologische Untersuchungen, Würz-burg 1992 (Beiträge zur Archäologie 20).
Helbig 1897 W. Helbig, Eine Heerschau des Peisistratos oder Hippias auf einer schwarz-figurigen Schale, SBMünchen 2 (1897), 259-320.
Hermary 1978 A. Hermary, Images de l’apothéose des Dioscures, BCH 102 (1978), 51-76.Hölscher 1973 T. Hölscher, Griechische Historienbilder des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr.,
Würzburg 1973. Hölscher 1997 T. Hölscher, Immagini dell’identità greca, in Settis 1997, 191-248.Hölscher 1998 T. Hölscher, Images and political identity: the case of Athens, in Boede-
ker - Raaflaub 1998, 153-183.Hölscher 1999 T. Hölscher, Immagini mitologiche e valori sociali nella Grecia arcaica, in
Im Spiegel des Mythos. Bilderwelt und Lebenswelt – Lo specchio del mito. Immaginario e realtà, Symposium (Roma, 1998), hg. von F. de Angelis - S. Muth, Wiesbaden 1999, 11-30.
Icard-Gianolio 1997 LIMC, VIII, 1, 1997, s.v. Triton, 68-73 (N. Icard-Gianolio).Immerwahr 1972 H.R. Immerwahr, Stesagoras II, TransactAmPhilAss 103 (1972), 182-186.Immerwahr 1990 H.R. Immerwahr, Attic script. A survey, Oxford 1990.Iozzo 2003 M. Iozzo, L’acqua e le donne ad Atene, in L’acqua degli dei. Immagini di
fontane, vasellame, culti salutari e in grotta, Mostra (Chianciano Terme, 2003), Montepulciano 2003, 17-23.
Jaccottet 2008 A.-F. Jaccottet, La démocratie en images ou l’archéologie d’une idée poli-tique, in Seifert 2008, 45-59.
Jacoby 1949 F. Jacoby, Atthis. The local chronicles of ancient Athens, Oxford 1949.Kardara 1951 C.P. Kardara, On Theseus and the Tyrannicides, AJA 55 (1951), 293-300.Keuls 1983 E.C. Keuls, Attic vase-painting and the home textile industry, in Moon
1983a, 209-230.Kilmer 2002 M. Kilmer, ‘Rape’ in early red-figure pottery. Violence and threat in homo-
erotic and hetero-erotic contexts, in Deacy - Pierce 2002, 123-141.Kluwe 1967 E. Kluwe, Die Vasenkumst der Peisistratidenzeit und ihr Aussage-
wert für die Wirtschafts- und Kulturpolitik der athenischen Tyrannen, WisszRostock 16 (1967), 469-472.
Kossatz-Deissmann 1981 LIMC, I, 1, 1981, s.v. Achilleus, 37-200 (A. Kossatz-Deissmann).Kossatz-Deissmann 2009 LIMC, suppl., 2009, s.v. Achilleus, 2-15 (A. Kossatz-Deissmann).Kosso - Lawton 2009 C.K. Kosso - K. Lawton, Women at the fountain and the well: imagin-
ing experience, in C. Kosso - A. Scott (eds.), The nature and function of water, baths, bathing, and hygiene from antiquity through the Reinassance, Leiden - Boston 2009, 87-108.
Kreuzer 2009 B. Kreuzer, An aristocrat in the Athenian Kerameikos: the Kleophrades Painter = Megakles, in Oakley - Palagia 2009, 116-124.
de La Genière 1995 J. de La Genière, Vases attiques à Agrigente au temps de Bacchylide et de Pindare, CRAI (1995), 1005-1021.
de La Genière 1999 J. de La Genière, Essai sur les véhicules de la légende d’Héraclès en Occi-dent, in Le mythe grec dans l’Italie antique. Fonction et image, Actes du Colloque international (Roma, 1996), éd. par F.-H. Massa-Pairault, Ro ma 1999, 11-27.
Laurens 1986 A.-F. Laurens, Autour de Thésée. Images de légitimité, légitimité des images, in Les grandes figures religieuses. Fonctionnement pratique et sym-
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
123
Pittura vascolare e Politica ad atene e in occidente
bolique dans l’antiquité, Rencontre internationale (Besançon, 1984), Paris 1986, 379-398.
Laurens 1989 A.-F. Laurens, Le bûcher de Crésus, in Actualité de l’antiquité, Actes du Colloque (Toulouse, 1985), éd. par J.-M- Pailler, Paris 1989, 71-83.
Laurens 1995 A.-F. Laurens, Les ateliers de céramique, in Verbanck-Piérard - Viviers 1995, 161-183.
Lullies 1956 CVA München, Museum Antiker Kleinkunst, 4, 1956 (R. Lullies).
Mackay 2010 E.A. Mackay, Tradition and originality: a study of Exekias, Oxford 2010 (BARIntSer 2092).
Massa-Pairault 1998 F.-H. Massa-Pairault, Contribution à la réflexion sur le catalogue et l’expo-sition, in Spina e il Delta Padano. Riflessioni sul catalogo e sulla mostra ferrarese, Atti del Convegno internazionale (Ferrara, 1994), a cura di F. Re becchi, Roma 1998, 143-156.
Massa-Pairault 2007 F.-H. Massa-Pairault, La domanda di ceramica attica e l’autorappresenta-zione dei ‘principes’. Alcune riflessioni, in Giudice - Panvini 2007, 45-55.
Menichetti 1994 M. Menichetti, Archeologia del potere. Re, immagini e miti a Roma e in Etruria in età arcaica, Milano 1994.
Menichetti 2007 M. Menichetti, Thamyris, il cantore della politica cimoniana e il cratere di Polion a Ferrara, in Giudice - Panvini 2007, 107-122.
Mommsen 1980 H. Mommsen, Achill und Aias pflichtvergessen?, in H.A. Cahn - E. Simon (Hg.), Tainia. R. Hampe zum 70. Geburtstag am 2. Dezember 1978, Mainz am Rhein 1980, 139-152.
Mommsen 1988 H. Mommsen, Zur Deutung der Exekias-Amphora im Vatikan, in Christi-ansen - Melander 1988, 445-464.
Mommsen 2002 H. Mommsen, Siegreiche Gespannpferde, AntK 45 (2002), 27-38.
Moon 1983a W.G. Moon (ed.), Ancient Greek art and iconography, Madison (Wisc.) 1983.
Moon 1983b W.G. Moon, The Priam Painter. Some iconographic and stylistic consid-erations, in Moon 1983a, 97-118.
Moore 1980 M.B. Moore, Exekias and Telamonian Ajax, AJA 84 (1980), 417-434.
Moore 1986 M.B. Moore, Exekias and the harnessing of a chariot team, AntK 29 (1986), 107-114.
Moore 1987 M.B. Moore, The Amasis Painter and Exekias: approaches to narrative, in Papers on the Amasis Painter, 153-167.
Mugione 1997 E. Mugione, Temi figurativi della ceramica attica e committenza occiden-tale. Una esemplificazione: il mito di Teseo, Ostraka 6 (1997), 109-128.
Mugione 2000 E. Mugione, Miti della ceramica attica in Occidente. Problemi di trasmis-sioni iconografiche nelle produzioni italiote, Taranto 2000.
Nadal 2007 E. Nadal, De la cavalerie à la flotte athéniennes: l’iconographie attique de Poséidon et l’histoire d’Athènes, Pallas 75 (2007), 151-171.
Nadal 2008 E. Nadal, Poséidon sur le passage d’Héraklès sur quelques vases attiques à figures noires, Pallas 76 (2008), 31-50.
Neer 2002 R.T. Neer, Style and politics in Athenian vase-painting. The craft of democ-racy, ca. 530-460 B.C.E., Cambridge 2002.
Neer 2009 R.T. Neer, The incontinence of civic authority: pictorial iambos in Athe-nian vase-painting, in Nørskov et al. 2009, 205-218.
Neils 1987 J. Neils, The youthful deeds of Theseus, Roma 1987.
Nenci 1991 G. Nenci, Filottete in Sicilia, in Épéios et Philoctète en Italie. Données archéologiques et traditions légendaires, Actes du Colloque international (Lille, 1987), éd. par J. de La Genière, Napoli 1991, 131-135.
Nørskov et al. 2009 V. Nørskov et al. (eds.), The world of Greek vases, Roma 2009 (AnalRom Suppl. 41).
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
124
Monica de cesare
Oakley - Palagia 2009 Athenian potters and painters, Proceedings of the Conference (Athenai, 2007), ed. by J.H. Oakley - O. Palagia, II, Oxford - Oakville 2009.
Ober 2003 J. Ober, Tyrant killing as therapeutic stasis: a political debate in images and texts, in K.A. Morgan (ed.), Popular tyranny: sovereignity and its dis-contents in ancient Greece, Austin 2003, 215-250.
Oenbrink 2004 W. Oenbrink, Die Tyrannenmörder. Aristokratische Identifikationsfigu-ren oder Leitbilder der athenischen Demokratie? Rezeption eines politi-schen Denkmals in der attischen Vasenmalerei, in J. Gebauer et al. (Hg.), Bildergeschichte. Festschrift K. Stähler, Mohnesee 2004, 373-400.
Osborne 1983-1984 R. Osborne, The myth of propaganda and the propaganda of myth, He -phaistos 5-6 (1983-1984), 61-70.
Panvini 2003 R. Panvini, Le ceramiche attiche dall’emporio arcaico di Gela, in R. Pan-vini - F. Giudice (a cura di), Ta Attika. Veder greco a Gela. Ceramiche attiche figurate dall’antica colonia, Mostra (Gela - Siracusa - Rodi, 2004), Roma 2003, 215-227.
Paoletti 1996 O. Paoletti, Per uno studio della ceramica figurata dal santuario della Malophoros a Selinunte, in I vasi attici ed altre ceramiche coeve in Sicilia, Atti del Convegno internazionale (Catania - Camarina - Gela - Vittoria, 1990), II, Catania 1996 (Cronache di Archeologia 30), 131-139.
Papers on the Amasis Papers on the Amasis Painter and his world, Colloquium (Malibu, 1986), Painter Malibu 1987.
Parke - Boardman 1957 H.W. Parke - J. Boardman, The struggle for the Tripod and the first Sacred War, JHS 77 (1957), 276-282.
Pedley 1987 J.G. Pedley, Reflections of architecture in sixth-century Attic vase-painting, in Papers on the Amasis Painter, 63-80.
Petre 1997 z. Petre, L’uso politico e retorico del tema del tirannicidio, in Settis 1997, 1207-1226.
Pfisterer-Haas 2002 S. Pfisterer-Haas, Mädchen und Frauen am Wasser. Brunnenhaus und Louterion als Orte der Frauengemeinschaft und der möglichen Begegnung mit einem Mann, JdI 117 (2002), 1-79.
Pierre 2008 H. Pierre, Le voyage de Triptolème en Étrurie et en Grande Grèce, Pallas 77 (2008), 111-132.
Pinney 1984 G.F. Pinney, For the heroes are at hand, JHS 114 (1984), 181-183.
Pipili 1992 LIMC, VI, 1, 1992, s.v. Nereus, 824-837 (M. Pipili).
Pollitt 1987 J.J. Pollitt, Pots, politics, and personifications in early Classical Athens, YaleUnivB 40 (1987), 8-15.
Pottier 1901 E. Pottier, Pourquoi Thésée fut l’ami d’Hercule, La Revue de l’Art 9 (1901), 1-18.
Pouzadoux 2005 C. Pouzadoux, L’invention des images dans la seconde moitié du IVe siècle: entre peintres et commanditaires, in Denoyelle et al. 2005, 187-199.
Reusser 2002 Ch. Reusser, Vasen für Etrurien. Verbreitung und Funktionen attischer Keramik im Etrurien des 6. und 5. Jahrhunderts vor Christus, zürich 2002.
Rosati 2002 R. Rosati, Eracle: l’immagine e il politico, in Iconografia 2001: studi sul-l’immagine, Atti del Convegno (Padova, 2001), a cura di I. Colpo - I. Fa -varetto - F. Ghedini, Roma 2002, 123-134.
Santi 2010 F. Santi, I frontoni arcaici dell’acropoli di Atene, Roma 2010.
Schauenburg 1975 K. Schauenburg, EΥΡΥΜΕΔΩΝ ΕΙΜΙ, AM 90 (1975), 97-121.
Schauenburg 1979 K. Schauenburg, Herakles Musikos, JdI 94 (1979), 49-76.
Schefold 1946 K. Schefold, Kleisthenes. Der Anteil der Kunst an der Gestaltung des jungen attischen Freistaates, MusHelv 3 (1946), 59-93.
Scheibler 1987 I. Scheibler, Bild und Gefäss. Zur ikonographischen und funktionalen Bedeutung der attischen Bildfeldamphoren, JdI 102 (1987), 57-118.
Schmidt 1997 M. Schmidt, Iconografia del mito, in Settis 1997, 867-896.
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
125
Pittura vascolare e Politica ad atene e in occidente
Schmidt 2005 M. Schmidt, Livello culturale di singoli pittori: dalla erudizione indivi-duale all’automatismo artigianale?, in Denoyelle et al. 2005, 201-206.
Schmidt 2009 S. Schmidt, Images of statues on Attic vases: the case of the Tyrannicides, in Nørskov et al. 2009, 219-237.
Schweizer 2006 B. Schweizer, Harmodios und Aristogeiton. Die sog. Tyrannenmörder im 5. Jh. v. Chr., in N. Kreutz - B. Schweizer (Hg.), Tekmeria. Archäologische Zeugnisse in ihrer kulturhistorischen und politischen Dimension. Beiträge für W. Gauer, Münster 2006, 291-313.
Seifert 2008 M. Seifert (Hg.), Komplexe Bilder, Berlin - Basel 2008 (HASB Beiheft 5).Sena Chiesa - Arslan G. Sena Chiesa - E.A. Arslan (a cura di), Miti greci. Archeologia e pittura 2004 dalla Magna Grecia al collezionismo, Mostra (Milano, 2004-2005), Milano
2004.Servadei 2005 C. Servadei, La figura di Theseus nella ceramica attica. Iconografia e icono-
logia del mito nell’Atene arcaica e classica, Bologna 2005.Settis 1997 S. Settis (a cura di), I Greci. Storia, cultura, arte, società, II. Una storia gre -
ca, 2. Definizione, Torino 1997.Shapiro 1980 H.A. Shapiro, Hippokrates son of Anaxileos, Hesperia 49 (1980), 289-293.Shapiro 1981a H.A. Shapiro, Courtship scenes in Attic vase-painting, AJA 85 (1981), 133-
143.Shapiro 1981b H.A. Shapiro, Exekias, Ajax, and Salamis: a further note, AJA 85 (1981),
173-175.Shapiro 1982 H.A. Shapiro, Theseus, Athens, and Troizen, AA (1982), 291-297. Shapiro 1983 H.A. Shapiro, Painting, politics, and genealogy: Peisistratos and the Ne -
leids, in Moon 1983a, 87-96.Shapiro 1984 H.A. Shapiro, Herakles, Kyknos and Delphi, in Brijder 1984, 271-274.Shapiro 1989 H.A. Shapiro, Art and cult under the tyrants in Athens, Mainz am Rhein
1989.Shapiro 1991 H.A. Shapiro, Theseus: aspects of the hero in Archaic Greece, in New per-
spectives in early Greek art, Proceedings of the Symposium (Washington, 1988), ed. by D. Buitron-Oliver, Washington 1991, 123-139.
Shapiro 1992 H.A. Shapiro, Theseus in Kimonian Athens. The iconography of empire, MedHistR 7, 1 (1992), 29-49.
Shapiro 1993 H.A. Shapiro, Hipparchos and the rhapsodes, in Dougherty - Kurke 1993, 92-107.
Shapiro 1994 H.A. Shapiro, Religion and politics in democratic Athens, in The archaeo-logy of Athens and Attica under the democracy, Proceedings of an interna-tional Conference (Athenai, 1992), ed. by W.D.E. Coulson et al., Oxford 1994, 123-129.
Shapiro 1996 H.A. Shapiro, Athena, Apollo, and the religious propaganda of the Athe-nian empire, in Religion and power in the ancient Greek world, Proceed-ings of the Symposium (Uppsala, 1993), ed. by P. Hellström - B. Alroth, Uppsala 1996 (BoreasUpps 24), 101-113.
Shapiro 1998 H.A. Shapiro, Autochthony and the visual arts in fifth-century Athens, in Boedeker - Raaflaub 1998, 127-151.
Shapiro 2003 H.A. Shapiro, Brief encounters: women and men at the fountain house, in Griechische Keramik im kulturellen Kontext, Akten des internationalen Vasen-Symposions (Kiel, 2001), hg. von B. Schmaltz - M. Söldner, Mün-ster 2003, 96-98.
Shefton 1960 B.B. Shefton, Some iconographic remarks on the Tyrannicides, AJA 64 (1960), 173-179.
Shefton 1962 B.B. Shefton, Herakles and Theseus on a red-figured louterion, Hesperia 31 (1962), 330-368.
Simon 1983 E. Simon, Festivals of Attica. An archaeological commentary, Madison (Wisc.) 1983.
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
126
Monica de cesare
Sinos 1993 R.H. Sinos, Divine selection. Epiphany and politics in Archaic Greece, in Dougherty - Kurke 1993, 73-91.
Slater 1999 N.W. Slater, The vase as ventriloquist. Kalos-inscriptions and the culture of fame, in E.A. Mackay (ed.), Signs of orality. The oral tradition and its influence in the Greek and Roman world, Leiden - Boston - Koln 1999, 143-161.
Smith 1929 H.R.W. Smith, New aspects of the Menon Painter, Berkely 1929 (Univer-sity of California Publications in Classical Archaeology 1.1).
Stissi 1999 V. Stissi, Production and consumption of Archaic Greek pottery (sixth and early fifth centuries BC), in The complex past of pottery. Production, circulation and consumption of Mycenaean and Greek pottery (sixteenth to early fifth centuries BC), Proceedings of the international Conference (Amsterdam, 1996), ed. by J.P. Crielaard - V. Stissi - G.J. van Wijngaar-den, Amsterdam 1999, 83-113.
Tiverios 1991 A.M. Tiverios, Ikonographie und Geschichte. Überlegungen anlässlich einer Abbildung des Strymon im Garten der Hesperiden, AM 106 (1991), 129-136.
Torelli 2007 M. Torelli, Le strategie di Kleitias. Composizione e programma figurativo del vaso François, Milano 2007.
Veder greco Veder greco. Le necropoli di Agrigento, Mostra (Agrigento, 1988), Roma 1988.
Verbanck-Piérard - Culture et cité. L’avènement d’Athènes à l’époque archaïque, Actes du Viviers 1995 Colloque international (Bruxelles, 1991), éd. par A. Verbanck-Piérard -
D. Viviers, Bruxelles - Paris 1995.Villanueva Puig 2007 M.C. Villanueva Puig, Des signatures de potiers et de peintres de vases à
l’époque grecque archaïque et de leurs interprétations, Metis, n.s., 5 (2007), 27-50.
Villard 2002 F. Villard, L’apparition de la signature des peintres sur les vases grecs, REG 115 (2002), 778-782.
Viviers 2002 D. Viviers, Le bouclier signé du Trésor de Siphnos à Delphes: ‘Régions stylistiques’ et ateliers itinérants ou la sculpture archaïque face aux lois du marché, in Ch. Müller - F. Prost (éds.), Identités et cultures dans le monde méditerranéen antique, Paris 2002, 53-85.
Viviers 2004 D. Viviers, Bien avant Boch … les céramistes athéniens. De l’artisanat à la manufacture, in S. Jaumain - K. Bertrams (sous la dir. de), Patrons, gens d’affaires et banquiers. Hommages à G. Kurgan-van Hentenryk, Bruxelles 2004, 51-67.
Viviers 2006 D. Viviers, Signer une oeuvre en Grèce ancienne: pourquoi? Pour qui?, in Les clients de la céramique grecque, Actes du Colloque (Paris, 2004), éd. par J. de La Genière, Paris 2006 (Cahiers du CVA France 1), 141-154.
Walters 1931 CVA Great Britain, British Museum, 6, 1931 (H.B. Walters).Webster 1972 T.B.L. Webster, Potter and patron in Classical Athens, London 1972.Weiss 1994 LIMC, VII, 1, 1994, s.v. Strymon, 814-817 (C. Weiss).Williams 1980 D. Williams, Ajax, Odysseus and the arms of Achilles, AntK 23 (1980),
137-145.Williams 1983 D. Williams, Herakles, Peisistratos and the Alcmeonids, in Image et céra-
mique grecque, Actes du Colloque (Rouen, 1982), Rouen 1983, 131-140.Williams 1986 D. Williams, A cup by the Antiphon Painter and the battle of Marathon,
in E. Böhr - W. Martini (Hg.), Studien zur Mythologie und Vasenmalerei. K. Schauenburg zum 65. Geburtstag am 16. April 1986, Mainz am Rhein 1986, 75-81.
Williams 1995 D. Williams, Potter, painter and purchaser, in Verbanck-Piérard - Viviers 1995, 139-160.
Williams 1997 D. Williams, From Pelion to Troy: two skyphoi by the Kleophrades Painter, in Athenian potters and painters, Proceedings of the Conference (Athe-
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html
127
Pittura vascolare e Politica ad atene e in occidente
nai, 1994), ed. by J.H. Oakley - W.D.E. Coulson - O. Palagia, I, Oxford 1997, 195-201.
Williams 2009 D. Williams, Picturing potters and painters, in Oakley - Palagia 2009, 306-317.
Worshiping women Worshiping women. Ritual and reality in Classical Athens, Exhibition (New York, 2008-2009), New York 2008.
zaccagnino 2007 C. zaccagnino, Cimone e la politica antipersiana. Una nuova lettura di un cratere del Pittore di Bologna 279 da Spina Valle Trebba, in Giudice - Pan-vini 2007, 97-106.
___________________________________________________________________________________________ Arte-Potere. Forme Artistiche, Istituzioni, Paradigmi Interpretativi. Atti del convegno di studio tenuto a Pisa
Scuola Normale Superiore, 25-27 Novembre 2010 - A cura di M. Castiglione e A. Poggio http://www.lededizioni.com/catalogo/503-arte-potere.html