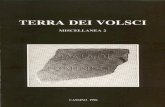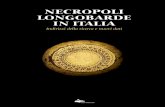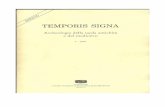I mosaici dell'edificio termale in contrada Palazzi di Casignana (Reggio Calabria)
Fabiola ARDIZZONE– Rossella GIGLIO – Elena PEZZINI, INSEDIAMENTO MONASTICO A MARETTIMO...
Transcript of Fabiola ARDIZZONE– Rossella GIGLIO – Elena PEZZINI, INSEDIAMENTO MONASTICO A MARETTIMO...
Sesión paralela 1: Novedades - Poster
L’isola di Marettimo, la più occidentale delle Egadi, rivestì un ruolo fondamenta-le nelle rotte del Mediterraneo, nei collegamenti fra Africa e Sicilia, anche se scarsissi-me sono le fonti letterarie sulla Ιερά νῆσος di Tolomeo (Ptol. 3, 4, 8) e Polibio (Plb. 1, 60, 3), la Hieronnesos di Plinio (Nat. 3, 92). Sappiamo che Annone nel 241 a. C., giun-gendo con la flotta da Cartagine, vi fa sosta e poi prosegue per Erice (Plb. 1, 60, 3; D. S. 24, 11, 1); sempre nella stessa occasione, dopo la sconfitta subita, Annone, aiutato da un vento favorevole, vi ritorna con la flotta superstite (Plb. 1, 61, 7). Questi episodi evocano la destinazione della più importante area archeologica, che si trova nella parte orientale dell’isola, in località “Case Romane” (m. 260 s.l.m.), in prossimità di una sor-gente di acqua dolce, che appare fortemente caratterizzata dalla posizione strategica: da lì sono infatti distintamente visibili le isole di Levanzo e Favignana, nonché tutto il li-torale trapanese fino ad Erice. È facile collegare quindi le strutture presenti nell’area ad una non occasionale frequentazione. Elemento centrale del breve pianoro é una chie-setta normanna a croce greca “atrofizzata” (XI-XII secolo) e resti di un grande edificio. Dopo un primo iniziale interesse negli anni sessanta del Novecento (V. Scuderi, A. M. Bisi e A. M. Fallico), solo nel 1994 il Servizio per i beni archeologici della Soprinten-denza per i Beni Culturali di Trapani, con la direzione dei lavori della scrivente, realizzò una campagna di scavo archeologico, per verificare le emergenze monumentali esisten-ti1. L’articolato complesso presenta infatti un edificio romano in opus quasi reticu latum, di chiara destinazione militare, di età tardo-repubblicana, con un sistema di strutture per il convogliamento delle acque, nell’area antistante l’ingresso; esso fu poi rimaneggia-
Fabiola A – Rossella G – Elena P
INSEDIAMENTO MONASTICO A MARETTIMO “CONTRADA CASE ROMANE”.
NUOVI DATI*
* La campagna di scavi 2007-2008 è stata realizzata nell’ambito del progetto di restauro e sistemazione dell’area archeologica di Contrada Case romane a Marettimo, diretto per la fase progettuale da Maria Grazia Sercia e da Rosa Di Liberto. Il contributo che qui presentiamo è il frutto del lavoro di una equipe costitui-ta da Fabiola Ardizzone, da Rosa Di Liberto e da Elena Pezzini, e da un gruppo di studenti dell’Università di Palermo tra cui si segnalano F. Agrò e F. Pisciotta che stanno studiando rispettivamente la ceramica me-dievale e quella tardoantica, S. Santamaria e B. Lombardo responsabili dello studio della ceramica residuale, dei vetri e dei metalli. A loro esprimiamo la massima gratitudine. Inoltre, la documentazione grafica, corre-do di questo lavoro, è stata realizzata da Rosa Di Liberto, Filippo Pisciotta, Vittorio Nicolosi, Pietro Mare-scalchi e Francesco Scirè; l’ortofotopiano della chiesa è stato realizzato da Pietro Orlando, Davide Emmolo, Salva tore D’Amelio; Maria Antonietta Parlapiano ci ha aiutato nella resa grafica di alcuni rilievi; le fotogra-fie dello scavo sono state eseguite da Francesca Agrò.
1 L’edizione completa dello scavo sarà realizzata, a cura della scrivente, dalla Soprintendenza per i beni culturali di Trapani. Per una relazione preliminare dei risultati di scavo, vedi F. A, R. D L, E. P, Il complesso monumentale in contrada “Case Romane” a Marettimo (Trapani). La fase medievale: note preliminari, in S. P U (ed.), Scavi medievali in Italia 1994-1995, Atti della prima Confe-renza Italiana di Archeologia Medievale, Cassino, 14-16 dicembre 1995, Roma 1998, pp. 387-424.
1248 – –
to in età tardo-antica con la monumentalizzazione dell’area che, anche grazie alla pre-senza della vicina sorgente, presenta una costante valenza sacrale. Nel 2007 il Comune di Favignana ha realizzato un progetto, finanziato dall’Assessorato Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali (Decreto Assessoriale n. 26/S6DPR 8/”/2005 PIT Isole minori, con l’alta sorveglianza della Soprintendenza per i Beni Culturali di Trapani), per il re-stauro e la sistemazione dell’area ai fini della fruizione – Itinerario di rivitalizzazione delle risorse storiche-archeologiche dell’isola di Marettimo - Completamento area archeo-logica Case Romane”, POR Sicilia 2000-2006, PIT 14 – attraverso il quale è stato possi-bile ampliare l’area archeologica già in parte esplorata nel 1994, ed è stato rimesso in luce un fonte battesimale ad immersione, rivestito da intonaco dipinto in finto marmo, di epoca proto-bizantina (VI-VII sec. d.C.), inserito nel contesto di un edificio ecclesia-le a tre navate, più ampio della chiesa di epoca normanna. Di notevole interesse risul-tano le strette connessioni con l’Africa settentrionale e soprattutto con la Tunisia, che confermano il rilevante interesse storico-archeologico dell’isola.
R. G.
L’
Il complesso monumentale di contrada Case Romane a Marettimo, presenta una fase tardo romana e proto bizantina, che vede il riuso dell’edificio militare romano in opus quasi reticulatum e la costruzione ex novo di un insieme di edifici tra cui una chie-sa a tre navate dotata di fonte battesimale (fig. 1).
Dalle fonti scritte sull’isola emergono due aspetti molto importanti per la ricostru-zione storica e la lettura del complesso monumentale: da una parte il ruolo di scalo sulla rotta che collegava la Sicilia all’Africa settentrionale2, in buona parte determinato dalla presenza dell’acqua nell’isola, dall’altra, l’aura di sacralità che l’isola aveva in età antica come indica il toponimo Ierà Nesos ricordato da Tolomeo e Polibio3. Di tale aura oggi ci sfugge il senso compiuto, dal momento che non sono state ancora ritrovate struttu-re di età antica, riferibili ad un santuario.
Dell’abitato in prossimità dello scalo abbiamo informazioni solo dall’Itinerarium per maritima loca che ricorda Maritima come statio sulla rotta da Capo Bon a Roma. Le fonti arabe di età normanna danno l’isola come disabitata4. Queste informazioni sono state smentite dai recenti dati archeologici che attestano una frequentazione del sito quasi ininterrotta dalla seconda metà del I sec. a.C. fino all’età sveva; le fasi individuate con
2 È citata da Plinio tra le isole ad Africam versae, Plin., Nat. 3, 92; per l’Itinerarium Antonini, K. M, Itinera Romana, Stuttgart 1916, pp. LXVII, 492-493; ancora nel medioevo è scalo importante lungo le rotte non solo africane ma di collegamento con la Sardegna: P. G D, Carte marine et portulan au XIIeXIIeXII siècle. Le “Liber de existencia rivierarum et forma maris nostri Mediteranei” (Coll. de l’École française de Rome 203), Roma 1995, p. 175, redatto a Pisa nel XII secolo; R. M, Il compaso de navigare, in AnnCag, in AnnCag, in 8 (1947), pp. 98-99, 107, 109-110, 112, datato alla metà del XIII secolo. Ancora nel XVI secolo i portolani catalani menzionano l’isola come tappa lungo la rotta Sicilia-Capo Bon: Alfonso Ventimiglia nel portolano del 1573 descrive l’isola così: “tiene abrigos y buena aqua”, vedi S. C, Portolani inediti in lingua volgare e spagnuola. Il portolano di Alfonso Ventimiglia, in Atti della Regia Accademia Peloritana 21 (1906), 1, pp. 3-72. Per una disamina delle rotte che passavano dalle isole Egadi vedi G. M. C, I porti della Sici-lia, Roma 1906.
3 Plb. 1, 60, 3; Ptol. 3, 4, 8.4 Nel XII secolo Idrisi, geografo di Ruggero II, descrive Malitimah come isola posta di fronte a Tunisi
ricca di pozzi ed animali selvatici, U. R, Idrisi, Il libro di Ruggero, Palermo 1994, pp. 26, 43. Ibn Jubayr nel XII secolo sotto il regno di Guglielmo II, dice che l’isola era disabitata.
“ ” 1249
chiarezza dalla ricerca archeologica sono infatti le seguenti: romana-tardorepubblicana con la costruzione di un edificio militare con funzione di faro5, tardoantica e altome-dievale (metà V-VIII sec.), durante la quale viene costruito il complesso di strutture di cui fa parte la chiesa con battistero; normanna (fine XI-XII secolo), con la fondazione di un cenobio legato al monachesimo greco, ed infine basso medievale (XIII secolo)6.
Tralasciando in questa sede la descrizione delle strutture relative alla fase romana, ci concentreremo sulla trasformazione cristiana dell’insediamento, avvenuta a partire dal V secolo e protrattasi, come vedremo, fino ai primi anni dell’VIII. Elemento principale di questa fase d’occupazione è una chiesa perfettamente orientata ad Est, del tipo mol-to semplice a tre navate suddivise da pilastri, di cui restano le fondazioni solo nella na-vata meridionale, con abside inscritta e priva di nartece (figg. 3-4). Ai lati dell’abside, rispettivamente a Sud e a Nord, sono presenti due piccoli ambienti simmetrici di cui quello nord ha ingresso a NE. Questo edificio aveva l’accesso principale sul lato ovest – oggi ancora perfettamente leggibile nelle strutture della chiesa medievale (fig. 5) – ed un ingresso laterale a SO. All’interno, la chiesa era pavimentata con un tenace coccio-pesto, visibile oggi solo nelle navate laterali, e nell’ambiente a Sud dell’abside. All’ester-no, ad Ovest, i piani di calpestio in terra battuta, relativi a questa fase di vita dell’inse-diamento, recuperati lungo la facciata occidentale della chiesa ad una quota più alta di circa 60 cm rispetto al livello pavimentale interno ci hanno permesso di ipotizzare che l’ingresso alla chiesa sul lato ovest avveniva mediante due gradini. La navata settentrio-nale, rispetto a quella meridionale, è in pessimo stato di conservazione: le sue strutture sono state rase al suolo nel medioevo per permettere un più agevole collegamento tra la chiesa normanna e l’edificio militare romano, che in questa fase è stato trasforma-to in cenobio. Nel XIII secolo, l’angolo NE della chiesa protobizantina è stato distrut-to irrimediabilmente da una grande buca di forma vagamente regolare: resta soltanto in fondazione il muro perimetrale nord e lembi della pavimentazione in cocciopesto. Questa chiesa presenta chiaramente almeno due fasi anche se allo stato attuale delle ri-cerche non è possibile precisarne le evoluzioni e la cronologia.
Alla seconda fase di questo edificio risale sicuramente l’inserimento dentro l’am-biente a Sud dell’abside, a ridosso del muro meridionale, di un fonte battesimale ad immersione, scavato in un’area rialzata di circa 15 cm rispetto al livello del pavimento della stanza (figg. 6-7). Ha forma ottagonale con due lati convessi e due rampe, di tre gradini ciascuna, sui lati ovest ed est; le superfici interne sono interamente rivestite di intonaco con tracce di decorazione dipinta a imitazione del marmo7. Al fondo, pavi-mentato da una lastra di marmo proconnesio, è un piccolo foro in corrispondenza del-l’angolo NE per il deflusso dell’acqua. La vasca sembra essere stata inserita in un mo-mento successivo alla realizzazione del vano, come è dimostrato dalla posizione defi-lata al suo interno e da una chiara ripresa dell’intonaco parietale, realizzato, in questa fase con un finissimo cocciopesto. Lungo la parete est, infine, è stata recuperata ancora
5 La costruzione del faro romano è stata messa in relazione con la presenza di Sesto Pompeo nella Sici-lia occidentale e con il conseguente bellum navale contro Ottaviano, vedi A, D L, P(op. cit. nota 1), p. 390.
6 La natura dell’insediamento di questo periodo non è ancora chiara. Appartengono a questa fase alcune grandi buche concentrate soprattutto nella navata nord della chiesa protobizantina.
7 Il fonte, profondo cm 108, rispecchia nel numero dei gradini, il canone descritto da Isidoro da Siviglia nel VII secolo. I tre gradini di accesso sono in funzione della triplice rinuncia, i tre in uscita sono relativi alla triplice professione di fede, il settimo ovvero il fondo della vasca è il luogo dove si riceve l’unzione, V. S, Les rites de l’initiation chrétienne du IIeLes rites de l’initiation chrétienne du IIeLes rites de l’initiation chrétienne du II au VIe au VIe au VI siècle. Esquisse historique et signification d’après leurs principaux témoins, Spoleto 1988, p. 543.
1250 – –
in situ una base modanata di cui al momento ci sfugge la funzione8. La presenza poi di un piccolo gradino in prossimità del muro dell’abside ci ha suggerito di ipotizzare un passaggio, destinato al clero, dall’abside al battistero. Lo stesso doveva avvenire nel-l’ambiente simmetrico settentrionale, che a Nord si apriva direttamente in un’area che potrebbe avere avuto funzione residenziale.
Non è ancora chiaro il collegamento tra la navata meridionale e il battistero, dal momento che una grande buca di forma rettangolare – forse la fossa di spoliazione del muro divisorio – li separa ad Ovest. A giudicare dalle strutture perimetrali conservate, l’ingresso a quest’ambiente doveva avvenire attraverso la navata meridionale mediante uno o più gradini, poiché la pavimentazione è ad una quota più bassa rispetto a quel-la della chiesa. La presenza della porta laterale sud della chiesa, ben si presta alla ri-costruzione di un percorso rituale dei catecumeni da questo ingresso fino al battiste-ro, secondo le regole previste dalla liturgia battesimale. Grazie ai crolli della copertura, sappiamo che il tetto della chiesa e del suo battistero era costituito da una struttura li-gnea a travi, ricoperta con tegole e coppi alcuni dei quali con una decorazione a dita-te. Tracce di crolli, meno sistematiche, ma pur sempre evidenti, sono state recuperate anche nella navata meridionale.
L’edificio di culto descritto non era isolato, ma era inglobato all’interno di un complesso di strutture di cui ancora non sono chiare la funzione e le dimensioni. Dai dati archeologici in nostro possesso, infatti, sappiamo che l’area compresa tra la chiesa e l’edificio romano in periodo protobizantino doveva essere in parte coperta, dal mo-mento che, a ridosso del muro settentrionale della chiesa, sono stati messi in luce la-certi di una pavimentazione in cocciopesto del tutto analoga a quella rinvenuta dentro l’edificio di culto. Questa area era delimitata ad Est da un grande muro costruito in opus africanum che prosegue in direzione Nord per circa 10 m oltre il perimetro del-la chiesa protobizantina. Il rinvenimento nella terrazza immediatamente ad Est di que-sta struttura di almeno due muri con andamento E-O e di piani pavimentali in coc-ciopesto, ci fa certi che l’insediamento continuava verso valle anche nella terrazza sotto-stante ad Est. In questo periodo, inoltre, anche l’edificio militare romano e l’area ad esso antistante vennero riconfigurati per essere inseriti all’interno di questo comples-so più ampio: dentro il faro romano, infatti, il vano sud ovest fu suddiviso in due pic-coli ambienti mediante la costruzione di un muro; venne rifatta la pavimentazione con un tenace battuto d’argilla e la copertura, in parte crollata, fu sostituita con un tetto di tegole di cui si è rinvenuta traccia nel vano II. Nell’area antistante l’ingresso principa-le dell’edificio romano venne costruito un recinto rettangolare lastricato che ingloba, al centro dei lati brevi, due vasche collegate, tramite un sistema di canalette, con una ci-sterna a monte che raccoglieva l’acqua proveniente dalla principale sorgente dell’isola. Lo scavo di parte del riempimento sottostante questo livello pavimentale ha restituito abbondante materiale ceramico databile al secondo quarto-metà del V secolo9. Questo dato, nella lettura generale della storia del sito è molto importante perché ci fornisce il terminus post quem per la datazione di questa fase di vita dell’insediamento, mentre il terminus ante quem è dato dal materiale ceramico rinvenuto negli strati di distruzione e di abbandono dell’edificio di culto datato alla fine VII-inizi dell’VIII secolo10. Si può
8 Questa base è realizzata nel calcare rosa locale.9 Questi contesti sono attualmente in corso di studio da parte di F. Pisciotta. Devo alla sua cortesia le
informazioni sulla ceramica qui rinvenuta.10 Per la ceramica recuperata dentro l’edificio romano relativa a questa fase di vita del complesso, vedi
A, D L, P, (op. cit. nota 1), pp. 408-411; F. A, Rapporti commerciali tra la
“ ” 1251
quindi ipotizzare che la chiesa sia stata fondata alla fine del V secolo, quando nasce l’insediamento, e che nel corso del VI sia stata trasformata con l’inserimento del batti-stero all’interno del vano sud e con l’apertura dell’ingresso a SO, connesso con la nuo-va funzione liturgica dell’ambiente.
Riguardo alle motivazioni che avrebbero determinato nell’isola la fondazione del complesso nel V secolo, lo stato ancora embrionale delle ricerche e la totale carenza del-le fonti scritte su Marettimo tardoantica e bizantina ci scoraggiano dall’avanzare ipotesi; mentre, per la fine dell’insediamento cristiano nell’isola, particolare rilevanza assume la notizia riportata da M. Amari dell’inizio di razzie via mare da parte degli Arabi d’Egitto nel 703. In quest’anno, infatti, Ata ibn Rafi, proponendosi di assalire la Sardegna giun-se in un’isola di Sicilia dove fece un grosso bottino d’oro, d’argento e gemme11. Ma la notizia a nostro parere più significativa è l’inizio di razzie via mare a partire dall’anno successivo, il 704, che portarono tra l’altro al saccheggio di una città siciliana, che lo stesso M. Amari, nella prima edizione della sua Storia, ipotizza essere Marsala, ipotesi che è stata di recente accolta da F. Maurici12. Comunque sia, la presenza aggressiva dei Musulmani nel Mediterraneo occidentale nei primissimi anni dell’VIII secolo, preludio alla conquista islamica della Spagna del 711, potrebbe essere stata la causa principa-le dell’abbandono dell’insediamento. Con questa data d’altronde concorda la datazione della ceramica relativa ai livelli di distruzione qui recuperati.
Resta comunque aperto il problema della natura dell’insediamento. La posizione del sito, arroccata ed isolata rispetto all’abitato in prossimità dell’approdo, la presenza del-la chiesa con il suo battistero all’interno di un complesso di edifici di cui molto ancora resta da scoprire, ed infine la presenza della sorgente d’acqua dolce nelle immediate vi-cinanze con cui sembrano in stretta relazione le strutture rinvenute nell’area immedia-tamente antistante l’edificio romano, ci hanno indotto ad ipotizzare l’esistenza nel sito di un insediamento monastico. Il fenomeno del monachesimo insulare è attestato nel Mediterraneo occidentale a partire dal IV secolo13. Notizie sporadiche del ritiro di per-sonaggi legati alla gerarchia ecclesiastica nelle isole che circondano la Sicilia si hanno a partire dal V secolo14. Le Egadi poi, a giudicare dal toponimo di Favignana (“gazirat al rahib” ovvero l’isola del monaco) attestato in età islamica, tradiscono la presenza di al-meno un eremita in periodo bizantino15; a Pantelleria nell’VIII secolo si ha l’attestazione
Sicilia occidentale ed il Tirreno centro-meridionale nell’VIII secolo alla luce del rinvenimento di alcuni conteni-tori da trasporto, in G. P. B (ed.), Atti del II Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Brescia, 28 settembre - 1 ottobre 2000, Firenze 2000, pp. 402-407; F. A, La ceramica da fuoco altomedievale della Sicilia occidentale (secc. VIII-XI), in S. P U (ed.), La ceramica altomedievale in Italia(Quaderni di Archeologia Medievale 6), Firenze 2004, pp. 375-386.
11 Nella fonte non è citata l’isola e M. Amari propone un’identificazione generica con la Sicilia. M. A, in C. A. N (ed.), Storia dei Musulmani di Sicilia, 1, Catania 1933-1939, pp. 292-293.
12 F. M, Medioevo trapanese. Gli insediamenti nel territorio della provincia di Trapani dal tardo antico alle soglie dell’età moderna, Palermo 2002, p. 30.
13 J. B, Le monachisme dans les îles de la Méditerranée nord-occidentale, in RACr 76 (2000), pp. RACr 76 (2000), pp. RACr351-374; B. M, F. S, Il fenomeno monastico nelle isole minori del mar Tirreno dal IV al IX se-colo. Fonti letterarie ed evidenze archeologiche, in RACr 76 (2000), pp. 621-650.RACr 76 (2000), pp. 621-650.RACr
14 Le prime attestazioni dalle fonti scritte di un monachesimo siciliano si trovano, sul finire del V secolo, in una lettera di papa Gelasio I e nella vita di San Fulgenzio che vide a Siracusa il monastero fondato dal suo vescovo Eulalio.
15 E. P, Le fonti medievali e i dati archeologici di Marettimo, in F. A, E. P, Prime attestazioni cristiane nell’arcipelago delle Egadi e presenze monastiche, in R. M. B C, E. V(ed.), La cristianizzazione in Italia fra tardoantico e altomedioevo, Atti del IX Congresso Nazionale di Archeo-logia Cristiana, Agrigento, 20-25 novembre 2004, Palermo 2007, pp. 1815-1836.
1252 – –
di un monastero di rito greco dedicato a San Giovanni16, e recenti indagini hanno por-tato alla luce i resti di ben due monasteri protobizantini17; a 10 km a Sud di Siracusa nell’isoletta di Ognina nel 1964 sono state messe in luce le strutture di una chiesa a tre navate18; a Lipari il culto di San Bartolomeo era già radicato nel VI secolo e nell’ottica di una presenza monastica potrebbe anche essere letto il rinvenimento nell’isola di Pa-narea, nella spiaggia di San Pietro, del frammento di una mensa d’altare del tipo a lo-bi decorata a rilievo con un tralcio di vite uscente da un kantharos19.
F. A.
L
Il rinvenimento della chiesa e del suo battistero rappresentano per la storia e l’ar-cheologia della Sicilia del primo cristianesimo una scoperta importante dal momento che ad oggi si conoscono per l’isola soltanto sei fonti battesimali: quattro noti dalla let-teratura archeologica e due ricordati nelle fonti scritte ed in particolare in un’epistola del vescovo Pascasino di Lilibeo ed in un’altra di Gregorio Magno. Il primo dei fonti di cui restano testimonianze materiali è stato individuato di recente alla foce del fiume Modione, antico Selino, nel territorio di Selinunte e datato per confronti tipologici al VI secolo20; il secondo si trova nell’isola di Pantelleria21; il terzo sarebbe stato ricono-sciuto da F. Tomasello in un ambiente annesso alla chiesa rupestre di Rosolini in pro-vincia di Siracusa, ipotesi che a tutt’oggi si presenta molto problematica soprattutto per la cronologia agli inizi del VII secolo22; il quarto, infine, si riferisce alla continuità d’uso nel tempo per funzioni battesimali della sorgente d’acqua dolce sotto la chiesa cinque-centesca di San Giovanni al Boeo a Marsala23, la cui cronologia ed impianto sono allo stato attuale delle ricerche poco chiari. Delle altre due testimonianze che ci vengono dal-le fonti scritte la prima riguarda proprio il territorio della diocesi di Lilibeo: una lettera del 444, mandata dal vescovo Pascasino a papa Leone, a proposito della data della pa-squa, racconta che nel 417, il fonte battesimale di una piccola chiesa rurale in vilissi-ma possessio Meltinas nel territorio di Lilibeo, si era miracolosamente colmato proprio nel giorno di Pasqua previsto dal calcolo alessandrino (Ep. 3, in Patrologia Latina 54, coll. 601-609)24; e un’altra di Gregorio Magno a Secondino, vescovo di Taormina, ripor-
16 J. T, A. C H, Byzantine Monastic Foundation Documents: a complete Trans-lation of the surviving Founder’s Typika and testaments (Dumbarton Oaks Studies 35), Washington 2000.
17 Pantelleria 1 e 2.18 L. B B, Ognina (Siracusa). Saggi di scavo, in BdA 1966, pp. 105-106; G. A, Recenti
scoperte di monumenti paleocristiani nel siracusano, in Akten des VII Internationalen Kongresses für Christ-liche Archäologie, Città del Vaticano-Berlin 1969, pp. 309-326.
19 L. B B, Le isole eolie dal tardo antico ai normanni, Ravenna 1988, p. 16: Gregorio di Tours cita una chiesa edificata sulla tomba del Santo; per Panarea, I., ibid., pp. 122-123, figg. 65-66.
20 C. G, Testimonianze paleocristiane e bizantine nel territorio della provincia di Trapani, in Sulle tracce del primo cristianesimo in Sicilia e in Tunisia, Musée National du Bardo, Tunis - Dar Bach Hamba, Tunis, 18 mai - 18 juillet 2007, Palermo 2007, pp. 217-228, si tratta in questo caso di un fonte ottagonale ad alveoli.mai - 18 juillet 2007, Palermo 2007, pp. 217-228, si tratta in questo caso di un fonte ottagonale ad alveoli.mai - 18 juillet 2007
21 Pantelleria 1 e 2 (op. cit. nota 17).22 F. T, La basilica rupestre di Rosolini (SR), in R. M. B C, E. V (ed.), La
cristianizzazione in Italia fra tardoantico e altomedioevo, Atti del IX Congresso Nazionale di Archeologia Cri-stiana, Agrigento, 20-25 novembre 2004, Palermo 2007, pp. 1673-1700.
23 G (op. cit. nota 20), pp. 221-223; di recente sono stati effettuati scavi archeologici in parte pub-blicati SicA; per il rapporto tra il monastero medievale di San Giovanni e la nostra fondazione cenobitica di età normanna, vedi infra il contributo di E. Pezzini.
24 S (op. cit. nota 7), pp. 559-560.
“ ” 1253
ta l’ordine del papa di smantellare il fonte battesimale nel monastero di Sant’Andrea super Mascalas e di edificarvi al suo posto un altare (Ep. 3, 56)25.
Nessuno degli esempi siciliani finora noti, presenta analogie morfologiche con il fonte battesimale rinvenuto a Marettimo che invece ci rimanda per la forma e per la posizione all’interno della chiesa all’ambiente nord africano della Bizacena (fig. 8)26. Il confronto con questa regione si è rivelato particolarmente significativo dal momento che la morfologia del nostro fonte sembra essere peculiare della Bizacena, tanto che il Bejaoui ha proposto per la produzione di vasche battesimali con questa forma un ate-lier regionale27. Fuori dalla Bizacena, infatti, questo tipo di fonte è presente in Cirenaica, nella basilica di Ras el Hilal, datata al VI secolo e posizionata, come nel nostro caso, nell’ambiente a Sud dell’abside28. Si tratterebbe quindi nel caso di Marettimo, dell’unico esempio fuori dal continente africano di questo tipo di manufatto, cosa che si potrebbe spiegare con un’influenza diretta della Bizacena. Sappiamo dalle fonti, infatti, che nu-merosi vescovi della Bizacena cacciati dai Vandali alla fine del V secolo, hanno trovato rifugio in Sicilia ed in particolare il vescovo Rufiniano avrebbe fondato un monastero “in una piccolissima isola vicino alla Sicilia”29. Non abbiamo elementi per affermare l’ar-rivo di un vescovo africano a Marettimo anche se questa potrebbe essere un’avvincente linea di ricerca. In quest’ottica si potrebbe spiegare la concomitanza di elementi che ci rimandano ad ambiente africano: muri costruiti con la tecnica a telaio, icnografia della chiesa, forma del fonte battesimale.
Per quanto riguarda l’icnografia della chiesa, invece, divisa in tre navate da pilastri, con l’abside iscritta e con la sua forma leggermente sproporzionata nel senso della lar-ghezza, essa presenta stringenti analogie con due piccole chiese rurali della Sicilia da-tate entrambe tra il V ed il VI secolo: una a Santa Croce Camarina in contrada Pirre-ra d’identica forma e proporzione, ma preceduta da un nartece30, l’altra a San Miceli
25 Questa lettera ha particolare rilevanza dal momento che indica come, malgrado le prescrizioni papali vietino la costruzione di fonti battesimali all’interno dei monasteri, vi siano state delle eccezioni, proprio in un contesto siciliano.
26 Qui a Sufetula, odierna Sbeitla, all’interno dell’episcopio sono state indagate due basiliche dotate di fon-te battesimale: la prima con battistero indipendente datato al IV secolo e la seconda datata alla fine del V se-colo, A. B A, M. B, M. F, S. R, Les basiliques chrétiennes de Sidi Jdidi, in RACr 76 RACr 76 RACr(2000), pp. 555-587. In entrambi i casi il fonte presenta la stessa forma di quello di Marettimo e nella Basilica II è sollevato dal pavimento, ha le scale poste sull’asse principale in corrispondenza dei due vani di accesso all’ambiente ed era posto sotto un ciborio sorretto da quattro colonne. Inoltre, per la posizione del fonte al-l’interno della chiesa confronta: Gouea dove è attestata una chiesa con fonte battesimale inserito nell’ambiente meridionale ai lati dell’abside ed in relazione con la navata laterale corrispondente (S. G, Monuments antiques de l’Algérie, 2, Paris 1901, p. 198; A. K, Les baptistéres paléochrétiennes, Paris 1962, p. 28, fig. 216), secondo uno schema molto diffuso nell’Africa cristiana a partire dalla fine del IV secolo fino al VI, vedi D. M, Strutture battesimali di IV e V secolo nell’Africa romana, Tesi di Dottorato in Archeo-logia e Storia dell’Arte Greca e Romana XXI ciclo, Università degli studi di Messina, p. 98.
27 F. B 2002, p. 209; F. B 2001.28 N. D, Les monumentes d’époque chrétienne en Cyrénaïque à la lumière des recherches récentes, in
Actes du XIeActes du XIeActes du XI Congrés International d’Archéologie Chrétienne, Lyon, Vienne, Grenoble, Genève et Aoste, 21-28 septembre 1986, 3, Rome 1989, pp. 2743-2796.
29 A. I (ed.), Pseudo-Ferrando di Cartagine, Vita di San Fulgenzio, Roma 1987, p. 67. Prima G. Agnello e la Cracco Ruggini ipotizzano che l’isola di Rufiniano fosse Ognina: G. A, (op. cit. nota 18); L. C R, Il primo cristianesimo in Sicilia (III-VII secolo), in V. M, S. P (ed.), Il cri-stianesimo in Sicilia dalle origini a Gregorio Magno, Atti del Convegno di Studi, Caltanissetta, 28-29 ottobre 1985, Caltanissetta 1987, p. 96.
30 Da ultimo G. D S, Ragusa. Chiesette rurali e cimiteri cristiani dell’altopiano. Revisioni e novità, in R. M. B C, E. V (ed.), La cristianizzazione in Italia fra tardoantico e altomedioevo, Atti del IX Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana, Agrigento, 20-25 novembre 2004, Palermo 2007, pp. 1540-1541.
1254 – –
presso Salemi in relazione con un centro rurale che si trovava alla confluenza delle vie di comunicazione che collegavano Marsala e Trapani alla Valle del Belice ed al territo-rio di Palermo31. Entrambi questi confronti sono di particolare interesse perché ci ri-mandano ad una architettura molto semplice di ambito rurale come quella della chiesa di Marettimo. Planimetrie simili si ritrovano anche in Nord Africa in Numidia32 e nel-le chiese rurali dell’entroterra libico33.
F. A.
L “” **
Nella prima età normanna, tra la fine dell’XI e gli inizi del XII secolo, in Contrada Case Romane si insedia un piccolo nucleo di monaci di rito greco34. I dati archeologi-ci sembrerebbero indicare che, all’arrivo dei monaci, le strutture murarie del complesso monastico proto bizantino fossero in parte in rovina, anche se la basilica era riconosci-bile nelle sue parti fondamentali. Quello che invece aveva retto alle ingiurie del tempo era l’edificio militare romano in opus coementicium. I monaci adattarono quest’ultimo a cenobio35 e sulle rovine della basilica proto bizantina edificarono una nuova chiesa di
31 B. P, La basilica di Salemi, in Monumenti Antichi dell’Accademia dei Lincei 24 (1916), coll. 697-736; Quattro note di Archeologia Cristiana in Sicilia, Palermo 1992, p. 10, fig. 17; I., La Sicilia, in Alle origini del-la parrocchia rurale (IV-VII seolo), Atti della giornata tematica dei Seminari di Archeologia Cristiana (Ecole Française de Rome, 19 marzo 1998), Città del Vaticano 1999, pp. 167-180. La chiesa di San Miceli è stata fortemente danneggiata dai lavori agricoli, la mancanza del nartece potrebbe quindi essere legata allo stato di conservazione del monumento.
32 Confronti molto vicini sia per le dimensioni dell’edificio di culto che per la sua planimetria si posso-no istituire con la Basilica 1 di Sila, datata al V secolo, I. G, N. D, J. P. C, Basiliques chrétien-nes d’Afrique du Nord, Inventaire de l’Algerie (Collection des Études Augustiniennes, Série Antiquité 129-130), Paris 1992, p. 212, tav. 106.
33 A. D V, La diffusione del cristianesimo nell’interno della Tripolitania attraverso i monumenti e sue sopravvivenze nella Tripolitania araba, in QuadALibia 5 (1967), pp. 121-142, fig. 9, per la chiesetta rurale nell’uadi Crema datata tra la fine del IV ed il V secolo di identica forma e proporzione; R. M. B C, Aspetti dell’architettura basilicale cristiana in Cirenaica fino all’età di Giustiniano, in La Cirenaica in età antica, (Macerata 1995), Pisa-Roma 1998, pp. 63-82, E., Il complesso paleocristiano a Nord del teatro di Sabratha, in QuadALibia 14 (1991), pp. 115-211.
** Ringrazio per i preziosi suggerimenti bibliografici Cristina Rognoni, Franco D’Angelo e Mario Re. Mi è stato inoltre di aiuto il confronto con Rosa Di Liberto che ringrazio.
34 Sulla fase normanna del complesso cfr. A, D L, P (op. cit. nota 1); A, P (op. cit. nota 15).
35 L’edificio, di m 13,80 x 13,65, era articolato originariamente secondo uno schema a pettine: un vano rettangolare a SW cui si attestavano altri tre ambienti rettangolari e paralleli di cui quello di NW suddiviso in due ambienti quadrati36. In età normanna tale articolazione interna era profondamente modificata: gli am-bienti rettangolari che si attestavano a quello di SW erano stati tutti suddivisi in modo da ricavare sei vani quadrati con i lati di dimensione oscillante tra m 3,40 e m 4 ca. Le recenti indagini (scavi 2007-2008) han-no dimostrato che anche l’ambiente di SW è stato ripartito in modo da ricavare due vani, uno rettangola-re allungato e l’altro di dimensioni minori e pari a quelle degli altri ambienti. All’originario ingresso sul la-to NE dell’edificio militare, ne venne aggiunto, in questa fase, uno nuovo, aperto nel muro SW. Non dispo-niamo di dati certi sul sistema di copertura, anche se sappiamo che in alcuni ambienti le volte a botte origi-narie erano già crollate ed erano state sostituite, in età tardoantica, da coperture in legno e tegole. Mancano tuttavia elementi che consentano di determinare con certezza se tutti gli ambienti fossero effettivamente in uso e quale fosse la loro distribuzione funzionale. Naturalmente alcuni dei vani a pianta quadrata totalmen-te disimpegnati saranno stati utilizzati dai monaci come celle. Non è escluso che l’ambiente di maggiori di-mensioni fosse destinato a spazio per il pasto in comune (trapeza).
“ ” 1255
dimensioni molto ridotte rispetto alla precedente: impiantarono la nuova chiesa in cor-rispondenza della navata centrale di quella più antica, utilizzandone la facciata e erigen-do l’abside in asse con la precedente, ma arretrata rispetto ad essa (figg. 1, 2, 5). Una rifondazione che tradisce una chiara volontà di recuperare un luogo santo e che, per le modalità in cui si declina, è stata, forse, in parte determinata dallo stato di conserva-zione dell’edificio più antico: la facciata in opus africanum, con grandi ortostati di pie-tra, doveva essere meglio conservata dell’abside in pezzame di pietra legato con terra. I caratteri della chiesa normanna, indicano che nella costruzione vi è stato un determi-nante apporto extraisolano: R. Di Liberto ha chiarito che l’impianto a croce atrofizzata della chiesa non trova paralleli in Sicilia mentre rimanda a esempi greco bizantini ex-traurbani (in particolare insulari: Sporadi, Cicladi, Cipro, Rodi, Creta) e cogenti con-fronti sono istituibili con alcune chiese rurali in terra di Bari36. Alla tradizione costrut-tiva siciliana rimanda invece la soluzione tecnica delle nicchie d’angolo per il raccor-do della cupola. Il dato architettonico induce pertanto ad ipotizzare che a Marettimo la “rifondazione” normanna sia avvenuta anche con apporti dalla Puglia se non diret-tamente dalla Grecia.
In questa fase sono state resecate probabilmente alcune delle strutture residue del complesso proto bizantino poste tra la nuova chiesa e l’edificio romano riattato a ce-nobio. Inoltre, sembrerebbe che l’area a est della nuova abside e a sud della chiesa sia stata utilizzata come cimitero della piccola comunità monastica: sono stati infatti rin-venuti resti di sepolture. Per finire non è escluso che un muro di recinzione fosse ri-cavato utilizzando parte dei preesistenti muri (si spiegherebbe così perché solo alcune delle strutture in opus africanum si siano conservate37).
Già alla fine del XII secolo il cenobio venne abbandonato e furono apportate mo-difiche nell’area, probabilmente in connessione con una diversa destinazione del com-plesso. Nella zona tra la chiesa e il cenobio, nel corso del XIII secolo, furono scavate numerose fosse e tra queste una di grandi dimensioni dal profilo regolare, forse desti-nata ad ospitare le fondazioni di una struttura poi non edificata38.
La costruzione della chiesa normanna in corrispondenza della navata centrale della precedente basilica proto bizantina sembra riflettere una volontà di restituzione al culto e si configura come una deliberata “rifondazione”. Ma perché questa rifondazione cri-stiana nell’estremo lembo della Sicilia occidentale nella prima età normanna? Si tratta di un fenomeno isolato? Possiamo ipotizzare che si conservasse una memoria dell’anti-co insediamento monastico e se sì in quali ambienti?
Nelle pagine che seguono si cercherà di rispondere a queste domande allargando il campo d’indagine e prendendo in considerazione gli altri monasteri di rito greco fon-dati in età normanna nella diocesi di Mazara ed in particolare le altre fondazioni co-siddette “basiliane”del Marsalese. Si affronteranno dunque questioni generali e per cer-ti versi svincolate da una descrizione di dettaglio dei risultati dello scavo per i quali ri-mandiamo alla pubblicazione definitiva delle indagini archeologiche.
Il complesso monastico di Marettimo non è un episodio isolato, ma si iscrive nel-l’ambito di quello che Vera von Falkenausen ha definito “strana fioritura del monache-
36 D L in A, D L, P (op. cit. nota 1), pp. 398-401.37 Per le attestazioni nelle fonti scritte di muri di recinzione dei monasteri calabri cfr. E. M, Mo-
nachesimo Greco in Calabria. Aspetti organizzativi e linee di spiritualità, in Quaderni della rivista di studi bi-zantini e slavi 15 (1996), pp. 77-78.
38 Devo i dati cronologici alla cortesia di Francesca Agrò che sta studiando la ceramica medievale con rivestimento vetroso del sito.
1256 – –
simo siculo-greco”39 e che è rappresentata non solo dai monasteri della Sicilia orienta-le, ma anche da quelli della parte occidentale dell’isola.
Sorprendente è il quadro offerto dall’osservazione dei dati di cui disponiamo sui monasteri greci geograficamente più vicini al cenobio di Marettimo (fig. 9); si tratta di Santa Maria della Grotta a Marsala e dei suoi metochia cioè San Giovanni al Boeo, San-ta Croce, Santa Venera, San Pantaleo nell’isola omonima (Mozia) e Sant’Angelo nel ter-ritorio di Rinazzo. In primo luogo si riscontra una significativa corrispondenza crono-logica con il cenobio di Marettimo: Santa Maria della Grotta, fondata nella prima età normanna (1098), risulta in abbandono alla fine del XII secolo40. Inoltre, recenti scavi e una revisione dei dati provenienti da vecchie indagini dimostrano che non solo Santa Maria della Grotta, ma anche San Giovanni al Boeo insiste su preesistenti edifici cristia-ni. Più complesso il caso di San Pantaleo perché le tracce medievali rinvenute nell’isola di Mozia sono di dubbia interpretazione. Si tratta dunque di casi differenziati che vale la pena analizzare separatamente.
Il monastero di S. Maria della Grotta venne fondato extra moenia – edificatum a fundamentis dicono i documenti – dall’emiro o amiras Cristodulo41 che fu a capo del-l’amministrazione della contea nel periodo compreso tra il 1107-1126. In parte ricavato in roccia, insiste su un lembo della necropoli paleocristiana di Lilibeo42, sviluppata ai
39 V. F, Il monachesimo greco in Sicilia, in La Sicilia rupestre nel contesto delle civiltà mediterranee, in Atti del VI convegno di Studio sulla civiltà nel mezzogiorno d’Italia (Catania - Pantalica - Ispica, 7-12 settembre 1981), Galatina 1986, p. 135.
40 Cfr. M. S, Il monachesimo basiliano nella Sicilia medievale. Rinascita e decadenza sec. XI-XIV. Ristampa anastatica dell’edizione del 1947 con aggiunte e correzioni, Roma 1982, pp 132, 407-408. Si tratta anche in questo caso di un fenomeno che tocca in generale i monasteri greci siciliani cfr. I., ibid., p. 75; V. F, L’archimandritato del San Salvatore in lingua phari di Messina e il monachesimo italo-greco nel regno normanno-svevo (secoli XI-XIII), in Messina il ritorno della memoria, catalogo della mostra (Messina, 1 marzo-28 aprile 1994), Palermo 1994, p. 51.
41 V. F, Cristodulo, in Dizionario Biografico degli Italiani 31 (1985), pp. 49-51; J. J, Arabic Administration in Norman Sicily. The Royal Dīwān, Cambridge 2002, pp. 69-74; nuovi dati sono sta-ti presentati da Vera von Falkenhausen al convegno su Giorgio d’Antiochia organizzato a Palermo dall’Isti-tuto di Studi Bizantini e Neoellenici, in corso di stampa. Cristodulo – chiamato Abd al-Rah (puntino sot-to) mān al-Nasrānī oppure Abd Allah nelle fonti in arabo, greco di Calabria o di Sicilia secondo parte del-la storiografia o arabo cristianizzato (status quaestionis in J (op. cit. in questa nota)) – promosse il mo-nachesimo greco: è il patrono del monastero dedicato alla Theotokos Odegitria di Rossano (Santa Maria del Patir); oltre a Santa Maria della Grotta a Marsala fonda forse anche una chiesa a Palermo consacrata ai san-ti Maria, Matteo, Senatore, Viatore e Cassiodoro. Per il ruolo nella fondazione del Patir si veda G. B, Nuovi contributi alla storia del Patir, Documenti del Vat. Gr. 2605, Roma 2005, p. 28.
42 Per il complesso di S. Maria della Grotta cfr. M. A. L, La Grotta della Sibilla, in A.V. Lilibeo. Testimonianze archeologiche dal IV sec. a.C. al V sec. d.C., Palermo 1984, pp. 200-207; E., La grotta della Sibilla, in M. G. G (ed.), Marsala, Palermo 1997, pp. 122-127 ; R. G, Lilibeo (Marsala). Area di Santa Maria della Grotta e del complesso dei Niccolini: recenti rinvenimenti archeologici, in Terze giornate in-ternazionali di studi sull’area elima, Gibellina ottobre 1997, Pisa-Gibellina 2000, pp. 655-680; ottobre 1997, Pisa-Gibellina 2000, pp. 655-680; ottobre 1997 R. G, Li-libeo (Marsala). Recenti rinvenimenti archeologici, in Atti VIII Congresso nazionale di Archeologia cristiana, Bordighera 2001, pp. 149-154; per l’impianto medievale cfr. E. C, L’abbazia basiliana di S. Maria della Grotta, in C. A. D S, A. C (ed.), Federico e la Sicilia dalla terra alla corona. Archeologia e Archi-tettura, catalogo della mostra, Palermo dicembre 1994-maggio 1995, Palermo 1995, pp. 239-245; I., S. Maria della Grotta: un’abbazia basiliana della Sicilia occidentale, in G (op. cit. in questa nota), pp. 161-171; P. T, Un’abbazia basiliana nel XIII secolo. Santa Maria della Grotta a Marsala: lo scavo e i materiali, in D S, C (op. cit. in questa nota), pp. 247-254. I risultati delle indagini archeologiche effet tuate nel corso dei restauri del complesso sono stati pubblicati solo parzialmente e segnalano la presenza di arcosoli paleocristiani e di una fase di riconfigurazione nella prima metà del XIII secolo. L’auspicabile pubblicazione integrale dello scavo e lo studio completo degli straordinari cicli pittorici (sui quali da ultima M. A. L,
“ ” 1257
margini di una vasta latomia. Si tratta di una fondazione promossa dai vertici del pote-re politico; dopo Cristodulo infatti anche Ruggero I e Adelasia e, successivamente, Rug-gero II dotarono riccamente il monastero43. Alla fine del XII secolo Santa Maria del-la Grotta, abbandonata e in rovina, venne annessa dall’imperatrice Costanza all’omoni-mo monastero di Palermo44.
I recenti scavi condotti a S. Giovanni al Boeo hanno messo in luce un sito pluri-stratificato e caratterizzato, come Marettimo, dalla presenza di una sorgente che ha fat-to ipotizzare un collegamento a un antico culto delle acque probabilmente connesso a un santuario di Afrodite45.
L’attuale chiesa sorge sopra il cosiddetto “antro della Sibilla”, una struttura di età romana riutilizzata in età paleocristiana come battistero46. Le indagini archeologiche han-no individuato, sotto la chiesa di età moderna, due precedenti edifici di culto datati, in via preliminare, rispettivamente a età bizantina e tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo47. Le più antiche tracce documentarie su San Giovanni sono conservate dalla trascrizione di un atto notarile del 1308 relativo alla composizione di una controversia tra l’abate di Santa Maria della Grotta di Palermo e il vescovo di Mazara; il primo ri-vendicava la pertinenza pleno iure della chiesa di San Giovanni all’Abbazia palermita-na, il secondo affermava che la chiesa era a lui subiecta lege diocesana48. L’atto testimo-nia chiaramente che nel 1308 l’abate di Santa Maria della Grotta non disponeva né di documenti comprovanti la dipendenza di San Giovanni dall’abbazia né dell’atto di fon-dazione della chiesa. La lettura incrociata dei dati archeologici e di quelli documenta-
Gli affreschi bizantini di Santa Maria della Grotta, in G (op. cit. in questa nota), pp. 172-181) permet-teranno di avere un quadro più chiaro della storia del monastero.
43 Archivio di Stato di Palermo Tabulario di Santa Maria della Grotta, 16. Pubblicato in C. A. G, I documenti inediti dell’epoca normanna in Sicilia (Documenti per servire alla storia di Sicilia 18), Palermo 1899, pp. 21-24, n. X. Si tratta del transunto di un privilegio in greco di Ruggero II che fa riferimento ad un precedente privilegio di Ruggero I e Adelasia. Come rileva Garufi, il privilegio ha una datazione incongrua è infatti prodotto da Ruggero rex e datato rex e datato rex ab origine mundi nel 6336, VI indizione; ma la VI indizione corri-sponde al 1128, il 6336 all’828 e Ruggero venne incoronato re nel 1130. Riferimenti al privilegio di Ruggero in un documento di Costanza del novembre 1198 (E. W, Acta Imperii inedita seculi XIII et XIV. Urkunden und Briefe zur Geschichte des Kaiserreichs und Königsreichs Sizilien in den Jahren 1198 bis 1723, 1, Innsbruck 1880-1885, p. 72, n. 77). Il privilegio concede ai monaci l’esenzione dalla giurisdizione vesco-vile, esenzioni doganali, il casale di Farchina (Rinazzo) con i suoi villani, l’isola Zobbugi (Mozia) con la sua salina e con la grangia di San Pantaleimone, le terre, il giardino, la fonte e la mandra de Muddo nel luogo detto Heraclia. Un vasto giardino viene poi concesso da Ruggero nel 1143 (G (op. cit. in questa no-ta), pp. 42-43).
44 S (op. cit. nota 40), pp. 132, 407-408.45 R. G, Scavi nel parco archeologico di Lilibeo: il ritrovamento della statua di Venere, in SicA 37
(2004), n. 102, pp. 91-96; E. C, S. T, Il culto di Afrodite a Lilibeo, in SicA 37 (2004), n. 102, pp. 97-106; M. C. C, P. V, La chiesa di S. Giovanni al Boeo a Marsala: gli interventi di restauro e lo scavo archeologico, in SicA 39 (2006), n. 104, pp. 121-132.
46 A. S, in NSc 1886, pp. 103-104, già rilevava l’importanza della fase paleocristiana dell’edificio; NSc 1886, pp. 103-104, già rilevava l’importanza della fase paleocristiana dell’edificio; NScM. A. L, La grotta della Sibilla, in G (op. cit. nota 42), pp. 122-127; R. M. B C, Testi-monianze archeologiche del primo cristianesimo nella Sicilia occidentale, in Congresso internazionale di Stu-di su S. Vito ed il suo culto, Mazara del Vallo 18-19 luglio 2002, Trapani 2004, pp. 41-42; E., Il primo cri-stianesimo a Lilibeo: aspetti, problemi e attualità della ricerca archeologica, in M. C, M. G. G-, Pasca sino di Lilibeo e il suo tempo, Caltanissetta 2002, pp. 93-96; F. M, La Sicilia occidentale dal-la tarda antichità alla conquista islamica, Palermo 2005, pp. 107-113; G, (op. cit. nota 20), pp. 221-223. Alla fase paleocristiana è riferibile un sepolcreto sub divo rinvenuto all’esterno dell’attuale chiesa C, T (op. cit. nota 45), p. 110.
47 C, V (op. cit. nota 45).48 Archivio di Stato di Palermo, Miscellanea Archivistica 2, 61, col. 55-59.
1258 – –
ri induce a ipotizzare pertanto che la chiesa di San Giovanni non sia stata fondata co-me metochion di Santa Maria e che, prima della ricostruzione medievale – la cui data-zione tra la fine del XII e gli inizi del XIII va tuttavia confermata –, continuasse ad es-sere in uso la chiesa più antica con il suo battistero; in altri termini si potrebbe pensa-re, come ipotesi di lavoro da verificare, a una continuità del culto cristiano anche du-rante l’età islamica. La pubblicazione integrale dello scavo potrà forse fornire elemen-ti dirimenti in proposito.
La “grangia” di S. Pantaleo si trovava nell’isola di Mozia e venne concessa a Santa Maria della Grotta da un privilegio di Ruggero II. Il testo del documento indica che la “grangia” preesisteva alla concessione: il sovrano concede un piccolo monastero, intito-lato a San Pantaleimone, fondato su un’isola con toponimo islamico (gazirat Zobbugi) e concede inoltre l’isola con la sua salina49. Della “grangia” normanna non si conserva-no chiare tracce in elevato; una carta settecentesca50 rappresenta, nell’isola, due pozzi, la salina, un “beveratura” e delle strutture definite genericamente “casa” localizzate in corrispondenza dell’attuale piccolo borgo di cui fa parte una chiesa moderna dedicata a San Pantaleo. In contrada Cappiddazzu – presso un pozzo d’acqua dolce in un luo-go occupato, in età punica, da un importante santuario urbano – è stata messa in luce agli inizi del 1900 una struttura absidata, ma non orientata ad est, per la quale è stata proposta l’identificazione con una basilica e che non è possibile attribuire ad un preciso ambito cronologico51. Gli scavi condotti negli anni sessanta, attenti anche alle testimo-nianze medievali, hanno riconosciuto cinque fasi costruttive nell’area, e hanno recupe-rato sia materiale tardoantico – tra cui diverse lucerne con simboli cristiani – sia mate-riale medievale52. Al momento dunque la presenza di un edificio di culto paleocristiano o proto bizantino nell’isola resta un’ipotesi di lavoro da sottoporre a verifica così come resta da determinare la localizzazione della “grangia” normanna.
Poco possiamo dire sui due metochia di Santa Maria della Grotta non indagati, Santa Venera e Sant’Angelo di Rinazzo, che presentano ambedue dediche greche.
Nel complesso dunque i nuovi dati su Marettimo e sulle fondazioni normanne del Marsalese ci propongono un palinsesto, il frutto di una stratificazione storica di cui è non è semplice dipanare le fila.
Come prima cosa sembra che la forza di attrazione di una preesistenza abbia avu-to un peso determinante nella scelta del sito su cui impiantare, in età normanna, que-sti monasteri di rito greco. Non si tratta di un’anomalia, i bioi dei santi greci e nume-
49 Si tratta del privilegio citato supra nota 43.50 Pubblicata da M. L. F, Mozia, in G (op. cit. nota 42), fig. 2, p. 16. 51 Agli inizi del XX secolo vi vennero condotti scavi da J. I. S. Whitaker e uno schizzo dell’area di T.
Ashby mostra distintamente una struttura absidata di notevoli dimensioni; tale struttura tuttavia non è orien-tata ad Est. Nel 1930 il sito venne scavato da P. Marconi che riconobbe quattro fasi: fenicia, ellenistica, ro-mana, bizantino-araba. La relazione di scavo identifica delle abitazioni bizantine costruite con materiale po-vero messo in opera a secco e caratterizzate da piccoli ambienti di pianta irregolare. In proposito si veda V. T, “Il Cappiddazzu”. I precedenti, in Mozia 1. Rapporto preliminare della Missione archeologica della Soprintendenza alle Antichità della Sicilia occidentale e dell’Università di Roma, Roma 1964, pp. 21-31, che pubblica sia la relazione di scavo sia lo schizzo di Ashby.
52 T (op. cit. nota 54); V. T, “Il Cappiddazzu”. Lo scavo del 1965, in Mozia 2. Rapporto prelimi-nare della Missione archeologica della Soprintendenza alle Antichità della Sicilia occidentale e dell’Universi-tà di Roma, Roma 1968, pp. 7-24; per le lucerne cfr. tav. IV 2, XII 2, XIX. Tra le strutture messe in luce e rilevate ve ne sono alcune, relative ad ambienti conservati solo in parte, riferite alla fase quarta che hanno orientamento diverso rispetto ai muri delle fasi precedenti e sono compatibili con un orientamento ad Est. Potrebbe essere di grande interesse una revisione dei materiali e della documentazione al fine di determi nare meglio i caratteri dell’insediamento.
“ ” 1259
rosi esempi della Sicilia orientale e della Calabria dimostrano che la scelta del luogo dove fondare un monastero spesso si orientava su un sito santificato da un preesisten-te edificio sacro53. Inoltre, come rileva Vera von Falkenhausen, i diplomi di fondazio-ne dei monasteri greci ricadenti nell’Archimandritato del San Salvatore in lingua Pharidi Messina si aprono con la richiesta da parte di un “monaco, eremita o abate, o più raramente un laico [che] si rivolge al conte pregandolo di concedergli una certa chiesa abbandonata col rispettivo terreno per fondarvi o ricostruirvi un monastero”54. Ma la Calabria prima della conquista normanna faceva parte dell’impero bizantino e la Sicilia orientale, durante tutta l’età islamica, ha mantenuto consistenti nuclei di popolazione greca e monasteri greci55. Diverso è il caso della Sicilia occidentale interessata, stando alle fonti, da un processo di arabizzazione e islamizzazione capillare. Come si spiega-no allora le rifondazioni normanne di Marettimo e di Marsala? Già nel 1986 Vera von Falkenhausen aveva ipotizzato l’esistenza “non solo di comunità cristiane ma anche di monasteri e monaci nella Sicilia Occidentale” in età islamica56. Annliese Nef in un re-cente lavoro sui “mozarabi” di Sicilia57, che rende conto della complessità della “Sicilia islamica”, ha rilevato come il fatto che i siti di Santa Maria della Grotta di Marsala e di San Michele Arcangelo a Palermo “soient à nouveau fréquentés à partir de l’époque normanne suggère le maintien d’une mémoire des lieux de culte et donc probablement d’une pratique locale de devotion”58. Si tratta secondo la studiosa, che prevede un mol-tiplicarsi di esempi simili, di un indicatore della presenza nella Sicilia islamica di cri-stiani discendenti da quelle comunità che i musulmani hanno trovato nell’isola al mo-mento della conquista e la cui cultura si è modificata a contatto con i conquistatori59. I rinvenimenti di Marettimo e San Giovanni al Boeo rafforzano tale ipotesi: la costruzio-ne in età normanna (o forse nella prima età sveva nel caso di San Giovanni) di almeno 3 (i due citati più Santa Maria della Grotta) monasteri di rito greco in siti occupati da precedenti edifici sacri di età tardo antica o bizantina è un indicatore forte. A questi si potrebbe aggiungere San Pantaleo se si riesce a dimostrare la localizzazione della gran-cia normanna in contrada “Cappiddazzu” e l’ipotesi di identificazione con un edificio sacro delle strutture tardoantiche e protobizantine rinvenute nella stessa contrada.
I dati archeologici di cui disponiamo al momento su San Pantaleo, San Giovanni al Boeo e Santa Maria della Grotta tacciono sulle fasi di età islamica e dunque è neces-sario attendere la pubblicazione integrale degli scavi effettuati negli ultimi due siti per capire se e sotto quale forma si articolasse la devozione durante tale periodo. A Maret-
53 Si veda per esempio e con particolare riferimento alla scelta del luogo santo secondo le fonti agio-grafiche bizantine Kaplan *** pp. 186-187 che tuttavia prende in analisi anche i casi di preesistenze paga-ne. Il bios di Bartolomeo da Simeri racconta che il santo quando decide di passare dalla vita contemplati-va a quella comunitaria sceglie come sede per il cenobio le rovine di “una casa di preghiera” costruita molti anni prima da un monaco e poi abbandonata ma di cui si conosceva la dedica originaria a Maria e al Batti-sta (vita di San Bartolomeo, cap. 13, G. Z ***). Per altro, come rileva B (op. cit. nota 41), p. 26) “Niente di più naturale che appoggiarsi alle rovine di un edificio precedente e sfruttare il materiale an-cora utile per la nuova costruzione”.
54 V F (op. cit. nota 40), p. 47.55 V F (op. cit. nota 39), pp. 163 e ss.56 V F (op. cit. nota 39), p. 162.57 A. N, L’histoire des “mozarabes” de Sicile: bilan provisoire et nouveau materiau, in C. A, M. P-
, P. R (ed.), ¿Existe una identidad mozárabe? Historia, lengua y cultura de los cristianos de al-An-dalus (siglos IX-XII), Collection de la Casa Velazquez, (Madrid 2003), Madrid 2008, pp. 255-286.
58 E., ibid., pp. 270.59 E., ibid., p. 279.
1260 – –
timo invece i dati di scavo dimostrano chiaramente che, in età islamica, la chiesa pro-tobizantina era ormai in rovina anche se ben riconoscibile come luogo di culto cristia-no. Peraltro sappiamo che la memoria della presenza monastica nelle Egadi si manten-ne per tutta l’età islamica, quantomeno attraverso la tenuta del toponimo preislamico di Favignana “isola del monaco”60 o “del romito”, un toponimo che rimase in uso si-no all’età normanna61.
Per concludere, sembrerebbe che la concentrazione di monasteri greci di età nor-manna nella città rinominata dagli Arabi porto di Ali o di Allah (questa l’etimologia del toponimo Marsala), nel suo territorio e nelle isole ad essa vicine, possa essere una eredità della Lilibeo cristiana62 retta, in età bizantina, da vescovi greci e nella cui dio-cesi la chiesa orientale di Mitilene aveva proprietà63. In sostanza i nuovi dati archeolo-gici farebbero intravedere per l’età islamica una città e un territorio abitati da una po-polazione composita di cui faceva parte una comunità cristiana64. Nella prima età nor-manna su questo tessuto si innesterebbe l’intervento del potere centrale – sia esso rap-presentato da colui che stava a capo dell’amministrazione della contea, cioè Cristodulo, sia esso direttamente rappresentato dal conte o, più tardi dal sovrano – che rafforza la presenza monastica greca.
È pertanto presumibile che, tra la fine dell’XI e gli inizi del XII secolo, il sito di Marettimo sia stato scelto con la deliberata intenzione di restituire al culto un edificio da tempo distrutto, ma di cui si serbava memoria o si aveva contezza presso le comu-
60 Il toponimo compare per la prima volta nel trattato geografico Libro delle vie e dei reami di Ibn Hurdādbah, morto nel 912. L’autore, tra le isole più celebri dei Rum, elenca assieme a Creta, a Cipro, e alla Sicilia anche un’isola del Rahib che Michele Amari identifica dubitativamente con Favignana M. A, Bi-blioteca Arabo-Sicula, Torino-Roma 1881, 2, p. 667, su questa fonte cfr. E. A, Trapani e i suoi din-torni secondo i geografi arabi, in La Fardelliana 1 (1982), pp. 29-30. L’identificazione proposta da M. Amari trova conferma ne Il libro delle curiosità delle scienze e delle meraviglie per gli occhi, un trattato reso noto di recente da J. Johns e datato entro il 1050 (J. J, Una nuova fonte per la geografia e la storia della Sicilia nell’XI secolo. Il kitab gara ib al-funun wa-mulah al- uyun, in Mélanges de l’École Française de Rome. Moyen Âge 116, 1 (2004), pp. 409-449; datazione a p. 410): il capitolo dedicato alla descrizione di al Mahdiyya con-tiene un itinerario marittimo da al-Mahdiyya a Palermo e in questo itinerario l’isola al-Rāhiba viene segna-ta come scalo tra Ra’s al-N.b.rah (presumibilmente capo Boeo) e Trapani (idem, ibidem p. 449). La presenza di una comunità cristiana a Favignana in età tardoantica è attestata dalla necropoli in contrada San Nicola: A, P (op. cit. nota 15), mentre di un’antica chiesa in grotta dedicata a Santa Maria, si con-serva traccia sempre in contrada San Nicola, all’interno del moderno cimitero.
61 Al Idrīsī (A (op. cit. nota 60), 1, pp. 52-3, p. 80); Ibn Ğubair (A (op. cit. nota 60), 2, p. 167) nel 1174, spiega il toponimo di origine altomedievale di Favignana facendo ricorso alla realtà del suo tempo: “A ponente di Trapani, discosto due parasanghe all’incirca giacciono circa tre isole piccole e vicine tra loro; delle quali una si addimanda Malitimah, l’altra Yabisah e la terza al Rahib (il monaco), così detta da un ro-mito dimorante su la sommità, in una specie di castello che v’ha. Questo offre luogo d’agguato a nemici. Le altre due isole sono disabitate: in questa non vive se non che il monaco suddetto”. Se dobbiamo prestare fe-de a Ibn Ğubair, la rioccupazione di età normanna, documentata dalle fonti archeologiche e monumentali a Marettimo coinvolgeva anche Favignana.
62 Su Lilibeo cristiana si vedano i recenti contributi di B C (op. cit. nota 46), M (op. cit. nota 46); G (op. cit. nota 20), pp. 218-224 con bibliografia. Per la storia di Marsala cfr. G (op. cit. nota 42) e, di recente, M (op. cit. nota 12).
63 F. B, Trapani e il suo vescovado in epoca bizantina, in La Fardelliana 13 (1994), p. 6.64 Per quanto riguarda le complesse questioni relative alla comunità cristiane presenti nell’“ecumene isla-
mica medievale” ma con particolare riferimento all’area vicino orientale, cfr. B. S A, A pro-posito di arabi cristiani e arabi musulmani, ovvero dei rapporti tra maggioranza e minoranze nell’islam medie-vale, in Cristianità d’Occidente e cristianità d’Oriente (secoli VI-XI), Atti delle settimane di Studio della Fon-dazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 51, Spoleto 2004, pp. 871-916. Per quanto riguarda la Si-cilia cfr. N (op. cit. nota 56).
“ ” 1261
nità cristiane e gli ambienti monastici dei vicini centri della Sicilia occidentale e, for-se, anche nel più ampio circuito del monachesimo greco, come farebbero ipotizzare i confronti in ambito pugliese e greco per i caratteri architettonici della chiesa. Si trat-tava peraltro di un sito caratterizzato da una particolare densità: non solo reso santo dalla memoria di un antico luogo di culto, ma anche “deserto” e per finire tappa in-termedia sulla rotta Sicilia-Africa. Se si considera infine che l’isola era del demanio65
diviene assai probabile che alla fondazione del piccolo cenobio abbia contribuito, co-me già sostenuto da R. Di Liberto, l’impulso del potere centrale66 nell’ambito di un di-segno più ampio di controllo di quella parte della Sicilia che da sempre aveva fatto da testa di ponte per l’Africa67.
E. P.
65 G. S, I capibrevi di Giovanni Luca Barbieri 1. I feudi della Val di Noto, Palermo 1879, p. 22.66 D L (op. cit. nota 36).67 Sulla funzione di controllo sulla viabilità esercitata dai monasteri italo greci cfr. L. A, Viabilità e
insediamenti nel Val Demone. Da età bizantina a età normanna, in La valle d’Agrò un territorio una storia un destino, in C B (ed.), Convegno Internazionale di Studi, Taormina-Baia D’Agrò (ME) 20-22 feb-braio 2004, 1. L’età antica e medievale, Palermo 2005. Per la funzione di controllo sul porto di Messina del San Salvatore in lingua Phari, cfr. F (op. cit. nota 40), p. 49.
1262 – –
Fig. 1 – Planimetria generale dell’area (R. Di Liberto, F. Pisciotta, V. Nicolosi, F. Scirè).
Fig. 2 – Veduta dell’area di scavo.
“ ” 1263Fi
g. 3
– P
lani
met
ria
del l’
area
del
la c
hies
a (R
. D
i Li
-be
rto,
F. P
iscio
tta, V
. Nic
olos
i, F.
Sci
rè, P
. Orla
ndo)
.
Fig.
4 –
Pia
nta
sche
mat
ica
rico
stru
ttiva
del
la c
hies
a pr
otob
izan
tina
(F. S
cirè
).
Fig.
5 –
Fac
ciat
a ov
est
della
chi
esa
norm
anna
.
1264 – –
Fig.
6 –
Am
bien
te m
erid
iona
le c
on f
onte
bat
tesim
ale.
Fig.
7 –
Fon
te b
atte
simal
e.
Fig.
8 –
Sbe
itla,
Fon
ti ba
tte-
simal
i (d
a N
. D
, F.
B-
, L
es r
uine
s de
Suf
etul
a,
Sbeï
tla, T
unis
1973
, fig
. 34)
.
Fig.
9 –
Mar
sala
, Ano
nim
o, P
iant
a de
lla c
ittà
e de
l ter
rito
rio,
fin
e X
VI
sec.
Son
o ra
ppre
sent
ati:
l’iso
la d
i san
Pan
tale
o, S
an
Gio
vann
i al
Boe
o, l
e iso
le E
gadi
e l
a co
sta
afri
cana
con
Ca-
po B
on. (
da L
. D
,
Atla
nte
class
ico
della
Sic
ilia.
Le
cit-
tà c
ostie
re n
ella
car
togr
afia
man
oscr
itta
1500
-182
3, P
aler
mo
1992
, n. 4
14, p
. 438
).