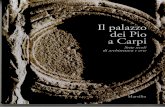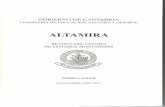L'insediamento medievale a San Giovanni Maggiore (Carlantino - FG): la motta e il castello
Il Castello Castro di Sant'Antioco - Castris apud portum Palmae de Sulcis
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Il Castello Castro di Sant'Antioco - Castris apud portum Palmae de Sulcis
CASTEL CASTRO DI SANT’ANTIOCO
Fonti documentarie e bibliografia
Epilogo: Castris apud portum Palmae de Sulcis1.
Il 28 ottobre 1881, il Consiglio Comunale di Sant’Antioco si riunisce per discutere diversi oggetti all’ordine
del giorno e, tra questi, viene trattata la vendita di dieci are di terreno a trattativa privata. Il Presidente, nonché sindaco, Giuseppe Milia riferisce all’adunanza il fatto di esser d’accordo che il
Consiglio proceda alla vendita del piccolo tratto di terreno circondato dai resti delle muraglie dell’antico
Castel Castro, poiché nessun profitto né vantaggio ricade sull’Amministrazione. Il Comune potrebbe
riservarsi solo la proprietà del suolo occupato dalle fondamenta di quel castello, con le pietre esistenti. Detto ciò, il sindaco invita il Consiglio a deliberare e questo decide, con voto palese e unanime, di procedere
ad “… alienare il piccolo tratto di terreno e ciò a trattativa privata sulla base del valore che verrà a risultare
da apposito estimo da praticarsi, riservando però la proprietà a quest’Amministrazione della circonferenza occupata dalle fondamenta unico avanzo del riferito Castello, ed il pietrame ivi esistente, e per compiere agli
incombenti all’uopo richiesti incarica la Giunta Municipale.
Addì 7 novembre 1881, S. Antioco. La deliberazione è stata resa nota al pubblico mediante affissione di copia all’Albo Pretorio nel giorno 6
corrente perché festivo, a cui è stata
significata opposizione dal Proprietario
Antonio Balia.”2 L’opposizione del Balia doveva essere
giustificata da un evidente diritto di
prelazione, forse, come confinante. Crediamo che ottenne ragione, perché nel
1928 (anno dell’epilogo del castello), al
momento della cessione al Comune, a titolo oneroso e bonario, del terreno per la
costruzione del campo sportivo comunale,
avvenuta con atto notarile del 28
settembre, risultano proprietari i signori Balia Luigi fu Salvatore e Balia Nicolò fu
Antonio. Quest’area di circa un ettaro,
con numero mappale 15 del Foglio XIV, risulta sita nella località “comunemente
nota Casteddu de Crastus, coerente per
tramontana a terreno vignato e seminativo
di Basciu Palmas Antioco Luigi fu Antonio, erede di Palmas Domenica fu
Giovanni Antonio, per levante alla linea
ferroviaria del Sulcis, siepe fichi moreschi frammezzo, per mezzodì già a Pabis
Beatrice fu Giuseppe vedova Murroni ed
ora Fagnani Fusconi Edmo fu Ferruccio, e per ponente a strada ora provinciale
Sant’Antioco-San Giovanni Suergiu.”3La
sovrapposizione del campo sportivo al castello avveniva quando solamente il toponimo, peraltro modificato,
e la memoria di un pozzo rimanevano l’unica attestazione dell’antico castello.
1 Carlo Baudi di Vesme, Codice Diplomatico di Villa di chiesa in Sardegna (raccolto e pubblicato da), colonne 376-
378 secolo XIV – Ristampa anastatica dell’edizione del 1877 – Edizioni della Torre Cagliari, Monastir giugno 1997. 2 Archivio Storico Sant’Antioco, in seguito A.C.SA., Serie Amministrazione - Registro 26/9, Deliberazioni originali
del Consiglio Comunale – Deliberazione del 28 ottobre 1881. 3 A.C.SA., Serie Istruzione Pubblica - Fasc. 10/1, Costruzione del campo sportivo in località “Casteddu de Crastu” –
1928-1931; 1938.
Planimetria del 1844 (carta De Candia), Frazione T R’, tavoletta 7 – “Regione Casteddu Crastu e s’Omu Setti Portas”. Sono riportate in modo
schematico le mura del castello ed il vecchio mappale n° 15.
Planimetria del costruendo campo sportivo comunale – da notare che il confine sud (ditta Fagnani) non è simmetrico ma forma una diagonale alla corrispondenza del lato posteriore del castello che era orientato verso l’asse nord-ovest / sud-est.
Nel 1890, nove anni dopo il passaggio di proprietà verso il privato, il Consiglio Comunale di Sant’Antioco rimpianse le scelte delle amministrazioni precedenti che, per motivi di opportunità, rasero al suolo il
castello.
Infatti nella seduta consiliare del 27 aprile 1890, mentre si decideva di effettuare le riparazioni urgenti al
carcere mandamentale, il consigliere Gaetano Idili faceva opportunamente osservare che il carcere non presentava tutti i requisiti igienici e di spazio necessari e che, per lo stato di perenne rovina, “a suo modo di
vedere il Municipio dovrebbe pensare a costruire un nuovo Carcere col sistema attualmente prescritto
prescegliendo ed occupando il fabbricato detto su Fortinu che trovasi per 28 Maggio p.v. messo all’asta pubblica per la tenue somma di £ 40. E così mentre si provvederà ad un nuovo stabilimento carcerario si
conserverà in questo Comune almeno una fra le antichità che il più prepotente vandalismo di cessate
amministrazioni hanno distrutto, tra le quali deve annoverarsi l’antico Castel Castro. Diversi Consiglieri appoggiano la proposta del Consigliere Idili”4. Il Consiglio riconobbe urgente la riparazione del carcere mandamentale, in base alla perizia di un mastro
muratore, e diede a trattativa privata i lavori per la somma di 230,30 lire, ma prese anche atto della proposta
di Idili rivolta all’acquisto del fabbricato detto “Su Fortinu”, di proprietà del demanio, per trasformarlo in nuovo carcere.
Ovviamente, la proposta del signor Gaetano Idili atta a trasformare il forte sabaudo Su Pisu, acquistato poi
nel 1902, stride col suo stesso sentimento di salvare l’opera come invece non fu col Castel Castro. Oggi probabilmente, oltre a non avere il castello, si avrebbe una fortificazione del 1813-1815 fortemente
rimaneggiata, che avrebbe dato problemi di lettura dell’opera originale a coloro che si sono impegnati nel
restauro del 1999-2000.
Testimone della distruzione del Castel Castro fu il sarto Gaetano Sanna che, da proprietario del tenimento confinante, nel 1876 chiese risarcimento dei danni subiti un decennio prima, a causa della mancata semina
del terreno. La deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 1876, presieduta dall’assessore
anziano Raffaele Manca, stante l’assenza del sindaco Luigi Campus, prese in considerazione la domanda di
risarcimento del signor Sanna, ammontante a 250 lire, perché gli fu impedito di “seminare a suo vantaggio alcuni tratti del terreno del suo chiuso che possiede in questo Comune regione Castel Castro , col passaggio
dei carri, che trasportavano le pietre in occasione che quest’Amministrazione nel 1867 ha fatto eseguire in
appalto i lavori di questa strada Comunale.” e per “… la quantità di pietre che gli furono tolte da quel chiuso, onde ne ha risentito danni immensi …”5.
Ecco il testo della domanda che offre qualche notizia sull’area in oggetto:
“All’onorevole Consiglio Comunale di Sant’Antioco
Il sarto Gaetano Sanna fu Not. Pietro, domiciliato in questo Comune di Sant’Antioco, consensè di umile ossequio alle S.S. L.L. Illustrissime ha il pregio di rassegnare che, in occasione che ebbe a tracciarsi lo
stradale Comunale, che da questo abitato conduce alla spiaggia di S.ta Catterina, e segnatamente dal 1867 al
1868, il Rassegnante dovette risentire la perdita di non aver potuto semenzare né a grano, né a fave, né finalmente ad ortaglie il di lui chiuso territoriale, ossia il chiuso che egli deve usufruire, di proprietà della fu
di lui moglie Maria Lucia Ollargiu, sito nella periferia di questo Comune, e precisamente denominato Castel
Castro, dacché sebbene il Rassegnante si fosse accinto a preparare il terreno non vi poté riuscire, atteso l’andirivieni di pedoni, carri per trasporto della pietra che escavasi dall’antico demolito Castello, e di
barcajoli, che colle loro barche attendevano al trasporto per via di mare della pietra che servir dovea pella
formazione dei ponti onde transitare a piedi asciutti nei mari; cosicché nel preindicato anno agrario il
Rassegnante dovette perdere i frutti che percevere dovea dal prodotto del suddetto chiuso, tanto in grano, che delle stoppie.
Occorre pure fare osservare che nel tracciamento del preindicato stradale Comunale, essendo mancata affatto
la terra, pel rialzo e terrapianare le protuberanze , onde d’ogni istante il terreno era pieno, convenne che escavassero a prestito la terra dalle parti laterali del suddetto stradale, cosicché non poca quantità si ebbe ad
escavarne nel chiuso del Rassegnante, che questa non fu avvalorata fino a tanto che l’opera fosse
completamente ultimata, abbenché di questa perdita il Rassegnante fino ad oggi non fu menomamente, né
4 A.C.SA., Serie Amministrazione - Registro 26/14, Deliberazioni originali del Consiglio Comunale – Deliberazione
del 27 aprile 1890. 5 A.C.SA., Serie Amministrazione - Fascicolo 28/18, Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale – Deliberazione
del 17 dicembre 1876.
alcunamente indennizzato.
Né può il Rassegnante passare sotto silenzio la perdita da esso risentita in cotale occasione giacché dal muro che serviva di cinta al di lui chiuso, verso la riva del mare, ed alla parte della pubblica strada gli furono tolte
quasi tutte le pietre di cui era composto quel muro che serviva di siepe al di lui terreno, onde ripararlo dai
danni che avrebbero potuto cagionargli non solo dai passanti, che dal bestiame errante d’ogni specie.
Tutti i sovra esposti fatti il Rassegnante si esibisce pronto giustificare per mezzo della prova testimoniale, e per le pietre del muro a lui involate si rimette alle risultanze di una perizia da praticarsi a tale oggetto, onde
farne rilevare il giusto valore.
Stante i sovra allegati fatti, resi ormai pubblici ed evidenziatissimi, il Rassegnante nutre viva fiducia che dal prudente Criterio di questo Onorevole Consiglio Comunale verrà presa nella più attenta dovuta
considerazione l’esposto, per cui prega la Bontà del prelodato Consiglio voler emettere favorevole il Loro
voto a pro del Ricorrente, provvedendo in guisa , che il Supplicante venga indennizzato dalle perdite e danni da lui sofferti nella contingenza di cui sopra si è accennato, da tassarsi dal prelodato Consiglio nella loro
Coscienza, od in difetto a giudizio di periti, avendo della presente quel riguardo di cui nella Loro Saviezza,
la stimeranno del caso. Grazie
Sant’Antioco lì 28 ottobre L’Umile Rassegnante
Gaetano Sanna.”6
Ancora nel 1881, di questa
preziosa strada se ne ricordava
l’indispensabile costruzione, avvenuta tra il 1867 ed il 1869.
In una delibera del Consiglio
Comunale si chiedeva un
sussidio al Governo, perché l’ingente somma di 149087,43
lire, servita a pagarne i lavori,
era stata versata, quasi per intero, dalle casse comunali. La
solerzia dell’amministrazione
“nella costruzione di detta
strada veniva suggerita dalla convenienza di aprire un
comodo passaggio nei due tratti
di mare esistenti lungo quella strada, e che prima valicavansi
con gravi stenti e secondo le
stagioni con vero pericolo della vita, come non rari casi si
sarebbero verificati se la carità
umana non fosse corsa a
salvare l’infelici minacciati di morte dalla corrente delle
acque. A suo ricordo puossi
annoverare fra gli altri il fatto del pericolo incorso da un
Brigadiere dei RR. Carabinieri
e da un suo dipendente mentre tragittavano quei due tratti di
mare e forse nella loro lotta con le acque sarebbero periti se lo stesso Esponente ed altri suoi compagni non
fossero accorsi in loro sollievo. Onde sottrarre a tanto pericolo i transitanti e risparmiare ai medesimi grandi
disagi, questo Comune con stragrandi sagrifizii si accollò un’enorme spesa superiore assai alle sue forze
6 A.C.SA., Serie Amministrazione - Fascicolo 28/18, Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale – Deliberazione
del 17 dicembre 1876.
Porzione della Planimetria della strada consortile..., a cura dell’ing. De Stefanis, 31
Luglio 1864, riportante sommariamente la posizione del Castello Castro.
finanziarie. Si accinse all’opera nel 1867 e la portò a compimento nel 1869, nel tempo appunto che il
Governo sanzionava la provvida legge del 30 Agosto 1868, diretta a rendere obbligatoria la costruzione delle strade comunali somministrandone i mezzi con i quali farvi fronte, ed elargendo copiosi sussidii a quei
Comuni che sarebbero più solerti a provvedere alla costruzione e sistemazione delle loro strade. Il Comune
di S. Antioco fu tanto solerte a costruire il suo tronco di strada avanti suaccennato che vi procedeva
contemporaneamente alla promulgazione della surriferita legge, dei cui benèfici effetti non poté fruire su quanto riguardava il sussidio che lo Stato avrebbe elargito in proporzione dell’importanza dell’opera e delle
spese nella medesima impiegate.” 7
Ciò che accadde non fu solo deleterio per le casse comunali ma , come già detto, comportò la distruzione del Castello Castro; si immagina che divenne urgente reperire materiale solido in quanto, in uno dei tanti
Consigli Comunali, si disse che la terra usata per il riempimento dello spazio acqueo, a causa dei ponti sotto
i quali defluiva l’acqua dallo stagno alle peschiere e indi al Golfo, veniva portata via, distruggendo in una notte l’opera che l’impresario svolgeva durante il giorno. La decisione di utilizzare le pietre del castello
maturò senz’altro a voce.
Il progetto della strada, già analizzato nella precedente edizione degli annali per l’area relativa ai ponti
romani, riporta per intero la planimetria dei lavori a partire dall’attuale Piazza Umberto, nel centro di Sant’Antioco, sino alla cantoniera di San Giovanni Suergiu. L’elaborato grafico, redatto dall’ingegnere De
Stefanis, per conto dell’Ufficio del Genio Civile nel luglio 1864, raffigura l’area del Castel Castro con un
semplice rettangolo attraversato da sottili linee oblique, secondo la convenzione dell’epoca dei progetti tecnici che, con tale simbologia, indicava aree urbanizzate o edifici.
Il Castello - Come tutti sanno, parecchie descrizioni del castello furono fornite dai
viaggiatori del XIX secolo. Tra le più
accurate vi sono quelle di Padre Angius che, per conto di Goffredo Casalis, ha redatto il
dizionario degli Stati di Sua Maestà per ciò
che concerne la Sardegna, e quella del generale Alberto Ferrero conte di La
Marmora che, promosso o esiliato in
Sardegna, divenne esperto di questa regione
nelle materie geologiche, storiche, archeologiche, botaniche e antropologiche,
grazie alla sua lunga permanenza e ai suoi
viaggi all’interno del territorio. Taluni viaggiatori citarono sommariamente il
castello, mentre altri, di passaggio a
Sant’Antioco, come Charles Edwardes nel
1882, trovando il solo fortino di Pontimannu, credettero di riconoscere l’opera solamente
sulla base delle descrizioni dei predecessori,
forse utilizzate quando dovettero scrivere i propri resoconti di viaggio, per arricchirli e
riordinarli.
William Henry Smyth, il “captain”della nave Adventure della Royal Navy di Sua Maestà
Britannica, mandato in Sardegna per redigere la carta delle coste nel 1823, pubblicò nel 1828, da esperto
cartografo ed idrografo , un libro descrittivo di 360 pagine, intitolato Sketch of the present state of the Island
of Sardinia, nel quale sono riportati i suoi appunti, le notizie prese durante il suo periplo e le discese a terra. Egli citò il Castel Castro col suo nome in sardo e disse che “l’antemurale, lungo 54 iarde e lungo 12, è di
porfido grezzo, il muro orientale è lungo un centinaio di iarde e alto 9. Vi sono anche i resti di un molo…”8.
7 A.C.SA., Serie Amministrazione - Registro 26/9, Deliberazioni originali del Consiglio Comunale – Deliberazione del
11 ottobre 1881. 8 William Henry Smyth, Relazione sull’Isola di Sardegna, a cura di Manlio Brigaglia, p. 289 – Ilisso Edizioni, Nuoro
1998.
Lido di Sant’Antioco: gli avanzi dell’antico molo nord.
John Warre Tyndale, nel suo libro pubblicato a metà del XIX secolo, fu altrettanto scarno e ribadì che
“…vicino alle antiche mura della città, si trovano le rovine del Castro, le cui mura di cinta, fatte di grosse pietre rozzamente squadrate, hanno una larghezza di circa 10 piedi, lunghe 775 e alte 36 ; la città era munita
di torri ai lati ed agli angoli, ed aveva un ingresso a volta con architrave lungo circa 13 piedi. L’epoca della
sua costruzione è sconosciuta per quanto, dallo stile, possa risalire all’ottavo o al nono secolo…”9.
Padre Vittorio Angius non diede lo
stesso parere di Tyndale per ciò che
riguarda l’epoca della costruzione e, mentre cita le varie dominazioni
sotto la quale è stata la Sardegna,
propende per l’epoca giudicale, facendo risalire il castello all’XI-
XII secolo, citando Torgotorio
(Mariano Torchitorio II) quando si
rifugiò nell’isola sulcitana nel 1108, dopo che il suo trono venne
usurpato dallo zio Torbeno nel
1104 circa. La descrizione del monumento da parte di Angius è
più precisa; egli si sofferma
ampiamente dicendo che “...in vicinanza all’angolo che le mura
dell’antica città faceano nella
concorrenza de’ lati, orientale e
meridionale, vedosi gli avanzi d’un gran castello. Esso figura d’un gran
parallelogrammo con un circuito di
metri 236; avendone nel lato maggiore 73, nel minore 45. A’
suoi angoli sono aggiunte
altrettante torri, e quindi tre altre
nei lati , orientale ed occidentale, e nel boreale, dov’era la porta, e può
vedersi la incavatura per il moto della saracinesca. La spessezza delle mura nel parallelogrammo è di circa
metri 3, nelle torri poco minore, fuorché in quella della porta. La superficie della gran figura era di metri quadrati 2709, e la complessiva delle torri di metri quadrati 175. Nell’interno vedonsi ancora due scale, una
nel lato orientale, l’altra nell’occidentale, ed una terza pare che fosse tra la porta e la torre dell’angolo sul
mare. Questa fortezza era circondata da un grosso fosso largo più di 15 metri dove entrava il mare a isolarla perfettamente. La sua costruzione è in grandi pietre rozzamente quadrate, e le più d’un enorme volume.
L’architrave della porta è lungo poco più di quattro metri. Vedendosi questo fabbricato dopo osservati gli
avanzi delle mura della città, si riconosce con certezza donde fu tolto il suo materiale. Le pietre non sono
sempre a ordini regolari, e tra quelle che sono piane vedonsene qua e là bugnate, che furono prese dallo zoccolo di altre costruzioni antiche”10.
Alberto Della Marmora chiarisce che non si tratta di un castello “propriamente detto, ma una cinta rinforzata da bastioni e fiancheggiata da sette torri. È una specie di campo trincerato che ha più la forma di un trapezio
che di un parallelogramma. Ha una superficie di circa 280 metri quadrati11; si compone di quattro muri
rettilinei non perfettamente paralleli a due a due, formanti una cinta con gli angoli muniti di una torre quadrata. Altre torri simili sporgono dal centro di tre lati, mentre l’ultimo, rivolto a sudest , non ha torre
9 John Warre Tyndale, L’Isola di Sardegna - volume secondo, a cura di Lucio Artizzu, p. 252 – Ilisso Edizioni, Nuoro
2002. 10
Angius/Casalis, dal Dizionario, La Sardegna Paese per Paese, vol. 7, p. 95 - Società Editrice L’Unione Sarda S.p.a.,
Cagliari 2004. 11
Probabilmente si intende circa 2800 metri quadrati.
Archivio di Stato di Torino, Paesi: Sardegna, Materie Feudali, Feudi per A e B – Memoria dell’ing. Bessone delle notizie prese nell’isola di S.t Antioco. Colla carta allegata alla medesima – 1754. Si nota il limite delle “vestigie della Città di Sulcis” che passa nei pressi del
Castello Castro.
mediana. Questa cinta mediana ha solo una porta praticata in basso della torre a, rivolta verso l’attuale
villaggio, e cioè verso il sito dell’antica città di Sulcis”12. Il generale rimane affascinato dalle dimensioni delle pietre che compongono le mura e dice che la porta
d’ingresso “è notevole per l’architrave in pietra, che conta 3,90 metri di lunghezza su 65 centimetri di
altezza e 66 di spessore. Non appena lo si è oltrepassato, varcando l’ingresso, si vedono sulla parete del
muro interno le scanalature verticali che fissavano la saracinesca o erpice a saliscendi con la quale la porta si chiudeva; più lontano in fondo allo stesso passaggio, ho creduto di riconoscere le tracce di una seconda
porta…”13 e, ancora, che nello spessore di circa tre metri dei muri “sono ricavate le scale per salire al piano
superiore, provvisto di un parapetto. Nella parte bassa del muro si notano le tracce di un grande fossato di dieci o quindici metri di larghezza, dove probabilmente entrava l’acqua del mare che è molto vicino”14.
La forma del castello è quella che potrebbe chiarire i dubbi, confermando le congetture sull’epoca della sua costruzione e sulla civiltà che lo eresse. La Marmora promette di argomentare in altre pagine, rispetto a
quelle in cui descrive il castello Castro, le motivazioni per cui ritiene che questo sia di origine araba, del
tempo in cui questa civiltà si fortificò nelle coste sarde.
Per fortuna, alla minuziosa descrizione si aggiunge anche un disegno la cui veduta “...è quella che nel 1821 ebbi modo di riprendere con la camera chiara; ne rilevai allora la pianta, ma in seguito, avendo avuto dei
12
Alberto Della Marmora, Itinerario dell’Isola di Sardegna - volume primo, a cura di Maria Grazia Longhi, p. 258 –
Ilisso Edizioni, Nuoro 1997. 13
Alberto Della Marmora, op. cit., pp. 258-259. 14
Alberto Della Marmora, op. cit., p. 259.
Planimetria, dimensioni ed orientamento del Castel Castro (tratto da: Alberto Della Marmora, Itinerario dell’Isola di
Sardegna - volume primo, a cura di Maria Grazia Longhi, p. 258 – Ilisso Edizioni, Nuoro 1997).
Veduta di Castel Castro di Sant’Antioco. La torre “A” in rovina si trova all’angolo nord dal lato della strada di ingresso al villaggio (tratto da: Giorgio Pellegrini, a cura di, L’esploratore innamorato. Alberto Ferrero della Marmora e la sua Sardegna, p. 73 – Abbà edizioni, 2009).
dubbi sulla sua esattezza, mi sono rivolto a un distinto ufficiale della Marina Reale Sarda che, pregato da
me, è ritornato sul posto e mi ha gentilmente consegnato i risultati dell’escursione…”15. Ecco, così, la vista presa con la camera chiara, usata come una sorta di antica macchina fotografica del
tempo, ovvero uno “strumento ottico basato su un prisma o un sistema di specchi che di un oggetto
riproduce su una superficie piana un’immagine virtuale i cui dettagli vengono poi ripassati in modo da
ottenere un disegno abbastanza fedele”16.
Nel disegno è raffigurata la torre A in rovina; la torre D, in parte smantellata, presenta un’evidente filatura
verticale lungo le pietre d’angolo, mentre la sommità dei muri appare ovviamente decapitata. Anche l’interno doveva contenere alloggi e casematte, come pure scale e ronde. La base sembra interrata da sabbie
che raggiungono la sommità della torre A. Ai posteri è apparso come un’ottima cava di pietra pronta, e
qualche delucidazione su alcune asportazioni ce la dà Valery (A. C. Pasquin), quando dice che il “Medioevo
è rappresentato nobilmente a fianco di queste rovine dell’antichità da un grande castello di granito rosso, in altri tempi composto da otto torri e demolito in parte dal governo nel 1804, per costruire il fortino del ponte
che collega Sant’Antioco al continente”17.
Il disegno riporta anche la scritta “preso da me Alberto colla camera lucida nel 1821 o 1823” e sotto scrive: “consimile al monumento del castello di Madaurus nella Zeuzitania a l’est di Bona, in Algeria. Fabbricato da
Trogotore Giudice di Cagliari dal 1108 al 1130”18. Vi sono riportate, inoltre, informazioni in contrasto con
ciò che scrive nel testo dell’opera Itinerario dell’Isola di Sardegna; infatti il generale cita il giudice Torchitorio Mariano II come costruttore, ma paragona il castello ad un monumento di fattura bizantina
dell’antica Madaura, a ovest della nuova cittadina di M'Daourouch nell’Algeria orientale. Ma nel testo
dell’Itinerario, assai più analitico e preciso di quanto non sia stato con questi appunti, esclude che possa
trattarsi di un’opera giudicale, tanto da paragonarlo definitivamente alla fortezza di Ain Tounga in Tunisia.
15
Alberto Della Marmora, op. cit., p. 257. 16
Alberto Della Marmora, op. cit., p. 257. 17
Valery, Viaggio in Sardegna, p. 177 – Ilisso Edizioni, Nuoro 1996. 18
Giorgio Pellegrini, (a cura di), L’esploratore innamorato. Alberto Ferrero della Marmora e la sua Sardegna, p. 73 –
Abbà edizioni, 2009.
Lo stesso Generale vuole approfondire la storia di questo monumento avvalendosi del signor Berbrugger
“dotto conservatore della Biblioteca e del Museo centrale di Algeri, per sapere se nei paesi dell’Africa settentrionale, da lui così bene esplorati per i loro monumenti antichi, ci fosse una fortezza che avesse un
qualche rapporto con il Castello Castro. Questo dotto archeologo mi rispose che effettivamente il castello ha
una singolare somiglianza con la cittadella di Thignica (Tonga in tunisino), salvo che l’edificio sardo è più
grande e ha sette torri, mentre quello africano ne ha solo cinque; tra i due - dice - ci sono affinità impressionanti e aggiunge che se quello di Castro fosse formato con pietre tolte da altre costruzioni e se nei
muri vi fossero anche epitaffi e dediche, piazzati in tutti i sensi, la somiglianza sarebbe perfetta.” (Lettera del
31 dicembre 1858)19.
19
Alberto Della Marmora, op. cit., pp. 258-259.
Sovrapposizione della planimetria del La Marmora sul progetto del campo sportivo comunale di Sant’Antioco, nel rispetto dell’orientamento, delle proporzioni, delle misure riferite anche dall’Angius. La figura trapezoidale si sovrappone al confine con la ditta Fagnani Edmo in modo quasi preciso ma verosimile con una possibile spartizione tra i
confinanti delle torri del fondo del castello.
Poiché l’articolo si propone di comparare l’edificio antiochense solamente sulla base di fonti letterarie e
documentarie, occorre sgombrare il campo relativamente ad alcune imprecisioni del passato che oggi possono anche esser citate, ma non possono fare letteratura vincolante in quanto le fonti documentarie, già
riportate all’inizio del presente articolo, le smentiscono. Il canonico Spano, nel suo Bullettino Archeologico
numero 5, anno III del maggio 1857 a pagina 79, riporta il fatto che il “il gran ponte che si è formato
nell’istmo che congiunge l’Isola è opera moderna. Per formare questo ponte si è distrutto in parte il Castello di Torgotorio...”20. Poiché nel 1857 il castello era ancora in piedi e nessun lavoro era stato effettuato lungo i
due tratti di mare che prima si attraversavano al posto dei ponti romani, detti “Ponti de mesu” e di “Santa
Caterina”, è da ritenere che l’affermazione dello Spano sia stata scritta solo successivamente perché apposta in una nota21. Infatti nel testo ricorda che il lungo ponte è rovinato e che il passaggio è stato abbandonato
“per cui bisogna passare in mezzo all’acqua, si può dire che oggi quella terra che diceasi penisola sia
divenuta Isola come nel primo tempo”22. Pensiamo che sia inutile ripetersi e riportare l’innumerevole quantità di precise deliberazioni del Consiglio Comunale di Sant’Antioco, conservate nell’Archivio Storico
Comunale, nel periodo 186023-1864, quando i lavori di costruzione della strada furono discussi, modificati,
progettati ed infine appaltati.
In quei cinque anni, si è passati dal pensare di ricostruire solo i due tratti di mare a partire dal piazzale del sito del fortino di Pontimannu, all’opportunità di risistemare l’intero tratto di strada e, infine, a stabilire, in
sede progettuale, che l’opera dovesse essere “consortile”, in quanto utile ad altre comunità quali Calasetta,
Palmas Suergiu e Tratalias. Il progetto prevedeva di sistemare la strada a iniziare dalla periferia del paese, ovvero dal Piazzale detto di Leopoldo (attuale Piazza Umberto), fino alla Nazionale che da Iglesias
terminava a Porto Botte, nel sito presso l’antica chiesetta di San Giovanni, nel borgo di Suergiu24.
Dionigi Scano, come Edwardes, pur competente di arte e architettura medievale, non approfondisce la storia che ha visto lo smantellamento del Castel Castro e confonde il fortino posto all’imboccatura del Ponte
romano, terminato nel 180825, con il castello bizantino, affermando che sulla sommità vi sono state costruite
alcune opere recenti26. Nel 1907, le opere recenti elevate nella piazza d’armi della vecchia fortezza,
acquistata dal Comune nel 188027, erano quelle relative alla costruzione delle nuove camere e alla necessità di uniformare i tetti dei vecchi e dei nuovi alloggi di servizio all’insediamento della Guardia di Finanza di
Mare, accasermatasi da Porto Botte a Sant’Antioco nel 1901, quando i lavori non erano ancora conclusi28.
Lo stesso Pasquale Cugia, autore del Nuovo Itinerario dell’Isola di Sardegna, edito a Ravenna nel 189229, a pagina 223, rammenta che, durante le occasioni in cui si recò a Sant’Antioco (1872-1875), non scorse nulla
nel sito del Castello Castro e che, avendo richiesto informazioni alle persone con cui era in contatto in paese,
gli fu risposto che la costruzione andò interamente distrutta.
Comparazioni - Individuate le fonti documentarie ed assemblata ancora una volta la bibliografia essenziale
relativa al castello sulcitano, rimane il compito di verificare se questa fortificazione sarda sia pertinente alla
stessa epoca dei castelli africani, se sia stata costruita per le stesse esigenze militari ed, ancora, se ve ne siano o ve ne siano state altre in Sardegna. Si ripropongono, in riassunto, anche gli studi che hanno portato
all’identificazione di quest’opera tra quelle costruite in epoca bizantina, dopo la conquista e la riconquista
20
Giovanni Spano, Bullettino Archeologico Sardo – volume II 1856-1857, a cura di Attilio Mastino, p. 79 – Editrice
Archivio Fotografico Sardo, Nuoro 2000. 21
Renata Serra, La possibile memoria di una fortezza bizantina in Sardegna. Il “Castello Castro” nell’Isola di
Sant’Antioco, pag. 85, in Archivio Storico Sardo, XXXVI, 1989. 22
Giovanni Spano, op. cit., p. 78. 23
A.C.SA. Serie Amministrazione – Fasc. 28/4, Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale – Deliberazione del 30
maggio 1860. 24
A.C.SA., Serie Lavori Pubblici – Fasc. 2/1, Profilo longitudinale e planimetria relativi al progetto dell’apertura e
sistemazione della strada consortile tra Sant’Antioco e la cantoniera di San Giovanni Suergiu – 31 luglio 1864. 25
Club Modellistico Cagliari, Cultura delle Coste, p. 52 – Litotipografia Pisano, Cagliari 1988. 26
Renata Serra, op. cit., p. 85. 27
A.C.SA, Serie Finanze – Fasc. 2/2, Acquisto fortezza Pontimannu e terreni limitrofi – 1875; 1878; 1880-1883; 1886-
1889. 28
A.C.SA, Serie Finanze – Fasc. 17/35, Corrispondenza relativa alle finanze – 1901. Vedi anche: A.C.SA, Serie Lavori
Pubblici – Fasc. 20/4, Adattamento della Fortezza Ponti Mannu ad uso caserma per la Regia Guardia di Finanza di
Mare – 1901; 1903; 1909. 29
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&s=17&v=9&c=4463&id=220613.
della Sardegna tra il 534 ed il 554 d.C. Cominciando da Nora, si può dire che poche siano le notizie relative
a una costruzione bizantina fortificata nel suo entroterra, ancora più scarse quelle che ci permetterebbero di stabilire se vi sia stata una fortificazione di controllo e opposizione ai barbaricini, in periodo romano e poi
bizantino, nel territorio di Escolca, dal momento che questo toponimo è da taluni assimilato a luoghi di
avvistamento. Tuttavia, nel vicino territorio di Serri in cui si trova il “santuario nuragico” di S.Vittoria, pare
vi sia stato un riutilizzo delle strutture preistoriche come avamposto30. Nel Comune di Samugheo, il castello detto “di Medusa” ha restituito due iscrizioni relative a Giustiniano e al suo successore Giustino II,
probabilmente riferibili alle fasi edificatorie, mentre Fordongianus divenne sede del dux bizantino, carica
militare insediata nel centro della Sardegna per il controllo e l’opposizione contro le scorrerie dei barbaricini nel Campidano. Nel territorio di Oschiri, nei pressi della sede diocesana di Castro e dell’ ex cattedrale di
S.Maria, sono state rinvenute le tracce di un nuraghe e di un insediamento romano a cui si è sovrapposto
quello fortificato bizantino31. Più a sud ovest, sono state rinvenute strutture fortificate nel territorio di Anela, mentre a est, tra Telti e Olbia, vi sono i resti del castrum detto “Sa Paulazza”. A Olbia, invece, pertinente a
funzioni militari urbane, vi era un castello simile a quello sulcitano, avente un perimetro di 560 metri circa e
tre torri nel lato del mare, altre agli angoli ed una “sulla uscita all’interno”32. Come si rileva dalla figura nella
pagina successiva, i castra cittadini, fuori dal perimetro delle mura urbane, sono stati costruiti nelle più importanti città costiere, mentre l’interno era delimitato dagli avamposti lungo la frontiera tra la Sardegna
romea e le civitates barbariae. A far da paragone rimangono i meglio conservati castelli dell’Africa
bizantina, ossia opere militari edificate sin dal periodo in cui Giustiniano, attraverso il valoroso generale Belisario, riconquistava l’occidente prima in Africa, con la presa di Cartagine e la cattura dell’ultimo Re
Vandalo Gelimero nel 553-534 e poi
in Italia, grazie alla vittoriosa guerra contro i Goti iniziata nel 535.
Successivamente, i nemici furono i
Longobardi che si insediarono nella
penisola italiana senza, però, riuscire a occupare la Sardegna. La
fortificazione sulcitana pare più
assimilabile a un’esigenza di controllo della città, affatto decaduta
dopo la crisi dell’impero romano,
sede di diocesi accertata nel 484 d.C.,
il cui importantissimo porto ospitò la flotta bizantina33 in quanto, da
sempre, ritenuto approdo sicuro e
riparato. Il castello di Olbia, peraltro non di
piccole dimensioni (560 metri di
perimetro), sembra avere un’analogia con il castello di Timgad. Padre
Angius afferma che vi erano tre torri
nel lato opposto all’entrata (lato
mare), due agli altri angoli e una all’ingresso che volge le spalle al mare. Il castello di Timgad, anch’esso molto grande, ha in più altre due
torri nei lati minori (fianchi). La regolarità della forma del castello algerino, così come quello tunisino di
Limisa (Ksar Lemsa), fa presupporre che si tratti di opere costruite ex novo in un terreno la cui natura non presenta irregolarità34. Difatti, le fortezze in cima ai colli, trovandosi in posizioni più aspre, sono costrette a
seguire l’andamento del terreno, mentre quelle poste a difesa dei centri urbani o costruite ex novo avrebbero
mura perimetrali regolari che formano parallelepipedi rettangolari o quadrati, con lievi differenze tra i lati.
30
Pier Giorgio Spanu, La Sardegna bizantina tra VI e VII secolo, p. 181 – Editrice S’Alvure, Oristano 1998. 31
Pier Giorgio Spanu, op. cit., pp.83 e 190. 32
Angius/Casalis, dal Dizionario, La Sardegna Paese per Paese, vol. 5, p. 187 - Società Editrice L’Unione Sarda
S.p.a., Cagliari 2004. 33
Mohamed Mustafa Bazama, Arabi e Sardi nel medioevo, p. – EDES, Cagliari 1988. 34
Renata Serra, op. cit., p. 86.
Timgad (Algeria) – 35°28’47.46”N – 6°28’04.09”E. 1072 metri s.l.m.
Rielaborazione della carta pubblicata in Francesco Cesare Casula, La Storia di Sardegna vol. I, p. 205 – Carlo Delfino Editore, Sassari 1994 in base ai rilevamenti archeologici condotti in varie campagne di scavo e riportati in Pier Giorgio
Spanu, La Sardegna bizantina tra VI e VII secolo, p. 176 – Editrice S’Alvure, Oristano 1998.
Nei secoli successivi le
modalità costruttive rimasero simili; variarono solamente
alcune strutture per la funzione
religiosa a cui erano destinate.
Laurent Daillez, in un suo libro, si sofferma nella
descrizione delle fortezze
templari e musulmane in un periodo di gran lunga
successivo ai primi castelli
giustinianei. Egli afferma che tali costruzioni “fossero esse
musulmane o cristiane
avevano uno stretto rapporto
con la guerra santa. Il ribat musulmano, al tempo stesso
fortezza, convento e rifugio, è
di molto anteriore agli ordini militari. Quando i musulmani
rimpiazzarono i bizantini, in
particolare sulle frontiere marittime, occuparono le
fortezze difensive edificate dai
loro predecessori e ne
costruirono altre seguendo lo stesso modello. L’insieme della fortezza presenta una pianta regolare, fiancheggiata ai quattro angoli da torri
rotonde o quadrate. Una merlatura corona torri e cortine. Altre torri quadrate più piccole difendono i lati
della fortezza e il loro numero varia a seconda della distanza tra una torre e l’altra. Questo sistema fu utilizzato in Terrasanta come nella penisola iberica”35. L’autore riferisce il fatto che molti suoi colleghi
rimproverano i Templari di aver copiato il sistema costruttivo dai musulmani, ma invece le sorprendenti
somiglianze richiamano esclusivamente Bisanzio.
Chi si è occupato di civiltà bizantina e ha analizzato le fortificazioni urbane sarde, sulla base dei racconti e dei rilievi dei viaggiatori, confronta i castelli sardi con quelli africani riferendosi, in particolare, al già citato
forte algerino di Timgad per via delle “proporzioni fra il tracciato e lo spessore delle mura, nonostante
l’andamento pressoché rettangolare a Thamugadi e, invece, marcatamente trapezoidale a Sulci”36. L’autrice Renata Serra si sofferma, come già detto, sul fatto che la lieve differenza si può imputare al riutilizzo di
preesistenti strutture e all’adattamento alla natura del terreno. A conferma, si impone la differenza tra le
fortificazioni di Ammaedara (Haydra) - irregolare - e quella di Sufetula (Sbeitla) - geometricamente regolare – perché costruita ex novo. Pier Giorgio Spanu menziona, a tal proposito, anche il castello di Formentera e il
forte isolato di Limisa. La Marmora invece, nel suo disegno e nel suo testo, paragona l’oggetto del nostro
articolo ai forti di Madaura e di Thignica. Madaura è una fortificazione bizantina impiantata attorno a un
teatro romano, il cui palcoscenico resta oltre l’ingresso del muro di prospetto del castello, dotato di porta rincassata rispetto alla torre e di altre due torri laterali agli angoli. Dietro il semicerchio che contiene le
gradinate, si nota la prosecuzione dei muri laterali del castello e una torre ad angolo nel fondo. Dalle
planimetrie aeree, rilevate come le altre da Google Earth, non si evidenziano il fondo né l’altra torre d’angolo del fondo stesso, forse perché rasa completamente al suolo o forse perché trattasi di opera
incompiuta. Ciò richiama il grandioso teatro romano di Busra, nel sud della Siria, il cui prospetto è stato
fortificato da torri simili al castello di Madaura, con la differenza che anche il fondo del teatro è stato fortificato con imponenti torri, che seguono l’andamento a semicerchio delle gradinate.
35
Laurent Daillez, I Templari – la vera storia dei cavalieri del Tempio ricostruita dai documenti originali, p. 115 –
Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2001. 36
Renata Serra, op. cit., p. 86.
Ksar Lemsa (Tunisia) – 36°02’09.80”N – 9°31’41.26”E - 424 metri s.l.m.
Madaurus (Algeria) - teatro romano al quale viene anteposta la struttura del castello bizantino – 36°04139.60”N – 7°54’06.31”E
- 932 metri s.l.m.
Madaurus - prospetto.
Ksar Lemsa - lato est demolito.
Il castello di Ain Tounga - Mancando nei recenti studi comparativi una descrizione e un’analisi della
fortificazione di Ain Tounga, probabilmente perché trattasi di una località minore e poco nota, i cui resti sono stati studiati solo in parte da una spedizione di archeologi, prima che il Governo Tunisino
interrompesse gli scavi col pretesto che la spedizione fosse in realtà più interessata a tesori o a portar via
reperti, faremo una descrizione solamente visiva e generale. A giustificazione di ciò si deve aggiungere,
inoltre, che il sottoscritto non è esperto di architettura e ha visitato l’opera, nel mese di ottobre 2009, solo a titolo di curiosità.
Ain Tounga si trova a circa 80 chilometri da Tunisi se si percorre verso ovest la strada P5, oppure ci si arriva
percorrendo la nuova autostrada per il Governatorato di Beja, lasciandola poi a pochi chilometri ad est di Testour. Noi, invece, abbiamo raggiunto Ain Tounga partendo dall’Hotel La Foret di Ain Draham, cittadina
di origine francese distante solo 30 chilometri dalla costa di Tabarka. Abbiamo percorso, quindi, le statali
P17 prima e P11 poi, attraversando Firnanah, Bou Salem, Thibar e i suoi vigneti, Teboursouk e Dougga. Dallo spiazzo dell’abbeveratoio in cui abbiamo parcheggiato, si vede, tra due casupole poste lungo la strada,
la torre d’ingresso rivolta a sud. Il lato ovest si presenta quasi interamente demolito, avente agli estremi le
due torri d’angolo decadute quasi allo stesso modo, mentre rimangono in piedi gli angoli bugnati, forse
perché più robusti grazie all’intreccio delle pietre. Numerosi blocchi di arenaria presentano scritte latine dell’epoca romana e sono inseriti casualmente in tutte le direzioni. La descrizione del castello si avvale di
una planimetria in cui sono segnate, con le lettere maiuscole dell’alfabeto, le torri e i punti più importanti
della struttura. Dalla torre d’angolo (A) si procede lungo una strada sterrata in salita che pare frutto di un riempimento
moderno, probabilmente utile a vetture e camion per raggiungere edifici e cave che si trovano oltre la
collina. La torre d’ingresso (B) presenta un arco con blocchi bugnati il cui ingresso non è frontale, ma nel lato sinistro, in modo da formare un ingresso a L a nord-ovest; l’architrave e gli stipiti sono interrati.
Proseguendo lungo il demolito frontale si arriva all’altra torre d’angolo, la quale emerge quasi per intero e,
nonostante il terrapieno artificiale, si presenta pressoché intera; essa si trova su un livello più alto della torre
opposta e così sembra essere anche quella d’ingresso. Tra il citato lato ovest e quello sud, dotato di ingresso, non ho percepito in modo evidente l’angolo acuto formato dai due lati, mancando la visione d’insieme e
planimetrica e, forse, anche perché si tratta di lati molto lunghi. Così, considerando che il lato nord, relativo
al fondo del castello, sarebbe quello obliquo che dovrebbe formare un trapezio, ci troviamo, invece, davanti ad un castello avente la forma di un tronco di piramide. Il lato corto, rivolto ad est, unisce le due grandi torri
d’angolo C ed E; esso non è un muro continuo e rettilineo come quello opposto a ovest, perché, dopo una
trentina di metri, forma un angolo retto verso l’esterno, causando un piccolo sbalzo o pseudo torre (D) e,
quindi, prosegue verso la citata torre d’angolo del fondo (E). Quest’ultima torre si presenta in buone condizioni esterne, quasi completa in qualche tratto, ricca di elementi derivanti dai monumenti romani poco
distanti, con l’ingresso, all’interno del castello, quasi sepolto e formato da un arco dal quale, però, non è
sicuro accedere. Sopra l’arco della porta della torre E, vi è una feritoia formata da una pietra stretta e verticale, inserita a rombo in un’altrettanto stretta e alta finestra. Per ottenere una porta di larghezza
accessibile è presente un rincasso nel muro del fondo. Questa muraglia, ben conservata, si presenta dritta per
il primo pezzo, quasi a formare un angolo retto con l’altro lato appena descritto. Il lato nord del fondo prosegue, dopo un piccolo sbalzo in diagonale, a formare quel trapezio segnalato dal dott. Berbrugger a La
Marmora nel 1858. Ho trovato che questa fosse la parte più suggestiva del castello: un lato quasi intatto
anche se, nella parte sommitale , lascia intravvedere la luce tra le pietre che sembrano smosse ed instabili.
Nella parte alta, lo spessore delle mura è sottile ed è formato da una sola pietra. La torre d’angolo, che chiude il fondo a nord ovest (G), è distrutta, come l’opposta sul lato ovest, ne rimane in piedi solo un angolo,
mentre il crollo lascia intravvedere la tecnica del sacco, ovvero, tra i due rivestimenti in pietre squadrate, le
piccole pietre e la terra a riempimento del vuoto tra i muri. Dal momento che il lato ovest è praticamente raso al suolo, siamo entrati, per terminare il giro, attraverso le mura viste dall’interno. Il fondo del castello
presenta una muraglia molto spessa sino a una certa altezza, mentre il resto s’ innalza sino alla sommità con
più filari spessi una sola pietra, attraverso i quali, come già detto, si vede la luce. Non si può stabilire bene se lo spessore maggiore alla base sia dovuto alla presenza del camminamento di ronda o se si tratti di una
demolizione. Sta di fatto che l’interno è un immensa pietraia e che nella parte ovest vi sono buche e assaggi
di scavo molto profondi. Infatti il castello sembra sia stato costruito su di un piano inclinato. Al centro del
lato costituente il fondo del castello, vi sono due pilastri poco distanti tra loro ovvero un elevato di pietre, largo quanto la base, che forma una pseudo torre (F) visibile solo all’interno. Il muro del lato est, quasi
demolito, si presenta più alto dalla parte interna e unisce le due torri E e C in modo discontinuo, grazie a
quell’angolo retto che ora rientra all’interno del castello. Questa pseudo torre D lascia intravvedere una
nicchia sormontata da un arco. La torre più grande, alta circa dieci metri (C), presenta un’a ltrettanto alta e
stretta porta sormontata da un arco, al cui culmine si trova un viso di donna. La guida ci spiega in modo semplice che si tratta di Thignica, la moglie del signore del castello. Epigrafi romane circondano il tutto. Per
la nostra guida, a causa della presenza di tali epigrafi, il castello è romano; l’altro ragazzo, invece, smentisce
e mi dà ragione. All’interno, una buca ci porta quasi alla base, dove una porzione di muro interno regge gli
ultimi pezzi di scale. L’interno è vuoto e presenta finestre e feritoie. Infine, il lato interno del prospetto o controprospetto (H) è più spesso del muro di cinta e, anche questa volta, è asimmetrico: infatti, a sinistra
dell’arco, per chi guarda dall’interno verso l’uscita del castello, il maggior spessore sporge per circa un
metro e mezzo, mentre sul lato destro si spinge per cinque metri abbondanti. L’architrave, recante anch’esso iscrizioni latine, si trova poco sopra il livello del terreno. Dopo aver fatto un giro tra il tempio, il teatro (del
quale rimane intatto solo il muro a semicerchio e parte del palcoscenico) e l’edificio termale, ho preso
ancora qualche altro scatto del castello e verificato meglio il fatto che le torri del prospetto siano effettivamente costruite su un piano inclinato; le laterali o d’angolo escono quasi per intero dal terreno di
riempimento, mentre quella centrale d’ingresso è sepolta sino all’architrave.
Planimetria del castello di Ain Tounga ricavata da Google Earth e adattata dalla visita e dal materiale fotografico reperito.
36°31’24.72”N – 9°21’34.08”E - 227 metri s.l.m.
Ain Tounga – torre C, in secondo piano il fondo del castello e la torre E.
Ain Tounga – torre B (ingresso nel lato ovest della torre).
Ain Tounga – torre E.
Ain Tounga – torre E (particolare).
Ain Tounga – torre E (vista dall’interno del castello).
Ain Tounga – pseudo torre F.
Ain Tounga – fondo del castello (interno), con torre F ed in secondo piano la torre G.
Ain Tounga – fondo del castello (esterno o lato nord).
Ain Tounga – pseudo torre D e sullo sfondo la Torre C.
Ain Tounga – torre C.
Ain Tounga – fondo del castello e torre G.
Ain Tounga – torre B: accesso al castello.
Ain Tounga – torre C (particolare).
Ain Tounga – torre B: veduta dall’interno (punto H).
Ain Tounga – insieme del castello.
Ipotesi e simulazione del prospetto del castello. Il riempimento formato dai crolli ed il terrapieno creato per formare la strada sterrata, lasciano supporre che le torri poggino su livelli naturali del terreno differenti tra di loro. Il lato ovest resta più in basso del lato est, pertanto le torri A e G si trovano in un livello inferiore rispetto a quelle opposte C e E. Il piano inclinato del fondo del castello tra la torre E e la torre G sembra più lieve di quello che si presenta nel prospetto qualora venisse scavato il terrapieno e l’ingresso portato interamente alla luce. Pertanto si presume che le tre torri del prospetto sembrano poggiare su tre diversi livelli del terreno o che la torre
d’ingresso (B) e quella laterale (A), data la breve distanza tra loro, potrebbero, al massimo, trovarsi su livelli uguali o di poco differenti. Analizzando l’intero perimetro delle mura, non sembra che vi sia nulla di simmetrico o che gli angoli siano di 90 gradi. Se si prende il lato ovest che unisce la torre A con la torre G come base di una figura geometrica, i lati corti che si dipartono verso est (prospetto e fondo) tendono a chiudersi come in tronco di piramide. Il lato est, affatto rettilineo perché interrotto dalla
pseudo torre D, pare sia l’unico che formi un angolo retto con quello del prospetto, all’altezza della maestosa torre C.