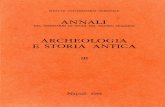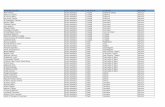Il castello di Baratonia e le strutture difensive del XIV secolo
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Il castello di Baratonia e le strutture difensive del XIV secolo
È ormai noto come la storia dei castelli medievali sia principalmente legata alla storia del popolamento e degli insediamenti, e come questi rappresentino la misura dell’estensione di un dominio e dei rapporti di quest’ultimo con l’autorità superiore(1). Molto più raramente l’edificazio-ne di un castello è determinata da necessità belliche, anzi la chiave di lettura strettamente militare spesso può essere fuorviante, se non errata. Parte della storiografia ha spesso voluto leggere nella geografia castella-na locale forme di coordinamento strategico e militare anacronistiche, che il medioevo non ha conosciuto e che, d’altra parte, non avrebbero potuto inserirsi in alcun modo nelle dinamiche di potere di signori o città. Ma in un’epoca di “bellicismo endemico”(2) come il medioevo, la storia dei castelli non può prescindere interamente dagli aspetti militari.
Se nel medioevo in tutte le tipologie di edifici, come chiese, cattedra-li, monasteri e palazzi pubblici cittadini, non si svolgevano solamente le funzioni per i quali erano stati principalmente costruiti(3), il castello era
(1) G. Castelnuovo, Castelli nelle Alpi, in Gli uomini e le Alpi, Atti del convegno (Torino, 6-7 ottobre 1989), Torino 1991, pp. 136-148; Id., Principati regionali e organizzazione del territorio nelle Alpi occidentali: l’esempio sabaudo (inizio XIII- inizio XV secolo), in L’organizzazione del territorio in Italia e Germania. Secoli XIII-XIV, a cura di G. Chittolini, D. Willoweit, Bologna 1994, p. 86 e nota 10.
(2) G. serGI, I confini del potere. Marche e signorie fra due regni medievali, Torino 1995, p. 14.(3) Negli edifici sacri, oltre a svolgersi le funzioni religiose e, più in generale, la vita
collettiva sulla base delle ricorrenze sacre, venivano convocate riunioni politiche cittadine o delle vicinie, oppure finanziarie, di mercanti o delle corporazioni, spesso si stipulavano trattati di pace o di alleanza, sfruttando lo spazio interno, organizzato secondo ripartizioni funzionali. In molti casi chiese e monasteri furono adattati a fortificazioni. Allo stesso modo negli edifici civili, destinati prevalentemente all’organizzazione della vita politica della comunità, si svolgevano commerci (a volte veri e propri mercati) o, come nel caso dei palazzi pubblici comunali, i notai svolgevano le proprie attività, pagando affitti onerosi per poter vantare una sede professionale tanto prestigiosa. Anche le abitazioni private potevano avere più destinazioni d’uso, come le case-bottega o le case-torri.
Il castello di Baratonia e le strutture difensive del XIV secolo
Marco Merlo
54 Baratonia. Dinastia e castello
l’edificio polifunzionale per eccellenza(4): il termine stesso castellum, o ca-strum, in realtà era un’etichetta generica che poteva includere strutture con funzioni diverse, inserite nel contesto di una fortificazione. Alcune fortificazioni furono erette con lo scopo principale di divenire residenza signorile, altre come centro di potere ufficiale, altre ancora come luogo di rifugio per le popolazioni in caso di pericolo (si pensi ai ricetti piemontesi)(5) oppure come depositi per merci o derrate alimentari, oltre che punti di controllo strategico, non necessariamente o esclusivamente militare, ma anche commerciale e viario. Nel corso della storia di un singolo castello più di una di queste destinazioni d’uso può essere coesistita, ma la capaci-tà di difesa della struttura fortificata restava il criterio cardine per la sua progettazione.
Proteggere e dominare
Lo scopo stesso del castello è quello di “proteggere e dominare”(6), ra-gioni per cui esso è necessariamente concepito come una struttura difen-siva in grado di offrire protezione dalle armi e dalle tecniche d’assedio coeve e, possibilmente, neutralizzarle. I criteri con i quali un castello è costruito rispondono sempre a esigenze difensive, anche quando la sua genesi e le sue funzioni non sono strettamente legate alla guerra: eretti in punti strategici, su luoghi di difficile accesso, sono dotati di strutture in grado di consentire differenti operazioni tattiche. Esso non rispondeva unicamente a istanze di ordine pratico: il castello diveniva anche simbolo di quella potenza militare che, per un signore, era sempre bene ostenta-re(7).
Gli aspetti formali erano comuni a tutti i castelli, a prescindere dal fatto che si trattasse di un centro di potere di un ufficiale principesco o di
(4) C. tosCo, Il castello, la casa e la chiesa. Architettura e società nel medioevo, Torino 2003, pp. 3-14.
(5) a.a. settIa, Fortificazioni collettive nei villaggi medievali dell’alta Italia: ricetti, ville forti, recinti, in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, LXXIV (1976), pp. 527-617; Id., L’illusione della sicurezza: fortificazioni di rifugio nell’Italia medievale, “ricetti”, “bastie”, “cortine”, Vercelli-Cuneo 2001.
(6) Id., Proteggere e dominare. Fortificazioni e popolamento nell’Italia medievale, Roma 1999.(7) Nel medioevo il concetto di potere politico era direttamente commisurato con la forza
militare. I signori quindi, in ogni situazione, pubblica o privata, assumevano atteggiamenti esteriori guerreschi, dall’abbigliamento alle proprie residenze.
55Le origini: visconti dei marchesi di Torino
una residenza signorile(8). È stato infatti rilevato come solo verso la metà del Trecento nel Delfinato, in Savoia e nell’alta valle della Dora Riparia si andasse delineando un vero sistema difensivo come forma di controllo dell’autorità comitale sulle diverse forme di potere radicate nelle vallate alpine(9). In questo sistema sono stati riscontrati tre contesti di forma-zione delle strutture fortificate, nessuno dall’esclusiva funzione militare: castelli della nobiltà militare locale come centri di potere della famiglia, entrati in un secondo momento nella sfera d’influenza dei Delfini; castelli di confine direttamente dipendenti dall’autorità comitale; castelli e torri interne al dominio con funzione di sedi rappresentative del potere(10).
D’altra parte il modello architettonico a cui attingere per la costruzio-ne di un castello, indipendentemente dalle sue funzioni, era quello del-la fortificazione(11) ed esteriormente i palazzi non si discostano quasi per nulla da questi ultimi. Il palazzo all’interno del castello di San Zenone, fatto erigere a metà del XIII secolo da Ezzelino da Romano, fu definito tutum et pulcrum palacium, in riferimento al fatto che era elegante, confor-tevole ma allo stesso momento munito di strutture difensive(12).
Le tipologie di castello a cui ispirarsi erano varie, derivanti dalle tradi-zioni culturali e dalle esperienze pratiche di ogni popolo o area geografi-
(8) Per una precisa trattazione sulle funzioni del visconte a Torino si veda il saggio di Giuseppe Sergi in questo stesso volume.
(9) C. tosCo, Architettura del medioevo in Piemonte, Savigliano 2003, p. 185.(10) L. cit.(11) Se spostiamo l’attenzione nella Toscana meridionale, nelle attuali province di Siena e
Grosseto, nel medioevo aree d’influenza senese, il fenomeno dell’incastellamento è stato molto ben studiato sia dal punto di vista documentario sia archeologico. Nella fase definita come “secondo incastellamento” (cronologicamente collocabile dalla seconda metà del XII alla prima del XIII secolo) tra le fortificazioni edificate ex novo e quelle ampliate in questa fase, solo una piccola parte è legata alle necessità difensive conseguenti alle guerre di questi anni, mentre la maggioranza fu concepita per il popolamento, i cosiddetti “castelli di popolamento”. Tuttavia il modello architettonico di queste strutture, a prescindere dalla destinazione d’uso principale, non è distinguibile: tutte si presentano con le medesime caratteristiche difensive (r. FarInellI, a. GIorGI, “Castellum reficere vel aedificare”: il secondo incastellamento in area senese. Fenomeni di accentramento insediativo tra la metà del XII e i primi decenni del XIII secolo, in Fortilizi e campi di battaglia nel medioevo intorno a Siena, Siena 1998, pp. 157-263). Nella stessa area, nel corso del XIV secolo, le strutture difensive furono concepite per essere in grado di affrontare le nuove macchine belliche e le moderne tattiche d’assalto, rendendo possibile l’identificazione di alcuni caratteri comuni, anche per quei castelli la cui principale destinazione era la residenza signorile (I. MorettI, Aspetti dell’architettura militare senese del medioevo, in Fortilizi e campi di battaglia cit., pp. 51-78)
(12) a.a. settIa, I caratteri edilizi di castelli e palazzi, in Arti e storia nel medioevo, II, Del costruire: tecniche, artisti, artigiani, committenti, a cura di E. Castelnuovo, G. Sergi, Torino 2006, pp. 209-210. Si tratta della stessa concezione architettonica dei broletti lombardi.
56 Baratonia. Dinastia e castello
ca(13). Sebbene non sia possibile identificare un modello di castello tipica-mente alpino, dalle comparazioni tipologiche delle strutture superstiti si scorgono caratteristiche comuni, non solo nelle tecniche costruttive e nei materiali impiegati, ma anche nella composizione planimetrica. Il modello principale si distingue per un perimetro quadrangolare, irregolare e asim-metrico, modellato sulle linee del terreno, normalmente un’altura, il cui edificio principale era il maschio, sovente posto al centro della struttura o nel punto più elevato, sfruttando tutti i vantaggi offerti dagli elementi ambientali circostanti.
In questa sede ci limiteremo all’analisi della struttura trecentesca del castello di Baratonia, e agli eventi che lo videro protagonista in questo secolo.
Il Trecento fu un secolo di grande rilevanza per la storia dei castelli. Le incessanti guerre di questi decenni portarono a numerosi e fondamen-tali cambiamenti nel modo di condurre le operazioni militari, a partire dalle istituzioni che consentivano il reclutamento di un esercito. A livello materiale i più significativi progressi hanno interessato la dialettica tra offesa e difesa. Questi non avvennero solo nella strategia, nella tattica e nell’evoluzione degli armamenti individuali, ma ebbero importanti riflessi sull’intera arte ossidionale, laddove la cultura tecnica aveva permesso il perfezionamento di macchine d’assedio e la nascita delle prime armi da fuoco. Nell’ideazione e nella costruzione dei castelli gli architetti furono obbligati a prestare particolare attenzione alle strutture difensive secondo le moderne concezioni(14).
Il castello di Baratonia nel XIV secolo
È stato dimostrato come il castello di Baratonia sia sempre stato usato come residenza signorile(15) ma le sue caratteristiche formali, come per tutti i castelli, lo resero idoneo anche a funzioni di controllo strategico e difesa militare. I ruderi ancora visibili lo confermano a partire dalla scelta
(13) Si vedano i risultati del recente convegno sulle motte, tenutosi a Scarlino (GR) dal 14 al 16 aprile 2011, dal titolo Fortificazioni di terra in Italia. Motte, tumuli tumbe e recinti, i cui atti compariranno su un numero monografico di “Archeologia Medievale”.
(14) In realtà furono ben pochi i castelli edificati ex novo nel Trecento. Per la maggior parte si tratta di ampliamenti, modifiche, ammodernamenti e ristrutturazioni di fortificazioni di fondazione più antica.
(15) G. ChIarle, Signori e castelli: la geografia politica, in Boschi & castelli. Itinerari medievali nelle terre dei visconti di Baratonia, a cura di Id., Torino-La Cassa 2007, p. 17.
57Le origini: visconti dei marchesi di Torino
del luogo.Sono situati su una collina piuttosto ripida, bagnata da due ruscelli: a
sud il rivo detto oggi di San Biagio e che nel XIV secolo, come si evince da un documento del 1329(16), era detto rivus Stephani, e a nord un rivo oggi senza nome specifico, ma che nello stesso documento è detto rivus Polio-rum. Questi percorrono entrambi i fianchi del castello per congiungersi sul lato est, vicino alla chiesa di San Biagio, circondando completamente il rilievo.
Alle spalle è protetto dalle propaggini delle montagne. I fianchi sono sempre protetti dalle alture che si allargano formando la vallata e con-sentendo, dalla sommità del castello, una buona visuale. Il lato frontale dominava il piano sottostante, luogo in cui si presume si trovasse il borgo e dove oggi si trova solo la chiesa di San Biagio.
La strada che dal borgo portava al castello saliva partendo da est, fian-cheggiando il lato sud, per girare a ovest dove si trovava l’unico accesso. Questo era quindi situato nel lato più protetto, coperto dalle montagne: il lato dal quale un attacco era impensabile. Mentre il lato est era quello più esposto, ma al contempo dominava il piano sottostante.
Il sentiero attuale è differente da quello medievale (a tutt’oggi non è ancora stato identificato con precisione), ma questo percorso da est a ovest è un percorso obbligato, essendo l’ingresso posto a ovest.
L’intero perimetro esterno si adatta alle curve di livello del terreno(17) e il fianco nord è troppo scosceso per consentire la salita. Quindi per acce-dere alla porta del castello era necessario un giro in senso orario. Questo dato è più significativo di quanto possa sembrare e per comprenderne la reale portata occorre soffermarsi sull’armamento difensivo medievale.
La principale arma difensiva, dall’XI all’inizio del XIV secolo, era lo scudo. Questo veniva tenuto con il braccio sinistro in modo tale da poter brandire con il braccio destro l’arma offensiva. Un percorso d’accesso in senso orario obbligava chiunque salisse verso il castello a esporre alle armi lanciatoie il fianco destro, la parte più vulnerabile del combatten-
(16) Il documento, redatto il 12 gennaio 1329 nel giardino del castello di Baratonia, è l’atto con cui i fratelli Franceschino e Tommaso, figli del defunto Antonio di Viù visconte di Baratonia, si spartirono gli edifici e le terre del castello: Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Archivio d’Harcourt, b. 1, n. 2. Il documento è commentato e riprodotto in: G. ChIarle, Sulle tracce del medioevo. Dai Baratonia agli Arcour, Varisella 1999, pp. 55, 57.
(17) I castelli dell’arco alpino occidentale, edificati o ampliati nel XIII e nel XIV, hanno come caratteristica comune proprio il fatto di adattare il proprio perimetro alle condizioni del luogo e allo spazio disponibile dei rilievi naturali, per quanto angusto, senza attuare mai un criterio di geometrizzazione e regolarizzazione della pianta, caratteristica peculiare nel Trecento anche di altre aree montane: tosCo, Architettura del medioevo in Piemonte cit., p. 200.
58 Baratonia. Dinastia e castello
te medievale. Per di più il castello, come diremo tra poco, era munito di una torre centrale, dalla quale era possibile controllare e tenere sotto tiro l’intero giro d’orizzonte, e quindi anche la strada d’accesso. Molti fori pontai esterni sono particolarmente profondi e ampi, forse testimonianza di ulteriori strutture difensive in legno, come bertesche, che assicuravano ulteriore possibilità di controllo(18).
Questo sistema difensivo (montagne alle spalle e ai fianchi, maschio centrale, ingresso posto nel lato più coperto e strada d’accesso in senso orario) è caratteristico di molti castelli di valle dell’intero arco alpino. I due esempi più celebri coevi, tra i molti che potremmo citare, sono il ca-stello di Sabbionara d’Avio in Trentino(19) e il castello di Saint Pierre in Valle d’Aosta(20).
Tuttavia, arrivati di fronte alla porta d’accesso del castello di Barato-nia, il primo sistema difensivo ancora visibile è tipicamente piemontese. Si tratta di un piccolo fossato scavato ai piedi della porta. Questo semplice espediente, comune a molti castelli del Piemonte anche di quest’area(21), risultava molto utile. Innanzi tutto per poter accedere al castello con ca-valli e carri era necessaria una passerella, e nel caso di Baratonia sembra esserci stato un ponte levatoio. Questa era una struttura che, soprattutto se posta nel lato più protetto come nel caso di Baratonia, poteva essere su-perata solo con l’ausilio di macchine d’assalto (del tipo che nel linguaggio comune si usa chiamare ariete). Ma con un fossato ai piedi del ponte, per quanto di ridotte dimensioni, le operazioni di avvicinamento e di assalto erano gravemente compromesse, e si rendeva necessario, da parte degli aggressori, il riempimento del fossato. Operazione che metteva in grave pericolo un numero elevato di uomini.
Nel documento del 1329 si dice che il castello di Baratonia era inoltre dotato di un tornafolle: questo era un palo girevole, munito tutt’intorno di raggi disposti orizzontalmente, che occupavano il diametro del passaggio
(18) La bertesca era una difesa lignea diffusa nei castelli piemontesi, sopratutto nel Canavese, detta in alcune fonti locali anche belfredo: C. BoGGIo, Torri, case e castelli nel Canavese, in “Atti della Società degli ingegneri e degli architetti in Torino” XXIV (1890), pp. 29-30. Ulteriori protezioni in legno molto semplici potevano essere riposte nei magazzini per essere usate solo nei momenti d’emergenza: nel deposito del castello di Vercelli nel 1340 erano conservati sessantaquattro assi di legno fornitos allo scopo di essere posti tra i merli del castello: a. anGeluCCI, Documenti inediti per la storia delle armi da fuoco italiane, parte I, Torino 1869, p. 15.
(19) L.G. BoCCIa, I guerrieri di Avio, Milano 1991, p. 15.(20) B. orlandonI, Architettura in Valle d’Aosta, II, Pavone Canavese 1996, p. 73-77.(21) A titolo di esempio il castello di La Cassa, vicino a Baratonia, a pochi metri dalla porta
d’ingresso è dotato di un piccolo fossato.
59Le origini: visconti dei marchesi di Torino
da controllare, in modo tale che potesse passare un uomo alla volta(22). In Piemonte furono eretti tornafolle sia per controllare l’ingresso dei castelli sia a difesa delle porte dei villaggi fortificati, come testimoniano gli statu-ti del 1343 di San Giorgio Canavese: qui sono citati tornafolle posti in ogni porta d’ingresso(23).
Differentemente la lettura delle strutture interne è piuttosto incerta. Si tratta di una suddivisione di circa dieci stanze, forse meno(24).
Nel già ricordato documento del 1329, con il quale i fratelli France-schino e Tommaso dividono tra loro il castello di Baratonia, la descrizione delle terre circostanti e le menzioni (a dire il vero piuttosto vaghe) degli edifici interni donano un quadro generale di una dimora rurale signorile anziché di una fortezza strategica(25). Vi era un giardino con una casa, una stalla e un sedime vuoto, una piccolo orto, alberi da frutta (meli, peri e noci) e una vigna. Le poche indicazioni sugli edifici interni(26) ci informano che le strutture difensive erano ben distinte da quelle di uso signorile, in-fatti nel documento è lessicalmente sempre distinto il castrum, la parte di destinazione esclusivamente difensiva, dal palatium, la residenza signorile vera e propria.
Dalle analisi di superficie sono ben riconoscibili solo due edifici: la cap-pella sull’angolo sud-est (nella quale s’intravedono piccole tracce d’into-naco e di colore, ultima memoria degli affreschi che la decoravano)(27), e, verso il lato ovest, a pochi metri dall’ingresso, la base di una torre qua-drangolare, quello che doveva essere l’edificio più alto dell’intero castello, se non il maschio.
Secondo i ritrovamenti all’interno del castello(28) possiamo suggerire la presenza di alcuni edifici: ma bisogna precisare che i reperti sono tutti
(22) Ducange lo confondeva con il battifolle: C. duCanGe, Glossarium mediae et infimae latinitatis, VIII, Niort 1887, p. 128. Cibrario invece ne fornì una descrizione dettagliata sulla base dei documenti piemontesi: l. CIBrarIo, Della economia politica del medio evo, I, Torino 1861, p. 237 e nota 1.
(23) BoGGIo, Torri, case e castelli nel Canavese cit., p. 28.(24) Allo stato attuale delle ricognizioni di superficie è complesso poter offrire una lettura
certa degli spazi interni del castello.(25) ChIarle, Dai Baratonia agli Arcour cit., p. 54.(26) Le divisioni espresse nel documento seguono la linea di un vecchio muro, probabilmente
eretto in occasione di una spartizione più antica, che tagliava il palazzo signorile.(27) Durante gli scavi compiuti negli anni Settanta, condotti dall’Associazione Archeologica
Valli di Lanzo diretta da Attilio Bonci, furono rinvenuti, tra gli altri oggetti che qui descriveremo brevemente, alcuni frammenti di affresco oggi esposti nell’Antiquarium di Varisella.
(28) Per una precisa descrizione degli oggetti si rimanda al contributo di Marco Subbrizio in questo stesso volume.
60 Baratonia. Dinastia e castello
riferibili alla metà del XV secolo, quindi posteriori di un secolo agli anni qui presi in esame, quando il castello subì ulteriori trasformazioni formali e “istituzionali”, a partire dai proprietari(29).
Vi dovevano essere delle stalle, almeno quelle del signore, come con-ferma il ritrovamento di due ferri di cavallo da guerra; le cucine, come te-stimoniano i vasi e le ciotole di uso comune(30); e un edificio in cui venivano conservate le armi: la varietà e lo stato di conservazione di alcune punte di quadrelli da guerra e di una da caccia(31) permettono di affermare che questi erano conservati a mazzi, come in altri castelli per i quali conser-viamo gli inventari(32).
I ciottoli delle mura crollate s’innalzano mediamente a circa un metro dal pavimento originale, ed è altamente probabile che tengano nascosti ancora molti reperti, ma solo con la conduzione di scavi sistematici e ra-zionali si potrà comprenderne la natura e contribuire proficuamente alla storia locale.
(29) Nel 1452 il nuovo signore di Baratonia è Guglielmo Arcour, che era venuto in possesso del castello per via matrimoniale. Da questo momento in avanti il castello sarà di proprietà degli Arcour, famiglia di origine non nobile, e assumerà sempre più l’aspetto di una residenza signorile: a. BonCI, I Visconti di Baratonia. Signori nelle Valli della Stura della Ceronda e del Casternone, Varisella 1982, pp. 67-97; ChIarle, Dai Baratonia agli Arcour cit., pp. 71-79; Id., Nobili borghesi. La fortuna degli Arcour (secoli XIII-XV), in “Bollettino storico-bibliografico subalpino” CVI (2008), pp. 39-99.
(30) M. Mazzon, La ceramica nel tardo medioevo in Piemonte, in Boschi & castelli cit., pp. 81-84.(31) Tra le punte di quadrelli ne è stata ritrovata una da caccia, dalla tipica forma a crescente
di produzione quattrocentesca (v. serdon, Armes du diable. Arcs et arbalètes au moyen age, Rennes 2005, pp. 123-128) e quindi riferibile all’epoca in cui il castello era di proprietà degli Arcour. Questa tipologia di punta era utile per cacciare grossi animali come cervi, orsi e cinghiali. In valle di Susa, come testimoniato da un documento del 1307, era possibile cacciare orsi, cinghiali, camosci e caprioli, oltre a selvaggina di piccola taglia. Un documento del 1455 testimonia come gli Arcour si preoccupassero di salvaguardare la fauna e i boschi, proprio per garantire ricche battute di caccia. Nel 1465 Guglielmo Arcour, nuovo signore di Baratonia, concede alla comunità di Fiano il permesso di cacciare tutti gli animali selvatici, con cani e armi, ma proibisce, salvo suo esplicito consenso, l’uso della balestra, con cui evidentemente si praticava un tipo di battuta che riservava a se stesso, come suo diritto (G. ChIarle, L’uso del bosco tema di confronto tra signori e comunità, in Boschi e controllo del territorio nel medioevo, a cura di Id., Torino-La Cassa 2008, pp. 62-65). La punta a crescente particolarmente raffinata, oggi conservata ed esposta nell’Antiquarium di Varisella insieme agli altri oggetti ritrovati a Baratonia, testimonia la passione degli Arcour per la caccia con la balestra.
(32) D. De Luca, R. Farinelli, Archi e balestre. Un approccio storico-archeologico alle armi da tiro nella Toscana meridionale (secc. XIII-XIV), in “Archeologia Medievale” XXIX (2002), pp. 455-487. Tuttavia dalla documentazione piemontese emerge che nella maggior parte dei casi i verrettoni erano conservati in casse: anGeluCCI, Documenti inediti I, cit., p. 14.
61Le origini: visconti dei marchesi di Torino
“Briganti” al soldo del Conte Verde
Dalla sua edificazione al suo definitivo abbandono, si suppone dall’XI secolo alla seconda metà del XVI secolo(33), per il castello è documentato un solo evento bellico(34). Questo si colloca nella guerra tra Amedeo VI di Savoia e il cugino Giacomo d’Acaia, combattuta tra il 1356 e il 1360, a seguito di ribellioni dell’Acaia nei confronti del Conte(35).
Il Trecento fu un secolo di guerre anche per i Savoia, impegnati in conflitti sia su scala regionale sia su scala, diremmo oggi, internazionale. Amedeo(36) condusse incessanti operazioni militari Oltralpe e in Italia(37)
(33) ChIarle, Signori e castelli cit., p. 17.(34) Id., Dai Baratonia agli Arcour cit., pp. 46-50.(35) P.l. datta, Storia dei principi di Savoia del ramo d’Acaia signori del Piemonte. Dal
MCCXCIV al MCCCCXVIII, I, Torino 1832, pp. 181-189; F. CoGnasso, Il Conte Verde (1334-1383), Torino 1926, pp. 96-113.
(36) Fin dall’infanzia Amedeo VI fu educato nell’arte della guerra, tanto che nel 1347, appena dodicenne, fu acquistata per lui a Parigi una copia del De re militari di Vegezio (cfr. Il teatro di tutte le scienze e le arti. Raccogliere libri per coltivare idee in una capitale di età moderna. Torino 1559-1861, Torino 2011, p. 301). Probabilmente questa lettura, insieme a quella del De regimine principum, altro manoscritto comprato a Parigi nella stessa circostanza in cui fu acquistata l’opera di Vegezio, contribuì in maniera significativa ad alcune sue vittorie, come quella ottenuta alla battaglia di Abres nel 1354 (Ph. rIChardot, Végèce et la culture militare au moyen âge Ve-XVe siècles, Parigi 1998, pp. 49-50). Oltre a essere stato abile stratega e comandante militare, fu anche valente e appassionato torneatore: non aveva ancora l’età per prendervi parte ma volle organizzare un torneo a Chambery, i cui partecipanti sabaudi si riunirono nell’Ordine della Tavola Rotonda. In occasione del matrimonio di sua sorella il Conte partecipò al suo primo torneo con alcuni compagni d’armi, che formarono i Cavalieri del cigno nero (d. Muratore, La prima giostra del Conte Verde, Torino 1912). Ma il torneo più celebre a cui prese parte, grazie alla descrizione scritta da Jean d’Orville, detto Cabaret, fu quello svolto a Bourg-en-Bresse nel 1356, durante il quale lui, i suoi compagni e le loro dame si vestirono con suntuosi abiti verdi, che in futuro contraddistingueranno Amedeo. Le armi ebbero un ruolo così determinante nella sua vita, come si addiceva a un principe, che ne fu fatta grande mostra durante il suo corteo funebre (n. PollInI, La morte dei conti e duchi di Savoia fra Tre e Quattrocento. Discontinuità naturale e continuità dinastica, in I re nudi. Congiure, assassini, tracolli ed altri imprevisti nella storia del potere, Atti del convegno di studio, Firenze, 19 novembre 1994, a cura di G.M. Cantarella, F. Santi, Spoleto 1996, pp. 127-142).
(37) F. GaBotto, La guerra del Conte Verde contro i marchesi di Saluzzo e Monferrato, Saluzzo 1901; CoGnasso, Il Conte Verde cit., pp. 58-70, 124-146, 239-256; e.l. Cox, The Green Count of Savoy. Amedeus VI and Transalpine Savoy in the Fourteenth Century, Princeton 1967; B. deMotz, La Politique internazionale du Conté de Savie durant deux siècles environ (XIIIe-XVe), in “Cahiers d’Histoire” XIX (1974), pp. 29-64; G. Castelnuovo, Ufficiali e gentiluomini. La società politica sabauda nel tardo medioevo, Milano 1994, pp. 55-88; a. Kersuzan, Défendre la Bresse et le Bugey. Les châteaux savoyards dans la guerre contre le Dauphiné (1282-1355), Lione 2005; B. Galland, Le rôle du comte de Savoie dans la «ligue» de Grégoire XI contre les Visconti (1372-1375), in “Mélanges de l’Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes” CV, II (1993), pp. 763-824.
62 Baratonia. Dinastia e castello
e fu uno dei più importanti principi europei a prendere parte alla crociata contro i Turchi, conquistando nel 1366 Gallipoli(38).
Nel corso della guerra che in Piemonte lo oppose al cugino, il Conte Verde alla fine del 1356 cinse d’assedio il castello di Balangero, dove si era ritirato Giacomo, per espugnarlo poco tempo dopo, nel 1357.
Apprendiamo da un documento del 27 gennaio 1360(39) che una parte del castello di Baratonia a quel tempo era tenuta non da un membro del-la famiglia dei visconti ma da Ugonino, Bastardo di Savoia, che l’aveva acquistata vent’anni prima, fatto unico nella storia del castello(40). Questi era uomo vicino a Giacomo(41), ed è facile quindi immaginare come da Baratonia l’assedio di Balangero fosse seguito con preoccupazione. Ciò è dimostrato dal fatto che Micheletto di Baratonia si recò presso Ame-deo, mentre questi era in exercitu Berengerii per guidare personalmente le operazioni militari, con lo scopo di porgergli omaggio, esattamente il 28 novembre 1356, uno dei primi giorni dell’assedio di Balangero, probabil-mente per scongiurare un attacco alla sua parte di castello(42). In questa occasione il Conte Verde investì il nobile domicello dei luoghi di Barato-nia e Varisella.
Nel già citato atto del 27 gennaio 1360, redatto a Rivoli, l’Acaia chiede che gli siano restituiti i castelli di Baratonia, Balangero, Fiano e Viù. Il suo vassallo Ugonino chiede un risarcimento di 1500 fiorini per alcuni danni subiti e per i beni derubati nel castello e nelle terre circostanti a lui pertinenti; chiede inoltre un risarcimento di 200 fiorini per altri danni subiti dai suoi uomini di Lemie e Usseglio; il rimborso di 50 fiorini che il castellano di Lanzo aveva indebitamente riscosso al posto di Guglielmo Caglio, suo uomo di Usseglio, e la restituzione di altre terre, tra cui quelle
(38) P.l. datta, Spedizione in Oriente di Amedeo VI conte di Savoia, Torino 1826; F. BollatI dI saInt-PIerre, Illustrazioni della spedizione in Oriente di Amedeo VI (il Conte Verde), Torino 1900; d. Muratore, Un principe sabaudo alla presa di Gallipoli turca (1366-1367), in “Rivista d’Italia” XV (1912), pp. 919-958; M. MaGnanI, The Crusade of Amadeus VI of Savoy between history and historiography, in Italy and Europe’s Eastern Border. 1204-1669 (Atti del convegno di Roma, 25-27 novembre 2010, in corso di stampa). Ringrazio Matteo Magnani per avermi fatto leggere il suo testo in corso di pubblicazione.
(39) Archivio di Stato di Torino, Corte, Protocolli Camerali, n. 17, Besson, cc. 24v-35v.(40) ChIarle, Dai Baratonia agli Arcour cit., p. 47.(41) Nel documento del 1360 è infatti ricordato come dominum Hugoninum de Sabaudia
militem, vassallum et fidelem dicti domini principis: Archivio di Stato di Torino, Corte, Protocolli Camerali, n. 17, Besson, c. 32v.
(42) Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Archivio d’Harcourt, b. 1, n. 10. I visconti di Baratonia erano sempre stati alleati degli Acaia, ma in questa situazione Micheletto, probabilmente intuendo meglio di Ugonino chi avrebbe vinto questa guerra, corse immediatamente a recare omaggio al Conte di Savoia: ChIarle, Dai Baratonia agli Arcour cit., p. 47.
63Le origini: visconti dei marchesi di Torino
di Vallo e Monasterolo, dipendenti dal castello di Baratonia, e l’alpeggio di Balma Agnelaria(43). Tutti danni subiti nella guerra che, per una politica di alleanze poco fortunata, lo aveva visto tra gli sconfitti. Ovviamente Ugonino non ottenne nulla di tutto ciò. Anzi, per quello che ci è dato sa-pere dalla documentazione d’archivio, il Conte Verde obbligò Ugonino a restituire ai visconti di Baratonia la parte di castello che proprio da loro aveva acquistato anni prima.
Ma dai danni elencati nel documento si evince che il castello fu attac-cato dagli uomini di Amedeo VI. Non conosciamo la motivazione preci-sa dell’operazione. Bonci ha supposto che Baratonia sia stata attaccata e conquistata anche prima del 2 gennaio 1357, poiché Amedeo si trovava a Lanzo il 20 novembre(44). Ma un vero e proprio attacco è documentato solo dalle richieste fatte a Rivoli dagli sconfitti. Quindi è parimenti pro-babile che il castello sia stato preso d’assalto dalle truppe di Amedeo nel corso della seconda rivolta di Giacomo d’Acaia, tra il 1359 e il 1360(45).
È stato ragionevolmente supposto che Amedeo, nel corso delle opera-zioni militari contro Balangero, non avesse voluto lasciarsi alle spalle una possibile minaccia come il castello di Baratonia(46), e quindi l’abbia assalito nei primi giorni di assedio di Balangero, probabilmente dopo aver ricevu-to l’omaggio di Micheletto.
Diversamente, sarebbe verosimile ipotizzare che l’attacco possa essere stato motivato dall’intenzione di piegare Ugonino, il quale si era rifugiato nella sua parte di castello a Baratonia(47), esattamente come Giacomo si era ritirato nel castello di Balangero(48).
Una terza ipotesi potrebbe vedere nell’obiettivo della spedizione la razzia e il bottino, probabilmente una cavalcata finalizzata soprattutto al guasto dei territori di pertinenza del Bastardo di Savoia: tesi supportata dalla richiesta di risarcimento dei furti subiti elencati nel documento di Rivoli, probabilmente come parte del pagamento alle truppe mercenarie. In effetti siamo a conoscenza che nel corso di questa guerra Amedeo aves-
(43) P. CanCIan, Le carte clusine dell’Archivio di Stato di Torino, in P. CanCIan, G. CasIraGhI, Vicende, dipendenze e documenti dell’abbazia di San Michele della Chiusa, Torino 1993 (Biblioteca storica subalpina 210), p. 398, doc. 81.
(44) BonCI, I Visconti di Baratonia cit., p. 56.(45) datta, Storia dei principi di Savoia cit., pp. 185-188. L’ipotesi è avanzata in: ChIarle,
Dai Baratonia agli Arcour cit., pp. 47-50.(46) BonCI, I Visconti di Baratonia, cit., p. 56.(47) Op. cit., p. 57.(48) Forse una scelta strategica presa di comune accordo tra il principe e Ugonino.
64 Baratonia. Dinastia e castello
se arruolato le prime compagnie mercenarie(49). Allo stato attuale delle ricerche tutte queste ipotesi risultano verosimi-
li e, nella complessità di una guerra, ognuna di esse potrebbe aver concor-so nella decisione di assalire castello e terre di Ugonino. Ma se la prima e la seconda risultano difficilmente documentabili, l’ipotesi della spedizione al fine di razzia e bottino trova ulteriori rilevanti riscontri.
Nei primi decenni del Trecento, a partire dalla Toscana, si diffonde la figura del “brigante a piè”. Si tratta delle prime piccole formazioni di fanteria mercenaria, distinte anche nel lessico dai fanti dei signori e dei comuni. Il termine “brigante” a quest’epoca non indicava ancora il fuori-legge, ma veniva dal francese brigaille che significa “multicolore”, sicura-mente in riferimento all’aspetto esteriore, particolarmente eterogeneo, di queste truppe(50). Da questi combattenti assume l’accezione di “trovarsi
(49) Amedeo ricorse con parsimonia all’arruolamento di compagnie mercenarie perché rappresentava una scelta troppo onerosa per le casse sabaude. Infatti il Conte Verde impiegò le truppe mercenarie per affiancare le sue milizie sovente come truppe ausiliarie: F. CoGnasso, Per un giudizio sul Conte verde sulle compagnie di ventura, in “Bollettino della società pavese di storia patria” XXVIII (1928), pp. 1-11. Le spese di arruolamento delle compagnie di ventura potevano essere sostenute, e non senza difficoltà, dai grandi poteri territoriali italiani, come le città comunali. Firenze per esempio non solo ne aveva le disponibilità finanziarie, ma creò istituzioni appositamente adibite al pagamento del soldo dei mercenari, come la magistratura degli Ufficiali della Condotta, istituita nel 1336, composta da sette cittadini in carica per quattro mesi, proprio con il compito di arruolare, stipendiare e gestire le compagnie mercenarie al soldo della città; o come il banco denominato Presto degli stipendiari, fondato nel 1362, che garantiva ai mercenari di non cadere nelle mani degli usurai e, allo stesso tempo, assicurava all’autorità cittadina che i soldati di ventura avessero sempre a disposizione i propri averi (soprattutto armi e cavalli, che altrimenti sarebbero andati in pegno agli usurai); nel 1367 questa istituzione fu migliorata e fu creato un Procuratore degli stipendiari: G. CanestrInI, Documenti per servire alla storia della milizia italiana, dal secolo XIII al secolo XVI, raccolti negli archivj della Toscana, Firenze 2007, pp. XXX-XXXI.
(50) L’armamento difensivo dei “briganti a piè”, formato da una combinazione di protezioni in cuoio cotto, tessuti ed elementi metallici come borchie o lamine, influenzò profondamente l’armamento difensivo delle fanterie leggere nei due secoli successivi. Infatti dalla metà del XIV secolo si diffuse la brigantina, che proprio dai “briganti a piè” prende il suo nome: un corpetto costituito da un insieme di lamine metalliche rivettate all’interno o all’esterno di uno scheletro in pelle o lino dai colori spesso vivaci. Nella prima metà del Trecento le fonti attribuiscono all’armamento difensivo del brigandus parti in lamine di metallo come difesa peculiare di questo combattente, contrapposto ai diploides, semplici vesti imbottite usate dai comuni fanti (A.a. settIa, De re militari. Pratica e teoria nella guerra medievale, Roma 2008, p. 170). La leggerezza e la flessibilità di questa protezione per il busto consentiva al guerriero di indossarla sopra una maglia di ferro o su qualunque altra protezione leggera. La più antica attestazione sull’uso del termine brigantina compare negli inventari delle armi esportate dal pratese Francesco Datini, che nel 1367 vendeva ad Avignone chorazine brigantine verniciate o stagnate (l.G. BoCCIa, L’armamento difensivo in Toscana dal Millecento al Trecento, in Civiltà delle arti minori in Toscana, Atti del I° Convegno, Arezzo 11-15 maggio 1971, Firenze 1973, p. 207). Le brigantine saranno in uso ancora per tutto il Cinquecento, epoca alla quale risalgono i reperti più interessanti (d.
65Le origini: visconti dei marchesi di Torino
insieme”, “cercare lavoro” e quindi “cercar briga”. Riferito principalmente a questi mercenari appiedati, il termine “brigante” si diffuse presto con il significato di “colui che attacca briga”. La più antica testimonianza pie-montese di queste truppe è del 1342, nel momento in cui fu costituita a Vigone la Compagnia del Fiore che contava tra le sue fila anche 500 bri-gandis(51). Dalla metà del secolo divengono numerose le testimonianze su briganti de Lombardia e Amedeo è uno dei primi signori a reclutare que-ste formazioni nel nord-ovest d’Italia(52). Dal 1350 (anno in cui arruola la banderia di Vione di Agliè, composta per la quarta parte di bonis brigandis et sufficientibus)(53) la documentazione su queste truppe assoldate dal Conte Verde si fa importante e una “banderia brigandorum” è presente tra i re-parti schierati sotto le mura di Balangero(54).
È stato scritto che in questa guerra sia stata impegnata la famosa Com-pagnia Bianca(55), la formazione mercenaria più celebre di questi anni. Era composta prevalentemente da inglesi, ma vi erano in realtà mercenari di ogni regione europea trovatisi disoccupati dopo la pace di Brétigny, che sanciva una tregua di nove anni tra Francia e Inghilterra, segnando la fine di quella che è comunemente nota come la prima fase della guerra dei Cent’anni(56).
Ma in realtà la pace di Brétigny fu stipulata l’8 maggio 1360 e la Com-pagnia Bianca fu creata nel 1361. Solo nel 1362 essa fece il suo ingresso in Italia sotto il comando di Alberto Sterz, richiamata da Giovanni II, marchese del Monferrato, che era stato abbandonato da Corrado di Lan-dau e dalla Grande Compagnia, per combattere prima Galezzo Visconti e poi Amedeo VI. Nel 1363 lo Sterz sconfisse la Grande Compagnia presso il ponte Canturino; il Landau nel corso del combattimento fu colpito a morte e i superstiti si unirono alla Compagnia Bianca: fu da questo mo-
dIotallevI, Per una storia della Brigantina, in Un vestito da battaglia. Una brigantina del ’500, a cura di M.G. Barberini, Roma 2008, pp. 22-27).
(51) G. Claretta, Gli statuti della Società militare subalpina del Fiore dell’anno 1342, in “Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino” XVI (1880-81), p. 665.
(52) settIa, De re militari cit., pp. 165-166. (53) Questi dovevano essere armati di platis, cervelleriis, ensis et pavesiis: CoGnasso, Per un
giudizio sul Conte verde cit., pp. 6-7.(54) F. GaBotto, Estratti dai “conti” dell’Archivio camerale di Torino relativi ad Ivrea, in
Eporediensia, Pinerolo 1900 (Biblioteca della Società storica subalpina 4), p. 423.(55) Id., L’età del Conte Verde in Piemonte secondo nuovi documenti (1350-1383), in “Miscellanea
di storia italiana”, XXXIII, 1896, pp. 121-122, 126-128; ChIarle, Sulle tracce del medioevo cit., p. 51; settIa, De re militari cit., p. 163.
(56) Ph. ContaMIne, La guerra dei Cent’anni, Bologna 2007, pp. 41-43.
66 Baratonia. Dinastia e castello
mento che gli uomini guidati da Alberto Sterz divennero in Italia truppe prezzolate e rinomate(57).
In realtà Amedeo, nella guerra contro il cugino Giacomo(58), assoldò una compagnia composta per la maggior parte da mercenari d’Oltral-pe, molti dei quali inglesi(59): si trattava della compagnia di Anichino di Baumgarten. Anneckin von Baumgarthen, o in alcune fonti Bongart, che era il suo vero nome, discendeva da una famiglia della piccola nobiltà ministeriale della diocesi di Colonia, probabilmente Bongart vicino Al-lrath(60). Arrivò in Italia nel 1351 al servizio dei Visconti e in seguito del papa. Nel 1356 fu al soldo di Bernardino da Polenta, convergendo nei ranghi della Grande Compagnia. Nel 1358, al soldo di Siena, combat-té alla testa di 800 barbute e 400 fanti alla battaglia di Torrita di Siena contro l’esercito di Perugia, dove venne sconfitto e fatto prigioniero. Nel 1359 servì nell’esercito del marchese di Monferrato contro Milano(61). Nel 1360 la sua compagnia venne arruolata dal Conte Verde, nonostante che Amedeo giudicasse Anichino in modo molto poco ragguardevole(62), con
(57) M. Mallet, Signori e mercenari. La guerra nell’Italia del Rinascimento, Bologna 2006, p. 44.
(58) Giacomo invece avrebbe potuto ottenere i servigi della Compagnia del Fiore, nel cui statuto s’impegnava a combattere i nemici del principe d’Acaia e dei marchesi di Saluzzo: Claretta, Gli statuti cit., pp. 656-657.
(59) In Piemonte la nutrita presenza di cavalieri inglesi è testimoniata anche prima del 1362, anno dell’arrivo della Compagnia Bianca. Il 7 settembre 1361 il domicello Richard Musard (Richardi Musardi anglici, dice la fonte), durante l’assedio di Carignano, dichiara di voler diventare un fedele di Amedeo VI, a patto di non essere mai obbligato a combattere contro il re d’Inghilterra (Archivio di Stato di Torino, Corte, Protocolli camerali, n. 58, c. 4r). Tuttavia non è possibile, come sosteneva Cognasso, che il Musard sia giunto in Piemonte con lo Sterz, proprio perché la Compagnia Bianca fece il suo ingresso in Italia solo l’anno successivo (CoGnasso, Per un giudizio sul Conte verde cit., p. 7 e nota 1).
(60) d. BalestraCCI, Le armi, i cavalli, l’oro. Giovanni Acuto e i condottieri nell’Italia del Trecento, Roma-Bari 2003, p. 41.
(61) J. stranGe, Genealogie der Herren und Freiherren von Bongard, Colonia 1866; K.h. sChäFer, Deutsche Ritter und Edelknechte in Italien während des XIV Jahrhunderts, vol. I, Paderborn 1871, pp. 36-95.
(62) Il Conte giudicava Anichino e i suoi uomini “ribaldi” e “gente da niente”: CoGnasso, Per un giudizio sul Conte verde cit., pp. 1-2. D’altra parte Anichino nel corso della sua carriera fu spesso sospettato di azioni infamanti. Durante la guerra tra Siena e Perugia, combattuta tra il 1357 e il 1359, il Baumgarten si trovò spesso a rispondere dell’accusa di “poca fede”. Durante l’assedio di Monte San Savino Anichino fu sospettato di prolungare volontariamente le operazioni d’assalto, senza mai decidersi a un’energica azione per piegare le difese nemiche, affinché l’ingaggio si prolungasse nel tempo, frodando in questo modo le casse di Siena. Sempre durante questo assedio fu indicato come responsabile del fallimento di un’azione offensiva, nel corso della quale morirono diversi cavalieri senesi. L’attrito tra le autorità comunali senesi e la Compagnia di Anichino raggiunse il culmine quando i senesi organizzarono un grosso attacco contro Monte
67Le origini: visconti dei marchesi di Torino
una condotta firmata a Pinerolo di ben 3000 fiorini al mese. Furono questi uomini che riuscirono a impadronirsi di Villar Perosa per conto di Ame-deo VI(63).
Verso la metà del Trecento in Piemonte circolavano diverse forma-zioni mercenarie composte da inglesi e una, tra le altre compagnie stra-niere, è ricordata da Pietro Azario nel De bello Canepiciano, arruolata dal marchese di Monferrato e sguinzagliata nel Canavese affinché con il sac-cheggio coprisse parte delle spese di arruolamento(64). Nel corso del 1360 la compagnia di Anichino Baumgarten assalì Savigliano e, dopo averla espugnata, le sue truppe si dettero a ogni sorta di brutalità sugli abitanti, senza alcun riguardo per il rango sociale, l’età o il sesso, al fine di estor-cere loro denaro e oggetti preziosi: un bottino promesso come parte del loro pagamento(65). Infatti la condotta firmata da Anichino e Amedeo au-torizzava i mercenari “ad saccandum prout eis melius videbitur” per tutto il tempo della ferma(66).
Si tratta quindi di truppe mercenarie straniere, composte per buona parte da inglesi, feroci nel condurre i saccheggi a scopo di bottino(67). Ma l’equivoco che ha visto la Compagnia Bianca prendere parte alle operazio-ni del 1360 al soldo del Conte Verde, anziché la compagnia del Baumgar-ten, è probabilmente dovuto al fatto che nel 1364, alle porte di Firenze, la Compagnia Bianca si sciolse e lo Sterz, con parte dei suoi uomini, si unì alle truppe guidate da Anichino, formando una nuova compagnia(68):
San Savino. I cronisti hanno tramandato che gli uomini di Anichino, non volendo seguire il piano d’attacco, fecero scoppiare una rissa nell’accampamento senese, che ebbe come bilancio la morte di decine di combattenti e il saccheggio della monition publica che era stata portata da Siena per la campagna militare. Dopo questo episodio la Compagnia abbandonò l’esercito senese: M. BorGoGnI, La guerra tra Siena e Perugia (1357-1359). Appunti su un conflitto dimenticato, Siena 2003, pp. 81-82.
(63) CoGnasso, Per un giudizio sul Conte verde cit., p. 8.(64) PetrI azarI JaCoBI De bello Canepiciano, Ivrea 1970, p. 69.(65) BalestraCCI, Le armi, i cavalli, l’oro cit., pp. 74-75.(66) CoGnasso, Per un giudizio sul Conte cit., p. 8.(67) Il Conte Verde e Bernabò Visconti intrapresero una campagna militare appositamente
per tentare di fermare le violenze delle compagnie di ventura prive d’ingaggio, che saccheggiavano città, villaggi e campagne della Lombardia e del Piemonte: L. CIBrarIo, Origini e progresso delle istituzioni della monarchia di Savoia, Torino 1855, p. 158. Dalla fine degli anni Sessanta del Trecento in Italia furono comuni alleanze tra città e tra principi per affrontare le minacce derivate dalle compagnie prive d’ingaggio. Celebre fu la Confederazione che coinvolse, dal 1366, il papa Urbano V, Firenze, Siena, Perugia e Bologna: CanestrInI, Documenti per servire alla storia della milizia italiana cit., pp. XLVII-LVIII.
(68) Gli altri mercenari elessero Giovanni Acuto (Johnn Hawkwood) come nuovo comandante, creando una compagnia che nel corso degli anni fu sempre più identificata con la
68 Baratonia. Dinastia e castello
la Compagnia della Stella, probabilmente così chiamata in omaggio alla stella che campeggiava nell’arme araldica del Baumgarten(69).
Del resto, se fosse stata la Compagnia dello Sterz a partecipare alla guerra di Amedeo contro l’Acaia, la teoria del saccheggio a scopo di botti-no sarebbe molto meno sostenibile: ciò che colpì anche i contemporanei fu proprio il fatto che gli uomini guidati dallo Sterz, e in seguito dall’Acuto, furono celebri per non essere “rapaci”, lasciandosi andare raramente a razzie e saccheggi (se non quando era previsto dal contratto di condotta o quando cercavano a ogni costo un ingaggio, come avvenne alle porte di Firenze nel 1364), anzi pagavano regolarmente le masserizie di cui ave-vano necessità(70).
Invece per pagare i “briganti” e gli uomini di Anichino(71), il saccheggio sarebbe stato un eccellente modo per far guadagnare altre ricchezze a questi mercenari, soprattutto di un castello che si rendeva appetibile an-che per alberi da frutto e vigne dai quali i mercenari avrebbero potuto re-quisire alimenti freschi e ricchi di vitamine(72), vere rarità in guerra, senza mettere ulteriormente le mani nelle casse del Conte, così com’era d’uso(73).
Nuove difese, nuove armi
Nonostante la guerra e gli armamenti stessero cambiando, le caratte-ristiche esterne del castello di Baratonia potevano essere sfruttate anche nel XIV secolo.
Risultava ancora estremamente efficace il percorso d’accesso alla porta d’ingresso in senso orario, che esponeva il fianco destro degli attaccanti alle armi dei difensori. È vero che verso la metà del Trecento l’uso del-lo scudo come arma difensiva, soprattutto da parte dei cavalieri, andava esaurendosi: l’armamento difensivo, tradizionalmente basato sull’usbergo
figura dell’Acuto stesso: Mallet, Signori e mercenari cit., p. 46.(69) BalestraCCI, Le armi, i cavalli, l’oro cit., p. 41.(70) Mallet, Signori e mercenari cit., p. 45.(71) Anchino servirà nuovamente il Conte Verde nel 1327, con una condotta di 20000 fiorini
al mese, firmata mentre Amedeo preparava la guerra contro il Marchese di Saluzzo e i Visconti: CoGnasso, Per un giudizio sul Conte cit., p. 9.
(72) Il castello di Baratonia era ricco di alberi da frutto, come descritto nel documento del 12 gennaio 1329: Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Archivio d’Harcourt, b. 1, n. 2.
(73) D’altra parte Amedeo non poteva permettersi ulteriori spese per l’arruolamento di mercenari, e quindi offriva la possibilità di saccheggiare a piacimento: CoGnasso, Per un giudizio sul Conte verde cit., p. 7.
69Le origini: visconti dei marchesi di Torino
di maglia di ferro, dall’inizio del XIV secolo si arricchiva di nuovi ele-menti in cuoio cotto o bollito, alcuni dei quali, come cosciali o cannoni d’avambraccio, rinforzati da stecche o borchie metalliche, e altri pezzi in-teramente formati da lamine di metallo, come ginocchielli e manopole(74). Dal terzo quarto del secolo si diffonde, a partire da Milano, l’armatura a piastre(75), e in questi anni gli armamenti difensivi piemontesi sono pro-fondamente influenzati dalla produzione armorara milanese(76). Protezio-ni queste che rendevano superfluo, quando non ingombrante, l’impiego di scudi e targhe.
Ma le tattiche difensive delle fanterie, anche per le operazioni d’as-salto, si basavano sull’utilizzo dei pavesi: uno scudo alto poco più di un metro e largo intorno al mezzo metro, usato da fanti specializzati detti appunto pavesari(77). Nella prima metà del XIV secolo i pavesari saranno massicciamente presenti negli eserciti piemontesi(78), e lo stesso Amedeo VI li arruolò spesso, molte volte come milizie mercenarie(79), anche per le
(74) L.G. BoCCIa, e.t. Coelho, L’armamento in cuoio e ferro nel Trecento italiano, in “L’illustrazione italiana”, I, 2 (1974), pp. 24-29.
(75) L’armatura a piastre più antica pervenutaci (Sluderno, Castel Coira, Armeria, inv. S 13) riporta punzonato il marchio P dell’armoraro milanese Pietro Negroni da Ello, uno dei più antichi membri noti della celebre famiglia Missaglia, la dinastia di forgiatori di armature più celebre del XIV e XV secolo. Il medesimo marchio è punzonato su un bacinetto, conservato nella Pinacoteca Comunale di San Gimignano. L’armatura di Castel Coira e il bacinetto di San Gimignano possono essere datati al 1370 circa.
(76) Già nel 1232 il comune di Vercelli, volendo installare in città una fabbrica d’usberghi, chiamò Aramannus Rubei osbergerii civitate Mediolani: e. Motta, Armaiuoli milanesi nel periodo visconteo-sforzesco, in “Archivio Storico Lombardo” XLI (1914), p. 188. Negli anni settanta del Trecento il maestro armoraro Martino da Milano, forgiatore di bacinetti, acquistava il prelavorato sul mercato di Avigliana, dove si smerciava il metallo estratto dalle miniere locali, già lavorato in piastre e lingotti per essere successivamente usato dagli armaioli per forgiare le varie tipologie di armi (generalmente con i lingotti si producevano le lame delle spade e con le piastre i vari pezzi dell’armatura). Lo stesso commercio, nei medesimi anni, proliferava anche a Pinerolo e a Lanzo, dove si vendeva il prelavorato estratto dalle miniere prealpine locali: l. FranGIonI, La tecnica di lavorazione dei bacinetti: un esempio avignonese del 1379, in Tecnica e società nell’Italia dei secoli XII-XVI, atti dell’XI° Convegno internazionale (Pistoia, 28-31 ottobre 1984), Pistoia 1987, p. 197.
(77) La più antica menzione del pavese è del 1231. Nel giugno di quest’anno il comune di San Gimignano acquistò chiodi per appendere i propri pavesi quando dovevano essere riposti nel deposito del comune. Per un’esaustiva panoramica sui pavesi: A.A. settIa, I mezzi della guerra. Balestre, pavesi e lance lunghe: la specializzazione delle fanterie comunali nel secolo XIII, in Pace e guerra nel basso medioevo, Atti del XL° Convegno storico internazionale (Todi, 12-14 ottobre 2003), Spoleto 2004, pp. 172-195. Adesso, con note integrative, anche in settIa, De re militari cit., pp. 219-235.
(78) La più antica attestazione piemontese risale al 1345, quando in gennaio il siniscalco angioino assoldò a Savigliano 12 pavesari provenienti da alcune località piemontesi. Questo documento e i successivi sono commentati in ordine cronologico in op. cit. pp. 164-166.
(79) Anche i “briganti” della Banderia di Vione di Agliè erano dotati di pavesi: CoGnasso, Per
70 Baratonia. Dinastia e castello
operazioni militari al di là delle Alpi(80). Allo stesso modo il principe d’A-caia introduceva i pavesari tra le milizie a lui fedeli, come nel 1355 quando ordinò agli uomini di Moncalieri di armarsi con pavesi(81). Ma è certo che Amedeo VI usò i suoi pavesari all’assedio di Balangero(82) e quindi questa specialità poteva essere presente anche nella spedizione contro Baratonia (spesso i pavesari offrivano appoggio e protezione tattica anche durante le cavalcate).
Costoro, per risalire il sentiero verso l’ingresso, per non offrire il fian-co, sarebbero stati obbligati a procedere in ranghi serrati muovendosi in modo innaturale, cosa che le tattiche dell’epoca non permettevano.
Il piccolo fossato innanzi al ponte levatoio avrebbe ostacolato le opera-zioni d’assalto, anche quelle condotte con macchine apposite. Amedeo, per piegare le resistenze di Balangero, fu costretto a impegnare un’imponente parco macchine(83): fece erigere un battifolle(84); furono portati trabucchi e costruita una troia, una macchina da lancio a contrappeso in grado di sca-gliare più pietre contemporaneamente(85); inoltre fece arrivare numerosi minatori per scavare gallerie di mina e per scalzare le mura con i picco-ni(86).
un giudizio sul Conte verde cit., pp. 6-7.(80) settIa, De re militari cit., p. 165.(81) Il principe ordinò che gli uomini di Moncalieri si dotassero di diploydes, plate, panzeroni,
gorgerie, cervellerie, barbute, pavexii, targe, lancee, iusarme et baliste in ea maiore quam poteritis quantitate: GaBotto, L’età del Conte Verde cit., p. 272.
(82) GaBotto, Estratti dai “conti” cit., pp. 397-398.(83) Soprattutto Oltralpe i conti di Savoia, dall’inizio del XIV secolo, avevano rinforzato le
difese dei propri castelli con un numero imponente di macchine belliche, rinnovate e rinforzate proprio da Amedeo VI, anche per attaccare i castelli avversari: Kersuzan, Défendre la Bresse et le Bugey cit., pp. 163-172.
(84) Un castello provvisorio, sovente in legno e terra battuta, munito di torri e fossato, eretto nelle vicinanze della località assediata, fungendo da base tattica per gli aggressori. Un esempio trecentesco lo si può ammirare nel celebre affresco di Simone Martini Guidoriccio da Fogliano all’assedio di Montemassi, Siena, Palazzo Pubblico, Sala del Mappamondo. All’interno del battifolle si può vedere il braccio di un trabucco, che in realtà era un grande braccio con fionda, inserito in un pozzo appositamente scavato: Guida alla Maremma Medievale, a cura di R. Farinelli, R. Francovich, Siena 2000, pp. 89-91.
(85) Già menzionata nello Pseudo-Turpino, alla metà del XII secolo, la sua presenza durante gli assedi è testimoniata ancora nella seconda metà del XIV secolo, come narrato da Jean Froissart: duCanGe, Glossarium cit., pp. 191-192. Tra il 1321 e il 1323 erano al servizio di Antonio, signore di Barge, il carpentiere Peretto Durandi e Pietro Pellipari, che furono pagati per la costruzione di macchine belliche per espugnare il castello e la città di Voyron, tra cui figura una troia: C. ProMIs, Gl’ingegneri militari che operarono o scrissero in Piemonte dall’anno MCCC all’anno MDCL, Torino 1871, pp. 416-417.
(86) l. CIBrarIo, Della qualità e dell’uso degli schioppi nell’anno 1347, Torino 1844, pp. 13-16.
71Le origini: visconti dei marchesi di Torino
Osserviamo a questo proposito che il castello di Baratonia fu modifica-to nel corso del XIV secolo, supponiamo in seguito ai danni subiti durante l’attacco degli uomini del Conte Verde, come lamentato da Ugonino; tali modifiche lo resero idoneo ad affrontare qualunque necessità difensiva.
Le innovazioni architettoniche del Trecento tentarono di conciliare una certa confortevolezza del palatium con le esigenze della difesa del castrum: le finestre divennero più ampie e l’entrata era aperta al piano ter-reno, ma in compenso le porte vennero protette da opere avanzate e ponti levatoi, che proprio in questi anni trovano la loro diffusione(87), costruzio-ni riscontrabili nelle strutture superstiti di Baratonia.
Gli elementi strutturali del castello tutt’oggi più visibili, e ricondu-cibili a tale periodo, sono due contrafforti posti sui fianchi, uno per lato, leggermente spostati verso est, la parte più esposta; muri controterra e una muraglia con una pronunciata inclinazione del parametro rispetto alla verticale(88). Probabilmente fu in questa occasione che venne anche co-struito il ponte levatoio, struttura idonea a resistere alle nuove e migliori armi da getto, come accadde per altri castelli piemontesi di cui possediamo ancora la documentazione(89). Difficilmente questi elementi architettonici furono aggiunti esclusivamente come rinforzi strutturali. È più probabile che siano frutto delle esperienze militari del primo Trecento, una lezione appresa se non durante l’attacco a Ugonino, almeno all’assedio di Balan-gero, con l’esplodere dei primi colpi di schioppi e bombarde.
Il terzo documento noto in Europa sull’impiego di armi da fuoco è pro-prio piemontese: nei conti della castellania di Gassino, il 16 aprile 1327, il castellano segnava una spesa di 72 soldi per un’arma da fuoco non me-glio precisata(90). A partire da questo documento la presenza di bombarde
Amedo VI richiamò altre volte i minatori per la guerra d’assedio. Per espugnare Gex nel 1353, ad esempio, il Conte Verde schierò i minatori delle valli della Stura di Lanzo, comandati da Aimone di Challant, signore di Fenis e castellano di Lanzo, per scavare gallerie di mina, mentre le macchine d’assedio furono dirette dall’ingegnere Giovanni di Longuecombe: ProMIs, Gl’ingegneri militari cit., p. 422.
(87) settIa, I caratteri edilizi di castelli e palazzi cit., pp. 205-206.(88) a.M. Casale, Castelli in Val Ceronda: caratteristiche e tecniche costruttive, in Boschi & castelli
cit., pp. 50-52.(89) Nel 1327 il castello di Caluso fu potenziato da nuove strutture, compreso un ponte
levatoio, proprio per resistere meglio alle nuove macchine belliche: a. aCtIs CaPorale, Notizie di impiego delle armi da fuoco in Canavese negli Trenta del XIV secolo, in “Armi antiche” 1997, pp. 21-23.
(90) Archivio di Stato di Torino, Sezioni riunite, Camerale Piemonte, art. 39, mazzo 1, rotolo 5, Conti della castellania di Gassino (novembre 1326-novembre 1327); a. anGeluCCI, Ricordi e documenti di uomini e trovati italiani per servire alla storia militare, Torino 1866, p. 143; Id., Catalogo dell’Armeria Reale, Torino 1890, p. 402; ProMIs, Gl’ingegneri militari cit., pp. 415-416; G. dondI, Il terzo documento sull’arma da fuoco in Europa, in “Armi antiche” 1997, pp. 31-43.
72 Baratonia. Dinastia e castello
e schioppi sui campi di battaglia e nei castelli piemontesi, come di tutta Europa(91), iniziò ad avere una notevole frequenza, soprattutto nei castelli del contado e nelle fortificazioni urbane(92): tra il 1337 e il 1339 vennero pagati dalla castellania di Caluso quadrelli e polvere “de sclopo”(93); a par-tire dal 1342 in Piemonte è testimoniata una produzione di “schioppi da posto”(94); nel 1346, oltre a essere ricordato lo schioppo posto sulla torre che difendeva il ponte sul Po(95), a Torino era attivo Girardino “magistro sclopi”, condannato all’impiccagione dalle autorità come ladro di strada(96)
(91) Sulle primitive armi da fuoco in Europa: CIBrarIo, Della qualità e dell’uso degli schioppi cit.; anGeluCCI, Documenti inediti I, cit.; Id., Catalogo dell’Armeria Reale cit., pp. 402-404; a. Peterson, Armi da fuoco nei secoli, Milano 1963, pp. 16-53; a. PasqualI-lasaGnI, e. steFanellI, Note di storia dell’artiglieria dello Stato della Chiesa nei secoli XIV e XV, in “Archivio della R. Deputazione romana di Storia patria” LX (1938), pp. 158-189; a. GaIBI, Un raro cimelio piemontese del Trecento. Ritrovamento di una bombardella di ferro presso il Castello di Verrua Savoia, in “Armi antiche” 1965, pp. 29-35; Id., Armi da fuoco italiane, Milano 1968, pp. 14-21; J.r. PartInGton, A History of Greek Fire and Gunpowder, Cambridge 1999; J.r. hale, Gunpowder and the Renaissance. An Essay in the History of Ideas, in Renaissance War Studies, Londra 1983; Ph. ContaMIne, La guerra nel medioevo, Bologna 1986, pp. 269-286; K. devrIes, Medieval Military Tecnology, Petersborough 1992, pp. 123-168; B.s. hall, Weapons and Warfare in Renaissance Europe: Gunpowder, Technology, and Tactics, Baltimora 1997; C. KönIG, Le più antiche informazioni scritte e iconografiche sull’uso delle armi da fuoco in Romania, in “Armi antiche” 1997, pp. 5-18; aCtIs CaPorale, Notizie di impiego delle armi da fuoco in Canavese cit., pp. 19-29; dondI, Il terzo documento sull’arma da fuoco cit., pp. 31-44; Id., Armi e armati alla guerra del Canavese (circa 1330-1350), in Il castellazzo di Caluso: idee per il recupero della fortezza, Atti del convegno (Caluso, 16 maggio 1999), a cura di A. Actis Caporale, Caluso 2001, pp. 146-149; F. sterrantIno, Tecnica delle armi da fuoco dal XV al XVI secolo, in Il castellazzo di Caluso cit., pp. 167-172; M. MorIn, The Earliest European Firearms, in Companion to Medieval Arms and Armour, a cura di D. Nicolle, Woodbridge 2002, pp. 52-62; settIa, De re militari cit., pp. 170-172; K. devrIes, r.d. sMIth, The Artillery of the Dukes of Burgundy, 1363-1477, Toronto 2005; K. Chase, Armi da fuoco. Una storia globale fino al 1700, Gorizia 2009, pp. 105-135. Come riferimento bibliografico si veda: F. BarGIGIa, a.a. settIa, La guerra nel medioevo, Roma 2006, pp. 134-136; C. de vIta, M. Merlo, l. tosIn, Le armi antiche. Bibliografia ragionata nel Servizio Bibliotecario Nazionale, Roma 2011, pp. 77-82.
(92) Oltreché nei castelli del contado (di cui la documentazione europea fornisce abbondanti testimonianze), nel Trecento le armi da fuoco erano posizionate sovente in luoghi strategici urbani, molto spesso in concomitanza con tumulti cittadini. A Torino, nel 1346, la torre che difendeva il ponte sul Po era armata di schioppo (CIBrarIo, Della qualità e dell’uso degli schioppi cit., p. 8; settIa, De re militari cit., p. 171). Nel 1378 a Firenze, durante la rivolta dei Ciompi, i ponti sull’Arno furono muniti di bombarde (BoCCIa, L’armamento in Toscana cit., p. 202). Sempre nello stesso anno alcune bombarde furono posizionate in Castel Sant’Angelo a Roma, in difesa dagli attacchi delle milizie urbane e dei principi avversari del papa Clemente VII (PasqualI-lasaGnI, steFanellI, Note di storia dell’artiglieria dello Stato della Chiesa cit., p. 155).
(93) aCtIs CaPorale, Notizie di impiego delle armi da fuoco in Canavese cit., p. 23.(94) A. duFour, F. raBut, Les armouriers, les fabricants de poudre à canon, et les armes de
diverses espèces, en Savoie, du XIV au XVIII siècle, in “Mémoires et documents publié par la Société Savoisienne d’histoire et d’archeologie” XXII (1884), p. 119.
(95) CIBrarIo, Della qualità e dell’uso degli schioppi cit., p. 8; settIa, De re militari cit., p. 171.(96) anGeluCCI, Documenti inediti I, cit., pp. 16; CIBrarIo, Della qualità e dell’uso degli schioppi
73Le origini: visconti dei marchesi di Torino
e, il 26 febbraio dello stesso anno, il castellano di Frassineto Po documen-tava l’avvenuta consegna di alcune armi, tra cui “schiopum unum cum pulvere et ferro causa discrocandi”(97); sempre nel 1346 polvere nera e quadrelli per schioppi furono acquistati per la difesa di Caluso, mentre a Cirié, nel 1347, fu allestito un nuovo telaio per uno schioppo e furono acquistati 100 quadrelli(98); tra gli anni 1360 e 1363 Amedeo VI favorì i maestri in grado di gettare artiglierie(99) e nel 1376 a Ivrea si produceva polvere nera per artiglierie e armi da fuoco manesche(100); nel 1381 sono registrate 21 libbre di polvere da schioppo per i castelli di Vercelli e Sa-lussola(101). Anche tra le armi dell’esercito del Conte Verde vi erano delle armi da fuoco, e almeno una di queste, uno schioppo dice la fonte, tuonò all’assedio di Balangero(102). Quindi per la ristrutturazione trecentesca è altamente probabile che si fosse tenuto conto degli effetti delle nuove e spaventevoli armi.
Vogliamo però segnalare un fatto curioso, e come tale lo considerere-mo.
Nel 1346 Margherita di Savoia chiese, per la difesa del suo castello di Lanzo, la fabbricazione di quattro schoppi di bronzo(103). L’artefice di que-ste armi fu tale maestro “Hugonino de Castellione Auguste” (Ugonino di Chatillon). Dal documento il maestro Ugonino sembra essere abile fondi-tore in bronzo: in diciotto settimane, con il solo aiuto di un collaboratore, riuscì a colare quattro bocche da fuoco con 238 libbre di bronzo(104). Non si può non osservare che nel 1343, quando Ugonino Bastardo di Savoia,
cit., p. 8.(97) anGeluCCI, Documenti inediti I, cit., p. 17.(98) GaBotto, Estratti dai “conti” cit., pp. 374, 378-379, 468.(99) a. duFour, F. raBut, Les Fondeurs de cuivre et les canons, cloches, etc. en Savoye, in
“Mémoires et documents publié par la Société Savoisienne d’histoire et d’archeologie” XXI (1883), pp. 119-121.
(100) duFour, raBut, Les armouriers, les fabricants de poudre à canon cit., p. 119.(101) anGeluCCI, Documenti inediti I, cit., p. 22.(102) CIBrarIo, Della qualità e dell’uso degli schioppi cit., p. 15.(103) Per una precisa trattazione del documento: CIBrarIo, Della qualità e dell’uso degli schioppi
cit., pp. 7-13. Trascrizione e traduzione del documento in: dondI, Il terzo documento sull’arma da fuoco cit., pp. 40-41. Citato anche in: duFour, raBut, Les armouriers, les fabricants de poudre à canon cit., p. 119; anGeluCCI, Documenti inediti I, cit., p. 17; Id., Catalogo dell’Armeria Reale cit., p. 403.
(104) Corrispondenti a 87.346 chilogrammi (l’unità di misura usata nel documento è la libbra di Lanzo di 367 grammi): CIBrarIo, Della qualità e dell’uso degli schioppi cit., pp. 10-12. Quindi è verosimile che per ogni schioppo (ammesso che fossero tutti uguali) fosse stato necessario impiegare circa 21.836 chilogrammi di bronzo. Per le ipotesi tecniche vedere: dondI, Il terzo documento sull’arma da fuoco cit., p. 41.
74 Baratonia. Dinastia e castello
figlio naturale di un Acaia(105), prese residenza nella parte di castello di Baratonia acquistata dai visconti, la principessa Margherita ordinò al ca-stellano di Lanzo di consegnare al Bastardo 48 lire viennesi(106).
Non diremo oltre sull’identificazione del personaggio, se Ugonino Ba-stardo di Savoia e mastro Ugonino fonditore rappresentino un caso di omonimia, come siamo obbligati a pensare in mancanza di approfondi-menti specifici. Ma molti studiosi hanno supposto che lo schioppo usato a Balangero potrebbe essere uno dei quattro colati da Ugonino per Mar-gherita(107). Ipotesi che, oggi mettendo a confronto le fonti sul Bastardo di Savoia e sul fonditore, oltre a essere suggestiva diviene degna di attenzio-ne per indagini future.
Perché proprio in quel luogo?
Il castello pone ancora alcune domande.La prima riguarda i due piani che si trovano sui poggi immediatamente
a est e a ovest del castello. Questi non sono certamente naturali, ma frut-to di un lavoro di livellamento dell’altura per ricavare una spianata che sicuramente doveva ospitare degli edifici(108): non abbiamo alcuna prova certa che ci permetta di formulare ipotesi precise, ma solo qualche sugge-rimento di lettura.
Il piano a ovest poteva ospitare una struttura difensiva a mo’ di anti-porta, probabilmente in legno, con altri edifici. Mentre quella a est, che senz’altro schermava il lato frontale del castello, poteva essere un pri-mo ingresso dal quale si inerpicava il sentiero che conduceva al ponte levatoio, una sorta di dogana. Alla luce dei documenti è probabile che si possa trattare della parte di castello acquistata da Ugonino, e anche questo argomento merita approfondimenti futuri. Vogliamo però ancora sottolineare che a tutt’oggi nessuna delle ipotesi formulabili può essere confermata.
La domanda da porsi è il motivo che spinse i visconti di Baratonia a
(105) ChIarle, Dai Baratonia agli Arcour cit., p. 55.(106) BonCI, I Visconti di Baratonia cit., p. 55.(107) CIBrarIo, Della qualità e dell’uso degli schioppi cit., p. 15; settIa, De re militari cit., p.
171.(108) Siamo molto ben informati sulla grande opera di livellamento della montagna per la
costruzione del castello di Casteldelfino in Val Varaita, ai piedi del Monviso, grazie all’abbondante documentazione conservata e ai rilevamenti archeologici. I lavori iniziarono nel 1336 sotto la direzione del castellano Raimondo Chabert: tosCo, Il castello, la casa e la chiesa cit., pp. 149-161.
75Le origini: visconti dei marchesi di Torino
edificare una struttura difensiva, che come visto doveva presentarsi note-volmente munita e imponente, proprio in quel luogo. I confronti tipologi-ci, precedentemente avanzati, con il castello di Avio e di Saint Pierre raf-forzano tale domanda. Anche per questi la funzione di residenza signorile non fu mai alterata, nonostante gli importanti eventi bellici di cui furono protagonisti.
Il primo, menzionato per la prima volta in un documento del 1053, fu posseduto dalla famiglia dei Castelbarco, uomini molto vicini agli Scali-geri di Verona. Esso domina un’ampia porzione della Val Lagarina, im-portante crocevia tra l’Italia e la Germania(109). Nel 1411 passò alla Sere-nissima, come avamposto veneziano in direzione di Rovereto e Trento. Nel 1509 fu occupato dall’imperatore Massimiliano I; riscattato nel 1516 come bene della Chiesa, non prima che fosse diroccato e incendiato da-gli imperiali, passò successivamente ad altre nobili famiglie trentine. Da questo momento il castello cadde in disgrazia, assumendo l’aspetto di un rudere, fino agli anni 1893, 1902 e 1912, quando i proprietari e le autorità austriache ne decisero il recupero(110).
Il castello di Saint Pierre, dominante il fondovalle della Dora Baltea in direzione di Aosta, fu posseduto nel corso dei secoli da diverse fami-glie: edificato prima della fine del XII secolo (è infatti citato in un docu-mento del 1191) e posseduto dalla famiglia dei “de Sancto Petro”, da cui il castello prese il nome; venne in parte ceduto nel secolo successivo ai signori di Quart. Nel 1321 un’altra porzione andò al duca di Savoia e nel 1405 tale cosignoria si estese anche alla famiglia Challant. I Roncas, che ne acquisirono l’intera proprietà all’inizio del Seicento, lo ampliarono. Le diverse fasi costruttive non risultano sempre evidenti anche perché nel 1873, con l’ultimo proprietario, il barone Emanuele Bollati, il castello co-nobbe profonde trasformazioni, sotto la direzione dell’architetto Camillo Boggio(111).
Entrambi i castelli, oltre a dominare i rispettivi borghi e le importanti vie di comunicazione sottostanti, s’inserivano all’interno di un sistema di-fensivo più ampio, formato da più castelli e torri(112) ed erano posseduti da
(109) G.M. varanInI, I Castelbarco dal Duecento al Quattrocento. Punti fermi e problemi aperti, in Castellum Ava. Il castello di Avio e la sua decorazione pittorica, a cura di E. Castelnuovo, Trento 1987, pp. 17-39.
(110) BoCCIa, I guerrieri di Avio cit., pp. 11-13; d. lorenzI, I castelli del Trentino, Trento s.d., p. 26.
(111) a. zanotto, Castelli Valdostani, Quart 1975, pp. 140-144.(112) Il castello di Avio, insieme a Castel Pietra, per la sua posizione strategica fu inserito
all’interno di un sistema di fortificazioni lungo la valle dell’Adige che aveva come punto centrale
76 Baratonia. Dinastia e castello
importanti famiglie locali che, grazie anche al possesso di questi castelli, riuscirono a inserirsi nella grande politica regionale. Il castello di Sab-bionara d’Avio e di Saint Pierre, come quello di Baratonia, hanno subito importanti modifiche strutturali nel corso del Trecento e il principale elemento difensivo, per questi tre castelli, era il maschio centrale. Però il castello dei visconti si trova in una valle chiusa, il cui controllo del terri-torio è forzosamente obbligato a un giro d’orizzonte di pochi chilometri quadrati. Il motivo preciso ci sfugge ancora oggi.
A questa domanda, e alle altre qui esposte, si potrà tentare di fornire ipotesi scientificamente valide solo con la conduzione di scavi archeologi-ci sistematici e confrontandone i risultati con le ricerche d’archivio come quelle svolte finora, delle quali si auspica la prosecuzione.
Mauro MerloRicercatore presso la Scuola Normale Superiore di Pisa
Castel Beseno, tanto che quest’ultimo castello nel XIV secolo era retto da un consortile formato dai Castelbarco, i signori di Avio, e dai Trapp, importante famiglia tirolese che aveva la sua residenza a Castel Coira presso Sluderno, in Alto Adige: G.M. varanInI, I conti di Tirolo, i principati vescovili di Trento e Bressanone, i loro rapporti con le signorie e i comuni dell’Italia settentrionale nei secoli XIII-XIV, in Incontri sulla storia dell’Alto Adige, a cura di G. Dalle Donne, Bolzano 1994, p. 84.