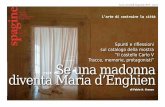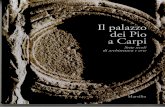Il Castello di Circello crocevia di popoli e culture
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Il Castello di Circello crocevia di popoli e culture
Costelli del Sonnio
IL CASTELTO DI CIRCEIIOCROCEVIA DI POPOLI E CUTTUREDai Sanniti ai Liguri Bebiani, dai Normanni ai Longobardi, da Carlo VIII di Francia agliarchitetti senesi: storia intensa ed intricata, lunga circa tre míllenní, ili an fortino sulle collí-ne beneventane. Che ne ha viste dawero di tutti i colori
di Pietro Dí Lorenz.o
Chiunque, sopraîtutto se campanodella pianura, non sia sîaîo almeno unavolta nell'alto Sannio beneyentarut stpriva delln possibilifà di recuperare unaparte dí sé sconosciuta, altrimenti de-stinata a restare nascosfa negli qngoli
îraîîerò solo di quest'ultimo, lasciandoalla perspicacia e alla esplorazione dellettore la scopefia (o la iscopefia) de-gli alîri viaggi nel tempo e nello spazio.
Anricipo. perché sentiti e doverosi. iringraziamenti: alla sig.na Maisa Mieleper la cordíale disponibilitò di alcunefontí e notizie popolari; al prof. CarloTartaglia Polcini e alla famiglía Di
do utili a ricostruire alcuni episodi pun-tuali, il castello di Circello è privo diuno studio specialistico compiuto, com-pleto ed esaustivo. Il lavoro che segueè stato impostato come una ricerca adampio raggio su l le lond. su l le not iz ie esulla bibliografia e si propone, come tut-ti i prodotti sperimentali, con risultatiparziali ed incompleti ma perciò per-
píù reconditi di quell'ínconsa-pevole bagaglio personale cheforma il patrimonio collettivo delgenere umano. La valle delTammaro e del suo tríbutario, ilto rrenî e Tammere c chia, e sîremonordo c cidentale de lla provinc iadi Benevento, partecipano piùdella storia che della geografia.Suoni, immagini, odori, gusti,s ens azioni taîîili ap p arent emen-îe semplici e spontanee evocanopercezíoni, emolioni, fanîasie edídee inspíegabílmente comples-se e indecifrabili. Risonanze dimondi lontani nello spazio e neltempo che, pur toccando tutte lecorde clella nostra personalitòLtmana, non síamo più in gradodí decifrare. Segní wnerabilt dipopolazíoni e di vicende dimen-îicate, quasi un pellegrinaggiotemporale. Paesaggi, ambienti eculture che consenano sentieriinesplorati, tracce di percorsidella storia. Elementi giò di persé stessí sufficienfi a giustifica-re I'interesse per il recupero e lavalorizzazione del terrítorio edelle sue emergenTe, e uîili spun-
fettibili. La bibliografia consul-tata è riportata in appendice.
I fondi documentari d'archi-vio disponibili, pubblici e priva-ti, laici e religiosi, sono stati tut-ti indagati, e, a dire il vero, conpochi risultati, soprattutto perquanto concerne la ricostruzio-ne delle vicende del castello.Quindi quanto segue, concer-nente le ipotesi di datazione, dievoluzione, e dì stratìficazìone,è il prodotto originale di una sin-tesi condotta parte per compara-zione con altri edifici coevi, par-te per interpolazione sulle vi-cende slorico-politiche note delteritorio.
l. Le preesistenze in età anticae la "Res Publica Ligurum" inloczlità Macchìa
Molto frequenti (nelle zone diforte e prolungata vocazioneagricola e pastorale) sono le leg-gende e i racconti tradizionaliche narrano di un "passaggio se-greto" di fuga dal castello. Ra-ramente tali racconti hanno ri-scontri documentari o archeolo-
ti per allestire spazi museali e didattici Somma per aver concesso la consulîa- gici. Proprio sulla scorta di tali notiziecoerenîí invece colpevolmente e para- zione e la riproduzione di alcuni tlocu- popolari, si è commissionata un'inda-dossalmente assenti. Tra i percorsi pos- menti inediÍi conseruati nei rispetti ar- gine archeologica (con metodi elettro-síbili: la preistoria e i Sanniî| la culîu- chíví privart; a María Tèresa Scarpa per resistivi) condotta a cura dalla dittara popolare e la transumanza, I'ar- la revisione delle bozze. Geosystem s.r.l. di Parma del dr. geo-cheologia classica dei Liguri Bebiani logo Carlo Cavazzuti, specializzata nel(quí deportati nel 180 a.C. e costituiti Premessa settore, incentrandola sul solo sito delin enclave autonoma, la "Res Publica Metodologia e fonti castello e delle sue pefiinenze. Ciò haLigurum", per secoli), la víta feudale e Pur non mancando monografie (a1- costituito strumento di capitale impor-I'incasfellqmento del Medíoevo. Quí cune di gran pregio) e aficoli oltremo- tanza per poter indagare 1e strutture in-
Circello, Castello Di Somma, porfale di ingresso al mastio
I.A PROVINCIA SANNITA 25
Costelli del Sonnio
terate e quelle coperte da macerie. Allostato non sono state rilevate tracce di al-lineamenti murad riconducibilì alle con-figurazioni tipiche degli insediamentipreistorici e protostorici. [l che non con-sente di poter avvalorate, con provescientificamente inattaccabili, le vicen-de della prima antropìzzazione preisto-rica del comprensorio e, tantomeno, leteor ie proposte c i rca la presenza d i uninsediamento sannitico nella zona delcastello. D'altra parte, lasciano apertaancora la questione sia I'ottima visibi-Iità a scala regionale che si gode dal col-le del castello sia la giustificazione cheteremoti ed interventi umani reiteratinel tempo possono aver cancellàto lestrutture principali (le sole ricognizza-bili con i metodi succitati).
Le indagini archeologiche esperite acura della Soprintendenza ai BeniArcheologici di Salerno, Avellino eBenevento hanno finora plivilegiato gliepisodi legati agli insediamenti deiLiguri Bebiani. Relativamente al lorocomprensorio, le fonti antiche parlanodi una "Res Publica Ligurum", quindisostanzialmente piÌr che di una città, diun territorio quasi autonomo, forse piut-losto popolato ad insediament i spar ' iche umanizzato intorno ad un nucleounico, almeno fino al I secolo doPoCristo. L ampiezza del territorio dellaRepubblica dei Liguri fu comunque in-taccata dalla sottrazione di terreni de-stinati ai coloni, veterani di Cesare, in-sediatisi in Benevento alla sua morte.
I ritrovamenti archeologici copronouna estensione piuttosto estesa intomoal s i to d i Macchia ( local i tà d is lan le c i r -ca 5 km dal sito attuale di Circello) iden-tifìcabile come il centro, la "city " del-
2ó IA PROVINCIA SANNITA
I'insediamento di età antica, con infra-strutture pubbliche tipiche per una cittàromrnr imper ia le; re te s l r i ìd f , le . foro.terme, insule etc., tutte prodighe dt re-per l i . come r isu l ta to dal le succe\s ive.anche se parziali, campagne di scavo at-tuate negli anni '80. In numerosi altrisiti si sono ritrovate tracce evidenti del-l r presenza umana d i e tà imper ia le. so-prattutto di tipo epigrafìco, fino al IIIsecolo
La ricchezza e la munificenza degliaristocratici cittadini, attivata per vo-lontà dell' imperatore Traiano, nel 101d.C., è documentata dalla Tavola Ali-mentare. Si tratta di un prezioso docu-mento bronzeo, utile per ricostruire lavita agricola ed economica delÌa città,in quanto è l'elencazione dei proprieta-ri tenieri che erano vincolati, grazie adun prestito imperiale, ad assicurare, conil ricavato degli interessi delle renditedei loro fondi, il sostentamento ai bam-bin i porer i de l la c i t là . La tabula è la p i i tantica tra le due rinvenute in ltalia - l'al-tra si rifedsce a Velleia (PC).
2. La scomparsa della "Res PubLicaLígurum" e I'alîo medioevo
ll riLrovamento di un rniliare della viaMinucia in un sito piuttosto lontano dalcentro di Macchia ha condotto all'ipo-tesi che a quell'epoca la città beblanafosse già in decadenza. Però, la cita-zione di un vescovo Marcus in docu-n.renti del 502, reÌativa alla diocesi diSamnium, identificabile con qualcheprobabilità proprio con la città deiLiguri, attesterebbe ancora una vitalitàcittadina nell'Alto Medioevo.
L abbandono graduale della città deiLiguri favorì il sorgere di altri piccoli
villaggi mrali medievali, olÍe gli attuali,documentati fino al XIV o addirittura alXV secolo. I centri di Casaldianni, For-cellata e Macchia Saracena, oggi scom-parsi, furono ricordati per lungo tempograzie alla persistenza di chiese panoc-chiali. Nel caso di Forcellata e di Casal-dianni i borghi furono Università (no-me del la îmmini \ l raz ione ìocale corr ì -spondente all'attuale Comune) che ces-sarono, verso il XV sec., di essere au-tonome, ricadendo sotto il dominio crr-cellese. Le cause degli abbandoni furo-no molteplici. Giova dcordare che tut-to il comprensorio appenninico, essen-do ad orogenesi recente, fu ed è conti-nuamente scosso da movimenti tellufi-ci. Nel passato, la minore capacità de-gli edifici, principalmente di quell nonmonumentr l i , d i res is lere a l le 'o l lec i tazioni sismiche provocava più ingenti ef-fetti sociali (danni, crolli e quindi sfbl-lati e mofii). Forse, i centri in argo-mento, danneggiati o distrutti dai telTe-moti, non furono più ricostniti. E ìn ar-ni quali quelli turbolenti delle lotte di-nastiche angioino-durazzesche, la mr-nore difendibilità poteva costituire unvalido motivo per consigliarne definiti-vamente 1'abbandono.
Uinsediamento antico probabilmen-te fu completamente distrutto, seguen-do un destino comune a molti centri delSannio, da una aggressione di truppemusulmane, alleate o mercenarie deglistati longobardi (Salerno, Benevento)l i lob iTant in i { Napol i . Caetar campani .perennemente in lotta tra loro per tuttoil IX e il X secolo. Ciò è avvalorato dalpersistere nei toponimi dei dintorni diindicazioni della presenza degli "infe-deli": la vicina Castelpagano è esem-plare, a tal proposito. Ma si è conser-vata memoria anche del toponrmo"Maccla saracenorum", testmoniato del-tr presenza di una panocchiale proprionell'area della città dei Liguri, proba-bilmente distrutta intorno al XV secolo(Rationes Decimarum Italiae, 1308). Ladistruzione cosiddetta saracena invogliòdefinitivamente 1a popolazione, forsegià parzialmente ivi emigrata, a trasfe-rirsi nel borgo attuale di Cúcello. aì pìe'di del castello.
3. L'archítettura: íl castello di Circello3.1 Le ípotesi sul sorgere del borgo an-tico rli Circello e del castello
L abbandono anche del sito cenffalee dell'area degli edifici pubblici dellacittà bebiana a favore dei vicini borghi
Círcello, CdsîeLlo, Palazz.exo Ducale dei Carafa
attualmente esistenti è motivabile ad-ducendo una molteplicità di ragioni con-correnti, successivamente o contempo-raneamente intervenute a causare I'eso-do dall'antico abitato.
Le invasioni de i popol i germanic i .dalla fine del IV secolo d.C., spinserole popolazioni residenti nelle città, so-prattutto di quelle ben collegate dallaviabilità romana, ad abbandonare i sitiìncapaci di garantire (per la posizionenaturale e nonostante le opere afificia-li di difesa) la sicurezza dell'abitato. Ilfenomeno altomedievale dell'incastel-lamento fu comune, perciò, a tuttaI'Italia e fu alla base del sorgere di mol-ti nuovi centri urbani. La città dei Liguri,che sorgeva in un sito naturale decisa-mente non favorevole alla difesa, fu ab-bandonata da una parte della popola-zione che si spostò su alcune delle fre-quenti alture calcaree affroranti dalle ro,tondeggianti cime dell'Appennino, dan-do origine agli attuali Campolattaro,Reino, Circello, Colle Sannita e Castel-pagano.
Nelle regioni in cui erano ubicati in-sediamenti in epoca preistorica e pro-tostorica, sopravvissuti attivi e fre-quentati fino alla conquista romana, sipreferì recuperare la posizione del sitoantico. Usuale, soprattutto nella Cam-pania intema, fu il riaggregarsi sponta-neo, prima in modo episodico ed occa-sionale poi in veste definitiva, in luoghianticamente occupati da arci o da recinîisannitici, sempre di grande preminenzaslralegica e paesaggistica. E anche ciòpotrebbe essere indizio della preesr-stenza sannitica nel sito oggi occupatodal castello.
Nell'alta valle del Tlmmaro, la scom-parsa di una rete strutturata di com-mercia lizzazione dei prodoni ponò. neipiccoli centri e a scala sociale estesa, adeconomie più semplici e a diffirsione lo-caìe. La precarietà degli insediament ifavorì I'incremento della pastorizia se-minomade e riportò in auge i tratturipreistorici e sannitici, resi inutili dalgrande latifondo agricolo romano rm-periale. La magnifica posizione del si-to sui cui sorge il castello di Circello fusfruttata a controllo di un vasto inter-vallo di tratturo (tfilizzato per la tran-sumanza delle greggi e degli ovini) e rncollegamento ottico con altri punti stra-tegici, principalmente con l'altura so-prastante Morcone (anch'essa con arcesannitica di base al castello medievale).
Se la distruzione musulmana della
città bebiana, intomo al IX secolo, fu lacausa originaria del sorgere dell'attua-le Circello, solo la valenza eccezionaledella sua collocazione geografica ne ga-rantì la sopravvivenza. Alcune testimo-nianze scultoree superstiti e I'esistenzanel centro abitalo della chiesa dedicataall'Arcangelo Michele (santo patronoper eccellenza della "Langobardia mi-nor") avvalorano I'ipotesi di una fon-dazione longobarda. Cefamente si trattòdi una fondazione er novo. priva peròdei presupposti ideologici e teorici diuna pianificazione dell'abitato. E ciònon perché ìa cullura longobarda fosseestranea alla ideazione di città intera-mente e razionalmente progettate: val-gano da citazioni esemplari, in propo-
sito, I'intero episodio urbano di Capuae gli interi quartieri, ancora esistenti,nelle altre due capitali Benevento eSalemo.
3.2 L'attuale sîruîtura del castello: de-scrizione
Preliminarmente all'esposizione del-le ipotesi atte a datare le archjtetture esi-stenti e la loro evoluzione storica, è in-dispensabile descriveme lo stato attua-le, rimandando l'analìsi e la valutazio-ne dello stato di conservazione alla se-zione tecnica della relazione.
Nella tradizione linguistica popolarelocale si è sempre indicato invariabil-mente con i termini castello e paTazzoI'intero complesso di edifici di anticopossesso feudale; complesso articolatoe vario per età di fondzzione, destina-zione funzionale, tipologia e tecnologia
Gostelli del Sonnio
costruttiva, nonché per pregio e impor-tanza arch ilel tonica delle costruzioni.Per esigenze di chiarezza è opportunoconcordare le seguenti nomenclature perdistinguere i quattro corpi di fabbricaprincipali: a) il castello-mastio vero eproprio; b) il bastione; c) il palazzo du-cale (con licenza per l'inesatta attribu-zione araldica: storicamente il feudo diCircello non fu mai ducato); d) gli edi-fici affacciati su via Porta di Sopra. Diesse segue la descrizione plano-volu-metdca.
3.2.1 Il castelloE' una struttura classificabile nella
tipologia del castello-mastio. Essa as-solveva alle funzioni di difesa estrcmaoltre che di privilegiata sede della con-servazione delle riserve materiali piùpreziose in caso di pericolo (attrezzragricoU. derrae alimentari etc.l. La pian-ta è un trapezio isoscele pressoché re-golare, con basi di metri 15,00 e 25,00;in asse con Ia base minore, in corr i -spondenza all'unico accesso alla strut-tura, sporge un vano rettangolare di 1,3m x ó m .
L'orientamento della pianta è conl'asse delle basi in ditezione Nord-Nord-Ovest. La struttura in alzato presentauna zoccolatì-ra scaryata compatta, didisuguale altezza per la differente quo-ta di fondazione sui grandi blocchi dicalcare alfiorante, variante ua un mini-mo di 3,5 m ed un massimo di circa 7metri. Sono ben leggibili nella muratu-ra le regolarità dei ricorsi del pietramecalcareo utilizzato in blocchi non per-fettamente squadrati, approssimativa-mente a faccia rettangolare. In corrr-spondenza degli spigoli angolari, i bloc-chi usad sono di regolarità e dimensio-ni maggiori.
Un ponte levatoio, oggi scomparso,impostato a ctca 4 m dal piano di cam-pagna, serviva da accesso all ' internooggi privo di strutture emergenti ed in-vaso dal la macer ie. f l p iano d i ca lpe-stio attuale del mastio è di circa duemetri più elevato rispetto alla quota diimposta del varco d 'accesso: in p i i rpunti, sottoposti di quota, si leggonotracce di imposte delle volte sulle mu-rature esterne.
Quest'ultime, molto dalneggiate daiterremoti di questo secolo, si elevavanomediamente per un'altezza di 8 metridalla soglia del ponte levatoio. Sui dueprospetti obliqui si aprono, sul primo li-vello, tre monofore sul lato verso S-O,
Circello, Castello, Bastione aragonese
TA PROVINCIA SANNITA 27
Costelli del Sonnio
una monofora per lato sulla tolTe-garit-ta d'ingresso; al secondo livello, sullepareti d'ingresso una finestra per lato,su lato S-O tre ampie flnesfte.
3.2.2 Il bastíoneE' posto all 'angolo orientale della
p i a n t a t r a p e z o i d a l e : l a g e o m e t r i a èquella derivante dall'inserzione un an-golo del castello in un quadrilatero qua-si rettangolare (metri 14,3 x lÓ,7),sporgente dal corpo principale rispet-tivamente per 8 e 4 metri circa, e Po-
3.2.4 Glí ambíentí aJfacciatí sL! via Portadi Sopra
A valle del Palazzo ducale, sottopo-sto ad esso di circa una decina di metri,sorge una porta di ingresso al recintodel castello, affiancata da alcuní am-bienti affacciati su via Porta di Sopra,sulla quale, però, non hanno ingresso.Risulta allo stato difficile individuarequali tra i suddetti ambienti losse di per-tinenza diretta del castello. Dell'anticatorre dell'orologio, eretta nel 1882 amargine del giardino del palazzo verso
interventi e sopmttutto alla luce dell'evo-luzione estetica ed architettonica e del-le funzioni strategiche e militari). Alloscopo di fornire una immediata visua-\izzazione di quanto ipotizzato, si af-fianca, alla descrizione delle strutturesupposte esistenti e alle loro destrna-zioni funzionali, una ricostruzione gra-fica (suggestiva) degli edifici.
Le ipotesi addotte sono impostatesull' analisi comparata stilistico-tecno-logica degli edifici del complesso conaltri monumenti, presenti sul teÍitorio,
sizionato in modo asimmetrico(sporgenze varianti îra ll4 e r 314delle dimensioni). L alzato è dicomplessivi 12 metri, di cui i Pri-mi 8 dal suolo, scarpati e rico-perti di blocchi di pietra calcareaperfettamente squadratl, connes-si e conclusi da un redondone to-roidale: nella zoccolatura si apro-no 5 luci (balestriere e canno-rìiere accopprate).
In asse al piano superiore so-no altre cinque aperture simili (an-ch'esse accoppiate). Esse dannoluce ai due camminamenti inter-ni sovrapposti, collegati da unascala, oggi murata; un passetto in-termedio al percorso della scala,alì'atto ostruito dai crolli dellestrutture del castello, collegava ilbastione con il corpo di fabbricaprincipale.
Eccezionale il coronamentoorizzontale soÍetto da mensolo-ni a sezioni di circonferenza, cia-scuno in due blocchi calcarei,conclusi da un elegante riccio.3.2.3 Il Palazzo Ducale
Uedificio, posizionato a Suddel complesso castello-bastione,presenta sul lato verso monte un
, i l
Circello, CasteLlo, Ingresso al mastio
omogenei per vicende storiche eculturali. L indagine archeologi-ca e le fonti d'archivio sono ser-vite a correggere il tiro e a verifi-care Ia validità delle supposizio-ni, consentendo di scartarne al-cune e di migliorarne altre.
3.3.1 La torre longobarda: ipote-sí di;fondazione
Se tra IX e XI secolo fosseroancora persistenti, e in quale for-ma, delle murature megalitichesannitiche è, allo stato, non pro-vato. Sicuramente, però, ancora vifu qualche resto ed esso rappre-sentò il sito ideale ove ubicare unfortilizio. E' raro che in epoca lon-gobarda si costruissero, a guardiadelle città, veri e propri castelli,nel senso di edifici destinati sia aresidenza dei rappresentanti delpotere centrale (gastaldi e conti)che ad ultimi baluardi della dife-sa delle mura stesse dei borghi.
Solo di rado ciò avvenne nellecapitali e nelle città di preponde-rante peso demografico, socio-po-litico e militare: non è sicura-mente plausibile pensare potesseaccadere per piccoli villaggi qua-
solo alzato, mentre a valle prospettanodue alzati, impostati sulle emergenzerocciose naturali. Al piano parzialmen-te interrato, cui si accede da una portaaperta di fronte lo spigolo del bastione,sono oggi 3 ambienti (adibiti a punto diristoro). Il piano "nobile" è suddiviso ln9 ambienti, tutti consolidati e risanati lnun recente interyento di restauro (1990)e da destinarsi a sede del ConsiglioComunale e di attività culturali. In oc-casione dei lavori di restauro alla quo-ta di fondazione degli ambienti dell'in-terrato furono ritrovati mud di orienta-mento, tipologia e posa in opera com-pletamente dilTerente da quelli sopra-stanti.
28 tA PROVINCIA SANNITA
il piccoto cortile su cui apre l'arco diPorta di Sopra, resta solo il basamento.
3.3 Le vicende costruttbe del comples-so dalla fondazione c 1400
Allo stato mancano pubblicaztonrmonografiche sul castello: sole due otre testi generali (in bibliografia) neprendano in considerazione le forme.
Qui si presentano ipotesí originali sul-1e fasi cosftuttive ed è quindi necessa-rio motivame la fondatezza.
Le ipotesi proposte seguono la cre-scita e la vita del complesso dal X alXIX secolo, suddividendone le vicendein 4 intervalli temporali grossomodoomogenei (dspetto alla filosolta degli
le Circello fu.Quindi, solo a rafforzamento della
cortina del borgo, questa sì murata e mu-nita, dové sorgere una primitiva torre diavvistamento e di coordinamento delledi[e'e. posta a guardia del punlo piir na-turalmente esposto al1'attacco perchémeno elevato rispetto al tereno circo-stante. Ad ultimativa giustificazronedell'ipotesi avanzata valga la conside-razione che una forlif,cazione imponentea Circello non avrebbe avuto alcuna va-Ìenza strategica, per la sua posizione co-sì periferica, alf intemo del vasto prin-cipato longobardo di Benevento, estesodal la Val le Teles ina r l Cargano. dal -1'Ofanto al Trigno.
:itiì*ìi
U ipotizzala tone, di non più di unatrentina di metri quadrati di superf,ciecoperta e di una quindicina di altezza,dové collocani nel punto più elevato delroccioso colle, nell'angolo N-E del cor-po principale dell'attuale castello.
3 .3 .2 Il recinto e il mastio normannoCon ragionevole probabilità un ca-
stello, propriamente detto, sorse allor-quando i Normanni del Ducato di Puglia,già padroni di gran pafe del Principatobeneventano, cominciarono ad. avanza-re militamente verso il Tirreno. La re-te tipicamente feudale dell'amministra-zione dei territori, piramidalmente rn-centrata sul vassallaggio reciproco. eI'esigenza di garantirsi sempre il con-trollo delle strade di comunicazione ver-so i possedimenti costieri adriatici, si av-valse anche di piccoli vassalli, suffeu-datari di più potenti baroni. Nel "Ca-talogus Baronum" (1150-68) Circello futrascritto come parte della Contea diCivitate, località della Capitanata in cui,circa un secolo prima, gli Altavilla ave-vano sconfitto iÌ papa Leone IX, obbli-gandolo a riconoscerli signori dei tem-tori conquistati. Con un borgo sicura-mente cresciuto demograficamente, perI'aftlusso di genti dai villaggi contem-poraneamente abbandonati, e quindi piùappetibile ad eventuali assalti, e con unfeudatado residente, il sito rnilitare dovéessere ampliato.
Le evidenze superstiti ponano ad ipo-tlzzxe un complesso del tipo "castelloa recinto sommitale con mastio isolato",configurato come descrino nel seguito.A difesa del colle, accessibile con faci-lità solo dal versante occupato dal bor-go, si innalzò una cortina muraria mu-nita, con camminamenti scoperti che, se-guendo le curve di livello ed appog-giandosi alle formazioni rocciose natu-rali, lo racchiudeva completamente.Questo primitivo recinto, perimetrabileinglobando l'attuale palazzo ducale e rlocali delle stalle, sotto la rampa d'ac-cesso al ponte levatoio, fu rafforzato rnalmeno 6 punti da torri, elementi indi-spensabili a realizzare una cinta inespu-gnabile. secondo le consuetudini teori-che dell'arte militare medìevale. L'ac-cesso avveniva in conispondenza di unvarco- atftaversato da un sentiero. oggita il palazzo e rl giardino, ottimamentedifendibile perché raggiungibile solo do-po un percorso contìnuamente guardatoe coperto balisticamente dalle mura delcastello. La murazione rinvenuta in fon-
dazione al di sotto del palazzo ducale,per orientamento e tipologia simile aquella del mastio, lascia suppone si trat-ti di uno dei resti oggi visibile di tale pe-rimetrazione difensiva, gli altri essendosrati inglobati nelle pareti della rimessaa N-N-O del mastio. La cinta, seguendole balze rocciose, giungeva fino all'at-tuale spiazzo antistante il bastione, chiu-dendolo completamente. Lo spazio li-bero, che lo isolava dalle ultime case delborgo (all'epoca esteso solo fino a vraPorta di Sopra), consentiva sia la possr-b i l i tà d i avv is tare per tempo i l nemicoaggressore sia di evitare che egli potes-se avvalersi degli edifici quali supportoper 1'assalto. Isolato a sua volta dallacortina di mura esterne sorgeva il ca-stello, in funzione di mastio, grandequanto I'intera sommità dell'altura, co-sì da sfruttare in fondazione le erte roc-ciose sottostanti. La tipologia adottataper I'insediamento fu quasi sicuramen-te. queìJa ancora oggi conservam: un uni-co blocco quadrilatero di altezza unifor-me, con, al più, due torretle, una in cor-rispondenza del vano del ponte levatoio{ indispensabile per controllarne l'azio-ne) e una nell'angolo N-E', rialzando orifacendo l'antica torre longobarda. Lastruttura dové essere a 2 piani in eleva-zione, con alcuni vani sottoposti, scava-ti nella roccia, e copertura piana, op-portunamente lasciata come disimpegnoper le due torette emergenti e i cammr-namenti di guardia.
Riguardo l 'es is tenza d i una cone in-tema al castello-mastio si resta nel cam-po delle illazioni prive, finora, di docu-menti probanti. Nella direzione di unapianta con corte interna conducono di-versi elementi: la difficoltà di coprire la
Gostelli del Sonnio
grande luce delle mura anche se con vol-te affiancate; la necessità di competen-ze ingegneristiche improbabili per unluogo periferico del Regno: l ' impossi-bilità di utilizzare la superficie di cal-pestio per operazioni militari qualora lasi fosse copefia con falde spioventi; lafavorevole e più razionale disposizionedegli ambienti, disimpegnaú su uno spa-zio apefio, probabilmente asimmetricoe accostato al lato N-E del perimetro. Afavore di un volume integralmente"chiuso" depongono: l 'accer tata es i -stenza storica, ìn tempi recenti (almenodal sec. XVI al 1811) di una coperturaa doppia falda; una maggiore economranella realizzazione. a parità di materia-li, avendo più spazi chiusi firibili; la ti-pologia consueta del mastio feudale nor-manno, rnteramente coperto (ma sr so-lito con tetto piano praricabile).
Forse, già nel corso del Trecento, dal-la presa di possesso da parte della fa-mig l ia Sci l la to. s i dovet tero u l ter ior -mente rafforzare le difese munendo lacortina edilizia su via Porta di Sopra,anche qui con mura ad alzato verlicaleuniforme, interrotte al più da due o tretoffi. I1 completamento del sistema di-fensivo, con il raccordo anche delle mu-ra esteme del borgo, si ebbe fbrse quan-do Circello pervenne ai della Leonessa.
3.4 Il Quatîrocenîo: il mastio, le murae la palnzzina ducale
Nel 1457 i Carafa presero possessodel feudo di Circello. Agli interventi daloro commissionati devono farsi risali-re le prime modifiche destinate a tra-sformare il castello in residenza signo-rile. I lavori ordinati furono motivati daragioni stilistiche ed estetiche (il gusto
Circello, Castello, mastío, prospefio sud
IA PROVINCIA SANNITA 29
Gostelli del Sonnio
mutava dal tardogotico al rinascimen-to) oltre che da ragioni di prestigio e diretor ica aulocelebraz ione del propr iopotere: assai probrbilmente però l'urono sicuramente imposti dalle necessitàstatiche (i danni causati del terremotodel 1456 e dalla sua replica del 14ó6).
Gli inten/enti in discussione nei para-graf i successi r i (scagl ionr l i in p iù [a ' i randrebbero ascritti al periodo tra il 1458e il 1528, legandoli alla presenza deiCarafa, potenti feudattLri del Regno. Seper le n.rodifiche del màstio e degli edi-iici di via Porta di Sopra si può con buo-na probabilità ipotizzarc :una datazloneagli anni immediatamente successivi aì-Ia presa di possesso (1460-70), per Ia pa-lazzina ducale potrebbe essersi trattatodi intervenri databìli ull 'ulÙmo decenniodel secolo o, addirittura, ai prir.r.ri arni del500. Sicuramente prima del 1496 luro-no abbattute le corline verso il pianoro anord-est per realizzaÉ il più impofiantedegli edihci superstiti, l'eccezionaìe ba-stione rinascimentale.
.\.4.1 Le norlilche ul ma.srio e alltt rirt 'ta muraria esternT su Yíq Porta díSopra
L occnsione dei restluri posl \ismi-ci 1i propizia per apdre ftnestre archi-travate e mensolate in sostituzione del-le strette feritoie del mastio medievale.Le nuove aperture, assolutamenteconformi agl i s tereot ip i napoletanì . po idifTusi anche nell'architettura popolarein tuua la va\ la area t ra Camprni r eMolise colpila dri terremolì di melà \ecolo XV diedero luce e aria agìi am-bient i in tern i . f ina lmente res i p ìù co-modi e salubri.
Anche Ia recondl c in ta fu t ras lbr-matr . prendendo l 'a 'pet to d i una quin-ta urbana. In particolare, è attfibuibilea tale epoca 1a configurazione dell'at-tuale ingresso su via Porta di Sopra.I n t a I i , l ' e d i l i c i o i m m e d i a t a m e n t e a l ' -f ianco del la por la . rnch es\o d i per l inenzl ducale. ha ancora oggì chiare er ì-denze tipologiche e struttunli (finestre,mensoloni a sostegno di uno spofio li-gneo scomparso) di inequivocabile ri-fer imento a l ì inguaggio archi te t ton icocivile della seconda metà del '400. D'al-tra parte, anche in questo caso, lo stem-ma congiunlo del le c lse Carala-Leonessa, pertinente a Carlo Carafa, ma-rito di Eleonora della Leonessa, collo-cato sullo spigolo esterno fbrmatoda1l'edificio, è a conforlo della validitàdelÌ'ipotesi di datazione.
30 IA PROVINCIA SANNITA
3.4.2 La palazzina ducaleNell'ottica di trasfotmare tutto il
complesso a fini residenziali dovetteessere deciso l' abbattimento parzialedella cinta murada più interna e del relativi sbararnenti, incamerandone e tra-sformandone una gran parte nelÌa nuo-va fabbrica della palazzina ducale. Lapalazzina, edificata su una pianta gros-somodo rettangolare, ha due aliall 'estremità, una delle quali, quella aN appena accennata, a delimitare unacofe rpet1a. L'inlerno. composto di sl-le regolari, presumibilmente conservò1a distribuzione originaria degli am-bienti, salvo le tramezzature apposte
3.5 ll Quotlrocento: iL bastione rina-,\cimenîale
E' senza dubbio 1'opera archítettom-ca più interessante tra quelle superstitrde l complerso. unica per I l t ipo logia eper alcuni particolari della realizzazto-ne. La sua erezione, pianificata rapida-mente sotto la spinta degli eventi, testi-monia in modo eccellente I'evoluzlonedell'arte militare aI 1496. Lt data ante
4aen è frssata in virtù di una battaglia.In giorno di venerdì, 3 giugno 1496 "laterra di Circello fu infelicemente com-battutta dài francesi; perciocché CunilloVitelli lideatore degli archibugeri a ca-vallo, n.d.r.l, mentre i guasconi anda-vano molto Ìenti e pigri a dar I'assalto[...], fatto con esso lui smontare moltida cavallo, toppo arditamente passò sot-to le mura, ricevuto un gran colPo disasso su I'elnetto si fu morto". Cosìscrisse Paolo Giovio nella "Histoliarulsui temporis", Firenze 1550-57 dellabatîaglia combattuta a Circello traArrgonesi rcu ierrno l l le l t i i Venezìanicomandati da Giovanni Sforza di Pesaroe Francesco Gonzaga di Mantova) eCarlo VIII di Francia (al soldo del qua-le mercenari svizzeri, tedeschi e truppedi ventura dei principi Orsini e deiVitelli erano sotto il comando dìGilberto di Borbone, viceré per il sovrano ftancese nel regno di Napoli). Ilfatto d'arme di Cilcello è uno dei tantiche funestò il Regno napoletano nei dueanni successivi all ' invasione di CarloVIII, fino alla rcsa completa tlelle for-ze filofìancesi. Il fatto poi che, dopol'episodio d'armi, Circello sia riprombata nella pirì assoluta provincialità sto-rica e feudale, ne ha garantito uno sta-to di conservazione eccezionale per I'as-senza di intervenú successivi. Il che ren-de l 'ep isod iu s t raord inrr i rmenle im-pofiante per la glande coerenza e la ra-rità di testimonianze coeve così altret-tanto ben conservate. L ipotesi di attri-buzione proposta fa riferimento alla pre-senza nel Regno del grande Francescodi Ciorg io Mart in i t S iena. 1439 - iv i .1526): la "gravità" dell'affermazione èsupportata dalle seguenti osservaztont.
3.5.1. Le fortificazioni nel RegnoIl Regno aragonese, conquistato da
Alfonso I rcl 1442, fu per tutta la suadurata finestato da successivi attacchipolitico-dinastici esterni sempre ap-poggiati da turbolenze baronali inteme:basti ricortlare il lentativo di riconquista di Giovanni d'Angiò, le due rivolte
/ - t \ . -, ' iú
Ò.i
Pianta di Círcello
alla fine dell'Ottocento. Le finestre, an-cora in gran pafie originali su tutti pro-spet t i . sono re l tangolar i . con orn ie inpietra calcarea grigia in evidente con-trasto con il bianco delf intonaco. Sullafacciata principale, quella verso il ma-stio, è collocato il portale affiancato dauna coppia di finestre per lato, stm-metriche. A parte le evidenze stiÌisti-che e volumetriche, sono ancora con-servati, nello spazio tra due tlnestre,fregio con l'arma dei Carafa, attestan-ti, senza alcun dubbio, la committen-za. Nel suo complesso la palazzina du-cale è una dimostrazione del sensibilemutamento del gusto verso le influen-ze rinascimentali toscane, di cui pro-prio i Carafa a Napoli furono tra i prin-cipali fautori (tl palazzo Carafa diMontorio in via S. Biagio dei Libra ela annessa collezione d'arte di DiomedeCarr fa iv i conservr ta erano celebr i intutta Italia).
baronali, la coalizione antifiorentina del1478, il saccheggio turco di Otranto etc.Ciò costrinse i sovrani, tutti rinomaticondottieri, ad aggiornare a più ripresegli armamenti delle truppe e le munr-zioni delle fortezze. Fino al 1480 talidnnovamenti dovettero essere opera dimaestranze locali, influenzate dagh ar-tefici reali di provenienza principalmentecatalana, delle quali non si è conserva-to il nome. Dal 1480 in avanti gli inter-venti cominciarono a seguire le nascentiteorie rinascimentali pubblicate dai Íat-
visitò le più imporranti fortificazioni pu-gliesi per circa re mesì. Un nuovo viag-gio. con una permanenza compJessivadi altri cinque mesi, awenne I'arìno suc-cessivo, il '92. Impossibilitato ad al-lontanarsi da Siena, ove era impegnatoin lavori all'acquedotto, Francesco stes-so consigliò ad Alfonso, nel febbratodel '94, di avvalersi dell'opera di An-tonio Marchesi da Settignano, suo di-scepolo, e di Baccio Pontelli (giovanema già celebre architetto fiorentino).Pontelli, autore della rocca di Ostia per
Qstel l i del Sonnio
cesco di Giorgio nel Meridione rimaseper tutto il periodo della riconquista diFerrante II, allontanandosene ad impre-sa compiuta. Il suo geniale interyentodi posa e di brillamento di una mina sot-to Castel Nuovo (in mano alle truppefrancesi in ritirata), grazie allo scavo diuna trincea, fu un successo che gli die-de chiara e def,nitiva fama.
L'attività di Francesco come inge-gnere militare negli anni precedentrl'aveva portato a realizzarc Îorîezze nelDucato di Urbino e nelle Marche pon-
tificie, e a completare la stesuradi un trattato, poi diffusissimo, icui disegni preparatori, anche du-rante le ripetute assenze dalRegno, firono affidati ad Anto-nello da Capua e fra' Giocondoda Verona, artisti entrambi attiviin Napoli (anche come ingegne-ri militari). Si è certi, quindi, chele innovative idee sul costruirefortezze fossero ben note e cir-coÌanti in ambito napoletano e re-gnicolo, tanto da divenìre di co-noscenza diffusa.
Per edificare la fbrtezza "idea-le" il trattato prevedeva le se-guenti regole:
1) "che in esse sia un pozzo ocistema sufnciente almeno per ilvitto ad alÍe opere occorrenti, si-tuato nel maschio, ovvero stan-za del castellano, sicché volendopossa torla agli altri, e a lui nonpossa dagli altri esser tolta: e deb-ba aver canali per i quali allestanze dei soldati possa mandar-
2) "che nella rocca sia un pri-
tatisti, manifestando concezionicomuni a tutta I'architettura ita-liana coeva, con i consueti adat-tamenti ai locali "dialetti" stili-stici meridionali, per la scelta deimateriali, la loro posa in opera ei paticolari decorativi.
3.5.2. L'opera di Francesco diGiorgío Martini
Fondamentale, in proposito, fuI'opera diretta e la divulgazionedelle idee di Francesco di GiorgioMartini. Operoso come scultore,pittore, architetto e ingegnere ci-vile, fu soprattutto famoso per lasua attività di teorico e progetti-sîa di fortezze militari, originaliper I'impianto e per l'aggiorna-mento alle nuove offese.Francesco di Giorgio entrò incontatto con gli Aragonesi già nel1479, allorquando fu mandatodalla Repubblica di Siena al ser-vizio di Alfonso II (allora ducadi Calabria, presente in Toscanacon le sue truppe in funzione dialleato dei senesi contro i fioren-tini). Alfonso seppe apprezzarne
Il ì
le doti di ingegnere militare tanto da in-vitarlo a visitare il Regno dopo i fatti diOtranto (città orrendamente saccheg-giata dai Turchi nel 1480 e da essi pos-seduta per un anno) : non s i è però ìnpossesso di documenti attestanti l 'ef-fettivo intervento in loco di Francesco.
D'altra pafe, a pianificare i soggior-ni esteri dell'artista senese (costante-mente con incarichi pubblici in patria)furono spesso le necessità politiche ediplomaúche della Repubblica di Siena.di cui egli, celatamente, fu uno degliinformatori più attenti. Nel '91, Siena,preoccupata per il crescere delle mirefrancesi, appoggiate dai fiorentini,sull'Italia, concesse al suo architetto unpermesso per recarsi in Napoli. Qui, alseguito di Alfonso. Francesco di Cìorgio
Giulio della Rovere (all 'epoca dellacommittenza ancora cardinale ma tnquel momento già papa con il nome diGiulio II e ostile alla casa aragonese),fu dopo poco licenziato perché sospet-tato di passare notizie dservate all'este-ro (in particolare al papa). Marchesi,quìndi, divenne l'artefice principale delRegno e, probabilmente, I'attuatore deidisegni, o comunque, delle idee del mae-stro.
Francesco di Giorgio, sempre pres-santemente sollecitato dagli Aragona,fu nuovamente inviato a Napoli, forsegià nel settembre del '94 (le cedole dipagamento ne accerlano la presenza so-lo dopo qualche mese, ai primi del '95),
appena la Repubblica senese sembròcerta della spedizione francese. Fran-
stino per macinare, e le macinel-le per la polvere da bombarda";
3) "un forno per molte cose occor-renti, oltre al cuocere del pane";
4) "che abbia il soccorso sicuro stc-ché senza grande difficoltà possa esse-re tolto.. .";
5) "che la tone principale del castel-lo sia la più forte ed eminente delle al-tre, e che possa tutto il resto della for-tezza offendere senza essere offeso: sic-ché il castellano sia degli altri signore":
6) "che nella stessa fortezza, più tor-ri principali per più castellani si faces-sero, allora l'entrate ed i soccorsi deb-bano in tal modo essere ordinati, cheI'un castellano senza la volontà dell'aÌ-tro non possa trarre o mettere alcunonella rocca";
7; "che la forlezza sia di minore cir-
jJ i- - :*{ -:,*.1î-ir: *l-,7 ' : s ^ > ' -
It-'r's-':- ' lr - l -. t
Circello, Caste o, Bastione araqonese, Saettera e cannonierú
tA PROVINCIA SANNITA g I
Costelli del Sonnio
conferenza che è possìbile, salva la de-bita proporzione";
8) "che le mura del circuito siano al-te per sé ma in basso loco situate, scar-pate i due terzi delì'altezza, con becca-te l l ì o muto l i , e f ra l 'uno e l 'a l l ro : ianoi piombatori";
9) "che le tolri siano applicate allemura per sé, o con ale di muri angula-t i . de l l 'a l tezza deì le mura. of f -ese perfianco";
l0 t "che innanzi a l la por ta s ia un r i -vellino, fatto in alcuna delle forme chedi sotto per il disegno mostrerò";
ma condizione: cioè che i torrioni sia-no tondi e i muri angolari";
17) "che le estremità degli angolì sìrolgano dove può essere la lbflezza piùroffesa dalle bombarde, acciò siano lemura fuggitive delle percosse sue";
18) "che i torrioni siano postai negliangoli congiungenti le linee, acciocchél'una e I'alÍa delle due linee per quel-li possa essere offesa: e similmente l'untorrione dall'altro";
l9) "(che è molto da considerare),che la rocca abbia facile uscita, in mo-do che diftìcile sia agl'inimici proibire
se le mura e terapienarle, laddove pos-s ib i le . fosse quasi sconta la tanto da r i -chiamarla appena, perché già entratanell'uso corrente del costruire. Espli-citamente, Francesco afferma, in un al-tro passo, che "i muri aìquanto più re-sistino lperché grossil nientedimeno rnqualche poco di tempo più che il con-sueto infine sono battuti per terra".Scopo dell'edificare conetto non sonoquindi la dimensione e la grandezza,bensì il disegno ossia la capacità di go-vernare le proporzioni e la simmetria.In pratica, la qualità più che la quantità.
3.5.3 Il bastíone di Circello:ip ote s i di atî r íbuzíon e
Da quanto riportato, la rea-lizzazione di Circello risultaesemplare: per quanto si sia tfat-tato di una fortezza non co-struita e.{ ,?0v, ma solo modifi-cata ed aggiornata, con pocotempo e con mezzi economicilimitati, rispetta in pieno i pre-cetti allora in voga. Ciò inducea datare la costruzione proprìoagli anni della presenza diFrancesco di Giorgio Martininel Meridione tra il 1480 e iÌ1496. E' infatti opinione con-solidata nella gran parte deglistudiosi che "se non è possibile escludere che Francesco siastato sollecitato ad occuparsidelle difese del Regno in dataanteriore a quella del suo primoviaggio nel Sud 11491ì, è certoche le situazioni per ìe quali ilsuo consiglio era tanto insi-stentemente richiesto si presen-tavano così complesse da esi-gere la sua permanenza sui luo-ghi per il tempo necessario edil suo ritorno ad intervalli nontroppo lontani tra loro, sia per
I 1) "che abbia lati e profon-di fossi, con alti ed estesi cigli,non verso la fortezza, ma unifor-memente difformi acciocchédalla fonezza ciascuno possa es-sere veduto e offeso"l
l2) "che le entrate siano re-verse con le vie copefie";
l3) "che le offese siano pro-pinque";
14) "le abitazioni della fami-glia siano nel circuito debil-mente edificate in loco che dal-la principal tone faciLnente pos-sano essere desolate";
15) "E' stata dagli antichi ap-provata la rotondità delle torri edei circuiti de' muri, la quale ioconfermo essere convenientis-sima alle torri perché pirì resi-ste e meno riceve ogni impeto:ma alle mura grandemente quel-la biasimo, perché volendo es-se fortificare di torri, sicchéI'una potesse guardar I'alÍa, sa-ria necessario farle propinquis-sime; dove ne segue grandissi-ma spesa. Un'altra incomoditàne segue, che le custodie facen-dosi fuori de' propugnacoli, ov-vero merli, non possono vederese non quasi perpendicolare: eperò avendo fia me esaminato il controllo delle opere che era-
quale figura alle mura fosse più utile,ho concluso nei circuiti la forma delrombo e del romboido essere delle al-tre pìù perf-etta. Appresso a questo,l'equilatero equìcrureo e il diversilate-ro: similmente il quadrangolo, ancoral'ortogonio, pentagono, esagono ed al-tre regolari figure";
16) "E' da sapere che quanto è la for-tezza di maggior circuito, tanto più an-goli ricerca la sua forma, ma tutte ln-differentemente, secondo che per il si-to e la proporzione del sito si possanomettere in uso. E questa è la sestadeci-
32 LA PROVINCIA SANNITA
che quelli di dentro, volendo, non esca-no sicuramente fuori dal circuito"'
20r-ed u l l ima. la quale s i estende so-pra tutti gli edifici sopra terra) è che lemura siano fatte sopra i fondamenti...".
Le regole sopra enunciate, unite alprecetto per cui la sicurezza della roc-ca si deve ad un "asperrimo monte ele-vato o perpendicolare, intomo espedi-to, dove la natura più presto che I'aÍesi debba laurare", costituiscono il det-tato principale deÌl'arte di Francescosul l ed i f ìcare lor tezze. E 'degno d i no-ta che la raccomandazione di tener gros-
no state iniziate, sia per l'esame dei nuo-vi problemi... Si può essere certi che aNapoli, in Abruzzo, Puglia, Calabriafunico luogo in cui i lavod documenta-ti sono identificabili con sicurezzal edaltrove egli abbia avuto tutto il tempoper suggerire e delineare assai più ope-re di quante poi le pratiche circostanzenon abbiano consentito di rea\zzare"(R. Pane. op. c i t . ro l . I [ . p . 227 e segg) .
Pur non ritrovando tra i disegni erra-dci e quellì dei manoscritti delle diver-se redazioni del trattato di architetturamilitare alcuna fortezza riconoscibile
I
ÈÉE ffi
Ecco dov'è Circello
Ía quelle esistenti nel Regno, non è dif-
ficile immaginare che i consigli, so-pra l lu t to per lavor i così urgent i e tm-ponanri. siano stati dil 'fusi e frequenti:e che ad altri artefici e ad altre mae-stranze fosse poi affidata Ia progetta-zione concreta e la realizzazrone'Ricordiamo, in proposito, che Francescodi Giorgio fornì i disegni, dopo un bre-
ve sopralluogo, per il Castello Orsini di
Bracciano. opera cui egli non panecipoaffatto nella fase di realizzazione. Si
consideri altresì che nel cedolario dellatesoreria aragonese risultano pagamen-li in data IZl5193 all'ebanista Vincenzode Cordona "pe' modelli che fa per le
fortezze del regno".Ciò valga a limitare definitivamente
la costrxzione del bastione circellese tragli anni 1491 e 1495.
All'atto della battaglia di Circello, il
bastione, sicuramente completato e at-
torniato da opere accessorie (quali fos-
sato e difese mobili), fu indispensabilealla salvezza del castello e del borgoLe fonti documentarie [in FG. Miele:"L evento delle cose"] riportano la cro-
naca diretta o indiretta dei fatti d'ameaccaduti, conferrnando che, nonostanteil bombardamento seguito da un assal-to ordinato e pianificato, Circello non
cadde in mano francese.Per quanto esposto, appare evidente la
fondamentale valenza culturale delleemergenze supentiti e non solo in un con-testo locale e paÍicolare, ma per una s1n-golare occasione di lettura di un episodiounico, splendidamente conservato di ar-
chitettura militare, stratificato nel corsodei secoli. Si consideri, infatti, che a dif-ferenza di tutte le altre fabbriche milita-ri coeve, documentate nel Regno e al di
fuori di esso, il castello di Circello nonpresenta come bastioni le consuete tomangolari cilindriche su basi troncoconi-ché, tipologicamente poi abbandonatenell'ane di coslrui.re [onez/e. bensi una
rarissima úpologia quadrangolare che henpuò considerarsi I'antenata dei baluardirinascimentali a punta di lancia' adottatidagli anni 1530-40 nel Meridione.
3.6 L'uso abitativo dei Di Somma: dal1528 al 1950
Negli anni irnmediatamente succes-sivi aú'assedio francese di Circello, i
Carafa forse non ebbero il tempo di pen-
sare ad effettuare modifiche sostanzta-li, alche per il mutare continuo della si-
tuazione politica generale del RegnoD'altra parte appena nel 1528 Giovan
Vincenzo Carafa fu privato dei feudi equindi anche di Circello ln un docu-mento risalente proprio all'apprezzo dei
beni del Carafa il complesso viene de-scritto come con "castello non multo ac-conczio con pochissime stanze". Con
I'arrivo dei Di Somma (1528), il mastiodovette essere definitivamente adibito apalazzo resídenziale, realizzando un vo-lume sostanzialmente compatto' com-pletamente coperto a padiglione. Si af-frontarono anche i restauri della parte
sommita le del bast ione. i l corn ic ione.probabi lmente danneggiato dai bom-'bardamenti
del t49Ó. A lali interventi'aggiornati alle istanze stilistiche rina-scimentali, di ispirazione toscanegglan-te, si possono far risalire le splendidemensole calcaree. Lo stato e la consl-stenza del complesso risulta bene dal
documento di concessione di Carlo V
\èt
i
ai Di Somma attestante l'investitura del
feudo: "... constaî cum castris seufor'tellicis domíbus palacíis ediftciís et lo-tiis aliis ín eisden csislc tibus. .." /con-
sta di fortezze ossia case, palazzi' edi-
fici fortificati ed altri luoghi in esso esr
stenn).A tali lavori (1528) fa riferimento,
indirettamente, la lapide, posizionatasull' accesso principale alla palazzrnaducale, iscritta nel 1628: "ANNoMDCXXVIII i NICOLAUS MARIA DESUMA MENIBUS TURRIBUSQ MUNI.VIT / NICOLAUS ET ALTER COLLÈSISPÚCEPS CIRCELLI MACH / CENTUMPOST ANNIS EXORNTAVIT ET
AUXIT", così tradotta: Anno 1628'Nicola Maria di Somma munì di murae torri; poi altro Nicola, Principe del
Colle, Marchese di Circello, dopo cen-
to anni omava ed ingrandiva".
Costelli del Sonnio
D'altra parte i Marchesi di Circello,poi anche Principi del Colle, risiedette-ro solo occasionaLmente e per brevl sog-giorni in Circello, lasciando al loroàgente feudale la cura dei beni agrico-Ii, la riscossione delle gabelle e dei da-
zi feudali e la gestione degli edifici; e
al giustiziere la amministrazione dellagiustizia civile e penale (la Camera mar-chesale era competente per pnmo gra-
do e per I'appello). Quindi è giustifica-bile l 'azione di restauro a di5lanza cosigrande di cento anni
Nel 1718 morì Domenico Maria Di
Somma, Iasciando erede lestamentaria'tutrice e curatrice degli interessi del fl-glio, Vincenzo Maria, sua moglie, laprincipessa Errica Ruffo.
Ellà. preoccupata di ben gesúre il pa-
trimonio del figlio e di garantirgli la
completa conservazione dell'asse ere-
ditario, forse da pretese di terzi, curò di-
versi successivi inventarí di tutti i beni,
feudali e burgensatici, mobili e immo-bili, esistenti nei feudi (Circello, Colle
etc.), in SoÍurn e in Napoli. ln quelì'oc-
casione, in una data sconosciuta un cer-
to Gio. d'Angelo Palmieri compilò un
inventario (ASN, Archivi Privati: Di
Somma del Colle, fasc. 5) alche, ed ec-
cezionalmente, dei beni di Circello, al-
trove ignorati perché ritenuti beni feu-
dati e quindi inalienabili da terzi salvo
dal sovrano stesso.Grazie a questo "inventado di tutti
eli mobili che Paggi si ricordano nelÉalazzo principale di Circello", databi-le t ra i l l7 l8 e i l 1740. possiamo r ico-
struire l'anicolazione interna degli spa
zi e, di conseguenza. ipotizzare. per via
documentaria, lo stato dei luoghi. Ciò è
di fondamentale importanza soprattul-to per i t mast io medievale. oggi con-sewato allo stato di rudere. Gli ambientiindicad lper ubicare la enumerazione e
la descrizione dei mobili e delle sup-pellettíli) sono i seguenti e risultano co-
si raggruPPau:a) nel "piano del cortile": camera, ca-
mera appresso, camera. .. vicino la stal-
la, camera... detta la segretana, stanza
sotteranea detto il gallinaio, magazzno;b) nel "quarto sup.[eriore] Opp.[id]o":
Corpo di Guardia, Cucina vicino alle
catceri, camela attaccata alla cucrna' ca-
mera detta il Tinello, camera appressodi parte sinistra, camera a man destra,carceri, camera che hà l' ingresso del
como di guardia, mezzanino av.[an]ti ilg,rardaroúba guardarobba, sala, riposto'Cappella;
":\
Pianta dí Circel[o
LA PROVINCIA SANNITA 33
Costelli del Sonnio
c) nel "quarto nuovo": Pfri]maCamer l ,2a Camera. Ja Camera. ant t -cameta, camera dell'alcova, camera ap-presso la stanzr delì'alcuova. camerinoper uso tener oglio. camera che corri-Àponde all'alcuovo, uno spazio di dettaCamera, camera ;n ler iore che corr i -sponde alla sala, dispensa di sopra, duesoppigni, Cucina sotto il descritto quar-to, passetto prima d'entrare nella di-spensa grande, dispensa grande, came-
de sala, probabilmente destinata allaCamera della giustizia, un guardaroba(per gli abiti cerimoniali), la cappella eun riposto gli arredi accessori della cap-pella. La presenza di un luogo di cultoè tutt'altró che insolita nei palazzi feu-dali. Qui sorprende il fatto che' pur es-sendo allestita con un certo decoro (vt
sono lapidi, quadri e arredi che ì'in-ventario fa intuire di un certo valore)non risulta mai nelle visite pastorali che
tolato a S. Maria del Carmine sito den-tro il Castello di detta tena ldi Circello]e per i l quale r ien r ich iesta la decima.
Quindi la cappella doveva essere dedi-cata alla Madonna del Canr.rine.
Alle carceri, scavate nel calcare na-turale di fondazione che affiora versoN-E, si accedeva probabilmente attra-verso una botola. Forse vi era anche uncollegamento con i conidoi casamatta-d del bastione rinascimentale, creato at-
ra sotto I'alcuovo, camerinofuori 1a camera dell'alcuovo;
d) nel "casino del giardi-no".
Uorganizzazione dell' in-ventario, affi dabile sebbenecompilato "a memoria" daipaggi, è strutturata PaÌese-mente su un percorso che,partendo dagli ambienti af-facciati su via Porta di SoPrae nello spazio sotto la scaladel mastio, ("al Piano del cor-tile"), prosegue attlaverso ilmastio ("quarto superlore oP-pido") e il palazzo ducale("quarto nuovo"); il casino delgiardino indicato Per ultimonon è stato possibile identifi-carlo con alcuna struttura og-gi esistente, neanche in rude-re; si potrebbe Pensare ad unpiccolo edificio di Piacere rea-lizzato forse in legno.
Il Palazzo ducale risultava,a quell'epoca comPosto: da 7ambienti princiPali e 2 di ser-vizio (con due minuscoli va-ni accessori adibiti a deposi-to "dell'oglio" e delle "giaree vasi di porcellana" (!) all'ín-terno della camera aPpressoall'alcova) al Piano "nobile";da cucina, dispensa e altri am-bienti usati come dePosito al
traverso le antiche mura me-dievali. Tale ipotesi è avvalo-rata da racconti PoPolari rac-colti riguardo l'esistenza divani oltre il camminamentodel primo livello del bastione,proprio in direzione del ma-stio. Altra prova documenta-ria awalorante I'iPotesi ded-va da un documento del 1811emanato del neonato Comunedi Circello. In esso, oltre a di-chiarare abolite le consuetu-dini "abusive" medievalidetl'ex-feudatario Di Sonìma,denunciandone le esose Pre-tese (in un fremito di demo-cratica adesíone, ricco di sfu-mature socìali e umanitarie,alle istanze rivoluzionarie re-pubblicane importate col co-dice napoleonico), si dichia-ra, al punto 9, "che il PrinciPeteneva le carceri nel ProPriocastello, luogo onido ed inac-cessibile, non pernettendovil'accesso a' congiunti de' Po-veri carcerati per Portar loroqualche soccorso o Pure slsoggettavano a mille strapaz-zi" .
Un libro di apprezzo deibeni immobili (teÍeni colti-vati, boschi, molini, case etc.)datato 1811, dell'ArchivioPrivato Di Somma, consetva
piano inferiore: 2 "iuPPigni ' -
ò"cupuno il sottotetto. Nel palazzo rt-sultano così concentrate le funzionr re-s idenzia l i pr ivate del la [amig l ia pr inc i -pesca.
II mastio, completamente coperto'ospitava due livelli. Al primo erano ubi-care le funz ioni d i serv iz io e una cuci -na con tinello (forse per il castellano-giudice); al piano superiore, cui sr ac-cedeva per mezzo di una scala in mu-ratura (probabilmente collocata in pro-
secuzione di quella diretta al bastione),erano gli ambíenti di rappresentanzapubblici per I'attività feudale: una gran-
34 ÌA PROVINCIA SANNITA
gli Arcivescovi di Benevento commls-sionavano, in ottemperanza alle dispo-sizioni del Concilio di Trento, in chie-se, cappelle etc. Ciò forse perché, puressendo consacran, era somrana alJa giu-
risdizione della Curia locale, essendo dipatronato di un famiglia napoletana.D e l l ' e s i s t e n z a i n d i r e t t a d i u n a C a p -pella, nel mastio, si ha notizia grazread un altro documento (ASN, ArchiviPrivati: Di Sornma del Colle, fasc. 61)nel quale si legge, in una controverslacontro l'Università di Circello, datata3110t1732, che es is te un benef ic io in t i -
una riproduzione grafica di come si pre-sentava il complesso a quella data. Il di-segno, acquerellato ed a colori, e contrat t i s t i l is l ic i t ip ic i de l la rest i tu / ionegrafica dell'inizio del '800, non è un ve-ro e proprio rilievo (seppur presente l'in-
dicazione geografica dei punti cardina-[i,; né una vedun t:ono palesemenle rio-
late le regole prospettiche) ma piuttostouna illustrazione schematica di corredoal testo seguente: "Disegno del Pallazzosue Castello, nella Terra di Circello disua Eccellenza Principe ed è fabricatosopra di una grossa Murgia, ed con mol-
I
KC..ec- úcqtqe.
ca;fapÈrù'o5. (rtr*. &\ 5e*r
It<.,"r'e$,*L
6:zrnpE\nro
R xr*." (en..e'''\g8oe. r CdSgr"oA ILd -Cvéf c* 1u-lu (r.<e- & 5Èt$ÒR 5-'lò -e,crf. c,"i'. L tr*sJòhèfcA 5-è 5-è-0id cicr^ FÈx.ùr, l' Fr.èìè 4 qatúr','
A{*.*' (dt€ 1",'-f,c '
f; O.rr:'i lCIcxq-c:oe
Circello: i confini
te abitazioni e poi si endra in dettoPallazzo alla parte di Levante, e mez-zogiorno nel Cortile addove si ritrova-no molte abitazioni con un quafiino perAbbitazione del Sig.re Aggente di ser-vizio di Sua EcceÌlenza Pdncipe, e conMagazzino di tutte scorte di Vittuvaglie,ed altre abitazioni, e poi si endra in derto Pallazzo alla parle di Íamontana, conPonte allevxlora e con Catene di Ferroe cosi Articamente fatto detto Ponte giu-sto per fortezza, e costodia di detto
reni ra ind jcata con sole 3 f inesrre. peraltro in accordo con quanto ancora te-stimoniato dall'attuale stato del pro-spetto S-O). Il mastio risulta ancora co-perto con una volta a padiglione (4 fal-de).
Proprio poco dopo il 1811, per nonessere soggetti al pagamento delle tasseerariali sull'immobile, (grande e ancorain buono stato, ma ritenuto scomodo eobsoleto) i Di Somma decisero di sco-perchiare il mastio, awiando così il ra-
Gostelli del Sonnio
Duca. dovel te sospendere la causa in-tentata. Il documento, onde attestare ilpacifico e antico possesso del castello edelle pertinenze, ne dcostruisce le vr-cende ru l la base d i a l t r i document i , c i -tati analiticamente, in possesso dei DiSomma e quindi esistenti e incontrover-tibili. Tra gli altri viene citato il privile-gio di concessione di Carlo V impera-tore del 1528. Ma è per noi d'interessela notizia di un apprezzo del 1822, re-datto per ordine della Principessa Rrano
Pallazzo ed Artificial-mente così fatto, ed Anti-camente come oggi si ve-de presentemente la suaAntichità, e Magnifi cenzadi detto Castello". Pochepagine oltre, si ritrovaun'altra rappresentazioneleggermente più esempli-ficata sia nei dettagli de-corativi e descrittivi, siaper lo stile grafico dellariproduzione.
Il complesso è visto damezzogiomo, dall'attualevia Roma, su cui è evi-dente la presenza di dueaccessi uno dei quali di-retto alla corte tra laPalazzina Ducale e il ma-stio, il che testimonia I'ab-bandono, forse già conso-lidato da tempo, dell'an-gusto accesso su via Portadi Sopra, relegato a in-gresso secondario; un al-tro portale conduce diret-tamente al giardino, an-cora oggi esistente, al disotto della PalazzinaDucale. Il giardino è com-preso in un altro catastodei beni di famiglia, data-to 1746, commissionato
Sforza, congiunta del decaias, ai fini di un proce-dimento di esproprio. Ilcastello di Circello risul-tava "un palazzo dtuto edinabitabile con piccologiardino e spiazzo adia-cente nella strada Palazzobaronale, ossia Castello edè isolato da tutti i lati. Afianco di detto palazzo viesiste una palazzina consette stanze superiori e dueinferiori di fabbrica col-I'intero loro stato isolato,confinante collo spiazzodeI Palazzo sopra indica-to . . . ". Più olÍe, nella stes-sa fonte, si ripofta un attonotarile del .1827 che rac-coglie la testimonianza di-retta della PrincipessaRiario a conferma di quel-lo già prodotto nel 1822.Lo stesso Duca Nicola, altermine, riassume lo stato, al 1887, dei suoi pos-sedimenti, ricostruendonein parte le vicende stori-che:
"Che l'antica fortezzadi Circello era cinta damura costrutte su di alpe-
dalla Principessa Ruffo, in cui è detto"orto" ed è rappresentato topografica-mente, con l'indicazione delle misure edel le essenze arboree prerent i t "5 p ie-di di noci"). Tornando allr descrizìonedel l8l I, si distinguono chiaramente lapalazzina Ducale (con i suoi due livel-l i e i l roppigno) . i l bast ione r ìnrsc i -mentale (schematicamente rappresenta-t o ) e i d u e l i v e l l i d e l m a s t i o i n c u i s iaprono le finestre. La presenza di quat-tro aperture sul prospetto N-E consen-te di individuare in quella zona la cap-pella descritta nell'inventario del 1700( la sa la. in fani . ne l lo s tesso inventar io .
pidissimo degrado delle strutture orrz-zontali e poi anche dei muri.
Lo stato del complesso e delle perti-nenze, così trasformato, fu descrino inuna comunicazione che il duca NicolaDi Somma (duca ad personam, per li-beralità di Vittorio Emanuele II red'Italia) trasmise nel 1887 al Comunedi Circello, fonte di grande importanzaperché prodotta per una controversia cl-vile di confine e di sicura attendibilitàperche a f i rma del Duca s lesso e. so-prattutto, perché di acclarata veridicità.Il Comune, infatti, non essendo in gra-do di contestare quanto opposto dal
stri rocce ìnaccessibilì co-me ùi osserva dalle pani lufl"a\ ia esislend.e nella parte più elevata dominava il co-sì detto Castello il quale aveva il suo ac-cesso dalla parte intema del paese sotto-posto mediante una scalinata e fiarco del-la quale vi erano delle rocce elevate edalla cima di esse vi erano costrutte le ga-ritte per le guardie di dilesa. come si os-serva presentemente dagli avanzi dei spia-namenti lavorati a puntillo sulle ridetterocce sporgenti. In continuazione di que-sti vi esistono tuttavia i ruderi dell'anti-che mura che lungo I'orlo delle rocce an-davano a terminarc verso la torre che di-fendeva la scalinata ed il ponte levatoio
llGrr{bn--{- \ lNCo,lO lÀRq<>Cq] rc<>
wl i.reuro .t$flÀq,\eo
ffi-l "lìNCcLO JSFrOh eoír{nîo }Jltl*lóD_r o s\rt€tso
ft:c*'o b't îÈAgpl tren o,t Ar€ €Bìa{oÀr6
I {s€s\ u\ È)ó11,1\0 \{oftoE}.BfIT.!o È& .L\ IJvdJJ HìÌÀ
tc&€ €ÈscN€ ÈRh.Jé')îùrA tgir= $!)Nsrc(fi)s€
,€ ÈÈ! aéiRltle*Js S€AJìAÈe€a))SU.$18
6F€F' ù\ €ElA\ClE
I e€A aoi egì\ A REat{o
I rc, sr *krqto ì16m3 f 4a,6aalÈ î€F€ÉL)rfr ù è€Aù\ €R6i1 O
Arscf\to ki t a$\\ {opo rFxriS{rl$$fi b6},ri.r \ ^}oìE(bJ Ètj RAEIÀìi
Circe llo : caratterist ic he de I te rrito rio
IA PROVINCIA SANNITA 35
,Affir' 'i.rn,d "úd!.' . & \ú
ar -qF { 'l,aÉ
r.i A,à)E ..i{ {ro A,*Ú
A és, .r.c""^,. /a ;E elE È , i|*. !.
aiJo rl..hi. !.L à4" .rùa *iC. & {t* '
qaúe:, *Frdì d €'r. qrà
Qr;.6"r. rrì- 1, 3 '/É + Gdr rÉ{
ÈnRó" . 6ré.;.A ió. J (raJó r !+é. ( r'r' 'FJ* ò\
c.i- i."iJ. a.'\,:d- r E È u- e
!-*" ù.-- r- tì.
(ùr) If'ú ?.rd r'
a"r- I.l.ì, . rl-- .r. c Fs ",!
."rr , . Pú 't r -q
,i ra L b\À. l. (É 6*rrti r r jte
,(È ó. ..! r--,ae r' ir.{-, ti.. q''6
, r N3d . rL r ! . : t .d } d 'J ' ' ; ' t r { r ' ' J !
Circello: cenni storici e sremna
Gostelli del Sonnio
da cui si accedeva alla pofia del maschiodel castello. Dalla parte estema del mu-
ro della torre si osservano degli adden-tellati delle anúche mura e dei buchi del-le ravi della casa addossata. che serviva
di alloggio alle guardie della porta e sca-
linara d'ingresso. Lo spazio che veniva
occuDato da quesla scalinaLa dalle garit-
te, dalla casa àelle guardie e dallo spraz-zo adiacente è appunto quello di cui il
sottoscritto à possesso [temine via Rom4antislante il basÙonel. ln questo spaziovi esisteva una porta di sortita che nel
1869 per ordine del Principe del Colle
fu abbarrata per diloccamento eseguitodi vecchie mura della palazzina. Nel 1884
ouella stessa porta fu distrutta dal Ducaquando incominciò inuovi restauri. per
aprire altra sortita sempre nell'area del-
laFortezza di suo Possesso".Sempre dalla stessa fonte si ha notl-
zia che negli stessi anni (intorno aÌ
1882) fu eretto (forse sfruttando i restidi una tor:re medievale) "il campaniledell'orologio", la torre civica di Circellocon I'orologio pubblico, parzialmentedistrutta dai lerremoli e poi. per ragio-ni statiche, capitozzala, oggi esistentenel solo livello basamentale alle spalledel1a palazzina ducale, verso via Pona
di Sopra.Dal 1884 i Di Somma, che nei seco-
li precedenti avevano risieduto solo spo-radicamente in Circello, decisero di ve-
nirvi ad abitare per allontanarsi dal d-
schio corente dell'epidemia di colerain Napoli: d'altra parte, I'apertura del-
1a strada "Bebiana-' (l'atnrale artena pro-
3ó IA PROVINCIA SANNITA
vinciale) rendeva decisamente più age-voli i collegamenti con Benevento lnquella occasione, furono affrontati la-
vori di risrrutturazione della palazzina
ducale, onde adattarne I'intemo al me-
slio all'uso abitativo dell'Ottocento, la-
iciandone intatta e 1a volumetria e la di-
sposizione degli estemitl tenemoto del Vulnre del 1930 cau-
sò il crollo pressoché completo deìle
strutture murarie superstiti del secondolivello del mastio, conservate in gran
oane orima di quella data come si evin-ce da preziose riprese fotografiche con-
seryate. Uuso abitativo dei Di Sommaconlinuò fino al 1950. anno in cui mori
Vincenzo Di Somma. Egli lasciò i beni
immobili del complesso agli OspedaliRiuniti di Benevento, alla soppresslonedei quali la proprietà del complesso del
c a \ t e l l o p a ; s ò ( 1 9 8 2 ) a l C o m u n e d i
Circello, attuale propnetario. Ulteriondanni al mastio e alla palazzina furono
causati dai terremoti del 1962 e del
1980. La sola palazzina Ducale è stata
fatta oggetto nel 1990 di lavori dì con-so[damento statico e strutturale e di le-
stauro degli ambienti al fine di diventa-." ,rn
""ritro propulsore di attività cul-
turali, progetto finora non realizzato'
4. APPENDICE BIBLIOGRAFICA EARCHIVISTICA
4.1. BiblíografiaArchivisti Napoletani. Fonti lrtLgones\
Napoli 1964
CARNEVALE, A.: Gli atchi'í della Valle del
Tammaro, 1993
CARRocclA, E.: strale ed insedíamenti nel
SannioDE FEo KEMP, C. M.. L'a tico borqo di
Circello,1992DI LoRENZo, P: It castello di Circello rn
"Le Province", anno Vl, n"3, aprile 1997
Do\sl CLNTII E, l . t L( Ionti dorumentarie
dei comuni delL'Alto Tammaro' 7995
FEDELE, F.: Campania archeologica, No-
vara, 1988
FENIELLo, A. - RoMANo,D.'. ln chiesa at-
ciprenle della SS Annunziata a Circello
FILANGÌERT R.: l registri della Cancelleria
Angioira, NapoÌi,1961 e ss.
CuADAcNo, C.: Sui ccntr i [ort( ic 'Lt i pre'
romani, Arch st Terra di Lavoro, vol VI,
t9't8-'79
lAstELLo,I.t ! Sannití, in "Almanacco del
Sannio, 1997"
JAMIsoN, E. (a cura di): Catalogus Ba'
fonun, l(oÍ14, rt t t
MARTINI, FRA.NCESCO D' GTO!(GIO. TTAItTI,O(li architettura milít(ùe, Roma, I 964
l1.úzoLENr,I.. Il regesto della Cancelleia
Aragonese, NaPoli, 1995
MtoN4 AR llNI, A.: / comLtni della Provinîia
dí Be evelrto, 189'7
MrEr,E,F. G... L'ewnto delle cose. Cin:ello
e Fragneto nel 1496' Circello, 1996
MtE ,E,M.: CírceIIo è iI mio paese, s I ' s d
PANE, R.: Rtnascít etxlo nell'Italia Me dio'
nale, Milano, 79'7'7
PATfERSoN, J: Sunni! i Liguri e RttnatLi
(Samnites, Ligúrians a d Roma s), 1988
PERoGALLI, C. IcHNo, M P - BAzzL S':
C as tellí I talianí, 1)1 9
RoccHL E.: Lelonli ^rtoríche dell'drchitet
îura militarc, 1905
Russo, F.: Le fonifícazioni Sanníte, in'
"Almanacco del Sannio, 1997"
SANToRO, L.: Cdrfelli angíoíni e araSone
si nel regno di NaPolr', Milàno, 1982
SANToRo, L r Le opere di fort i l icozíonenel paesaggìo e nel contesfo utbaúo' Napol''
1969SANToRo, L.: Residenze foúificate, Attr
conv. "Castelli e vita di Castello"' Salemo
TARTAGLIA PoLcINl, C.: Círcello è íl mio
paese, s.d..
TARTAGLIA PoLclNl, C.: I Di Somma, Jeu-datari dí Circello, in "Progetto", anno III n'
4-5, 1989TARTAGLIA PoLCNI, C '. Corso Palazzo, in
"Progetto", Anno [lI n. 2, 1989
4.2 Fonti archivisticheArchivio di Stato di Benevento, fondo Notai
AntichiArchìvio di Stato di Napoli, sezione Archivi
Privati archivio Di Somma del Coll '
Archivio della Chiesa Arciprctale della
Santissima Annunziata di Circello
Archivio Comunale di Circello
Archivio privato Famiglia Di Somma
Archivio privato Famiglia Tartaglia Pol
cini I