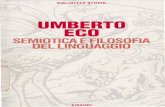La nascita della scienza giuridica, in L’antichità. Roma, a cura di Umberto Eco, Milano,...
Transcript of La nascita della scienza giuridica, in L’antichità. Roma, a cura di Umberto Eco, Milano,...
Roma
Storia politica, economica e sociale II
10
L’ANTICHITÀa cura di
Umberto Eco
A10_001-007_M1_01-11 09/11/11 16.34 Pagina 3
LA GRANDE STORIA - L’ANTICHITÀa cura di Umberto Eco
Vol. 10 - Roma Storia politica, economica e sociale II
Realizzazione editoriale Encyclomedia Publishers srlDirezione generale Danco SingerCoordinamento editoriale Margherita MarcheselliRedazione Silvia Di Pietro (coordinamento), Ilaria Milano,
Stefania Bonini, Giulia StegagnoSegreteria di redazione Alice VedovatiProgetto grafico e impaginazione Fabio Lancini e studio SlashCopertina Susanne Gerhardt
Content Management System Mauro Mattioli, Agnese Fogli
Ricerca iconografica Alessandra Guadagni, Rossana Di Fazio, Paola Mambretti
Carte storiche Daniela Blandino, Milano
Referenze fotografiche Per le referenze fotografiche dell’intera opera si rimanda all’ultimo volume
Si ringraziano gli editori che hanno reso disponibili i testi utilizzati nelle citazioni.
© 2011 Encylomedia Publishers srl, Milano
© 2011 RCS Quotidiani S.p.A.Edizione speciale per il Corriere della Sera Pubblicato su licenza Encyclomedia Publishers srl
LE GRANDI COLLANE DEL CORRIERE DELLA SERA RCS Quotidiani S.p.A.Via Solferino 28, 20121 MilanoSede legale via Rizzoli 8, 20132 MilanoDirettore Responsabile: Ferruccio de BortoliReg. Trib. Milano n. 179 del 15/03/2006ISSN 1828-0501
Finito di stampare nel mese di novembre 2011
A cura di RCS Quotidiani S.p.A. Presso Nuovo Istituto di Arti Grafiche, BergamoPrinted in Italy
In copertina: Anatre e ambiente lacustre, particolare, II sec. a.C.., mosaico, Pompei, Casa del Fauno;© Frederic Soltan/Corbis
A10_001-007_M1_01-11 10/11/11 14.36 Pagina 2
La scienza giuridica è una disciplina che studia il diritto, inquadrandolo razio-nalmente ed elaborandolo in modo tale che l’interpretazione delle norme siacompiuta attraverso procedure logiche verificabili in ogni passaggio. Nella sto-ria della cultura giuridica dell’umanità una vera e propria scienza del diritto sitrova sviluppata per la prima volta nel mondo romano, mentre non se ne ri-scontrano tracce significative né nella cultura giuridica dei paesi del VicinoOriente antico, né nella Grecia antica.
Il diritto come scienza e le origini della scienza giuridica a RomaLa scienza giuridica è una disciplina che studia il dirittoe lo considera come una materia a sé stante, separata daglialtri campi del sapere. Quando si afferma che lo studio deldiritto è da considerarsi una “scienza”, si intende comune-mente fare riferimento a un contesto politico, sociale e cul-turale in cui il diritto viene inquadrato razionalmente e vie-ne elaborato in modo tale che l’interpretazione delle normesia compiuta attraverso procedure logiche verificabili inogni passaggio.Perché si possa parlare, in relazione a un determinato con-testo, di scienza giuridica, è dunque necessario che in quelcontesto esista il diritto, anche se non sempre l’esistenza diquesto dà luogo a una scienza giuridica. Infatti, mentre il di-ritto consiste in un insieme di norme con cui si regolamen-tano i rapporti tra i consociati per prevenire e disciplinare iconflitti di interesse intersoggettivi, l’esistenza, in un deter-minato sistema, di una scienza giuridica presuppone che ilcomplesso delle norme sia organizzato in un articolato siste-
330
La nascita della scienza giuridicadi Lorenzo Gagliardi
A10_328_421_A_012-580_prima_bozza 09/11/11 16.53 Pagina 330
ma di principi. Come scrive Rudolf von Jhering (1818-1892), tra un sistema di principi e un sistema di regole vi èuna differenza che può essere paragonata a quella tra unascrittura alfabetica e un sistema di ideogrammi.Secondo l’opinione oggi dominante, nella storia della cultu-ra giuridica dell’umanità una vera e propria scienza del di-ritto si trova sviluppata per la prima volta, e con un livello dielaborazione molto elevato, nel mondo romano e ancora og-gi lo studio del diritto romano si ritiene che fornisca al giu-rista moderno sia l’alfabeto, sia la grammatica del pensiero
331
La nascita della scienza giuridica
Lex spoletina;vietava il tagliodegli alberi in due boschi sacridel territoriospoletino; scolpita in solennelatino arcaico(semi-umbro)su due cippi, III sec. a.C.,Spoleto, MuseoArcheologico
A10_328_421_A_012-580_prima_bozza 09/11/11 16.53 Pagina 331
giuridico. La caratteristica peculiare del mondo romano,che porta alla nascita della scienza giuridica, è dovuta alfatto che in esso si sviluppano un’inedita riflessione eun’altrettanto innovativa elaborazione dei concetti giuri-dici da parte di personale specializzato, i giuristi o giuri-sprudenti (da iuris prudentia, ovvero “conoscenza del di-ritto”), che studiano e pubblicano opere espressamentededicate allo studio del diritto, costituendone il principa-le fattore di sviluppo.
Possibili origini della scienza giuridica fuori da Roma? Non tutti concordano sul fatto che la nascita della scienzagiuridica sia da collocarsi a Roma. Alcuni studiosi, in tempirecenti, hanno sostenuto l’opinione che essa trovi le sue ori-gini nel Vicino Oriente antico. Le fonti principali di cui di-sponiamo per la conoscenza del diritto di queste civiltà è co-stituito principalmente da alcuni codici del secondo millen-nio a.C., tra cui possiamo citare, come uno dei più famosi, ilCodice di Hammurabi, proveniente da Babilonia, scritto inaccadico e risalente al 1750 a.C. Ebbene, secondo parte del-la dottrina moderna questi codici sarebbero trattati scientifi-ci di diritto, ai quali si sarebbe ispirata in seguito la scienzagiuridica romana.La natura scientifica dei diritti del Vicino Oriente antico vie-ne motivata sulla base della considerazione che la forma deidetti codici è casistica: essi sono composti dalla previsione diuna serie di casi, che ricorrono spesso in differenti codici, an-che se non sono necessariamente presentati negli stessi ter-mini e vengono risolti in modi che possono essere di volta involta differenti. Alla luce dei tratti comuni a tutti, si sostieneche la loro origine vada ricondotta a una scienza mesopota-mica, il cui metodo sarebbe basato sulla compilazione dielenchi, formati da casi, cui viene data una soluzione. A par-
332
ROMA ö Storia ö Diritto
A10_328_421_A_012-580_prima_bozza 09/11/11 16.53 Pagina 332
tire da ciascuno di essi la giurisprudenza modifica i partico-lari della fattispecie, creando una serie di variazioni intornoa essa, che diventa così oggetto di studio e può poi essere usa-ta come paradigma per l’insegnamento, o per ulteriori di-scussioni. Gli studiosi moderni fautori di questa ipotesi os-servano che i codici in questione contengono il prodotto diuna tradizione giuridica stratificata, fino a formare un cano-ne di problemi, che per un verso si diffonde nelle diverse ac-cademie del Vicino Oriente antico e per altro è posto alla ba-se dell’attività legislativa compiuta da alcuni sovrani. A que-sto proposito occorre rilevare che, pur volendo ipotetica-mente ammettere che quella mesopotamica sia una scienzagiuridica, essa in verità non conosce la definizione di concet-ti astratti e la classificazione in categorie e sotto-categorie. Sicaratterizza piuttosto per essere una “scienza di liste”, cheprocede attraverso il concatenamento di esempi, raggruppa-ti per associazione. Sembra dunque più opportuno ritenereche si tratti di una scienza assai elementare e certamente mol-to più semplice di quella romana. Manca altresì ogni provache la scienza giuridica romana possa derivare da quella me-sopotamica. Minori dubbi vi sono, tra gli studiosi moderni,nel negare che nella Grecia antica esista una scienza giuridi-ca. Invero in Grecia non è mai esistita un’attività specialisti-ca di elaborazione di concetti giuridici, né è mai esistito per-sonale specializzato in tale campo. Esistono gli esegeti, ma es-si sono soltanto interpreti delle regole del diritto sacrale, concompetenza unicamente in materia religiosa (ad esempio, incaso di controversia sulle regole relative alla purificazione deiresponsabili di omicidio) e sono più simili a sacerdoti chenon a giuristi, sono detentori di verità piuttosto che interpre-ti di norme giuridiche. Analogamente, ma per motivi diversi,non sono giuristi neppure i famosi “logografi giudiziari” delmondo ateniese, vale a dire gli oratori che scrivono su com-missione e dietro compenso le orazioni giudiziarie che i loro
333
La nascita della scienza giuridica
A10_328_421_A_012-580_prima_bozza 09/11/11 16.53 Pagina 333
clienti recitano successivamente in giudizio: essi hanno uni-camente una competenza in campo retorico. Nel mondo gre-co antico non sono giuristi neppure i giudici, i quali sono in-caricati di giudicare nelle cause dopo che un magistrato hasvolto la parte istruttoria del processo e sono per lo più sem-plici cittadini senza alcuna competenza specifica nella mate-ria. Escludendo l’esistenza della scienza giuridica in Grecia,non si vuole tuttavia negare ogni influenza della cultura gre-ca sulla nascita della giurisprudenza romana. Al contrario,bisogna sottolineare l’importanza dei modelli filosofici svi-luppati dai Greci, che a partire dal II secolo a.C. vengono im-portati a Roma, influenzando notevolmente la giurispruden-za romana di età classica. Tra le principali innovazioni cheRoma deriva dal mondo greco si trova l’introduzione di con-cetti giuridici astratti, in funzione sia euristica sia prescritti-va, cui si collega l’uso di tecniche classificatorie di origineplatonica, aristotelica ed ellenistica: si pensi all’uso di catego-rie come quelle di genus e di species, e al metodo diairetico.È dunque al mondo romano, variamente influenzato da ap-porti provenienti da altre culture ad esso più o meno vicine,che si deve rivolgere l’attenzione per trattare del modo in cuinasce la scienza giuridica.
La scienza giuridica a Roma dalle origini al II secolo a.C. Le ragioni della nascita della scienza giuridica a Roma si con-nettono e devono essere viste in relazione con la particolarenatura del nucleo più antico e più importante del diritto ro-mano, detto ius civile (“diritto dei cittadini”), e con le moda-lità originarie con cui è possibile, nella Roma arcaica, venirea conoscenza del suo contenuto. Lo ius civile è un diritto non scritto e a base consuetudinaria,essendo costituito principalmente da mores (appunto “con-suetudini”) risalenti alla fase pre-civica. Il carattere orale del
334
ROMA ö Storia ö Diritto
A10_328_421_A_012-580_prima_bozza 09/11/11 16.53 Pagina 334
diritto antico pone il problema, anche durante la fase civica,nel periodo regio della storia di Roma (tradizionalmentecompreso tra il 753 e il 509 a.C.), della “memoria” dei mores.Essa è affidata ai pontefici, un collegio di sacerdoti patrizi in-caricato di celebrare i culti religiosi dello stato. I pontefici so-no esclusivi depositari della conoscenza del diritto e sono isoli incaricati di fornirne interpretazione; essi sono così ingrado dare ai cittadini che ne facciano richiesta responsi suquale sia il contenuto del diritto in relazione a un determina-to punto specifico e procedono altresì a un lavoro di massi-mazione del diritto vigente, i cui risultati essi mantengono ri-servati. È da sottolineare che l’attività di interpretazione del-lo ius civile compiuta dai pontefici non si pone sullo stessopiano dell’interpretazione della legge nei sistemi giuridicimoderni: dato che il diritto non è scritto, essi non sono inter-preti di un testo legislativo, sono piuttosto coloro che dichia-
335
La nascita della scienza giuridica
Lex Ursonensis,tavola 1,promulgata daMarco Antoniopoco dopo lamorte di Cesareper la ColoniaGenua Iulia, conaggiunte di epocaflavia, da Urso(Osuna), secondametà I sec. d.C.,Madrid, MuseoArcheologicoNazionale
A10_328_421_A_012-580_prima_bozza 09/11/11 16.53 Pagina 335
rano ciò che è il diritto. E poiché sono i soli depositari dellasua conoscenza, l’attività di interpretazione è da loro com-piuta con grande libertà e con effetti innovativi nello svilup-po dell’ordinamento privatistico romano di questa fase.Qualche tempo dopo l’inizio della repubblica la popolazio-ne appartenente alla classe plebea, numericamente superiorea quella d’estrazione patrizia, aspira a una maggiore certezzadel diritto, in modo che esso non riposi più solo su ciò cheviene di volta in volta dichiarato dai pontefici. In un periodoprofondamente segnato da lotte di classe i plebei sospettanoche la pronuncia dei pontefici (esclusivamente patrizi) sullavalidità di particolari atti giuridici possa non essere sempredel tutto disinteressata, soprattutto quando la questione ri-guardi un conflitto di interessi tra un patrizio e un plebeo. Ècosì che, intorno al 450 a.C., alcuni dei principali mores ven-gono fissati in forma scritta, nelle famose XII Tavole, da unacommissione probabilmente a composizione mista patrizio-plebea, formata da dieci magistrati, detti decemviri. Anchedopo il periodo post-decemvirale e dopo la parziale redazio-ne in forma scritta dello ius civile, l’attività di interpretazionedei pontefici non si ispira tuttavia a un gretto letteralismo, macontinua, come in precedenza, con accenti che all’occorren-za possono essere fortemente innovativi e che possono giun-gere a creare nuovi istituti sconosciuti al diritto precedente.Questo accade, ad esempio, quando i pontefici interpretanouna norma delle XII Tavole che limita l’arcaico potere deipadri di vendere i figli. Infatti nel mondo romano un padrepuò vendere il proprio figlio a un estraneo, per il quale il fi-glio lavorerà quasi come uno schiavo. L’acquirente può libe-rare la persona che ha acquistato, ma essa ritorna sotto il con-trollo del padre, che, se desidera farlo, può rivenderla − e co-sì per più volte. Nelle XII Tavole è previsto il limite massimodi tre vendite, dopo le quali il figlio è definitivamente libera-to dal potere paterno. I pontefici interpretano in modo inno-
336
ROMA ö Storia ö Diritto
A10_328_421_A_012-580_prima_bozza 09/11/11 16.53 Pagina 336
vativo la norma e ideano, partendo da essa, l’istituto del-l’emancipazione, basato proprio su un procedimento di trefinte vendite, che il padre compie con un amico: dopo ognifinta vendita l’amico lascia libera la persona e dopo la terzavendita e la terza manomissione questa è definitivamente li-berata. Attraverso l’interpretazione dello ius civile i pontefi-ci finiscono con il rendere i padri in grado di emancipare i fi-gli dal loro potere mediante il ricorso a un atto volontario diautonomia privata, cosa fino ad allora neppure ipotizzabile. Fra il IV e il II secolo a.C. compaiono a Roma nuove fonti deldiritto oltre ai mores orali. Vi si trova innanzitutto la leggescritta, approvata dal popolo nei comizi (che tuttavia di radoattiene al diritto privato) e poi fa la sua comparsa l’editto delpretore urbano. Quest’ultimo è un magistrato eletto ogni an-no dal popolo; è incaricato di istruire i processi in materia didiritto privato e quindi di inviare le parti davanti a un giudi-ce che emetterà la sentenza. Il pretore ogni anno emana, alsuo ingresso in carica, un editto, che viene scritto su grandipannelli di legno ed esposto nel foro. Il pretore dell’annosuccessivo conserva l’editto del pretore dell’anno preceden-te, ma può apportarvi le innovazioni e le modifiche che ritie-ne necessarie. L’editto contiene una serie di formule che ven-gono usate per lo svolgimento dei processi e attraverso lequali il pretore è in grado di creare diritto nuovo. Questo nonconfluisce nello ius civile, ma va a costituire un (sotto)siste-ma normativo a sé stante che prende il nome di diritto preto-rio (ius honorarium).La mutata fisionomia del diritto privato romano nel periodoin esame non fa immediatamente venire meno le funzionipontificali. Tuttavia, tra III e II secolo a.C., l’accresciutacomplessità del sistema normativo privatistico fa sì che la sfe-ra del diritto sia percepita sempre più come distinta da quel-la religiosa. Perciò la centralità dei sacerdoti come i soli de-positari della conoscenza dello ius vacilla. D’altro canto, né i
337
La nascita della scienza giuridica
A10_328_421_A_012-580_prima_bozza 09/11/11 16.53 Pagina 337
pretori, né i giudici, né gli avvocati hanno una formazionegiuridica e hanno pertanto bisogno dell’aiuto di esperti. Ecosì, dalla seconda metà del III secolo a.C., si ha notizia del-la nascita a Roma di una classe di esperti di diritto, che nonsono più i sacerdoti, né rivestono formalmente alcun ruolonell’amministrazione della giustizia, ma hanno la preparazio-ne necessaria per spiegare il diritto ai cittadini che ne faccia-no richiesta. Costoro sono dunque dei laici, senza alcun im-mediato rapporto con la religione cittadina e sono espressio-ne della nobiltà patrizio-plebea, detentrice in quest’epocadel potere politico. Il passaggio delle funzioni interpretativedel diritto a questi nuovi giuristi è noto come “laicizzazionedella giurisprudenza”. In un primo tempo i giuristi laici nonsono pagati, e considerano il loro lavoro come una sorta diservizio pubblico. Sono i nuovi custodi del diritto. La fonda-mentale differenza fra loro e i pontefici è che essi svolgonol’attività di interpretazione del diritto apertamente e in pub-blico. La loro attività si intensifica a partire dal I secolo a.C.e va perfezionandosi nelle tecniche adoperate e nei risultatiraggiunti.
La scienza giuridica a Roma tra I secolo a.C. e III secolo d.C. È questa l’età nota come il periodo classico della giurispru-denza romana, che termina nel 235 d.C., quando, con la mor-te dell’imperatore Alessandro Severo (208-235), si esauriscela forza propulsiva dei giuristi e l’innovazione del diritto di-penderà massimamente dall’attività delle cancellerie impe-riali in forma sempre più accentrata e burocratizzata.I giuristi classici sono studiosi che si dedicano al diritto, del-la cui pratica si occupano quotidianamente, rispondendo al-le necessità di chi si rivolge loro. Essi inoltre fondano scuolee pubblicano in opere anche molto corpose le loro raccoltedi responsi o i loro commenti al diritto. In ragione di ciò so-
338
ROMA ö Storia ö Diritto
A10_328_421_A_012-580_prima_bozza 09/11/11 16.53 Pagina 338
no i soli ritenuti in grado di avere una conoscenza veramen-te approfondita del diritto e di determinare quando siano ne-cessarie riforme delle norme vigenti. La loro attività di interpretazione si concentra sullo ius civilenon scritto, con ampio spazio per innovazioni; ma essi inter-pretano anche le leggi scritte, ad esempio indagando di voltain volta, secondo i casi concreti sottoposti alla loro disamina,se debba prevalere lo stretto tenore letterale di un testo nor-mativo o piuttosto il suo spirito; ancora, danno consigli aiprivati cittadini che chiedano loro come devono compiere undeterminato atto giuridico. Indicano anche come si debbanointerpretare atti giuridici già compiuti, specialmente attiscritti (come per esempio i testamenti), determinando sedebba prevalere, secondo i casi, l’oggettivo significatoespresso dall’autore dell’atto o piuttosto la sua reale intenzio-ne, seppur manifestata in modo ambiguo. La grande impor-tanza della giurisprudenza romana risiede anche nel fatto chele interpretazioni date dai giuristi e pubblicate nelle loro ope-re costituiscono esse stesse diritto, del quale sono una dellefonti. L’elaborazione del diritto classico compiuta dai giuristiè fondamentalmente incentrata su casi reali o ipotetici, que-sti ultimi inventati nelle scuole. Muovendosi entro un talemetodo, può darsi che diversi giuristi diano soluzioni diver-se a uno stesso caso, partendo da una differente interpreta-zione delle stesse norme vigenti. Ciò tuttavia non impedisceche divergenti interpretazioni giurisprudenziali siano tuttepercepite allo stesso tempo come diritto vigente. È quelloche comunemente si intende quando ci si riferisce al dirittogiurisprudenziale romano come a un ius controversum (“di-ritto controverso”), che raggiunge il suo apice tra il I e il IIsecolo d.C., a causa del contrapporsi su numerosi temi delledue principali scuole dell’epoca, quella dei Sabiniani e quel-la dei Proculeiani. È questa l’epoca in cui i giuristi romani ini-ziano anche un processo volto alla sistematizzazione e alla ca-
339
La nascita della scienza giuridica
A10_328_421_A_012-580_prima_bozza 09/11/11 16.53 Pagina 339
tegorizzazione del loro sistema casistico, tendente per naturaa diventare sempre più intricato e complesso, e lo fanno ri-correndo ai metodi greci di classificazione. Tra i giuristi del I secolo a.C., l’ultimo dell’epoca repubbli-cana, bisogna menzionare Quinto Mucio Scevola, il primo atentare l’esposizione dello ius civile in categorie logiche, eServio Sulpicio Rufo, celebrato autore di responsi, che fon-da una scuola con tendenze prevalentemente pratiche.A partire dal 23 a.C., con l’ascesa al potere di Augusto (chemuore nel 14 d.C.), avviene il passaggio all’impero: gli impe-ratori progressivamente si attribuiscono sempre crescentipoteri legislativi, che si esplicano mediante l’emanazionedelle cosiddette “costituzioni imperiali”, aventi un’efficaciaequiparata a quella delle leggi comiziali. Queste costituzioniconsistono per lo più in editti, ovvero provvedimenti nor-mativi a carattere generale, e in rescritti, ovvero risposte da-te dall’imperatore a questioni giuridiche poste da litiganti oda pubblici funzionari. Tutte queste novità che si produco-no in campo costituzionale ma con riflessi anche sul versan-te delle fonti del diritto non diminuiscono minimamentel’importanza della giurisprudenza. Al contrario, i giuristi co-stituiscono un ceto gradito agli imperatori, che a loro si ap-poggiano per la redazione delle costituzioni. Ciò è dimostra-to dal fatto che già Augusto per primo attribuisce a certi giu-risti il diritto (detto ius respondendi) di esprimere opinionifornite dell’autorità imperiale, probabilmente per alleviare ilcarico di lavoro gravante sulla sua cancelleria a causa del-l’elevata richiesta di rescritti. Tutti i suoi successori confer-mano tale innovazione e nel II secolo d.C. Adriano disponeche le opinioni di tutti i giuristi muniti di tale diritto, qualo-ra in accordo tra loro, debbano avere per i giudici la forzavincolante di una legge. Soltanto nei casi in cui vi sia conflit-to tra i pareri di due giuristi entrambi forniti di ius respon-dendi è lasciata ai giudici la scelta tra le due discordanti opi-
340
ROMA ö Storia ö Diritto
A10_328_421_A_012-580_prima_bozza 09/11/11 16.53 Pagina 340
nioni. Tra i primi giuristi del I secolo d.C. ricordiamo Capi-tone e Labeone, capiscuola rispettivamente della correntedei Sabiniani e di quella dei Proculeiani. Il primo è un calo-roso fautore di Augusto ed è pertanto molto gradito negliambienti ufficiali, ma non godrà di molto successo presso iposteri. Il secondo resterà invece famoso nel tempo come unardito innovatore in campo giuridico. Molto importante èanche Masurio Sabino, allievo di Capitone, che perfeziona eriprende lo schema espositivo dello ius civile proposto daQuinto Mucio Scevola. Da Sabino prende in effetti il nomela scuola dei Sabiniani, mentre il nome dei Proculeiani deri-va da Proculo, un allievo di Labeone. Tra i giuristi del II se-colo d.C. si trovano Salvio Giuliano, Pomponio e Gaio. Ilprimo viene incaricato da Adriano di fissare in forma defini-tiva l’editto dei pretori, dato che questi ultimi progressiva-mente sono stati privati dagli imperatori del potere di inno-vare il diritto privato attraverso lo ius honorarium. Il secon-do è autore di ampi commenti allo ius civile e all’editto delpretore e ci lascia altresì un importante profilo della storiadella giurisprudenza romana dalle origini ai suoi giorni. Ilterzo è autore di numerose opere, tra le quali particolaresuccesso ha avuto nel tempo un breve manuale per l’inse-gnamento del diritto nelle scuole, intitolato Institutiones(“Istituzioni”, ovvero “insegnamento introduttivo”). Tra lafine del II e l’inizio del III secolo d.C. troviamo i giuristi piùimportanti, quelli che operano durante l’impero della dina-stia dei Severi (da Settimio Severo asceso al potere nel 193d.C. alla morte di Alessandro Severo nel 235 d.C.). I più in-signi sono Papiniano, Paolo e Ulpiano. Tutti e tre, oltre a es-sere giuristi al servizio imperiale, svolgono anche la carrierapolitica, giungendo a ricoprire la più alta carica, quella diprefetto del pretorio. Ciascuno di essi è quindi al contemposia il principale funzionario dell’imperatore nel campo giu-ridico, sia il suo capo di stato maggiore. Sono tutti autori
341
La nascita della scienza giuridica
A10_328_421_A_012-580_prima_bozza 09/11/11 16.53 Pagina 341
molto fecondi. Papiniano, prefetto del pretorio di SettimioSevero e poi messo a morte nel 212 dal successore di que-st’ultimo, Caracalla, eccelle nell’analisi di casi particolari.Paolo e Ulpiano, entrambi prefetti del pretorio di Alessan-dro Severo (il secondo di essi è ucciso dalle guardie ammu-tinatesi nel 223 d.C.), sono noti per i loro grandi commenta-ri che sintetizzano l’opera dei predecessori, trasmettendo al-la posterità i principali esiti della giurisprudenza classica, inuna forma molto matura e assai complessa. Con la fine del-l’età severiana termina il periodo classico della giurispru-denza romana. L’interpretazione del diritto vigente spettaormai soltanto alle cancellerie imperiali e, anche se questeultime compiono sforzi affinché sia mantenuto lo stesso li-vello di elaborazione scientifica dei periodi precedenti, lacrisi delle scuole di diritto e il cessare dell’attività letterariadei giuristi fanno venire meno la possibilità che si crei nuo-vo ius controversum e, con ciò, la scienza giuridica romana siinaridisce, cessando di continuare a rappresentare una com-ponente vitale del diritto. Gli scritti dei giuristi romani nonsono pervenuti fino a noi in forma integrale, con la sola ec-cezione delle Institutiones di Gaio. Ampi estratti di essi, tut-tavia, sono conservati da Giustiniano (imperatore romanod’Oriente tra il 527 e il 565) in una sorta di antologia dellagiurisprudenza classica, i Digesta, che egli fa compilare aisuoi collaboratori e che dota della forza di legge. Ciascunodei frammenti dei giuristi classici inserito nei Digesta recal’indicazione della fonte di provenienza. Numerose traccedello ius controversum della giurisprudenza classica ancoratraspare dai testi conservati, anche se talune delle contrad-dizioni tra i diversi giuristi sono state appianate dai “compi-latori” di Giustiniano. Lo studio dei Digesta, interrotto du-rante il Medioevo, riprende intorno al 1200 d.C. a Bologna,a opera di una scuola fondata da Irnerio e dai suoi successo-ri, che costituisce la prima università dell’epoca moderna.
342
ROMA ö Storia ö Diritto
A10_328_421_A_012-580_prima_bozza 09/11/11 16.53 Pagina 342
343
La nascita della scienza giuridica
}}} Vedi anche Vicino Oriente, vol. 1, Storiaö Gli Stati territoriali: Assiri, Babilonesi e Ittiti (2000 a.C. - 1500 a.C.) -La Babilonia all’epoca
di Hammurabi
Grecia, vol. 4, Storia ö Diritto - Il diritto dei Greci; Il diritto senza lo stato; Diritto e retorica
Grecia, vol. 5, Filosofiaö Platone e Aristotele -Platone; Aristoteleö La filosofia nell’età ellenistica -La filosofia ellenistica: luoghi, scuole e caratteristiche
Grecia, vol. 7, Letteraturaö L’età classica -L’oratoria
Roma, vol. 9, Storia ö Nascita e sviluppo di una città (750 a.C. ca - 264 a.C.) - Roma repubblicanaö I primi due secoli dell’impero: da Augusto a Commodo (31 a.C. - 192 d.C.) - Augusto:
il fondatore dell’impero; I Flavi: il primato dell’amministrazione
Roma, vol. 10, Storia ö Antropologia e società - La guerra a Roma; Matrimoni, figli, parentela nel mondo romanoö Diritto - Le fonti del diritto
Esso continua tutt’oggi e i metodi scientifici ideati dai giuri-sti romani per l’interpretazione del diritto influenzano anco-ra profondamente la scienza giuridica contemporanea.
A10_328_421_A_012-580_prima_bozza 09/11/11 16.53 Pagina 343
![Page 1: La nascita della scienza giuridica, in L’antichità. Roma, a cura di Umberto Eco, Milano, Encyclomedia Publishers, 2012, pp. 8 (288-295) [ISBN 9788897514190]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010907/6312e0d5fc260b71020ed6a6/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: La nascita della scienza giuridica, in L’antichità. Roma, a cura di Umberto Eco, Milano, Encyclomedia Publishers, 2012, pp. 8 (288-295) [ISBN 9788897514190]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010907/6312e0d5fc260b71020ed6a6/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: La nascita della scienza giuridica, in L’antichità. Roma, a cura di Umberto Eco, Milano, Encyclomedia Publishers, 2012, pp. 8 (288-295) [ISBN 9788897514190]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010907/6312e0d5fc260b71020ed6a6/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: La nascita della scienza giuridica, in L’antichità. Roma, a cura di Umberto Eco, Milano, Encyclomedia Publishers, 2012, pp. 8 (288-295) [ISBN 9788897514190]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010907/6312e0d5fc260b71020ed6a6/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: La nascita della scienza giuridica, in L’antichità. Roma, a cura di Umberto Eco, Milano, Encyclomedia Publishers, 2012, pp. 8 (288-295) [ISBN 9788897514190]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010907/6312e0d5fc260b71020ed6a6/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: La nascita della scienza giuridica, in L’antichità. Roma, a cura di Umberto Eco, Milano, Encyclomedia Publishers, 2012, pp. 8 (288-295) [ISBN 9788897514190]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010907/6312e0d5fc260b71020ed6a6/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: La nascita della scienza giuridica, in L’antichità. Roma, a cura di Umberto Eco, Milano, Encyclomedia Publishers, 2012, pp. 8 (288-295) [ISBN 9788897514190]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010907/6312e0d5fc260b71020ed6a6/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: La nascita della scienza giuridica, in L’antichità. Roma, a cura di Umberto Eco, Milano, Encyclomedia Publishers, 2012, pp. 8 (288-295) [ISBN 9788897514190]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010907/6312e0d5fc260b71020ed6a6/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: La nascita della scienza giuridica, in L’antichità. Roma, a cura di Umberto Eco, Milano, Encyclomedia Publishers, 2012, pp. 8 (288-295) [ISBN 9788897514190]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010907/6312e0d5fc260b71020ed6a6/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: La nascita della scienza giuridica, in L’antichità. Roma, a cura di Umberto Eco, Milano, Encyclomedia Publishers, 2012, pp. 8 (288-295) [ISBN 9788897514190]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010907/6312e0d5fc260b71020ed6a6/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: La nascita della scienza giuridica, in L’antichità. Roma, a cura di Umberto Eco, Milano, Encyclomedia Publishers, 2012, pp. 8 (288-295) [ISBN 9788897514190]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010907/6312e0d5fc260b71020ed6a6/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: La nascita della scienza giuridica, in L’antichità. Roma, a cura di Umberto Eco, Milano, Encyclomedia Publishers, 2012, pp. 8 (288-295) [ISBN 9788897514190]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010907/6312e0d5fc260b71020ed6a6/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: La nascita della scienza giuridica, in L’antichità. Roma, a cura di Umberto Eco, Milano, Encyclomedia Publishers, 2012, pp. 8 (288-295) [ISBN 9788897514190]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010907/6312e0d5fc260b71020ed6a6/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: La nascita della scienza giuridica, in L’antichità. Roma, a cura di Umberto Eco, Milano, Encyclomedia Publishers, 2012, pp. 8 (288-295) [ISBN 9788897514190]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010907/6312e0d5fc260b71020ed6a6/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: La nascita della scienza giuridica, in L’antichità. Roma, a cura di Umberto Eco, Milano, Encyclomedia Publishers, 2012, pp. 8 (288-295) [ISBN 9788897514190]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010907/6312e0d5fc260b71020ed6a6/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: La nascita della scienza giuridica, in L’antichità. Roma, a cura di Umberto Eco, Milano, Encyclomedia Publishers, 2012, pp. 8 (288-295) [ISBN 9788897514190]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010907/6312e0d5fc260b71020ed6a6/html5/thumbnails/16.jpg)