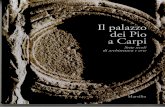Navigare nel passato Problemi della ricerca archivistica in Internet
Lo scavo nel cortile interno della Torre dell’Uccelliera di Carpi (MO). Alcune considerazioni...
-
Upload
denkmalpflege-bw -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Lo scavo nel cortile interno della Torre dell’Uccelliera di Carpi (MO). Alcune considerazioni...
347
Archeologia MedievaleXXXVII, 2010, pp. 347-360
Carla Corti
Lo scavo nel cortile interno della Torre dell’Uccelliera a Carpi (MO). Alcune considerazioni sulla nascita della signoria
e le difese del castrum nel XIV secolo
Tra il dicembre 2007 e il luglio 2008, nell’ambito della ristrutturazione del Palazzo dei Pio a Carpi (MO), è stato effettuato a più riprese uno scavo archeologico nel cortile interno della Torre dell’Uccelliera per cercare di individuare la presenza dei resti della vasca ornamentale rinascimentale, nota attraverso un documento d’archivio (fig. 1). L’analisi dei resti e dei dati emersi durante lo scavo1, inserita nel più ampio contesto storico, con particolare attenzione alla riorganizzazione delle fortificazioni del castrum in età medievale, pur nell’esiguità dei dati stra-tigrafici desumibili in un’area fortemente intaccata da scassi recenti e rimaneggiata già in antico, ha consentito comunque di giungere ad una nuova proposta di scansione cronologica degli apprestamenti difensivi e a un nuovo quadro d’insieme delle difese di Carpi nel XIV secolo.
I. IL CASTRUM DI CARPI. BREVE NOTA INTRODUTTIVA SULLE CARATTERISTICHE DELL’INSEDIAMENTO
L’abitato alto medievale di Carpi si è formato presso la chiesa di Santa Maria, la cosiddetta “Sagra”. Questo primo nucleo insediativo, così come le future espansioni urbane, risulta topograficamente inserito nei resti della ripartizio-ne agraria centuriale di età romana2. La fondazione della chiesa carpigiana è stata attribuita ad Astolfo. La notizia, di discusso fondamento storico, si conserverà a lungo nel-la tradizione storiografica locale. Nella documentazione d’archivio a noi pervenuta la prima menzione del luogo di culto, definito ecclesia posita in villa Carpana, risale invece all’anno 879, quando, in seguito ad un incendio
che compromise gravemente l’edificio, papa Giovanni VIII chiese a Paolo, vescovo di Reggio Emilia, di provvedere al ripristino (Frison 1984). La costruzione doveva presentare un qualche rilievo architettonico e/o decorativo, se il papa si preoccupa di stabilire che essa dovesse essere restaurata e restituita al precedente decoro e ordine (Tosco 2008, p. 17). A partire dal X secolo la chiesa compare con il titolo di pieve (Frison 1984). La situazione odierna dell’edificio è la diretta conseguenza della riduzione a un terzo della struttu-ra romanica, risalente a un periodo compreso tra il 1110 e il 1130, voluta da Alberto III Pio agli inizi del Cinquecento e dei restauri e ripristini realizzati da Achille Sammarini tra il 1871 e il 19283. Gli scassi effettuati all’interno della chiesa nel 1935 e nel 1980 hanno messo in luce sia resti pertinenti ad almeno una fase edilizia precedente del luogo di culto, che tracce di un edificio di età romana4.
All’inizio del X secolo il sito era dotato di un appresta-mento difensivo. In un diploma di Berengario I databile tra il 916 e il 924, trascritto parzialmente in un diploma di Enrico II del 1014, la pieve risultava infatti «sita in castro Carpense» (Frison 1984, p. 162). Non abbiamo dati per poter desumere l’aspetto, l’estensione e le caratteristiche tecniche di questo apparato difensivo. Esso, se consideria-mo quanto riscontrato nel resto dell’Italia settentrionale, doveva essere molto probabilmente costituito da una semplice palizzata in legno con terrapieno e fossato peri-metrali (cfr. Fortificazioni 1998). All’inizio dell’XI secolo Carpi sembra caratterizzasi come castrum populatum, ovvero un insediamento fortificato che comprende la chiesa ed edifici residenziali, come si può desumere da un documento che viene siglato nel 1001 da Teodaldo di Canossa «infra castro locus qui dicitur Carpense (…) in quadam mansione ipsius castri» (Tosco 2008, p. 21). Nel 1077 vi dovevano inoltre essere edifici idonei a ospitare papa Gregorio VII in fuga da Enrico IV e ancora nel 1083 le difese del castrum furono ritenute sufficienti per soste-nere l’assedio delle truppe imperiali (Ghizzoni 1997, p. 16). Resti in muratura del battiponte del ponte levatoio della porta di San Pietro, posta lungo il lato settentrionale del castrum, certamente in uso nei secoli XII e XIII, sono emersi in corrispondenza di via Rodolfo Pio5.
1 Lo scavo è stato condotto dalla scrivente sotto la direzione della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, nelle per-sone del Soprintendente Luigi Malnati e di Donato Labate, che desidero ringraziare per avermi affidato lo studio dei dati emersi e autorizzato la pubblicazione con lettera del 3 giugno 2009 (prot. 6459, pos. B/5 e D/13). Allo scavo ha costantemente partecipato Antenore Manicardi, presidente del Gruppo Archeologico Carpigiano, a cui va tutta la mia gratitudine per il supporto sul campo e per la sistemazione dei materiali in deposito. Un sentito ringraziamento va anche allo staff tecnico, a Giovanni Gnoli e Livio Bartoli del Settore A4, a Luca Menani della CMB e a Manuela Rossi, direttore dei Musei Civici di Palazzo Pio, per l’accesso al deposito dove sono conservati i materiali. Infine, ma non certo per ultima, desidero ringraziare Lucia Armentano, dell’Archivio Storico Comunale, sempre disponibile a discutere e a condividere i risultati delle sue ricerche ancora in corso. Notizia preliminare dello scavo è stata data in Corti 2010.
2 Bocchi 1986, p. 8 segg.; Lugli 2005, pp. 21, 75; Ghizzoni 2004b, pp. 121-127; si vedano inoltre Gelichi, Librenti 2008 e sull’evoluzione del centro storico di Carpi da ultimo Tosco 2008, cui si rimanda per la bibliografia precedente.
3 Si rimanda a Tosco 2008, pp. 17-26, con bibliografia prece-dente.
4 Ferrari, Garuti, Ontani 1984, ptc. pp. 112-117; un tentativo di rilettura dei dati dello scavo del 1980 in Corti 2002, pp. 103-112.
5 Notizia preliminare dello scavo effettuato tra dicembre 2005 e maggio 2006 con una prima analisi dei dati inseriti nell’evoluzione del sistema ossidionale carpigiano in Corti 2006 e 2008.
348
NOTIZIE SCAVI E LAVORI SUL CAMPO
A partire dalla seconda metà del XII secolo per effet-to di un consistente incremento demografico nacquero attorno all’antico insediamento fortificato, prima a sud (borgo Superiore o di San Giacomo, poi borgo Forte, a cui si aggiunse nel XIII secolo il borgo di San Francesco) e a nord (borgo Inferiore o di Sant’Antonio), successi-vamente a ovest (borgo della Teza o Castelnoglioso, poi Borgogioioso, a cui si aggiunse borgo Novo), una serie di borghi autonomamente difesi da palancati lignei (Ghizzoni 2004a, p. 27 ssg., fig. 2). All’interno di questo sviluppo urbano articolato per borghi, in forte crescita nel corso del XIV secolo, il castrum «divenne un impor-tante “elemento polarizzante”» (Ghizzoni, Svalduz 2008, p. 61). Per un ampliamento del perimetro della cinta esterna dobbiamo attendere gli anni 1518-1520, quando Alberto III Pio progettò un ammodernamento del sistema difensivo (Ghizzoni 1997, pp. 69-78, 84). Nei documenti di fine XV secolo l’area urbana occupata dall’antico castrum è denominata “castello murato” o “castelvecchio” e più frequentemente “cittadella” in quelli dell’inizio del secolo successivo (Garuti 1983, p. 11).
La prima metà del XIV secolo dovette corrispondere ad un periodo di fervore edilizio, le notizie tramandate riguardano principalmente il sistema difensivo che ver-sava in pessime condizioni nel 13066 e a cui mise mano prima Rainaldo Bonacolsi con la realizzazione nel 1320 di un gironum, di cui si conserva tuttora il mastio (pres-so l’angolo nord-occidentale), poi Manfredo Pio con la realizzazione nel 1332 delle mura. La costruzione della Torre dell’Uccelliera risale invece alla fine del XV secolo e costituisce parte integrante di un successivo ammoder-namento delle fortificazioni (vedi infra).
Le informazioni (documentarie, cartografiche e ar-cheologiche) a nostra disposizione per la ricostruzione dell’evoluzione del sistema ossidionale e dell’assetto ur-bano dell’antico castrum sono inesistenti o frammentarie fino alla fine del XV secolo, quando per Carpi possiamo disporre dei dati desumibili dal catasto urbano del 1472 per la ricostruzione di un quadro il più possibile organico dell’insediamento alle soglie dell’età moderna7. Anche per quanto riguarda i rilievi cartografici disponibili, essi non risalgono oltre la seconda metà del XV secolo8.
Nel corso del Trecento, con il consolidarsi della signo-ria dei Pio a Carpi, zone diverse all’interno del vecchio castrum furono destinate alle residenze fortificate dei membri della famiglia (Ghizzoni 2004b). Esse si concen-trarono principalmente nella porzione occidentale, dove nel terzo quarto del Quattrocento troviamo a nord la Rocca Nuova, che venne occupata e ampliata da Giberto I, Alberto II e Lionello I (padre di Alberto III), e a sud la Rocca Vecchia, le cui strutture furono in parte inglobate nel 1443 nel Torrione cosiddetto di Galasso (Galasso III), poi degli Spagnoli9. La Rocca Nuova comprende anche
fig. 1 – Prospetto, sezione e pianta della Torre dell’Uccelliera, seconda metà XVIII secolo (da Ghizzoni 1997).
6 Guaitoli 1877, pp. 43-44, ivi bibliografia specifica e i rimandi archivistici.
7 Da ultimo Ghizzoni, Svalduz 2008 con bibliografia precedente.8 Per una rassegna dei documenti cartografici e d’archivio si vedano
Materiali 1977 e Cartografia urbana 1987.9 Ghizzoni 2004b, pp. 139-140; Ghizzoni, Svalduz 2008;
per il Torrione di Galazzo, che inglobò due torri antecedenti, si veda Goldoni 2008.
la Torre del Passerino e nelle sue immediate adiacenze si trova la Torre dell’Uccelliera (angolo nord-ovest). A que-sta disomogeneità con nuclei residenziali distinti (Rocca Nuova e Rocca Vecchia), già collegati da un “corridoio” lungo il lato occidentale delle mura (il cosidetto “pala-zolo”), a cui si aggiunsero proprietà acquisite da privati (post 1472), cercò di dare uniformità Alberto III (1475-1531), con un intenso programma edilizio che comprese pure la realizzazione del cortile d’onore. Tuttavia, il complesso di Palazzo Pio divenne una realtà residenziale unitaria solo con gli Este10. Nella porzione orientale del castrum, si stabilì invece nel 1443, nel cosiddetto palazzo di Castelvecchio, accanto alla chiesa della Sagra, il terzo ramo della famiglia (Giberto II e Marco II)11.
II. LO SCAVO NEL CORTILE INTERNO DELLA TORRE DELL’UCCELLIERA
II.1 La torre dell’Uccelliera
Nulla si è conservato in alzato del perimetro murario tardomedievale della Cittadella, corrispondente all’ulti-ma fase dell’evoluzione del sistema ossidionale dell’area del vecchio castrum, ad eccezione delle fronti delle cortine
10 Su Palazzo Pio si rimanda a Folin 2008 e Svalduz 2008.11 Il palazzo fu in precedenza occupato da Marco I (unico signore
di Carpi negli anni 1389-1418). Quando i figli di Galazzo III nel 1469 furono accusati di congiura nei confronti di Borso d’Este ed estromessi dalla signoria, Giberto III, figlio di Marco II, trasferì la sua residenza nel Torrione di Galazzo; Giberto III cedette poi nel 1499 la sua parte di dominio su Carpi a Ercole I d’Este in cambio di Sassuolo; sulla famiglia Pio si rimanda da ultimo a Ori 2009.
349
NOTIZIE PRELIMINARI DALL’ITALIA
La denominazione “uccelliera” deriva dalla ricon-versione della struttura attribuita ad Alberto III, che sul tetto, ora a copertura conica, ma in origine presu-mibilmente coronato da una merlatura, come si può desumere dal disegno della torre gemella nel prospetto a volo d’uccello della città di Luca Nasi (1677), vi dovette realizzare una sorta di voliera. Lo spazio interno tra la torre e il Palazzo fu contemporaneamente riutilizzato per l’impianto di un giardino con vasca ornamentale. La riconversione funzionale della torre difensiva risultava già effettuata nel 1525, quando in un rogito compare appunto la menzione dell’Uccelliera (oexelleriam) come punto di riferimento geografico14, quindi come una realtà già esistente all’interno della Cittadella carpigiana.
Della trasformazione d’uso rimane la copia, redatta nella seconda metà del XVIII secolo, di una planimetria, con prospetto e sezione trasversale della parte superiore della torre (fig. 1)15. La ristrutturazione prevedeva anche una “camera da fresco” realizzata nel vano principale della torretta16, alla quale si accedeva da due piccole porte ad arco poste ai lati della vasca ornamentale (D, P, H) e per mezzo di una scala (Q), che consentiva di scendere nella stanza. Il piano del cortile risulta infatti rialzato. La vasca, di forma ottagonale, era composta da sei ripidi gradini. Tale destinazione d’uso, prettamente voluttuaria e legata al soggiorno di una corte e del suo Signore, dovette decadere precocemente e probabilmente non sopravvisse a lungo all’allontanamento di Pio da Carpi (1525).
Intorno al 1877 l’area del cortile interno era in com-pleto abbandono, con il piano di calpestio abbassato al livello dell’esterno e quello che rimaneva della vasca interrato, come ci documenta Hans Semper in un dise-gno allegato al suo libro su Carpi, pubblicato a Dresda nel 188217. La situazione rappresentata da Semper deve precedere di poco il riutilizzo della torretta, che nella se-conda metà del XIX secolo risulta destinata a «Deposito di Petrolio per l’Illuminazione notturna della Città»18. Questo utilizzo dovette cessare nel 1898, quanto furono posizionati i lampioni per l’illuminazione elettrica19.
fig. 2 – Veduta a volo d’uccello di Carpi realizzata da Luca Nasi, seconda metà del XVII secolo. Particolere dell’area del
vecchio castrum (da Ghizzoni 2004a).
difensive coincidenti con gli edifici del Palazzo dei Pio e dell’angolo nord-occidentale, dove troviamo una delle due torri angolari del perimetro fortificato, la Torre cosiddetta “dell’Uccelliera”. Una torre gemella, opposta nella prospettiva della fronte ovest del Palazzo, si trovava presso l’angolo meridionale (fig. 2). Essa venne abbattuta nel 1780 per far posto all’edificio ora sede del Comune (Garuti 1983, p. 31 e nota 57).
La costruzione delle due torri risale molto probabil-mente al 1480, quando sono documentate a Carpi con-sistenti opere in muratura, in gran parte corrispondenti alla ristrutturazione e all’aggiornamento del circuito difensivo (Ghizzoni 1997, pp. 34-37). Vedremo più avanti come i dati di scavo possano supportare questa datazione. Secondo quanto riportato da Paolo Guaitoli, sulla base di documenti conservati nell’Archivio Pio di Savoia ed ora non più reperibili, questi interventi si debbono attribuire a Marco II12.
La torre è composta da tre vani unici sovrapposti. Quello inferiore, ora interrato, risulta praticabile solo per metà: un muro diagonale divide infatti lo spazio e la metà anteriore, più esposta all’interno del fossato, era riempita di terra fin dalla sua costruzione. Un accorgi-mento volto a sostenere le artiglierie e a ottimizzare la funzione di fiancheggiamento della torre (Cassi Ramelli 1964, p. 100). Gli interventi di ristrutturazione dell’edi-ficio hanno previsto anche lo svuotamento, all’inizio del 2008, di questo vano, coperto con volta a botte e con due feritoie, in origine provviste di sistema di chiusura, per il tiro radente a protezione delle cortine poste a nord e a ovest13.
12 Guaitoli 1877, p. 49.13 Nel giugno del 1992 il Gruppo Speleologico della Città di Carpi
è stato incaricato di esplorare l’ambiente interrato. In quell’occasione, tolta l’acqua, è stato sgombrato l’accesso dal piano superiore, svuotati entrambi i vani delle feritoie e rimossa la parte dei detriti in corrispon-denza dell’angolo est, quello rivolto verso il lato settentrionale delle mura (relazione presso l’Ufficio Tecnico). Nel 2007 l’ambiente risultava reinterrato e i vani delle feritoie in massima parte ostruiti.
14 ASCC, A, n. 23, fasc.2, Archivio Notarile, Spogli fatti da don Paolo Guaitoli, p. 717 (rogito del 14 ottobre 1525); la notizia si deve a Lucia Armentano, che ringrazio. Il documento era stato pubblicato con data 1521 (Garuti 1983, p. 24, nota 32).
15 Garuti 1983; Ghizzoni 1997; nella legenda, al punto G, della pianta compare la denominazione «dell’Ucceliera» con l’aggiunta «detta così volgarmente».
16 Tre finestre, provviste di seduta antistante, furono allora aperte nella struttura (G, L), annullandone così definitivamente l’originaria funzione difensiva.
17 Semper 1999, p. 319, tav. 5; nel disegno si può inoltre osservare come l’intervento di abbassamento del livello del cortile avesse messo in luce le fondamenta ad arco dell’ampliamento della Rocca Nuova.
18 Come si evince dalla legenda della «Mappa del Pian-tereno dell’antico Palazzo nel Castello di Carpi» (Garuti 1983) eseguita nella seconda metà del XIX secolo in previsione di un progetto di trasferimento degli uffici comunali.
19 Evidenti tracce lasciate dal petrolio per lampade rimanevano sui muri della camera interrata e all’esterno, presso l’accesso inferiore con apertura ad arco della vecchia vasca ornamentale, che in quell’oc-casione dovette essere parzialmente riaperto; le tracce sono emerse a circa 30/40 cm dal piano della vecchia pavimentazione; i residui del petrolio continuavano fino alla profondità di 55 cm ca., dove una soglia chiudeva all’esterno l’apertura; copiose fuoriuscite rimanevano poi nel tamponamento inferiore.
350
NOTIZIE SCAVI E LAVORI SUL CAMPO
fig. 3 – Planimetria dello scavo.
II.2 Lo scavo
Il recente scavo effettuato all’interno del cortile ha interessato la zona circostante la torre. Sono stati messi in luce i resti della vasca ornamentale (USM 1) e di una struttura difensiva quadrangolare, orientata come la Torre del Passerino, di cui però si ignorava l’esistenza (USM 2-5) (figg. 3-4). Il pavimento in mattoni (US 3) fu successivamente riutilizzato come base per la vasca (fig. 5). È stata raggiunta una profondità che va dai 184 cm del pavimento ai 242 cm della risega inferiore del muro di raccordo USM 4, messa in luce dallo scavo del pozzetto per la pompa di drenaggio dell’acqua20. Su tutta l’area, fino a una profondità di 100/115 cm, il terreno
risultava sconvolto dall’impianto di utenze e fognature varie. Il tubo in cemento di una di queste fognature pog-giava direttamente sulle strutture della vasca, mentre un pozzetto di raccordo in muratura aveva interferito con il muro orientale (USM 2) e con la copertura con volta a botte (USM 7), che su di esso poggiava.
Tutte le strutture sepolte risultavano in massima parte smantellate, con i resti fortemente rimaneggiati già in passato e i depositi archeologici all’interno delle strutture rimossi. Un riempimento con materiali di età contempo-ranea (US 1), mescolati a ceramiche di epoca precedente, era a diretto contatto con le murature21. Sul fondo della
20 Le quote hanno come riferimento la soglia del portone di ingresso del cortile (posta a +20 cm dalla quota 0 del cantiere).
21 È assai probabile che presso i margini est e ovest dello scavo a questo riempimento si aggiungessero buche di scarico, sempre con materiali di età moderna e contemporanea. Di questi interventi recenti nessuna traccia rimane nella documentazione di archivio.
351
NOTIZIE PRELIMINARI DALL’ITALIA
fig. 4 – Panoramica dell’area di scavo. fig. 5 – Resti della vasca ornamentale (USM 1, USM 3).
vasca rinascimentale una fossa quadrangolare (US 9) tagliava il pavimento (US 3) e risultava tamponata con alcuni mattoni ricollocati in piano (US 10) (figg. 3, 5). Al di sotto del tamponamento, nel terreno di riempimento della buca, sono stati recuperati alcuni frammenti di ceramiche in uso nel Sei, Sette e Ottocento22.
Gli unici strati non alterati e ancora in posto sono stati rilevati all’esterno del muro orientale (USM 2), che dava verso nord-est e il centro del fossato, e all’esterno del muro meridionale (USM 3), attorno al muro di rac-cordo (USM 4), in direzione della Torre del Passerino. Si tratta dei resti del fossato (US 2, US 7) e della sua sponda (US 8), conservati a partire dal punto in cui è arrivato lo spoglio delle murature. L’interesse si è concentrato sui depositi meridionali, che seppure presenti in una zona estremamente limitata23, hanno contribuito a definire funzione e cronologia dell’uso della struttura difensiva quadrangolare.
I resti strutturali emersi durante lo scavo possono essere riferiti a tre periodi distinti, che coprono un arco cronologico compreso tra il XIV e l’inizio del XVI secolo, con due fasi posteriori, non necessariamente coincidenti, relative al riutilizzo della Torre dell’Uccelliera (fine XIX
secolo) e allo spoglio delle strutture sepolte, avvenuto in un momento non meglio precisabile.
Periodo IAl Periodo I sono riferibili i resti della struttura di-
fensiva quadrangolare, inquadrabile cronologicamente, come vedremo, tra il 1320 e il 1375. Questa torre ha forma irregolare, con due muri paralleli (USM 2 e USM 5) e il terzo (USM 3) che si raccorda ad essi in modo non ortogonale. Di essa nessuna memoria rimane nella documentazione d’archivio superstite e nelle fonti ico-nografiche disponibili. La struttura risulta ruotata di 45° rispetto alle cortine, come la restrostante Torre del Passerino, collocata più a sud ad una distanza che va dagli 8 m dell’angolo ovest ai 9 m dell’angolo est.
Di questa antica torre sono stati rinvenuti i muri est (USM 2), sud (USM 3) e ovest (USM 5)24, mentre nulla rimane sul fronte nord, dove si impostò la Torre dell’Uc-celliera (Periodo II) (fig. 3). L’impianto della rondella, ancora più avanzato all’interno del fossato, ha infatti cancellato, su quel lato, i resti della precedente struttura.
Il muro orientale (USM 2), largo 100/110 cm, è stato rinvenuto a una profondità che va da 41,5 cm a 105,1 cm.
22 Il termine più recente è dato dalla presenza di ceramica invetriata al manganese (cfr. Gelichi, Librenti 1997, p. 196).
23 Lo spoglio di USM 3 è arrivato in profondità (-183/185 cm), fino a raggiungere la quota del pavimento (US 3), ed i limi del fossato non alterati ed ancora in posto (US 7) corrispondevano quasi al punto di affioramento delle acque di risorgiva.
24 La distinzione in diverse unità stratigrafiche murarie di un unico corpo di fabbrica è dovuta alla difficoltà di riconoscere immediatamen-te durante lo scavo il collegamento delle strutture, che emergevano a quote diverse, ed è stata mantenuta perché i muri presentavano carat-teristiche strutturali diverse (larghezza e tipo di paramenti); analoghe sono invece le dimensioni dei mattoni impiegati.
352
NOTIZIE SCAVI E LAVORI SUL CAMPO
Il paramento murario esterno presenta uno schema molto regolare con un mattone disposto per il lato breve alterna-to rispettivamente a uno e due mattoni messi in opera per il lungo. Altrettanta regolarità non è stata invece riscontrata all’interno. Analogo paramento esterno presenta anche il muro occidentale (USM 5)25, mentre maggiore libertà di posa, svincolata da uno schema preciso, è stata riscontra-ta nel muro meridionale USM 3 e nel raccordo USM 4. All’interno della torre, a una profondità di 180/184 cm, è stata rinvenuta una pavimentazione (US 3) composta da file parallele di mattoni, anche frammentati, disposti irre-golarmente e con evidenti segni di usura. I mattoni erano messi in opera di piatto su uno strato di cocciopesto di 6/8 cm, con sottostante vespaio in frammenti laterizi di almeno 60/70 cm. Presso l’angolo sud-est è conservato il lacerto di un’altra pavimentazione con mattoni disposti di taglio su una preparazione in pezzame laterizio e malta, emerso a una quota superiore (-152,1 cm). In angolo troviamo una cavità, che doveva ospitare un palo quadrangolare (US 5). Questo lacerto (85×80 cm) parrebbe sovrapporsi a US 3, ma la relazione non è chiara per la presenza di malta sulle superfici piane26. Tutta questa zona, spogliata, era infatti inglobata nella vasca ornamentale (USM 1; Periodo III). L’unica misura rilevabile è quindi la larghezza massima della torre: 7,30/7,35 m.
Il muro orientale si raccorda con quello meridionale (USM 3), formando quasi uno sperone. A metà del se-condo, largo in media 72,5 cm (62,5 cm all’attacco con USM 2) e smantellato fino a una profondità che va da 128,6 a 185,8 cm, si innesta, in modo non perfettamente ortogonale, il muro USM 4. Quest’ultimo27, largo 85 cm, funge da raccordo tra la torre e la sponda del fossato (US 8), a cui si appoggia (fig. 6). La fondazione di USM 4 presenta una scarpatura a gradini, così come l’attacco a USM 328. In angolo, appoggiato sul primo gradino e inglobato nel limo del fossato (US 7), è stato rinvenuto un fondo di boccale su alto piede in ceramica graffita arcaica padana “precoce”, databile tra la seconda metà del Trecento e l’inizio del Quattrocento (tav. 1, 3)29. Nella sua fase di vita, la torre quadrangolare era posta all’esterno del circuito delle mura, all’angolo nord-ovest, inglobata nelle acque del fossato. Si tratta di caratteristi-che strutturali che consentono di identificare questa torre quadrangolare come un barbacane, un corpo di fabbrica avanzato adatto alla difesa radente30.
I materiali ceramici rinvenuti tra il muro meridionale e il terrapieno, sia tra i limi del fossato che sulla sponda,
fig. 6 – Muro USM 4 e tracce del fossato (US 7, US 8).
sono inquadrabili tra la metà del Trecento e la metà del Quattrocento. Sono stati recuperati due frammenti di maiolica arcaica, forse pertinenti allo stesso boccale, di-pinti in verde ramina e nero manganese. Si tratta di due pareti, una con foglie polilobate entro girali, databile al pieno Trecento, l’altra con attacco inferiore dell’ansa a nastro, inquadrabile nella seconda metà del secolo (tav. 1, 1-2)31. Oltre al fondo di boccale sopra menzionato, la ceramica graffita arcaica padana “precoce”, dipinta in verde ramina e bruno ferraccia e prodotta tra la metà del Trecento e l’inizio del Quattrocento, è documentata anche da un orlo di ciotola con decorazione suddivisa in comparti che racchiudono losanghe tagliate in croce (tav. 1, 5). Appartengono invece alla fase “diffusa” un orlo di ciotola con decorazione analoga, ma maggiormente semplificata (tav. 1, 6), e una porzione di boccale con al centro una grande losanga curvilinea, tagliata in croce, con grandi foglie lobate che spuntano dal centro dei lati (tav. 1, 4)32. È riferibile invece alle produzioni di ceramica graffita rinascimentale un frammento di parete di ciotola in ceramica graffita sia all’interno, con motivo a foglie ac-cartocciate su fondo tratteggiato, che all’esterno, con mo-tivo a corolla con ordini di petali sovrapposti, che risulta databile al secondo venticinquennio del XV secolo (cfr. Nepoti 1991, p. 189, n. 14). Infine, accanto alle cerami-che da mensa è stato recuperato anche un orlo di grande catino-coperchio in ceramica grezza senza rivestimento (tav. 1, 8). Contenitori da cucina con orlo ad arpione e parete esterna con solcature risultano diffusi in contesti pieno e basso medievali (Librenti 1987, p. 46).
25 Il muro occidentale (USM 5) risulta invece poco leggibile perché in massima parte inglobato nella fontana, di cui costituiva il muro di contenimento esterno.
26 Rimanendo così isolato, in seguito allo spoglio e rimaneggiamento delle strutture murarie, risulta poi difficile comprenderne appieno anche la funzione (oltre a quella relativa al sostegno-contenimento del palo) e attribuire una cronologia.
27 Il muro è conservato da -101,6 cm a -176,6 cm.28 Nel pozzetto per la sommersa ne sono stati individuati tre,
rispettivamente a -227,1 cm, -234,6 cm e -242,1 cm.29 Sulle graffite arcaiche padane si rimanda a Nepoti 2008, pp.
26-30, con bibliografia precedente. Un boccale in graffita arcaica su alto piede svasato è stato rinvenuto a Rubiera (RE) (Ravanelli Guidotti 2004).
30 Per quanto riguarda il termine “barbacane” vedi Cassi Ramelli 1964, p. 457.
31 Cfr. Librenti 1996, p. 286, fig. 120, 2; per un inquadramento generale vedi da ultimo Nepoti 2008, p. 25.
32 Nepoti 2008, pp. 26-30, in ptc. per il boccale cfr. p. 52, n. 7.
353
NOTIZIE PRELIMINARI DALL’ITALIA
tav. 1 – Ceramiche rinvenute durante lo scavo: 1-2. Maiolica arcaica; 3-6. Ceramica graffita arcaica; 7. Ceramica graffita; 8. Ceramica grezza senza rivestimento. Scala 1:3.
354
NOTIZIE SCAVI E LAVORI SUL CAMPO
fig. 7 – Particolare del raccordo tra il muro inferiore della rondella, USM 2 e la volta a botte (USM 7).
fig. 8 – Strutture murarie del lato est (USM 2 e USM 7).
fig. 9 – Strutture murarie del lato ovest (USM 5 e USM 7).
Periodo IIIl Periodo II coincide con la fase di ristrutturazione
del sistema difensivo avvenuta nel 1480. All’angolo nord-ovest della Cittadella fu costruita una rondella angolare (Torre dell’Uccelliera), inserita nelle cortine murarie. La Torre è tuttora ben conservata; interessa in questa sede evidenziarne alcune caratteristiche strutturali originarie emerse dai dati di scavo. Il barbacane non venne com-pletamente atterrato. La parte bassa delle sue murature fu inglobata nella nuova costruzione, come si evince dal raccordo tra USM 2 e il muro inferiore della rondella (fig. 7), che chiudeva il vano inferiore con feritoie: su di esso poggiano anche i resti di una volta a botte (USM 7) (fig. 8) impostata, a circa 135 cm dal pavimento in mattoni (US 3)33, sui muri orientale (USM 2) e occidentale (USM 5) del barbacane, non completamente atterrati. Al centro della stanza, la volta doveva raggiungere un’altezza di circa 2 m. Gli interventi legati alla riconversione funzio-nale del corpo di fabbrica (Periodo III) non consentono di leggere chiaramente il rapporto tra la rondella e questo vano, presumibilmente un deposito interrato funzionale alla nuova torretta angolare, che doveva comunicare con la camera inferiore e conferma l’esistenza di un riutilizzo delle vecchie strutture del barbacane anche il rapporto
33 Il pavimento in mattoni US 3 apparteneva al barbacane e viene ora per la prima volta riutilizzato. Esso risulta infatti tagliato dal muro inferiore circolare della nuova torre, mentre si appoggia alle murature interne della torre quadrangolare.
355
NOTIZIE PRELIMINARI DALL’ITALIA
tra il muro esterno circolare USM 6, il muro occidentale USM 5 e la volta a botte USM 7 (fig. 9).
Questa ristrutturazione del sistema difensivo del vec-chio castrum qui ha comportato anche lo spostamento del fossato. La nuova rondella angolare, a differenza del barbacane, risulta infatti inserita direttamente nel circuito delle mura. La nuova cortina aveva poi dei con-trafforti lungo il perimetro interno; uno di questi è stato rinvenuto presso l’odierno portone di accesso al cortile (USM 8) (fig. 3). In seguito a questo aggiornamento delle fortificazioni, la zona tra la nuova torretta circolare e gli edifici del castello fu interrata.
Periodo IIICon il rapido evolvere dell’assetto ossidionale e ur-
banistico di Carpi, all’inizio del XVI secolo la rondella angolare venne defunzionalizzata e questa parte del-l’antico castrum trasformata e inserita nella residenza di Alberto III. Lo scavo ha messo in luce ciò che rimane della vasca ornamentale (USM 1), confermando nella sostanza, e per quanto rimane della struttura originaria, l’attendibilità del disegno eseguitone nella seconda metà del XVIII secolo (figg. 1, 5).
La vasca appariva purtroppo già ampiamente spoglia-ta. Lo smantellamento delle murature, che ha coinvolto anche i muri del barbacane (USM 2-5), parrebbe essere avvenuto in tempi più recenti, come provano i materiali rinvenuti nel terreno di riempimento (US 1).
Nel disegno della seconda metà del XVIII secolo in questo spazio interno alle mura troviamo una vasca po-ligonale a sei gradoni (B) con una fronte monumentale, composta da una nicchia centrale con una statua (pro-babilmente si trattava solo di un dipinto34), affiancata dalle due porte di accesso al vano principale della torre (D) (fig. 1). Sotto la nicchia vi era una porta passante ad arco, che serviva ad alimentare la vasca (F).
Della vasca ornamentale, realizzata interamente in muratura e rivestita da uno strato di cocciopesto, di cui rimangono varie tracce, è conservato solo parte del gradino inferiore, sul lato occidentale alla sinistra della porta, e l’attacco del penultimo gradino. Rimane anche l’inizio della vasca alla destra della porta, ma il resto è stato interamente asportato. Alla sommità i gradini sono realizzati con mattoni disposti di taglio (figg. 1, 5). Per fondo della vasca, il cui perimetro è grossomodo ricostruibile seguendo le tracce della malta dei muri asportati, fu riutilizzato il pavimento in mattoni (US 3), mentre i muri perimetrali della torre medievale dovettero fungere da contenimento dell’invaso, che, considerando le caratteristiche del gradino rimasto (largo 35 cm, 28 cm all’attacco sulla fronte) e la distanza di questo dal penultimo (53,5 cm), doveva avere uno sviluppo verti-cale pronunciato35, con grande effetto scenografico, ma decisamente poco praticabile. Il livello del cortile era quindi molto superiore all’attuale.
34 Cfr. relazione preliminare del 25/02/2008.35 Nel disegno settecentesco manca la sezione della vasca. Non
è pertanto possibile stabilire se i gradini, come probabile, avessero un’altezza crescente man mano che ci si avvicinava al fondo. Se si assegna infatti ai gradini un’altezza costante di 53,5 cm, la vasca avrebbe dovuto raggiungere alla sommità la quota di +185,9 m dalla soglia del portone.
La parte superiore della vasca ornamentale dovette essere rimossa quando il livello del cortile venne drasti-camente abbassato per consentire l’accesso diretto alla piazza. In un disegno del prospetto del Castello del 1779 è presente la porta di comunicazione tra cortile e piazza e pertanto la rimozione era già cosa fatta36. Lo stato di abbandono del cortile nel 1877, con cumuli sparsi di terra, è documentato da Hans Semper. Lo spoglio della parte inferiore avvenne però solo successivamente, come documentano i materiali più recenti presenti nel riempi-mento che ricopriva le strutture smantellate (US 1)37.
Durante lo scavo sono stati recuperati frammenti ricomponibili di una scodella in ceramica graffita con stemma dei Bentivoglio entro cornice polilobata, databile al terzo venticinquennio del XV secolo (tav. 1, 7)38. I frammenti provengono da punti diversi dell’area: alcuni sono stati rinvenuti all’esterno del muro meridionale (USM 3), immediatamente al di sopra di US 7, mentre gli altri sono stati rinvenuti sparsi presso il muro orientale (USM 2), finiti nel riempimento US 1. Si segnala, infine, il rinvenimento di un unicum, recuperato nel terreno ampiamente rimaneggiato che riempiva il vano inferiore dell’Uccelliera. Si tratta di vari frammenti di un boccale in ceramica graffita con l’impresa del “brocco fronzuto”, composta da un tronco di pino reciso circondato da frasche verdi terminanti in pigne dorate. Essa compare anche nella decorazione della Rocca Nuova trecentesca e fu adottata dai Pio in seguito al matrimonio di Man-fredo I con Flandina Brocchi, alla cui famiglia l’impresa apparteneva (cfr. Dieghi, Previdi, Rossi 2008, pp. 151-152, nota 4).
II.3 Prima dell’Uccelliera
I resti della struttura difensiva quadrangolare sono riferibili a una torre avanzata all’interno del fossato (barbacane), eretta a protezione del mastio (Torre del Pas-serino) (cfr. Cassi Ramelli 1964, p. 233 e ss., fig. 150). Si tratta di un’opera di copertura della cortina realizzata per il tiro radente di fiancheggiamento a completamento del tiro piombante della torre angolare. La rotazione di circa 45° rispetto alla cortina, che facilitava il controllo di tiro riducendo gli angoli morti, è analoga a quella della Torre del Passerino. Esempi di torri ruotate di 45°, utilizzate sia nelle strutture dei castelli, sia nelle cinte dei borghi, compaiono nel Veneto occidentale e solo sporadicamente in Piemonte (Fossano, Monticello d’Alba, Stupinigi). Ben conservati sono i casi documentati nel castello di San Zeno a Montagnana (PD) e in quello di Este (PD). Si tratta di un tipo di fortificazione affermatosi nell’area tra XIII e XIV secolo (Tosco 2001, p. 87).
Quanto alla datazione del barbacane del castrum di Carpi, tenendo conto dei dati emersi durante lo scavo e dei dati storico-archivistici, si possono avanzare tre ipo-
36 Il prospetto del castello del 1779 compare in Garuti 1983. Anche la realizzazione del rilievo delle strutture ancora conservate dovette presumibilmente avvenire prima del 1779.
37 Si segnala la presenza in US 1 di una bottiglietta in vetro per lucido da scarpe Sutter e un di flacone in vetro della ditta farmaceu-tica PIAM, in attività a partire dall’inizio del Novecento, rinvenuti in profondità, quasi a contatto con il pavimento US 3.
38 Cfr. Nepoti 1991, p. 194, n. 24, ma con al centro coniglio accucciato.
356
NOTIZIE SCAVI E LAVORI SUL CAMPO
tesi, tutte circoscrivibili al pieno XIV secolo. Il barbacane potrebbe essere contemporaneo alla Torre del Passerino, vista la stretta relazione funzionale e strutturale esistente tra i due corpi di fabbrica e, dunque, far parte del girone realizzato dal Bonacolsi nel 1320 (vedi infra). La seconda ipotesi di datazione vedrebbe il barbacane come parte integrante del nuovo circuito delle mura, attribuito a Manfredo I Pio e iniziato nel 1332. Allo stato attuale delle conoscenze, questa appare la circostanza più probabile. Infatti, il rinvenimento presso l’angolo sud-est delle mura di una torre di dimensioni e orientamento analoghi (vedi infra), inglobata nel 1514 nel bastione, accrediterebbe l’esistenza di un unico progetto di ristrutturazione gene-rale delle cortine, che abbia per l’appunto portato alla realizzazione di entrambe queste torri angolari. Infine, è doveroso menzionare la possibilità che il barbacane sia stato costruito in seguito all’espansione della Rocca Nuova, già esistente nel 137539 all’esterno delle mura, nell’area occupata dal fossato. Questo nuovo corpo di fabbrica, che si imposta a est della Torre del Passerino, andava indubbiamente a interferire con la sua ampia visuale, pregiudicandone la portata difensiva. Il barba-cane, invece, con la sua avanzata posizione all’interno del fossato, viene in parte a sopperire alle sopraggiunte carenze, rafforzando la posizione del mastio. Questa ipotesi è stata avanzata considerando la presenza del terrapieno (US 8), cui si appoggia il muro di raccordo del barbacane (USM 4) che può essere sia strettamente legato alla realizzazione della Rocca Nuova, sia indipendente e precedente rispetto a essa. Il terrapieno può infatti aver avuto funzione difensiva come scarpatura in terre-no sciolto40. Purtroppo, lo smantellamento della parte superiore delle strutture non consente di comprendere appieno le eventuali caratteristiche ossidionali di quel riporto di terreno. Questa proposta, benché plausibile, appare la meno verosimile.
Il delicato periodo storico qui preso in considerazio-ne, all’interno del quale si inserisce la costruzione del barbacane, coincide con lo stabilizzarsi della signoria Pio a Carpi.
Questa torre quadrangolare anticipa la funzione della successiva rondella (Torre dell’Uccelliera) inserita nella cortina nel 1480, come parte integrante del circuito delle mura. La nuova torre circolare è in posizione ancora più avanzata all’interno del fossato. Il barbacane perse infatti gradualmente la sua efficacia difensiva in seguito al pro-gressivo spostamento verso nord dell’area residenziale del castello. Il consolidamento della signoria dei Pio nel XIV secolo e la gestione consorziale del potere comportatono la necessità di recuperare spazi per alloggiare degnamente tutti i membri della casata. Nel già congestionato castrum ciò potè avvenire, in questo settore, solo a discapito dello spazio destinato al fossato. Nel 1375 esisteva già la Rocca Nuova, che inglobava il girone del Bonacolsi, cambiando la fisionomia di quella parte del castello. A questa prima addizione, corrispondente all’attuale Sala delle Muse del piano ammezzato e alla Sala Ornata del primo piano,
per volontà di Lionello (1463-1477) furono aggiunti ulteriori ambienti (Garuti 1983, p. 20; Folin 2008, p. 52). Questa nuova espansione nella parte settentrionale corrisponde alla Stanza dei Cartigli, alla Sala dei Gigli e alla Sala degli Stemmi del piano ammezzato e allo Studiolo, alla Sala dei Trionfi e alla Sala dell’Amore del primo piano. Né mancano tracce giunte sino a noi dei paramenti murari esterni con motivi e ornamentazioni di gusto araldico della Rocca Nuova trecentesca (Dieghi, Previdi, Rossi 2008, p. 151).
Sembrerebbe far parte del primo ampliamento della Rocca Nuova, piuttosto che del girone bonacolsiano, considerando il posizionamento all’interno della plani-metria degli edifici, anche il muro inglobato nell’angolo nord-orientale dell’Aggiunzione Estense. Il restauro ha messo chiaramente in evidenza le caratteristiche strut-turali ed architettoniche di questa muratura una volta esterna e attualmente visibile nel Salotto Degoli del percorso espositivo del secondo piano. Anche qui sono state rinvenute tracce di decorazione pittorica attribuita agli anni tra il 1375/1378 e il 1420/30 circa (Dieghi, Previdi, Rossi 2008, p. 151).
III. LA NASCITA DELLA SIGNORIA E LE DIFESE DEL CASTRUM DI CARPI NEL XIV SECOLO. CONSIDERAZIONI
I resti emersi nello scavo del cortile interno della Torre dell’Uccelliera risaltano nella loro giusta prospettiva solo se contestualizzati storicamente e rapportati all’insieme delle fortificazioni del castrum.
III.1 La torre all’estremità sud-orientale delle difese del castrum
Nel 1514 Alberto III intraprese una ristrutturazione delle difese, anche per rafforzare la propria posizione nei confronti di Alfonso I d’Este, interessato a riavere Mo-dena e Reggio Emilia. In quell’occasione fu messo mano al «bastion de Borgo Forte» (Ghizzoni 1997, pp. 60-67). Con l’intenzione di realizzare una cinta bastionata, come risulta dai documenti relativi alle spese sostenute, fu allora inglobato nel nuovo circuito delle mura del vecchio castrum, un baluardo che si trovava all’angolo sud-orientale del circuito difensivo. Risulta infatti più che plausibile che in quell’occasione non venisse solo ricostruita la cinta, dopo averne rifatto le fondamenta, ma che, con l’intenzione di potenziarne la capacità di resistenza e di offesa, si fosse proceduto a un intervento più complesso41. A conferma di questo assunto si può ora portare la testimonianza fornita da una pianta, cor-redata da sezioni trasversali, recentemente riscoperta tra i documenti dell’Archivio Storico Comunale (Manicardi 2007, pp. 66-69). Essa riporta le strutture rinvenute nel corso della demolizione del baluardo in questione, de-
39 Archivio Storico del Comune di Carpi, Archivio Guaitoli, filza 31, fasc. 1, c. 51; Garuti 1983, p. 16; Ghizzoni, Svalduz 2008, p. 63, nota 14.
40 Si veda quanto osservato in Cassi Ramelli 1964, pp. 263-266, fig. 128.
41 Ghizzoni 1997, p. 65. La mofologia del baluardo, realizzato ora con fianco arretrato (Ibid., nota 37, con bibliografia) venne per-fezionata proprio nel primo decennio del XVI secolo da Giuliano e Antonio da Sangallo, a cui se ne deve la paternità. È probabile che l’atterramento delle vecchie strutture difensive abbia consentito il recupero di molti mattoni, per questo furono sufficienti solo duemila nuove prede (per il numero esiguo di mattoni acquistati per costruire la bombardera vedi Ibid., p. 68).
357
NOTIZIE PRELIMINARI DALL’ITALIA
fig. 10 – Carpi, angolo sud-orientale del vecchio castrum. Rielaborazione del rilievo planimetrico del “Forte a levante della Rocchetta” (1904). In evidenza, la nuova cinta muraria
cinquecentesca.
nominato “Forte a levante della Rocchetta”, avvenuta nel 1904, durante l’abbattimento delle mura. Ben in evidenza nel rilievo planimetrico, oltre al muro esterno di contenimento, attribuibile alla fabbrica dell’inizio del XVI secolo, esistono strutture difensive più antiche, occultate nel terrapieno interno (fig. 10)42. Purtroppo nessuna relazione accompagna la documentazione. Pertanto, le considerazioni relative a questa importante scoperta si devono limitare al riscontro planimetrico. Si tratta di strutture necessarimanete rimaneggiate – la co-struzione del baluardo deve aver richiesto, quanto meno, l’atterramento delle murature precedenti – e, forse, in parte inglobate nel nuovo apprestamento difensivo. Di quelle strutture ci sfuggono inoltre in massima parte i rapporti reciproci di dipendenza, anche stratigrafica. Non si esclude che i rilievi siano stati effettuati quando parte della demolizione del 1904 era già avvenuta, pregiudi-cando la lettura dei resti rimasti43. Fatte queste necessarie premesse, risulta tuttavia ben evidente nella pianta una torre pseudo-quadrangolare, di forma irregolare, delle dimensioni massime di 7,60×9,10 m alla base del muro a scarpa, dello spessore di 95 cm (120 cm alla base). Lacerti di una cortina rientrante, interrotta in prossimità
42 Il rilevo venne effettuato il 26/04/1904 da G. Canevazzi dell’Uffi-cio tecnico del Comune di Carpi (Archivio Storico del Comune di Carpi, Archivio Nuovo, b. b 9, fasc. 16). Cfr. fig. 2 per il posizionamento della struttura difensiva presso l’angolo sud-orientale del vecchio castrum.
43 Sulle vicende legate al rinvenimento si rimanda a Manicardi 2007, p. 67.
della torre, sul lato nord, potrebbero suggerire la presenza di una pusterla, un’apertura di ridotte dimensioni nelle mura. L’esistenza qui di un accesso parrebbe plausibile se consideriamo che lungo il lato orientale della cerchia muraria del castrum non è nota la presenza di porte. L’evidenza oggettiva dell’importanza del rinvenimento appare poi amplificata se lo si inserisce nel quadro generale delle fortificazioni bassomedievali di Carpi. Il lato esterno della torre angolare ha infatti orientamento simile, ruotato di circa 45° rispetto alle cortine, a quello della Torre del Passerino, che si trova al vertice opposto del circuito delle mura, la cui sistemanzione, o sarebbe meglio dire, il cui “apprestamento”, è attribuibile all’anno 1320. È forse possibile identificare queste strutture come parte della cosiddetta “Rocchetta”, nota attraverso la documentazione d’archivio, che si trovava, isolata da un fossato, a levante della porta meridionale del vecchio castrum, la porta di San Possidonio, opposta alla porta di San Pietro, i cui resti, muniti già nel corso del XII-XIII secolo, sono stati rinvenuti in occasione dell’allestimento dei locali della nuova biblioteca comunale nell’ex Ma-nifattura Loria44.
III.2 Passerino Bonacolsi e Manfredo I Pio: la nascita della signoria di Carpi e i sistemi di difesa
Un rinnovato interesse per la ristrutturazione e l’ag-giornamento dei sistemi difensivi esistenti in Italia set-tentrionale coincise con la nascita e l’affermazione delle signorie, a partire dai decenni centrali del XIII secolo (Betti 1993, p. 399). Un forte impulso in tal senso venne dato da Ezzelino da Romano (1194-1259), che introdusse sistematicamente la pratica di costruire fortezze all’inter-no delle mura delle città conquistate (Settia 1999, pp. 159-162). La fortificazione interna, denominata sovente girone/zirone (gironum)45, serviva per esercitare un forte controllo sull’abitato all’interno del quale sorgeva e so-prattutto sui residenti, specialmente quando riluttavano ad accettare un nuovo potere autocratico.
All’inizio del XIV secolo, in piena contesa politica, Carpi è ancora priva di una signoria stabile (Bonacini 2008, pp. 382-388). Fu così che non appena venne as-segnata a Rainaldo Bonacolsi, detto Passerino, nel 1320 fu iniziata la costruzione all’interno del castrum di un girone, di cui rimane la torre principale (mastio), che prese il nome dal Passerino46. Di questo intervento dá notizia Giovanni da Bazzano in un capitolo del Chroni-con Mutinense (Cronache 1888, p. 137 TB).
Il Bonacolsi non riuscì a conservare il potere e già nel 1327 Manfredo I Pio ottenne conferma del possesso di Carpi, che nel 1331 gli fu attribuita in feudo (Bonacini 2008, p. 384). Anch’egli l’anno seguente intraprese pron-tamente un progetto per il riassetto delle fortificazioni,
44 Desidero nuovamente ringraziare Lucia Armentano dell’Archivio Storico Comunale per la segnalazione riguardante i documenti d’ar-chivio, da lei in corso di studio. Per quanto riguarda i resti di porta San Pietro vedi Corti 2008.
45 Sul termine “girone” vedi Settia 1999, p. 160; per indicare situa-zioni in cui troviamo una “fortezza dentro la fortezza” possiamo trovare anche il termine “dongione” o “rocca” (Settia 1984, p. 470).
46 Settia 1999, p. 263, nota 90; Bonacini 2008, p. 387; Tosco 2008, p. 29.
358
NOTIZIE SCAVI E LAVORI SUL CAMPO
con la ricostruzione del circuito esterno delle cortine difensive47. Per costruirsi un solido consenso locale, il consolidamento della signoria fu portato avanti dalla casata anche attraverso un’oculata politica di alleanze matrimoniali. Manfredo I sposa nel 1306 Flandina Brocchi, ultima erede di una della più potenti famiglie carpigiane ed emancipata dal padre. Essa trasferì a Manfredo per testamento «omnem jurisdictionem et honoratiam Carpi» che le spettava come erede del padre Gandolfo48.
Dell’importanza di questo legame per radicare e legittimare il potere degli eredi di Manfredo a Carpi, è indiretta testimonianza l’adozione da parte dei Pio dell’impresa del “brocco fronzuto”, appartenente alla famiglia Brocchi, e soprattutto il suo ripetuto utilizzo nella decorazione pittorica della Rocca Nuova (ante 1375)49. L’impresa compare anche su ceramica graffita (vedi infra).
Per quanto riguarda la riorganizzazione delle difese del castrum assistiamo tra il 1320 e gli anni successivi al 1331 a importanti interventi. Le iniziative del Bona-colsi e di Manfredo I Pio paiono integrarsi a vicenda e rientrare, viste le caratteristiche ossidionali adottate con sistematicità (torri angolari ruotate di 45°), in un progetto di ristrutturazione che presenta caratteristiche di unitarietà.
III.3 Le difese del castrum nei decenni centrali della metà del XIV secolo: una prima sintesi
Il castrum di Carpi, attestato a partire dal 100150, nasce attorno alla pieve di Santa Maria51. Con la co-struzione della torre campanaria, tra il 1217 e il 1221, con chiara funzione difensiva e di controllo del territorio circostante, quali che fossero le motivazioni della sua erezione, viene ribadita la centralità della chiesa come matrice dell’insediamento fortificato ancora nel XIII secolo52.
Un sostanziale cambiamento nell’articolazione del-l’apparato difensivo del castrum avvenne invece con l’arrivo a Carpi di Passerino Bonacolsi, che si affrettò a costruirvi un girone. Il cambiamento di assetto per la vita del castrum e dei suoi abitanti non fu solo esteriore. A conferma di ciò, possono essere riportate le parole di Leon Battista Alberti, parafrasate da Aldo A. Settia: «Le difese di una città – consiglia Leon Battista Alberti
fig. 11 – Carpi, Palazzo Pio. Particolare del rilievo del piano terra comprendente la cosiddetta “Rocca Nuova”, la Torre dell’Uccelliera e l’Aggiunzione Estense, seconda metà XIX se-colo (da Garuti 1983). In evidenza, il perimetro esterno delle
strutture murarie attribuibili al girone bonacolsiano.
47 Garuti 1983, p. 14, nota 7; Corti 2006, p. 167, con bibliografia precedente; si vedano inoltre Armentano 2004, pp. 15-17 e Tosco 2008, pp. 29-30.
48 Bonacini 2008, p. 386; Andreolli 2008, p. 408; sulla natura delle prerogative signorili della famiglia Brocchi si veda Bonacini 2008, pp. 385-386.
49 Sulla dislocazione di questa impresa nei residui della decorazione parietale del castello si veda da ultimo Dieghi, Previdi, Rossi 2008, pp. 151-152, con bibliografia precedente.
50 Manaresi 1957, pp. 472-475, n. 265; vedi inoltre infra, para-grafo I.
51 In area rurale era la chiesa a fungere da primo rifugio in caso di pericolo e ciò in molti casi portò alla fortificazione del luogo in cui essa sorgeva (Settia 2001, p. 12).
52 Bonacini 2008, p. 366; sul ruolo di primo piano dei canonici carpigiani nella gestione del castrum tra la fine del dominio canossano (1115) e la supremazia del comune di Modena (1255) e, ancora, tra Due e Trecento vedi quanto osservato in Ghizzoni 2004a, pp. 23-25.
– è bene siano organizzate in ragione del tipo di dominio cui essa è soggetta: se colui che governa “è spinto dal desiderio di beneficare i cittadini non meno che dal suo tornaconto personale”, le fortificazioni saranno sempli-cemente rivolte contro i nemici esterni; se si tratta invece di personaggio cui i cittadini “debbono obbedire anche contro voglia”, egli dovrà munire la città considerando “i concittadini suoi nemici allo stesso modo degli stra-nieri”» (Settia 1999, p. 158).
Che il luogo necessitasse di interventi all’apparato difensivo generale appare comunque evidente già nel 1306, quando, nell’ambito delle lotte per la supremazia a Modena e nel suo territorio53, si decise di rafforzare e rifornire il castrum. Tuttavia, la mancanza di un potere stabile dovette allora lasciare inevasa la decisione.
Il girone del Bonacolsi era composto da almento tre torri con muro a scarpa e chiuso verso l’interno. Di esso è ancora conservato, inserito nelle successive trasformazioni del castello, il mastio (Torre del Passerino), ruotato di 45° e collocato presso l’angolo nord-occidentale del castrum. Altre due torri di dimensioni minori e ortogonali alle mura, che facevano parte di quella fortificazione, furono succes-sivamente inglobate nella Rocca Nuova trecentesca. Esse si trovavano presso l’angolo nord-est e sud-est del girone, come documenta una pianta del palazzo della seconda metà del XIX secolo (fig. 11), dove appare evidente, e non ancora del tutto alterato, il loro impianto54. Il muro orien-
53 In quell’occasione Egidio Pio, uno dei capi della fazione ghibellina dei Ghisolfi, Tommasino da Gorzano, Giovanni e Francesco Pico si allearono con il Comune di Bologna, Guido Bonacolsi e Alberto della Scala, signori rispettivamente di Mantova e Verona, contro Azzo VIII d’Este, per cacciarlo da Modena, Reggio e Carpi (Guaitoli 1877, pp. 43-44; inoltre, Bonacini 2008, nota 84 a pp. 380-381).
54 La presenza di queste torri è stata in passato attribuita a epoca precedente Passerino Bonacolsi (Spinelli 1906, pp. 76-77) o alla co-struzione della Rocca Nuova (Garuti 1983, pp. 16, 20, ripreso nella bibliografia posteriore).
359
NOTIZIE PRELIMINARI DALL’ITALIA
tale esterno, tra le due torri, presentava caditoie difensive sostenute da archetti a sesto acuto (Garuti 1983, p. 41, nota 11). Esso venne mantenuto come muro esterno del primitivo nucleo della Rocca Nuova. È stato inoltre rileva-to come la parete occidentale della Rocca Nuova, visibile nel cortiletto interno di accesso alla Torre del Passerino, abbia conservato tracce evidenti delle profonde modifiche subite (finestre tamponate, caminetti demoliti, logge, locali e tetti abbattuti) (Lugli 2005, pp. 65-67; Garuti 1983, p. 16). In particolare, al margine meridionale risulta evidente la presenza di uno spesso muro di cortina, di circa 1 m, malamente livellato, con camminamento di ronda. Esso doveva chiudere il lato meridionale del girone.
Il barbacane rinvenuto durante lo scavo del cortile interno della Torre dell’Uccelliera e la torre rinvenuta durante l’atterramento del bastione all’angolo sud-est dell’antico castrum dovevano invece far parte integran-te del circuito esterno. Questa seconda torre si trovava presso la cosiddetta Rocchetta, le cui caratteristiche strutturali, per ora, in gran parte ci sfuggono. La rota-zione di 45° rispetto alle mura pone queste due torri in stretta relazione funzionale e cronologica con la Torre del Passerino. Esse sono attribuibili a un progetto unita-rio di ristrutturazione, che va a integrarsi con il girone, inquadrabile tra il 1320 e la metà del secolo.
BIBLIOGRAFIA
Andreolli B., 2008, Dai ‘Figli di Manfredo’ ai Pio: genesi di una signoria, in Storia di Carpi 2008, pp. 395-412.
Armentano L., 2004, Tracce di cultura astrologica alla corte dei Pio, in Teatro del cielo e della terra, Carpi (MO), pp. 15-22.
Betti F., 1993, voce Castello-Italia, in Enciclopedia dell’arte medievale, IV, Roma.
Bocchi F., 1986, Carpi, in Atlante storico delle città italia-ne, a cura di F. Bocchi, E. Guidoni (Emilia-Romagna, 1), Bologna.
Bonacini P., 2008, Il governo del comune cittadino tra Due e Trecento, in Storia di Carpi 2008, pp. 353-394.
Cartografia urbana 1987 = Cartografia urbana di Carpi (secoli XV-XX). Lettura storico-morfologica dello sviluppo della città, Carpi.
Cassi Ramelli A., 1964, Dalle caverne ai rifugi blindati. Trenta secoli di architettura militare, Milano.
Corti C., 2002, Antiche chiese del Carpigiano tra Tardoantico e Altomedioevo, in Pagani e cristiani. Forme e attestazioni di religiosità del mondo antico in Emilia, II, a cura di C. Corti, D. Neri, P. Pancaldi, Bologna, pp. 95-130.
Corti C., 2006, Le fortificazioni del castrum Carpense. Lo scavo archeologico presso l’Ex Manifattura Loria di Carpi: notizia preliminare, «Taccuini d’arte», 1, pp. 65-71.
Corti C., 2008, Tracce delle difese del castrum Carpense nei recenti rinvenimenti archeologici, in Storia di Carpi 2008, pp. 461-468.
Corti C., 2010, Carpi, Torre dell’Uccelliera. Torre difensiva medievale e vasca rinascimentale, «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Mo-denesi», serie XI, XXII, pp. 357-359.
Cronache 1888 = Cronache modenesi di Alessandro Tassoni, di Giovanni da Bazzano e di Bonifazio Morano, ed. L. Vischi, T. Sandonnini, O. Raselli, Monumenti di Storia Patria delle Provincie Modenesi. Serie delle cronache 15, Modena.
Dieghi C., Previdi T., Rossi M., 2008, L’apparato decorativo di Palazzo Pio, in Il palazzo dei Pio 2008, pp. 151-203.
Ferrari C., Garuti A., Ontani A., 1984, Carpi la Chiesa della Sagra, Modena.
Folin M., 2008, Nei palazzi quattrocenteschi dei Pio: apparati decorativi e organizzazione degli spazi di corte, in Il palazzo dei Pio 2008, pp. 51-59.
Fortificazioni 1998 = Fortificazioni altomedievali in terra e legno, Atti del convegno nazionale (Pieve di Cento 1996), Castella 60, Padova.
Frison C., 1984, La pieve “sita in castro Carpense”, in Ricerche archeologiche nel Carpigiano, Modena, pp. 162-166.
Garuti A., 1983, Il palazzo dei Pio di Savoia nel “castello” di Carpi, Modena.
Gelichi S., Librenti M., 1997, Ceramiche postmedievali in Emilia Romagna, in Archeologia postmedievale: l’espe-rienza europea e l’Italia, a cura di M. Milanese, Atti del convegno nazionale di studi (Sassari 1994), «Archeologia Postmedievale», 1, pp. 185-229.
Gelichi S., Librenti M., 2008, Carpi nell’alto medioevo. Il contributo dell’archeologia alla storia del popolamento, in Storia di Carpi 2008, pp. 209-230.
Ghizzoni M., 1997, La pietra forte. Carpi: città e cantieri alle fortificazioni (XII-XVIII secolo), Casalecchio di Reno (Bo).
Ghizzoni M., 2004a, Appunti per una storia della topografia ecclesiastica carpigiana in età medievale, in Chiese di Carpi tra arte, storia e topografia urbana, Modena, pp. 7-73.
Ghizzoni M. 2004b, Ordinamenti politici e strategie signorili: note di storia urbanistica carpigiana tra Medioevo e Rinasci-mento, in L’ambizione di essere città. Piccoli, grandi centri dell’Italia rinascimentale, a cura di E. Svalduz, Venezia, pp. 121-153.
Ghizzoni M., Svalduz E., 2008, Le residenze dei Pio e il catasto del 1472, in Il palazzo dei Pio 2008, pp. 61-69.
Goldoni M., 2008, Il Torrione di Galasso, in Il palazzo dei Pio 2008, pp. 45-49.
Guaitoli P., 1877, Descrizione del Castello murato di Carpi nell’anno 1472, «Memorie storiche e documenti sulla città e sull’antico principato di Carpi», I, pp. 42-50.
Il palazzo dei Pio 2008 = Il palazzo dei Pio a Carpi. Sette secoli di architettura e arte, a cura di M. Rossi, E. Svalduz, Venezia.
Librenti M., 1987, Ricognizioni archeologiche in alcuni inse-diamenti medievali tra Sillaro e Quaderna, in Insediamenti medievali nella pianura tra Sillaro e Quaderna, Casalecchio di Reno (Bo), pp. 35-65.
Librenti M., 1996, Il territorio di Castel S. Pietro ed il Bo-lognese orientale in età medievale. Le fonti archeologiche, in Castel S. Pietro e il territorio claternate. Archeologia e documenti, a cura di J. Ortalli, Castel S. Pietro Terme (Bo), pp. 253-288.
Lugli F., 2005, I numeri raccontano Carpi. Uno studio di archeologia della misura, Carpi (Mo).
Manaresi C., 1957, I placiti del “regnum Italiae”, II, 1, Roma.
Manicardi A., 2007, Cenni storici sull’abbattimento delle mura di Carpi, in Luci e ombre nel passaggio del secolo a Carpi. Uomini, opere e istituzioni tra ’800 e ’900, a cura di A.M. Ori, C. Tamagnini, Carpi (Mo), pp. 58-69.
Materiali 1977 = Materiali per una storia urbana di Carpi, a cura di A. Garuti, F. Magnanini, V. Savi, Catalogo della mostra, Modena.
Nepoti S., 1991, Ceramiche graffite della donazione Donini Baer, Faenza (Ra).
Nepoti S., 2008, Le ceramiche della Rocca, in S. Nepoti, M. Severi, Le ceramiche della Rocca di San Martino in Rio, San Martino in Rio (Re), pp. 23-120.
360
NOTIZIE SCAVI E LAVORI SUL CAMPO
Ori A.M., 2009, A proposito dei Pio…, in Storia di Carpi, II, La città e il territorio dai Pio agli Estensi (secc. XIV-XVIII), a cura di M. Cattini, A.M. Ori, Modena, pp. 451-458.
Ravanelli Guidotti C., 2004, Antiche ceramiche a Rubiera, Montorio (VR).
Ricetti e recinti fortificati 2001 = Ricetti e recinti fortificati nel basso Medioevo, Atti del Convegno (Torino 1999), a cura di R. Bordone, M. Viglino Davico, Torino.
Semper H., 1999, Carpi. Una sede principesca del Rinasci-mento, rilievi e disegni di F.O. Schulze e W. Barth (Dresda 1992), a cura di L. Giordano, Pisa.
Settia A.A., 1984, Castelli e villaggi nell’Italia padana. Popo-lamento, potere e sicurezza fra IX e XIII secolo, Napoli.
Settia A.A., 1999, Proteggere e dominare. Fortificazioni e popolamento nell’Italia Medievale, Roma.
Settia A.A., 2001, “Ricetti”, “bastite”, “cortine”: fortificazioni di Rifugio nell’Italia medievale, in Ricetti e recinti fortificati 2001, p. 11 ss.
Spinelli A.G., 1906, Le Motte e Castel Crescente nel Mode-nese, Pontassieve.
Storia di Carpi 2008 = Storia di Carpi, I, La città e il territorio dalle origini all’affermazione dei Pio, a cura di P. Bonacini, A.M. Ori, Modena.
Svalduz E., 2008, “Fabbriche infinite”: il palazzo di Alberto Pio, in Il palazzo dei Pio 2008, pp. 71-115.
Tosco C., 2001, Il recinto fortificato e la torre: sviluppi di un sistema difensivo nel basso Medioevo, in Ricetti e recinti fortificati 2001, pp. 77-98.
Tosco C., 2008, Memoria e architettura: dalla pieve al castello di Carpi, in Il palazzo dei Pio 2008, pp. 17-33.