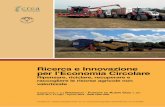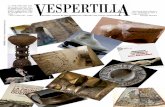L’arte Maya del Periodo Classico e il posizionamento spaziale del passato
Navigare nel passato Problemi della ricerca archivistica in Internet
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Navigare nel passato Problemi della ricerca archivistica in Internet
181
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
Contemporanea / a. IV, n. 2, aprile 2001
Le frequenti e dettagliate rassegne delle risorse on line a disposi-zione dello studioso di storia ne segnalano una costante crescita edifferenziazione1. Anche in quest’ambito, come ovunque in Internet,i soggetti responsabili dei siti web sono molteplici e di diversa natu-ra. Comprendono istituzioni pubbliche, enti di ricerca affermati ericonosciuti, associazioni private, gruppi amatoriali e singoli indivi-dui. Fra questi soggetti, le istituzioni archivistiche hanno ormai con-solidato forme di presenza significative, il cui potenziale rilievo percoloro che utilizzano Internet all’interno della propria attività di ri-cerca storica è difficile sottovalutare, trattandosi di istituzioni checonservano e mettono a disposizione del pubblico la parte più cospi-cua delle fonti documentarie ereditate dal passato – e ciò è tanto piùvero per gli archivi di stato nazionali o centrali e per quelli periferici,che vantano una storia spesso ultrasecolare2. È per questo che lescelte compiute e le metodologie adottate possono non essere indif-
Navigare nel passatoProblemi della ricerca archivistica in Internet
Stefano Vitali
Questo saggio costituisce una rielaborazione delle relazioni presentate al conve-gno SISSCO «Linguaggi e siti: la storia on line» (Università Europea di Fiesole, 6-7aprile 2000) e al seminario «Archivi storici e archivi digitali tra ricerca e comunicazio-ne» (Dipartimento di Storia dell’Università di Firenze, 20-21 ottobre 2000). Ringraziovivamente Isabella Zanni Rosiello che ne ha letto una prima stesura ed è stata prodigadi critiche costruttive ed importanti spunti di riflessione. I siti web citati sono staticontrollati il 10 gennaio 2001. La traduzione dei documenti in lingua diversa dall’ita-liano sono a cura dell’autore.
1 Per una rassegna generale delle tipologie di risorse on line e delle problematicheconnesse cfr.: G. Abbattista, Ricerca storica e telematica in Italia. Un bilancio provviso-rio, Cromohs, 4 (1999), <http://www.unifi.it/riviste/cromohs/4_99/abba.html>; cfr.anche: History Highway 2000. A Guide to Internet Resources, a cura di Dennis A.Trinkle e Scott A. Merriman, Armonk, N.Y., M.E. Sharpe, 2000.2 Siti di istituzioni archivistiche di tutto il mondo sono elencati a cura di TerryAbraham dell’Università dell’Idaho, nel sito «Repositories of Primary Sources»,<http://www.uidaho.edu/special-collections/Other.Repositories.html>; altra risorsache guida, in modo ragionato, all’accesso a siti archivistici è l’Unesco Archives Portal,<http://www.unesco.org/webworld/portal_archives/>.
182
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
ferenti nel condizionare i tempi e i modi di quelle trasformazioni, cuianche il mestiere di storico sembra destinato ad essere sottopostodai processi di sviluppo delle nuove tecnologie dell’informazione3.
Delle aree sulle quali si distribuiscono i «servizi» on line forniti daisiti archivistici (a) informazioni istituzionali sulla vita, le attività, iprogetti scientifici, le condizioni di accesso alla documentazione,ecc.; b) strumenti di ricerca e di accesso ai fondi archivistici conser-vati; c) riproduzione digitale di documenti; d) iniziative di valorizza-zione, quali mostre «virtuali» e sezioni didattiche on line) sono certa-mente la seconda e la terza che possono avere le maggiori ricadutein termini di conoscibilità e di accessibilità delle fonti storiche e che,pertanto, sono destinate ad avere le maggiori ripercussioni sul lavo-ro dello storico. È proprio sui caratteri degli strumenti di ricerca online e sulle strategie di riproduzione digitale di documentazione ar-chivistica che intendiamo svolgere di seguito qualche riflessione.
Immagini o fonti digitali?
È probabilmente sul fronte della riproduzione digitale di docu-mentazione archivistica che si concentrano le maggiori aspettative,non foss’altro perché attraverso la consultazione a distanza l’archi-vio sembra arrivare direttamente sulla scrivania del ricercatore erealizzare il sogno, probabilmente sempre coltivato nell’immagina-rio dello storico, di fare dell’archivio una sorta di accessorio del suopersonale laboratorio. D’altronde che una tale finalità sia considera-ta particolarmente congeniale alla spiccata multimedialità di Inter-net appare confermato dalla crescente offerta di riproduzioni digitalidi documenti all’interno dei siti archivistici europei ed americani.Da questa proliferazione documentaria sul web si potrebbe ricavarel’impressione che ci si trovi davvero di fronte ad un processo irrever-sibile di trasferimento di interi patrimoni archivistici dai tradizionalisupporti cartacei a quelli elettronici. Una più puntuale verifica diquell’offerta conduce, tuttavia, a smorzare i toni ottimistici e a porsi
3 Vari spunti di riflessione su questo tema in P. Ortoleva, Presi nella rete? Circolazionedel sapere storico e tecnologie informatiche, in Storia & Computer. Alla ricerca del pas-sato con l’informatica, a cura di S. Soldani e L. Tomassini, Milano, Bruno Mondadori,1996, pp. 64-82. Cfr. anche il «Dossier dell’Indice», Il documento immateriale. Ricercastorica e nuovi linguaggi, a cura di G. Abbattista e A. Zorzi, «L’Indice dei libri delmese», n. 5, maggio 2000, per l’edizione elettronica, <http://lastoria.unipv.it/dossier/index.htm>.
183
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
piuttosto qualche domanda su quali sono i criteri e le strategie chesovrintendono oggi a quel trasferimento.
Un primo elemento di riflessione è costituito dal fatto che fra letipologie di documenti riprodotti sono largamente privilegiati i mate-riali grafici (fotografie, carte geografiche, mappe, ecc.) piuttosto chequelli testuali di tipo tradizionale. A ciò indubbiamente contribuisceproprio il carattere multimediale del mezzo, che fa sì che i materialigrafici, possibilmente a colori ed esteticamente appetibili, abbiano unrichiamo maggiore rispetto al grigiore dei testi scritti. Inoltre, a benvedere, una parte notevole dei documenti riprodotti sono collocati al-l’interno delle sezioni dei siti web riservati alle cosiddette mostre vir-tuali, sia permanenti che temporanee oppure a quelle dedicate all’of-ferta di materiali destinati all’insegnamento della storia. Ciò implicache la pubblicazione on line di documentazione archivistica finisceper privilegiare documenti carichi di forti significati simbolici, capacidi rappresentare momenti, eventi o valori altamente evocativi. Inoltre,il materiale è in genere estratto dal contesto archivistico di apparte-nenza o presentato con scarsi o labili riferimenti ad esso.
Impostazioni di questo genere caratterizzano anche molti progettidi una certa ampiezza portati avanti da istituzioni archivistiche nor-damericane ed australiane, spesso direttamente col sostegno e l’in-coraggiamento dei rispettivi governi. Ad esempio i National Archivesdi Washington, oltre ad ospitare nel proprio sito corpose esibizionipermanenti e temporanee ed una scelta di documenti per fini didat-tici, stanno realizzando un progetto per la digitalizzazione di 200.000documenti, da rendere accessibili on line. I criteri di selezione diquesti documenti sono assai significativi: insistono sulla preferenzada dare a materiali che dimostrino «i diritti dei cittadini americani, leattività dei funzionari federali, e l’esperienza della nazione e [che]abbiano un ampio richiamo geografico, cronologico, culturale e te-matico», danno la netta priorità a documenti iconografici quali «ma-teriali grafici (poster e lavori artistici), mappe e disegni architettoni-ci, fotografie», oltre a «registrazioni sonore» e solo in ultima battutafanno riferimento a «documenti testuali». Le NARA Guidelines forDigitizing Archival Materials for Electronic Access4 segnalano qualiesempi di tipologie di documenti da digitalizzare:
4 NARA Guidelines for Digitizing Archival Materials for Electronic Access, <http://www.nara.gov/nara/vision/eap/eapspec.html>.
184
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
documenti presidenziali, comprendenti la corrispondenza fra FranklinD. Roosevelt e Giuseppe Stalin all’epoca della Seconda guerra mondiale; ildiscorso alle truppe di Dwight D. Eisenhower prima dello sbarco del D-day,e il suo messaggio «In caso di fallimento» [...]; mappe relative alle battagliedella Guerra civile, all’esplorazione dell’Ovest e alla vendita del demaniopubblico; fotografie significative quali foto panoramiche delle foreste nazio-nali [...], immagini di John K. Hillers, Jr di delegazioni e villaggi degli indianid’America, fotografie di Mathew Brady di personalità e scene della Guerracivile [...].
Più che degli storici, più o meno di professione, scelte di questogenere tengono conto di altre tipologie di utenti quali, ad esempio,giornalisti, architetti, pianificatori urbani, o professionisti della co-municazione interessati ad un possibile sfruttamento commercialedi materiali iconografici. Ma si rivolgono anche ad un pubblico total-mente nuovo e tipico di Internet, animato, probabilmente, da ridottemotivazioni culturali, ma da curiosità di altro genere, il pubblico co-stituito dai «surfisti» del web, i quali, come ha, recentemente, sottoli-neato un’archivista olandese nel corso della presentazione del sitoweb degli archivi municipali di Amsterdam, «nel corso dei [loro]viaggi giornalieri sul worldwideweb, sono in cerca di avventure, di-vertimento, affari». Per loro sono, soprattutto, pensate le pagine dedi-cate ad esposizioni virtuali a riproduzioni di documentazione icono-grafica e, talvolta, sonora. Come ha spiegato ancora con efficacia lastessa archivista, a tali «navigatori» è dedicata una parte consistentedel sito degli Archivi della capitale olandese:
[il surfista] è sorpreso di vedere sul nostro sito web un film con WinstonChurchill durante un giro per canali di Amsterdam, ride quando sente gliuccelli che cercano di sopraffare con il loro canto le campane della famosaWest Church e è contento di poter ordinare una fotografia della vecchia Am-sterdam da regalare a sua zia per il suo compleanno la settimana dopo [...]5.
Questa attenzione ad un pubblico non tradizionale è indizio difenomeni che si riflettono anche nei siti Internet delle istituzioni ar-chivistiche, ma le cui radici sono altrove, in trasformazioni più com-plessive che coinvolgono l’identità degli archivi all’interno del mon-
5 E. Fleurbaay, Structure and content of the New Website of the Amsterdam Archives, inAtti del Summit Dace- Archivio Storico Capitolino, Roma 24-27 marzo 2000, Bergamo-Roma, Associazione Giovanni Secco Suardo, 2000, p. 39.
185
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
do contemporaneo e quella che potrebbe definirsi come la loro «fun-zione sociale». Per condensare questo processo in una battuta, si po-trebbe dire che il referente degli Archivi, il loro interlocutore princi-pale sempre meno è il mondo degli storici «accademici» e semprepiù invece è un’udienza non specialistica, sono in particolare i cosid-detti «genealogisti» che conducono ricerche su origini e storia dellefamiglie. Sempre meno (almeno in proporzione) agli Archivi si ri-volge la ricerca storica tradizionale e sempre più, invece, essi diven-tano strumenti di costruzione, recupero, conservazione di forme dimemoria, tradizionali o nuove, individuali o collettive. Queste ten-denze, che all’estero hanno raggiunto dimensioni formidabili6 e chestanno diventando ben visibili anche in Italia7 sembrano trovare inInternet un terreno privilegiato per manifestarsi proprio per il carat-tere tendenzialmente di massa del mezzo. È così che i siti web sem-pre più propongono strumenti rivolti espressamente (o almenoprincipalmente) a questo tipo di pubblico, come, tanto per citare unesempio, è stato fatto dai National Archives del Canada attraverso lamessa a disposizione on line di banche dati quale quella relativa alcensimento dello stato dell’Ontario del 18718 – non a caso predispo-sta in collaborazione con la Ontario Genealogical Society – e quelladei circa seicentomila soldati che hanno fatto parte del Corpo di spe-dizione canadese nel corso della prima guerra mondiale, affiancatadalla riproduzione digitale dei moduli di giuramento, compilati dal-le reclute all’atto del loro arruolamento. Di questa ultima iniziativanon deve, ancora un volta, sfuggire il valore simbolico, essendo lapartecipazione alla prima guerra mondiale considerata l’episodiochiave per la fondazione dell’identità nazionale canadese9.
6 In un intervento tenuto al Congresso dell’Australian Society of Archivists lo scorsoagosto, un’archivista del Public Record Office londinese ha segnalato come nel 1999gli interessi dei visitatori di quell’archivio si distribuissero secondo le seguenti per-centuali: interesse personale, compresa la storia della famiglia, 76%; settore educati-vo, 9%; ricercatori professionali, 7%; altri, 8%: cfr. E. Hallam Smith, Lost in Cyberspace:Have Archives a Future?, <http://www.archivists.org.au/whatsnew.html>.7 Secondo rilevazioni del 1996, le percentuali dei frequentatori della sala di studiodell’Archivio di Stato di Firenze erano le seguenti: ricercatori professionali (docentiuniversitari, funzionari del Ministero per i beni culturali, ecc.) 35%; studenti e laure-andi, 26%; ricercatori non professionali e per interesse personale, 40%: cfr.: I. Cotta,L’Archivio di Stato di Firenze e il suo pubblico, di prossima pubblicazione negli atti delconvegno Dalla carta alle reti.8 <http://www.archives.ca/02/020108_e.html>.9 <http://www.archives.ca/02/020106_e.html>. Sulla «costruzione» della memoriadella prima guerra mondiale in Canada attraverso gli archivi, cfr.: R. McIntosh, The
186
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
Spesso, perciò, è proprio in riferimento a questo pubblico che i pro-getti digitalizzazione sono portati avanti e pubblicizzati. Affiancati aconsimili iniziative in ambito bibliotecario o più latamente culturale,se ne sottolinea la portata tendenzialmente democratica, quali stru-menti per offrire ai cittadini un ampio, libero e generalizzato accessoal patrimonio archivistico della nazione10. In realtà, come è piuttostoovvio e come è stato efficacemente dimostrato da un dibattito svoltosinella lista degli archivisti canadesi (Arcan-l) all’inizio del 2000 a pro-posito degli ambiziosi progetti di digitalizzazione perseguiti dal gover-no di quel paese con l’intento di democratizzare l’accesso dei cittadinial patrimonio culturale nazionale11, i costi della digitalizzazione sonotalmente alti – comprendendo non solo l’investimento iniziale, maanche la spesa per contrastare, attraverso onerose migrazioni periodi-che, la rapida obsolescenza degli ambienti hardware e software e de-gli stessi supporti – che la sua realizzazione su basi realmente di mas-sa richiederebbe necessariamente l’intervento del settore privato, conconseguente introduzione di servizi a pagamento e quindi di discrimi-nazioni nell’accesso, piuttosto che la sua democratizzazione12. Variarchivisti hanno sostenuto, piuttosto, che l’obiettivo primario dovreb-be essere quello di far conoscere quali risorse culturali esistono, dovesono dislocate e come si può avere accesso ad esse:
abbiamo bisogno di conoscere prima quali risorse culturali possediamo[...] – ha scritto ad esempio Kent Haworth dell’Università di York, Toronto –dove sono conservate, e come tutti i canadesi possono avere accesso ad esse.Solo dopo che questo compito principale è stato assolto, dovremmo comin-ciare a prendere in considerazione progetti di digitalizzazione su basi moltoselettive13.
Great War, Archives, and Modern Memory, in «Archivaria», n. 46, Fall 1998, pp. 1-31, p.18 per i riferimenti alle iniziative sul sito web. Nel primo anno dalla pubblicazione online la banca dati è stata interrogata da circa mezzo milione di visitatori.10 Uscendo dall’ambito delle istituzioni archivistiche, particolarmente esemplificatividi una impostazione del genere appaiono operazioni come il sito della Library of Con-gress «American Memory», <http://memory.loc.gov/ammem/ammemhome.html>, op-pure quello sponsorizzato direttamente dal governo canadese, «Canada’s Digital Collec-tion», <http://collections.ic.gc.ca>.11 Per questi progetti, in riferimento agli archivi, cfr.: E. Krug, Canada’s Digital Collec-tions: Sharing the Canadian Identity on the Internet, <http://www.archives.ca/04/042419_e.html>.12 Cfr. la discussione svoltasi su Arcan-l ([email protected]) fral’11 e il 16 gennaio 2000.13 Cfr. il messaggio di Kent Haworth ([email protected]), 11 gennaio 2000, subject:«Fwd: CBC Commentary». La sottolineatura è nell’originale.
187
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
In effetti, di fronte allo sterminato patrimonio archivistico carta-ceo ereditato dai secoli passati – compreso quello di per sé immensodel secolo appena spirato – una strategia di riproduzione digitale chesia basata su precise scelte di priorità, che sia quindi, appunto «moltoselettiva», è l’unica ipotizzabile. Ciò non è vero soltanto come astrattaaffermazione di buon senso, ma è vero anche nella pratica, nel sensoche i progetti di digitalizzazione oggi realizzati, sono e non possonoche esserlo, su basi fortemente selettive.
Come avvenga la selezione in buona parte dei casi lo si è accenna-to. Si privilegiano scelte di documenti particolarmente significativiod evocativi, ritenuti più rappresentativi rispetto alle finalità che sivogliono raggiungere o all’immagine del passato che ci si propone dielaborare. La conseguenza è che, piuttosto che offrire fonti da sotto-porre all’interpretazione storiografica, si propongono spesso narra-zioni storiche attraverso i documenti che tendono a farsi veicolo diuna determinata visione del passato, una visione a tema, spesso adesplicito contenuto civile, talvolta non esente da una certa ideologiz-zazione. Un coerente esempio di ciò è costituito da sito «Documen-ting a Democracy. Australia’s story», frutto della collaborazione divari archivi australiani, compreso il National Archives of Australia.Fra le sue finalità esso rivendica, ad esempio
uno scopo ambizioso – tracciare lo sviluppo della democrazia australia-na attraverso i documenti chiave che indicano il sentiero costituzionale, in-trapreso finora [...]. Raccolti in questo sito web vi sono nuclei di documentiche raccontano la storia della democrazia australiana Essi sono stati sceltiperché ciascuno è importante per le nostre vite oggi. [...] La democrazia au-straliana funziona grazie ai suoi strumenti giuridici. L’Australia è una demo-crazia documentaria – noi possiamo raccontare la storia del nostro paese,risalendo ai documenti che danno ai nostri governi il diritto di governare14.
Un indirizzo diverso è invece quello tentato da altri progetti quali,per fare degli esempi, la pubblicazione on line della riproduzionedigitale dello Stadtarchiv di Duderstadt15 oppure dell’Archivio Medi-
14 «Documenting a Democracy. Australia’s story», <http://www.foundingdocs.gov.au/home.htm>. Per la citazione cfr. la presentazione del sito, <http://www.found-ingdocs.gov.au/site/intro.htm>.15 Si tratta di un progetto coordinato da Manfred Thaller relativo alla documentazio-ne fino al 1650 conservata nell’archivio comunale della piccola città vicino a Gottinga,<http://adyton.phil.uni-erlangen.de/~p1ges/reimers/fricke/duderstadt/dud-d.htm>.
188
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
ceo del Principato conservato presso l’Archivio di Stato di Firenze16,che si sono proposti di offrire non tanto delle pure e semplici imma-gini di documenti ma delle fonti documentarie che, attraverso unadifesa del contesto archivistico nel quale sono incardinate, conservi-no tutto lo spessore storico e la polisemia che sono loro proprie. Inquesto caso si sono digitalizzati interi fondi (o parti omogenee e si-gnificative) e si è operato per cercare di rendere trasparenti le strut-ture all’interno delle quali la documentazione cartacea è organizza-ta, a partire da quelle elementari, come il fascicolo, la busta, la filza,a quelle più complesse, come la serie e, ovviamente, il fondo affinchésia sempre possibile riconoscere nell’immagine sullo schermo undocumento archivistico, che fa parte di aggregazioni più ampie checontribuiscono ad arricchirlo di significati.
Certo, anche all’origine di questi ultimi progetti non vi possononon essere scelte basate su un qualche criterio che individui i fondida riprodurre all’interno di un quadro di possibilità che è teorica-mente enorme: basti pensare al fatto che rispetto ai più di 70 chilo-metri di materiale documentario conservato presso l’Archivio di Sta-to di Firenze il Mediceo avanti il Principato non occupa che pochimetri. È inevitabile che in casi come questo la scelta finisca per esse-re guidata, se non in un certo senso imposta, dalla storia e dalla tra-dizione: essa tenderà a cadere sui fondi che si trovano in miglioricondizioni di ordinamento e che sono dotati di inventari analitici,possibilmente a stampa come è appunto il caso del Mediceo avanti ilPrincipato, attraverso i quali offrire quella descrizione dettagliatafino al documento che è necessaria per operazioni di questo genere,fondi sui quali si è anche concentrato, nel corso del tempo, un inte-resse storiografico esteso e profondo, che la stessa riproduzione digi-tale può contribuire a confermare e consolidare, nonostante le pos-sibili flessioni legate al mutare degli indirizzi storiografici17.
16 <http://www.archiviodistato.firenze.it/Map/>. Per i caratteri del progetto cfr. F.Klein, Una fonte documentaria on line: il Mediceo avanti il Principato, in «I Medici inrete: ricerca e progettualità scientifica a proposito dell’archivio Mediceo avanti il Principa-to», Firenze, 18-19 settembre 2000, <http://www.archiviodistato.firenze.it/atti_map/>.17 Per la flessione degli studi sul Rinascimento condotti presso l’Archivio di Stato diFirenze (passati dal 21% dei primi anni Novanta al 9% del 1999) cfr. I. Cotta, Il Medi-ceo avanti il Principato e ricerca: rilevazioni e riflessioni, in I Medici in rete, cit. Per unripensamento della categoria di «Rinascimento» all’interno di una delle storiografiepiù agguerrite sul tema, come quella americana, cfr. A. Molho, The Italian Renais-sance, Made in USA, in Imagined Histories. American Historians Interpret the Past, acura di A. Molho e G.S. Wood, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1998, pp.263-294.
189
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
Queste ultime considerazioni in realtà sollecitano un altro inter-rogativo: quali possono essere le conseguenze delle scelte, necessa-riamente selettive, di digitalizzazione del patrimonio archivistico,come, più in generale, di quello culturale? Notava qualche anno fal’autore di un’analisi dei caratteri salienti del fenomeno Internet chein una fase, come l’attuale, nella quale «si assiste a una intensa attivi-tà di trasferimento delle informazioni da supporti cartacei a supportimagnetici» si concorre anche «a stabilire ciò che dovrà essere ricor-dato [...] e cosa no», a fissare i confini fra la memoria e l’oblio:
L’esito della contesa tra digitale e analogico inciderà sulla storia come unarivoluzione. È un momento propizio per cancellare archivi, cancellare cultu-re, fare roghi di libri senza nemmeno toccarli, inventarsi una tradizione18.
Si tratta di una diagnosi, probabilmente, eccessivamente allarma-ta. Ma certo la presenza o meno sul web può contribuire ad accre-scere o, alternativamente, a ridurre la «visibilità» di una determinatafonte e ad incoraggiare, o dissuadere, il ricorso ad essa. Può condi-zionare quindi i percorsi di ricerca e, se non la conoscibilità, almenola conoscenza effettiva del passato. Sta a chi il passato vuole real-mente conoscere essere ben cosciente che ciò che gli arriva diretta-mente sulla scrivania non è che una parte limitatissima di ciò che ilpassato ha tramandato. D’altronde, c’è un rischio esattamente oppo-sto a quello indicato da De Carli: il rischio cioè che l’oblio non derividal restare al di qua della soglia digitale, quanto piuttosto dal varcar-la con eccessivo entusiasmo, non tenendo conto della fragilità deisupporti cui le memorie elettroniche sono affidate.
Dalla carta al «digitale»: gli strumenti di ricerca on line
Per poter essere consultati gli archivi, digitali o cartacei che siano,devono essere forniti di strumenti di accesso, devono essere in qual-che modo descritti. E, come ci ricordavano più sopra gli archivisticanadesi, Internet può essere un ottimo strumento per far conoscerequali fondi sono conservati in quali archivi. Ma comunicare descri-zioni archivistiche attraverso Internet non è la medesima cosa chefarlo con i tradizionali strumenti cartacei. Si tratta di un dato cheemerge con chiarezza navigando fra i siti web delle istituzioni archi-
18 L. De Carli, Internet. Memoria e oblio, Torino, Bollati Boringhieri, 1997, pp. 123-124.
190
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
vistiche di tutto il mondo. Colpisce immediatamente la varietà di ti-pologia e di struttura degli strumenti di ricerca in cui ci si può imbat-tere e che risulta particolarmente ampia se posta a confronto conquanto accade in ambiti relativamente vicini, come, ad esempio lebiblioteche dove tale diversificazione è molto minore o non esisteaffatto. Le modalità di ricerca negli OPAC bibliografici possono com-binarsi secondo soluzioni più o meno raffinate, ma nella sostanzaesse danno accesso ad un’unica tipologia di strumento per la ricercaon line del materiale bibliografico e cioè la banca dati catalografica,che a sua volta riproduce abbastanza fedelmente nel nuovo ambien-te elettronico la struttura del tradizionale schedario cartaceo. Il pa-norama degli strumenti di ricerca archivistici attualmente presention line è invece alquanto articolato e non sempre si dimostra sempli-ce stabilire corrispondenze fra i nuovi prodotti digitali e i tradizionalistrumenti cartacei19.
Questa varietà è indizio di come il passaggio dal supporto carta-ceo a quello elettronico non possa avvenire senza trasformazioni piùo meno consistenti nelle pratiche descrittive. Anche in questo, comein molti altri casi, il mezzo condiziona fortemente la struttura e icontenuti delle informazioni. Lo stesso contesto nel quale si verifica
19 Schematizzando molto, tali prodotti potrebbero essere distribuiti nelle tre seguenticategorie principali, articolate a loro volta in talune sottocategorie: 1) Banche dati arestituzione dinamica dell’informazione, che comprendono: a) banche dati che de-scrivono vari fondi (ad esempio, quelli conservati in un’unica istituzione archivisticaoppure in una pluralità di istituti di conservazione dello stesso tipo o della medesimaarea geografica), con informazioni che si limitano al fondo o ai livelli immediatamen-te successivi (ad esempio le serie); b) banche dati che invece descrivono un fondo, oanche più fondi, nella sua o nella loro articolazione complessiva, includendo, oltrealle serie, anche «schede» (ovvero record) per ciascuna unità archivistica; mentre lebanche dati del tipo a) costituiscono una delle possibile forme di trasposizione inambiente digitale delle guide archivistiche di tipo tradizionale, quelle del tipo b) po-trebbero essere piuttosto assimilate agli inventari cartacei, con la non secondaria dif-ferenza che quasi mai questi ultimi contengono descrizioni di una pluralità di fondiarchivistici. 2) Strumenti di ricerca costituiti da pagine statiche in HTML oppure inEAD – su cui vedi più oltre – o in altri formati di codificazione digitale (ad esempio,PDF), che possono essere ricondotti alla tipologia della guida o, alternativamente,dell’inventario cartaceo, a seconda del loro contenuto descrittivo. 3) Infine, una com-binazione delle due categorie precedenti, rappresentata da banche dati che descrivo-no i livelli superiori (fondi e serie) e che restituiscono dinamicamente l’informazione(in genere in formato HTML) e che sono «linkate» a pagine statiche, per lo più inHTML, (ma talvolta anche a banche dati) che invece contengono le liste (o insieme direcord) di descrizioni delle unità archivistiche dei medesimi fondi e serie. In questocaso è più difficile trovare un preciso corrispettivo nel mondo «cartaceo», perchéun’esatta corrispondenza fra guide ed inventari è assai rara, trattandosi di strumentispesso ispirati da finalità diverse e redatti secondo criteri non sempre convergenti.
191
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
la comunicazione è, in Internet, profondamente diverso da quelloche in genere caratterizza il luogo tipico nel quale gli strumenti diricerca sono di solito utilizzati e per il quale sono in genere concepiti,cioè le sale di studio delle istituzioni archivistiche. La pubblicazionein linea di descrizione archivistiche non può fare affidamento sullamediazione fra documentazione, strumenti ed utente che è assicura-ta dall’interazione «faccia a faccia» fra archivista e ricercatore, attra-verso la quale è spesso veicolata informazione preziosa per l’indivi-duazione e il recupero della documentazione cercata. Ciò è partico-larmente vero in una situazione come quella italiana, dove frequen-temente l’accesso ai fondi conservati in istituzioni archivistiche chehanno una lunga storia alle loro spalle, come taluni Archivi di Stato,è reso possibile solo grazie ad una stratificazione secolare, se nonultrasecolare, di inventari, indici, repertori, regesti redatti per scopi esecondo metodologie talvolta assai distanti fra loro e che spesso ri-chiedono di essere «decodificati» da chi ne conosce approfondita-mente le chiavi.
Questi caratteri degli strumenti di ricerca utilizzati all’interno del-le sale di studio danno anche conto di come una loro pura e semplicetrasposizione in ambiente digitale sia raramente soddisfacente. Cisono dei casi, come il Public Record Office di Londra, in cui ciò èstato realizzato su grande scala, ma la situazione di partenza era ec-cezionalmente favorevole20. I tentativi compiuti nel nostro paese sisono invece dimostrati, per adesso, scarsamente convincenti21. Asconsigliare di procedere in questa direzione non vi sono, in questocaso, solo «le difficoltà che la difformità di linguaggio e di formati[delle descrizioni] frapporrebbero alla ricerca, con inevitabile gran-de presenza di “silenzio” e di “rumore”», ma vi è anche il rischio
20 Il progetto PROCAT ha previsto la riconversione elettronica e l’integrazione dellaPublic Record Office Guide (o Current Guide) – che contiene le informazioni di conte-sto (descrizione dei soggetti produttori, della struttura dei fondi e delle serie ecc.)relative ai circa 280 fondi (lettercodes nel gergo archivistico locale) e alle 15.500 serie(classes) – e degli 85 metri di inventari e liste cartacee che descrivono, secondo i fondie le serie di appartenenza, le singole unità archivistiche. Cfr.: <http://catalogue.pro.gov.uk/ListInt/Default.asp?>.21 La trascrizione degli inventari esistenti nella sale studio di alcuni Archivi di Statoitaliani è stata sperimentata sul sito dell’Amministrazione archivistica. Cfr. alcuniesempi nelle pagine relative agli Archivi di Stato di Napoli e Siena, <http://archivi.beniculturali.it/>. Tuttavia la pagina <http://archivi.beniculturali.it/Patrimo-nio/ricerca.html>, dalla quale si accedeva alla consultazione dell’insieme degli in-ventari trascritti è da qualche tempo in ristrutturazione, indizio forse, di un qualcheripensamento.
192
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
«della perdita delle informazioni indirette sulla natura di ogni singo-lo strumento e della stessa sua individualità di strumento redatto inuna determinata epoca e contesto»22.
Queste considerazioni possono valere meno per strumenti chesono concepiti fin dall’inizio per essere consultati a distanza, comegli inventari e le guide a stampa. Questi, almeno dal punto di vistadel linguaggio e dei contenuti, presentano in genere minori proble-mi per una loro trasposizione digitale, che è stata, in taluni casi, spe-rimentata anche nel nostro paese, vuoi attraverso la riproduzionedigitale23 vuoi attraverso il riversamento, indubbiamente più com-plesso e con risultati più discutibili, all’interno di una struttura dibanca dati24. Ma anche per gli strumenti a stampa, come d’altrondeper tutti gli altri, si pone il più generale problema, delle conoscenze,implicite e di background, che sono trasmesse dal modo stesso con ilquale l’informazione è strutturata, all’interno di un volume cartaceo,dalle convenzioni grafiche o tipografiche adottate, dalla sua specificaarticolazione e via dicendo25.
In realtà si tratta di una questione che è ben nota agli studiosi dicomunicazione: l’adozione di un nuovo media produce necessaria-mente una perdita di informazione. Il passaggio dall’oralità allascrittura comporta la perdita di tutte quelle informazioni «accesso-rie» che sono contenute nei gesti, nelle espressioni del volto, nell’in-tonazione della voce e così via. Ma comporta altresì dei vantaggi,ovvi e ben noti – quali la possibilità di tramandare i testi, riutilizzarliecc. – sui quali non vale la pena di soffermarsi. Questo principio valeanche nel nostro limitato ambito. Il passaggio dagli strumenti carta-cei a quelli informatizzati e on line – così come dal documento origi-nale alla sua riproduzione digitale – ha delle conseguenze positive (a
22 M. Savoja, Lo standard ISAAR come riferimento per la messa a punto di sistemiinformativi archivistici in «Bollettino d’informazioni», Centro di ricerche informaticheper i beni culturali della Scuola Normale Superiore di Pisa, IX (1999), n. 2, pp. 31-50.23 È questo il caso dell’inventario del Mediceo avanti il Principato (Archivio mediceoavanti il Principato. Inventario, a cura di A. Panella, F. Morandini, G. Pampaloni e A.D’Addario, vol. 4, Roma, Ministero dell’Interno 1951-1963) riprodotto come strumentodi accesso alla banca dati di immagini del fondo, cui si è fatto riferimento precedente-mente.24 I quattro volumi della Guida generale degli Archivi di Stato, voll. 4, Firenze, LeMonnier, 1981-1994 sono stati convertiti in una banca dati consultabile on line,<http://www.maas.ccr.it/cgi-win/h3.exe/aguida/findex_guida>.25 Su questi aspetti cfr. S.J. DeRose, Navigation, Access, and Control Using StructuredInformation, in «The American Archivist», vol. 60 (1997), n. 3, pp. 298-309, in partico-lare p. 300.
193
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
cominciare dalla più banale: la possibilità di una loro consultazionea distanza) ma implica anche dei costi in termini di potenziale scom-parsa di informazione.
Ciò significa che, per ridurre la perdita di questa informazionenon verbale, si dovrà quanto meno cercare di rendere esplicito ciòche è implicito, formalizzare flussi di conoscenze informali, raziona-lizzare procedure e comportamenti irriflessi e «spontanei», altri-menti c’è il forte rischio che lo stesso contenuto del «messaggio» siafortemente depauperato di senso, con una perdita secca dal punto divista del suo potenziale conoscitivo. Si tratta di problematiche chenon dovrebbero interessare soltanto gli addetti ai lavori, come gliarchivisti o gli informatici, ma anche coloro che agli strumenti diricerca e ai documenti si avvicinano in qualità di ricercatori o, comesi usa dire oggi con pessima espressione, di «utenti».
Un contesto irrinunciabile
Non è certamente una novità che le modalità di comunicazionecondizionino non solo i percorsi e i metodi per la ricerca delle infor-mazioni, ma anche la loro interpretazione e il complesso dei proces-si conoscitivi che dal loro recupero prendono le mosse. È stata, tutta-via, la diffusione delle tecnologie informatiche, e di Internet in parti-colare, che ha riproposto con rinnovata consapevolezza l’attenzionesu questo genere di problematiche, proprio perché ha costretto aconfrontarsi con meccanismi di cui si è trattato – e in buona parte sitratta ancora – di valutare pienamente gli effetti.
Se si riflette sulle pratiche di ordinamento e di descrizione preval-se all’interno delle istituzioni archivistiche negli ultimi 100/150anni, ci si dovrebbe facilmente rendere conto di come esse si sianobasate su alcuni principi fondamentali, la cui applicazione – nono-stante gli storici non vi abbiano probabilmente posto sufficiente at-tenzione – ha finito per costituire una sorta di «precondizione meto-dologica implicita» all’utilizzo della documentazione archivistica,all’interno di quelle procedure di selezione-scomposizione-critica-interpretazione-ricomposizione delle fonti, che tradizionalmentehanno costituito il nucleo fondamentale del mestiere di storico. In-fatti tali principi – che hanno con la storiografia radici comuni, quali,ad esempio, la filologia e la diplomatica, e che si sono consolidati, fraromanticismo storicista e positivismo scientista, contestualmenteall’affermarsi della storiografia come disciplina dotata di un proprio
194
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
specifico statuto disciplinare – hanno teso a salvaguardare il conte-sto di origine e le forme di aggregazione attraverso le quali la docu-mentazione è pervenuta. Le pratiche di ordinamento, nel loro inten-to di salvaguardare le strutture archivistiche originarie, e i metodidescrittivi che tali strutture si propongono di rendere trasparenti,hanno evidentemente una forte carica «storicizzante» e perciò rap-presentano una sorta di critica implicita della documentazione, una«precondizione», appunto, che dispensa lo storico, ogni qual voltautilizza documenti d’archivio, dalla verifica puntuale del contestod’origine di ciascuno di essi, dato che questo, in genere, è reso evi-dente ed esplicito dal modo in cui essi sono stati ordinati e descrittidagli archivisti. Proprio perché costoro tendono a preservare e a ren-dere esplicito il contesto di origine – e quindi il significato e il «valo-re» originari – della documentazione, è possibile per lo storico utiliz-zare le informazioni tratte dai documenti, ricomponendole all’inter-no di altri contesti26. Questi presupposti comuni delle pratiche stori-che ed archivistiche hanno spesso generato quell’illusione di «neu-tralità» degli strumenti di ricerca, assai diffusa, ma probabilmentescarsamente fondata.
Di solito gli storici hanno considerato come un diaframma fraessi e le fonti archivistiche l’esistenza o meno di inventari ed espri-mendo giudizi sulla loro qualità hanno insistito sulla quantità diinformazioni fornite, piuttosto che sui modi in cui esse sono orga-nizzate e presentate. In realtà questi ultimi non costituiscono maiun terreno totalmente neutrale: l’articolazione degli strumenti diricerca e la struttura stessa delle descrizioni archivistiche hannonon raramente significati più ampi. L’immagine della documenta-zione che essi tendono a trasmettere contiene nuclei di interpreta-zioni storiografiche, più o meno forti, ma comunque in grado dicondizionare il modo in cui essa, e il processo della sua produzio-ne, vengono percepiti dal ricercatore. Basta pensare alle scansioniperiodizzanti – mai totalmente neutre, ma portatrici di determinatevisione della storia – sulla cui base sono sovente organizzati glistrumenti di ricerca. Insomma qualsiasi ipotesi di strutturazionedell’informazione contiene, implicitamente o esplicitamente, una
26 Cfr. le stimolanti riflessioni di C. Pavone e I. Zanni Rosiello, Di archivi e di altrestorie. Conversazione tra Isabella Zanni Rosiello e Claudio Pavone, in L’archivista sulconfine. Scritti di Isabella Zanni Rosiello, Roma, Ministero per i beni e le attività cultu-rali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 2000, pp. 420-421.
195
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
proposta, forte o debole che sia, di attribuzione di senso all’infor-mazione stessa. Nelle condizioni nelle quali si è svolta fino adessola comunicazione fra archivista e ricercatore, soprattutto se stori-co, più o meno di professione, la cornice dei riferimenti che si ri-flette nella struttura dell’informazione si colloca, con tutta probabi-lità, all’interno di un terreno condiviso e si esprime in linguagginon difficilmente decodificabili.
L’ingresso dell’informatica e delle reti in questo settore ha indub-biamente complicato le cose, poiché non solo ha accentuato il ruolodella tecnologia quale mediatore fra produttore e ricettore delle in-formazioni, ma ha riproposto in forme inedite il problema del rap-porto fra la struttura e i contenuti dell’informazione e soprattutto,rendendo tale rapporto molto più complesso e meno trasparente diquanto è potuto apparire fino adesso, ha sollecitato una riflessionesu come esso condizioni i processi cognitivi27.
Già altri hanno notato come l’informatica e la rete mettano in discus-sione «la distinzione rigida fra gli strumenti tecnici, da sempre ritenutiutili ma sostanzialmente neutri rispetto ai contenuti, e i contenuti stessi,il cui elemento di verità si suppone indipendente dalla forma fisica incui è esposto»28. In forma ancora più articolata simili riflessioni sonostate ripetutamente proposte in recenti occasioni da Salvatore Settis:
È [...] importantissimo sottolineare che, sul piano concettuale, è l’informa-zione che dà forma alla struttura, che si traduce in «cornici tecnologiche»; ed èla struttura tecnologica che, canalizzando l’informazione ne predetermina laricevibilità, dunque gli usi. Distinguere informazione da struttura dell’infor-mazione è del tutto artificiale: le forme di strutturazione infatti sono più omeno marcatamente ideologizzate, contengono esse stesse informazione. Èsolo l’insieme di informazione e struttura che costituisce, genera, diffonde (onon diffonde) conoscenza. Le idee che si nascondono nella strutturazione del-l’informazione non sono meno importanti dei contenuti dell’informazionestessa; in altri termini, le infrastrutture tecnologiche determinano la trasmis-sibilità dei contenuti (e la non-trasmissibilità di altri contenuti); per converso,le infrastrutture tecnologiche possono essere determinate da un precisa vo-lontà di convogliare certi contenuti a preferenza di altri29.
27 Su queste tematiche cfr. R. De Simone, La terza fase. Forme di sapere che stiamoperdendo, Roma-Bari, Laterza, 2000.28 Cfr. P. Ortoleva, La rete e la catena. Mestiere di storico al tempo di Internet, in «Me-moria e ricerca», n.s., VII, n. 3, pp. 34-35.29 Cfr. S. Settis, L’illusione dei beni digitali, in «Il manifesto», 21 gennaio 2000, p. 26. Lesottolineature sono nel testo.
196
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
Per tornare al nostro ambito, ciò che in sostanza è in giuoco è, daun lato, la possibilità di conservare, nel passaggio dalla carta al digi-tale, quelle «precondizioni implicite» del tradizionale lavoro storio-grafico, fino adesso incorporate nelle pratiche archivistiche; dall’al-tro, l’intelligibilità da parte del ricercatore delle metodologie e delleoperazioni di strutturazione delle informazioni che stanno all’origi-ne degli strumenti che si trova ad utilizzare.
Per quanto riguarda il primo aspetto, il punto nodale è il destino diquel principio che è stato posto fino adesso al centro di quelle prati-che: la salvaguardia del contesto e la sua esplicitazione attraverso lastruttura degli strumenti di ricerca. In effetti, quando si parla di «con-testo», ci si intende riferire a due declinazioni diverse, seppure inti-mamente connesse, del concetto: da un lato, alla situazione e allecondizioni generali e specifiche che sono state all’origine della sedi-mentazione e della trasmissione di un determinato fondo documen-tario, quindi, fondamentalmente agli enti, persone, famiglie che lohanno prodotto e conservato; dall’altro alla struttura nella quale ilfondo si articola, alla sua ripartizione in serie, sottoserie, unità archi-vistiche, documenti ecc. Fra le due diverse accezioni di contesto esi-ste, in realtà, un nesso strettissimo, poiché la struttura non è, in ge-nere, neutra, ma è portatrice di una pluralità di significati che atten-gono ai soggetti produttori – dei quali possono mettere in evidenzadeterminati caratteri, modalità organizzative, aspetti di una evolu-zione storica –; ma attengono anche ai singoli documenti, la cui col-locazione all’interno della struttura non è indifferente per una com-prensione ed una valutazione non parziali delle informazioni in essidepositati. Su questi significati del contesto archivistico hanno pro-dotto riflessioni importanti non solo archivisti, ma anche storici del-le istituzioni e dell’amministrazione, che ad essi sono particolar-mente sensibili30. È soprattutto il contesto, nella seconda accezione,che è salvaguardato dal modo in cui le descrizioni sono presentate
30 «L’archivio dell’istituzione pubblica offre allo storico delle istituzioni qualcosa dipiù che non un deposito di informazioni [...]. Sin nella sua strutturazione (il modostesso della sua organizzazione, la tipologia dei suoi documenti e le regole della suaconservazione) l’archivio costituisce lo specchio dei rapporti interni all’istituzione. latestimonianza diretta del funzionamento dell’apparato istituzionale»: G. Melis, Il«Censimento», gli studi di storia amministrativa dell’Italia contemporanea, i problemidella memoria storica dell’amministrazione, in Per la storiografia del XXI secolo. Semi-nario sul progetto di censimento sistematico degli archivi di deposito dei ministeri rea-lizzato dall’Archivio centrale dello Stato, Roma, 20 aprile 1995, Roma, Ministero per ibeni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1998, p. 57.
197
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
all’interno degli inventari e degli altri strumenti di ricerca. Esso è,infatti, per lo più veicolato da elementi non verbali, ad esempio dallastessa articolazione dello strumento, dai codici grafici utilizzati (cor-pi tipografici, indentazioni, ecc.), dalla collocazione delle descrizionial suo interno.
Una pesca piuttosto rumorosa (o troppo silenziosa)
Non tutti i modi di strutturare le informazioni e di presentarle sulweb sono in grado di salvaguardare nella stessa misura il contestoarchivistico e di renderlo esplicito. Vi sono, al contrario, metodologiedi ricerca e di restituzione delle informazioni che, al contrario, ten-dono piuttosto a dissolverlo. Eppure si tratta di metodologie assaidiffuse in Internet ed in genere molto popolari. È questo, ad esempio,il caso di molte delle interfacce proposte per la ricerca all’interno dibanche dati di descrizioni archivistiche. In genere esse sono moltosimili a quelle utilizzate in campo bibliografico. Consentono cioè ri-cerche, per parola o per campo, secondo combinazioni e tecnichepiù o meno complesse (ad esempio, utilizzando gli operatori boolea-ni), restituendo uno o più record che rispettano le condizioni postenella query. L’accesso all’informazione è un accesso tipicamentepuntiforme: i dati vengono «pescati» all’interno di un «mare» (la ban-ca dati) che rimane, sullo sfondo, oscuro, così come difficilmentepercepibile è la sua struttura e il modo in cui i dati sono organizzati.Ciò finisce per costituire una sorta di filtro opaco fra l’utente e l’ar-chivio, la cui struttura, che nel mondo di carta è in genere restituita,come abbiamo visto, dall’articolazione dell’inventario e dai suoi co-dici grafici, rimane molto spesso inattingibile: si vedono i singolirami, le singole foglie, ma l’albero cui sono appese rimane nascosto.
Così mentre l’organizzazione complessiva dei fondi archivisticiscompare alla percezione del ricercatore, il recupero puntiforme deisingoli record restituisce spesso descrizioni, la cui collocazione nelcontesto è espressa tutt’altro che chiaramente: ad esempio, vengonorestituiti record che descrivono singole unità archivistiche senzache il legame con i livelli gerarchicamente sovraordinati sia effica-cemente evidenziato31. Talvolta la conclusione di percorsi di ricerca
31 È questo, ad esempio, il caso della ricerca effettuata tramite il National ArchivesInformation Locator (NAIL) dei National Archives di Washington, <http://www.nara.gov/nara/searchnail.html>.
198
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
di questo genere porta al recupero di singole immagini di documen-ti, con un effetto anche più decontestualizzante. In quest’ultimo casol’accesso diretto per interrogazione e recupero «puntiforme» di sin-gole immagini irrelate, rischia di rappresentare il dissolvimento diquelle aggregazioni materiali di base (la filza, la busta, il registro, ilfascicolo...) che nel mondo di carta suggeriscono già a livello di per-cezione fisica l’appartenenza del documento a complessi più ampi,ne fanno una singolarità inevitabilmente condizionata dalla molte-plicità, costituendone una prima elementare contestualizzazione,fino adesso scontata e banale, in futuro forse non tanto32.
Un altro elemento denso di implicazioni problematiche è il fattoche il buon esito di questo tipo di ricerche dipende dai meccanismiofferti dal software o dalle strategie adottate dal ricercatore per ri-durre entro proporzioni accettabili il rapporto fra informazione cer-cata e il «silenzio» o il «rumore» contenuti nei dati restituiti. In ultimaanalisi il successo è affidato alla congruità della terminologia utiliz-zata e deriva dalla capacità di formulare richieste alla banca dati inun linguaggio che si avvicini il più possibile a quello che le è proprio.Obiettivo non sempre facilmente raggiungibile, date le ambiguitàdel linguaggio corrente, per ricordare le quali non occorre ricorrerealla sterminata messe di studi che da angolature diverse varie disci-pline gli hanno dedicato, ma è sufficiente l’esperienza quotidiana.
La comunicazione scritta concede ampio margine al fraintendimento.[...] La stessa parola del resto può avere più di un significato: rifiuto puòindicare l’atto di dire no a qualcosa che si ritiene sbagliato, ma può essereanche un avanzo, un sinonimo di spazzatura33.
Per il ricercatore, le conseguenze di una domanda mal formulatanon saranno certo tragiche come quelle della cartolina equivocatanel romanzo di McEwan: cercando «Florence» nel NARA ArchivalInformation Locator tutt’al più ci si dovrà districare fra un nugolo direcord nei quali il nome indica una persona e non una città dellaToscana, cosicché, dei molti chiamati, pochi si riveleranno esseredavvero gli eletti. Ma è certo che in una banca dati archivistica ilricercatore dovrà affrontare il sovrappiù di difficoltà costituito dalla
32 È ancora il caso del National Archives Information Locator, citato nella nota prece-dente.33 I. McEwan, Amsterdam, Torino, Einaudi, 2000, p. 143.
199
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
dimensione storicamente e geograficamente stratificata che dalladocumentazione archivistica descritta si riflette all’interno del lin-guaggio utilizzato per descriverla.
La dipendenza dalla terminologia appare più rilevante che neitradizionali strumenti cartacei, proprio perché, mentre in questiessa viene acquisita – interattivamente, si potrebbe dire – nel corsodella ricerca stessa, cioè via via che lo strumento e la documentazio-ne vengono consultati, di fronte ad una banca dati che non può esse-re «sfogliata», ma solo interrogata – come una sorta di oracolo –l’unico modo per avere risposte soddisfacenti è conoscerne in antici-po logica e linguaggio, cosa che in genere non è possibile o è possibi-le solo in parte. Ne risulta una sorta di paradosso per il quale il mi-glior ricercatore all’interno della banca dati finisce per essere coluiche l’ha implementata. E non è infatti un caso che prima dell’avven-to delle reti le banche dati on site esistenti presso gli archivi fosseroconsultate quasi sempre attraverso la mediazione degli archivistiche, in un certo senso, ne conoscevano tutti i segreti.
In ultima analisi il punto debole di questi strumenti non è poimolto diverso da quello dei motori di ricerca in Internet, di cui unarecente ricerca americana ha dimostrato la pesante, ma un po’ ov-via, inefficienza quali strumenti per recuperare sul web informazio-ni relative a documentazione archivistica34.
Eppure, nonostante gli evidenti limiti, queste metodologie di re-cupero dell’informazione hanno un loro non indifferente fascino,che non deriva soltanto dalla rapidità e dalla puntualità con cui of-frono risposte a chi le utilizza, ma che è connessa ad un’altra attraen-te sensazione: quella di ridurre e, forse anche di eliminare, il fasti-dioso ruolo esercitato dalle tradizionali figure di «mediatori» dell’in-formazione, come appunto nel nostro ambito sono dagli archivisti,mettendo il ricercatore direttamente a contatto con il dato «puro»,non manipolato e quindi, come tale, più affidabile e certo35. Ovvia-
34 Cfr. K. Feeney, Retrieval of Archival Finding Aids Using World-Wide-Web SearchEngines, in «The American Archivist», vol. 62, Fall 1999, pp. 206-228: «I risultati diquesto studio suggeriscono che Internet è un terreno di ricerca troppo grande ed ete-rogeneo nel quale localizzare informazioni relative a documentazione archivisticafacendo ricorso alle pratiche e agli strumenti di ricerca comunemente usati in Inter-net»: p. 223.35 Sull’illusione per la quale «parlando di dati o di basi di dati, si rischia talvolta dicredere che il dato è neutro, mentre non lo è affatto, e il modo come crea (o non crea)conoscenza dipende da come è strutturato e da come è presentato» cfr. l’articolo diSalvatote Settis citato precedentemente.
200
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
mente le cose non stanno proprio così e come ha notato PeppinoOrtoleva,
i software di informatizzazione degli archivi [...] condizionano la ricerca,anzi in qualche misura «fanno» la ricerca assai più di quanto accadesse congli strumenti preinformatici, essi pure per altro assai più influenti e condi-zionanti di quanto generalmente si pensasse36.
In realtà, le uniche strategie che riescono efficacemente a ridurreil «silenzio» ed il «rumore», sono proprio quelle nelle quali la «mani-polazione» dei dati è più cospicua, grazie agli interventi realizzati amonte per la predisposizione di indici, che basandosi sulla standar-dizzazione della terminologia, tendano a ridurne l’ambiguità, oppu-re all’utilizzo di linguaggi di codifica, che rendano possibili ricerchenon puramente testuali (basate sulla corrispondenza fra le stringhedi caratteri ricercate e quelle restituite, cioè fra i termini imputati e iquelli contenuti nei record proposti) ma anche semantiche e cioèancorate al contesto di utilizzo della parola. Vi è un grado di sogget-tività, se non di arbitrarietà, in tutte queste operazioni che poco hache fare con il mito della «purezza» del dato.
Navigare in un mare trasparente senza smarrire la rotta
Per tornare alle considerazioni da cui abbiamo preso le mosse –quelle relative alla «difesa» del contesto nelle descrizioni archivisti-che sul web – occorre rilevare che un’alternativa all’accesso punti-forme all’informazione esiste ed è la cosiddetta «navigazione» all’in-terno della struttura dell’archivio, basata su rappresentazioni delfondo che ne mettano in evidenza, come nell’inventario cartaceo,l’articolazione gerarchica e che rendano possibile discendere e risa-lire la gerarchia dei livelli descrittivi, dal fondo, alle serie, alle unitàarchivistiche, ma anche di passare dalle descrizioni della documen-tazione a quella dei soggetti produttori e viceversa e di compiere in-fine tragitti trasversali, che combinino entrambe le possibilità. Sitratta di un approccio che non necessariamente esclude una ricercalibera per parola o una, molto più efficace, per liste di termini nor-malizzati o sottoposti, come si usa dire in linguaggio tecnico, a con-trollo di autorità. Nulla vieta che le diverse metodologie si integrino
36 P. Ortoleva, La rete e la catena, cit., p. 35.
201
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
e si rafforzino reciprocamente, ma è certo che la navigazione ha ilpregio di rendere più trasparente la struttura dell’archivio e quindipiù consapevoli e meno misteriosi, i percorsi al suo interno: il ricer-catore sa dov’è e perché c’è. Ed è per questo che essa dovrebbe esse-re sempre adottata come tecnica di ricerca in tutti gli strumenti ar-chivistici pubblicati sul web, banche dati comprese, per interrogarele quali dovrebbero essere costruite idonee interfacce in grado nonsolo di dar conto della struttura gerarchica dei fondi ma, soprattutto,di restituire i record recuperati attraverso interrogazioni per campi oper parole, all’interno del relativo contesto archivistico e quindi ledescrizioni delle singole serie all’interno del relativo fondo, quelledelle singole unità all’interno dei relativi fondi e serie e via dicendo.
Nonostante che soluzioni di questo genere siano lungi dall’esseregeneralizzate, tuttavia, vanno prendendo piede37, anche se non sem-pre le soluzioni tecniche adottate per rappresentare la struttura ge-rarchica del fondo o per esplicitare il contesto di appartenenza sonoeleganti e chiare. Spesso, infatti, non viene rappresentata tanto lacollocazione della singola entità archivistica all’interno della strut-tura complessiva del fondo, quanto vengono predisposti link iperte-stuali per il passaggio da un livello all’altro, l’attivazione dei quali,posiziona su pagine diverse da quella di partenza, cosicché pochipassaggi portano ben lontano da questa e fanno smarrire l’orienta-mento della navigazione.
Come alternativa ai sistemi di gestione di banche dati, più recen-temente sono stati elaborati strumenti che puntano alla salvaguar-dia del contesto e della struttura gerarchica nella presentazione del-le descrizioni archivistiche sul web attraverso un recupero che sia ilpiù integrale possibile delle tradizionali pratiche di elaborazionedegli strumenti di ricerca. Tale è stata, ad esempio, l’elaborazione diuno strumento di codifica testuale basato sui linguaggi cosiddetti di«marcatura» (markup languages) come SGML e più recentementeXML, l’ Encoded Archival Description. Sviluppato negli Stati Uniti,ma diffuso anche in altri paesi, soprattutto anglosassoni, l’EAD, ri-produce in modo abbastanza fedele la struttura tradizionale degli
37 Un buon esempio di «navigazione» all’interno della struttura dell’archivio è quellosviluppato nel sito degli Archivi della Comunità Europea, <http://wwwarc.iue.it/eha-ren/dbasemap.html>. Una interfaccia efficiente e chiara è anche quella sviluppata nelprototipo messo a punto dal Centro di ricerche informatiche per i beni culturali dellaScuola Normale Superiore di Pisa per il Sistema bibliotecario e archivistico della Re-gione Emilia-Romagna, <http://sibar.cribecu.sns.it:81/newtestsibar.html>.
202
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
inventari cartacei, permettendo un tipo di consultazione, che, fatte ledebite proporzioni, è sostanzialmente simile a quella di tali strumen-ti38. Se non sarà EAD, che tende a riflettere pratiche descrittive nor-damericane, non necessariamente coincidenti in tutto e per tuttocon quelle di altri paesi con patrimoni archivistici secolari e storica-mente molto più stratificati come il nostro, è tuttavia probabile che ladirezione che esso indica, cioè lo sviluppo di appositi linguaggi dicodifica per strumenti di ricerca archivistici, conoscerà in futurouna sempre maggiore diffusione, proprio per la possibilità che essioffrono di conservare e rendere esplicite, attraverso la codificazione,le informazioni che sono implicitamente veicolate dalla forma e dal-la struttura dei documenti cartacei.
Con buona pace dell’illusione che l’informatica – e la rete – con-sentano di ridurre od eliminare le mediazioni fra i «dati» e chi neusufruisce, è quindi solo una forte strutturazione a monte dell’infor-mazione che è in grado di svilupparne al massimo le potenzialitàconoscitive e di salvaguardarne a pieno i significati. È, tuttavia, cer-tamente vero che, con l’informatica, le metodologie e i processi at-traverso i quali l’informazione è trattata e viene presentata al ricer-catore sono meno trasparenti e meno facilmente decodificabili chenel mondo cartaceo, dove pure lo spessore dell’elaborazione cui essaè sottoposta, anche all’interno delle pratiche di redazione degli stru-menti di ricerca archivistici, è in genere assai consistente. Si tratta diun fenomeno che, come si è visto, sarebbe ingenuo pensare di ri-muovere andando alla ricerca di strumenti «neutri» in grado di resti-tuire informazione «pura». Il ricercatore dovrebbe, piuttosto, essereconsapevole delle possibili ricadute che i processi di selezione, orga-nizzazione e strutturazione dell’informazione, così come i caratteridelle tecnologie di comunicazione utilizzate, possono avere sulla suaricerca e sull’interpretazione dei suoi risultati. E per acquisire unatale consapevolezza egli dovrebbe essere messo in grado di conosce-re e di valutare quei processi e quelle metodologie soprattutto nelcaso, molto frequente, che essi si presentino tutt’altro che autoespli-cativi. Perciò nel predisporre strumenti di ricerca per la rete – e amaggior ragione archivi digitali di immagini – gli archivisti non do-
38 Esempi di strumenti di ricerca codificati per mezzo di EAD possono essere consul-tati nel sito dell’American Heritage Virtual Archive, <http://www.oac.cdlib.org/dy-naweb/ead/amher/>. Su EAD molte informazioni sul sito della Library of Congress,<http://lcweb.loc.gov/ead/>.
203
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
39 Un esempio tipico della scarsa attenzione a fornire informazioni sulle origini delledescrizioni archivistiche pubblicate in Internet è costituito dagli strumenti presentinel sito web dei National Archives of Canada, <http://www.archives.ca/>, il GeneralInventory che offre una descrizione a livello di fondo e serie della documentazione dinatura pubblica e privata conservata e il database Records created by departments andagencies of the Federal Government che contiene circa 1 milione e 200.000 descrizionia livello di fascicolo relativi a documentazione prodotta da dipartimenti ed uffici delgoverno federale canadese. Mentre ampie e dettagliate istruzioni guidano l’utentenell’impostare le strategie di ricerca, nessuna informazione è fornita sulla strategiacomplessiva che ha guidato l’offerta in linea di queste risorse nonché su origini, fina-lità e caratteri tecnici delle banche dati. I molti interrogativi sui caratteri degli stru-menti (ad esempio, come mai le due banche dati non comunicano) sono destinati arimanere senza risposta.
vrebbero limitarsi a fornire istruzioni più o meno dettagliate per laloro proficua consultazione, ma dovrebbero descrivere con chiarez-za e precisione le loro caratteristiche complessive, dando conto dellastruttura logica (architettura dei sistemi, loro storia, modello deidati, ecc.) e delle componenti più squisitamente tecniche dei sistemi(strumenti software ed hardware utilizzati ecc.) nonché dei criteriadottati nel trattamento delle informazioni (modalità di selezionedei dati, loro origine, se sono stati elaborati espressamente o ricavatida precedenti supporti cartacei, strumenti di normalizzazione adot-tati, ecc.). Si tratta di elementi minimi di conoscenza attraverso i qua-li si può cercare di ridurre quell’aura di «oggettività naturale» chesembra circondare, proprio a causa della loro opacità, i processi dielaborazione e di comunicazione dell’informazione realizzati attra-verso le nuove tecnologie. Essi possono, altresì, mettere il ricercato-re in grado di formulare una prima valutazione dei sistemi che sitrova di fronte e delle informazioni che da essi può ricavare, ponen-do in sostanza le condizioni per fondare sulla critica attiva e nonsulla ricezione passiva il rapporto con la tecnologia e con i contenutidi informazione che essa veicola. E tuttavia è ancora raro che talebackground informativo su origini, presupposti e caratteri dei siste-mi accompagni la pubblicazione sul web di strumenti di ricerca o dibanche dati di immagini. Talvolta, è francamente difficile farsi unaqualche idea dell’organizzazione dei dati che sta a monte di quanto èproposto all’interno dei siti anche di importanti archivi39. Quasisempre non è rivendicata nemmeno la responsabilità intellettualedegli strumenti di ricerca, né sono indicati autori o curatori dellesingole descrizioni archivistiche, quasi che esse dovessero essere at-tribuite non agli uomini e alle donne che le hanno elaborate, ma aglistrumenti tecnologici che le veicolano. Eppure, se ci sono istituzioni
204
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
che dovrebbero essere attente a difendere la qualità dell’informazio-ne diffusa attraverso la rete, queste sono proprio gli archivi. E difen-dere la qualità non implica soltanto una forte attenzione ai contenu-ti, ma anche agli strumenti che ne rendono trasparente la valuta-zione.