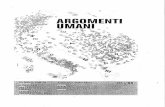Alcuni problemi dell'analisi hohfeldiana dei diritti soggettivi
-
Upload
izw-berlin -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Alcuni problemi dell'analisi hohfeldiana dei diritti soggettivi
ALCUNI PROBLEMI DELL'ANALISI HOHFELDIANA DEIDIRITTI SOGGETTIVI
Materiali per una storia della cultura giuridica, XLIV 2 (2014)
Pierfrancesco [email protected]
penultima versione
1. Premessa e piano dell'articolo
Gran parte della discussione in lingua inglese – ma non solo – sulconcetto di diritto soggettivo fa un uso esplicito o implicito dell'analisi delgiurista statunitense Wesley Newcomb Hohfeld (1879-1918) presentata unsecolo fa in due articoli usciti sullo Yale Law Journal1, e successivamentediscussa, emendata, e ampliata da un numero cospicuo di altri autori2.L'obiettivo inseguito da Hohfeld era quello di individuare i concettifondamentali del linguaggio giuridico, fornendo al giurista una serie distrumenti in grado di aiutarlo a districarsi tra i problemi della propriadisciplina3. Secondo Hohfeld, infatti, «uno dei più grossi ostacoli verso unapiena comprensione, una formulazione incisiva, e una vera soluzione deiproblemi giuridici», dipendeva dall'assunzione che tutte le relazioni legali
1 W.N. Hohfeld, Fundamental Legal Conceptions, in «Yale Law Journal», 23, 1913, e26, 1917. Negli anni successivi alla prematura morte del giurista di Yale i due articolisono stati raccolti in un unico volume che ha avuto numerose edizioni. Per le citazioniho adoperato l'edizione Ashgate/Dartmouth curata da N. Simmonds, D. Campbell, e P.Thomas: W.N. Hohfeld, Fundamental Legal Conceptions as Applied in JudicialReasoning, Burlington, Ashgate/Dartmouth, 2001.2 Senza pretese di esaustività: G. Williams, The Concept of Legal Liberty, in R.Summer (a cura di), Essays in Legal Philosophy, Oxford, Basil Blackwell, 1970; J.B.Brady, Law, Language, and Logic: The Legal Philosophy of Wesley Newcomb Hohfeld,«Transaction of the Charles Peirce Society», 8, 1972; D.M. Adams, Hohfeld on Rightsand Privileges, «Archiv für Rechtsphilosophie», 21, 1985; C. Wellman, A Theory ofRights, Totowa, Rowman and Allanheld, 1985; L. Sumner, The Moral Foundation ofRights, Oxford Clarendon, 1987; M.H. Kramer, Rights Without Trimmings, in M.H.Kramer, N. Simmonds, H. Steiner (a cura di), A Debate over Rights, Oxford, Clarendon,1998; N.E. Simmonds, Rights at the Cutting Edge, in A Debate over Rights, cit.; L.Wenar, The Nature of Rights, «Philosophy & Public Affairs», 33, 2005; G. Rainbolt,The Concept of Rights, Dordrecht, Springer, 2006.3 W.N. Hohfeld, Fundamental Legal Conceptions, cit., p.4: «Lo scopo principale dicolui che scrive è rimarcare alcune questioni spesso trascurate che possono aiutare acomprendere e risolvere problemi pratici e quotidiani del diritto».
1
potessero «essere ridotte a diritti e doveri», termini questi che nella prassirisultano spesso sfuggenti, ambigui, e in ultima analisi «camaleontici»4.Hohfeld avanzò pertanto un'analisi dei “rapporti giuridici fondamentali”basata su otto termini primitivi incastonati in una griglia concettuale di“opposti” e “correlati”: in questo modo, diventava possibile districare ognisituazione all'apparenza complessa e confusa in un'insieme di concettielementari collegati tra loro da una logica nitida e precisa, e da quiprocedere poi a un'agile risoluzione del problema.
Il lavoro di Hohfeld assunse in breve tempo uno statuto paradigmaticoall'interno della giurisprudenza analitica, in particolar modo per la suaanalisi dei diritti5. Negli anni la portata applicativa del quadro analiticohohfeldiano si è allargata ben oltre i confini della teoria giuridica,penetrando negli ambiti della filosofia morale e sociale6, e ad oggi è tramiteil vocabolario hohfeldiano che è espressa buona parte delle discussioniteoriche riguardo ai diritti soggettivi, sopratutto se ci riferiamo a essi nellaloro concezione statica. Secondo una dicotomia oramai canonica, infatti, aproposito dei diritti si può distinguere tra due paradigmi di analisi, l'unostatico, l'altro dinamico. Bruno Celano così li caratterizza: il primo «vedeun diritto come una posizione normativa soggettiva elementare (atomica),compiutamente determinata, o come un insieme finito, compiutamentedeterminato (un aggregato, una molecola), di posizioni siffatte»; il secondoparadigma, invece, «vede un diritto soggettivo come il nucleo germinale di(come una ragione atta a giustificare l'attribuzione o il riconoscimento di)posizioni normative determinate, o insiemi determinati di posizioni siffatte(come la ratio che spiega, giustificandola, l'attribuzione o il riconoscimento
4 Ibidem, p.11.5 Sullo statuto paradigmatico dell'analisi hohfeldiana vedi T.D. Perry, A Paradigm ofPhilosophy: Hohfeld on Legal Rights, «American Philosophical Quarterly», 14-41,1977, e J.W. Singer, The Legal Rights Debate in Analytical Jurisprudence fromBentham to Hohfeld, «Wisconsin Law Review», 975, 1982. L'importanza del lavoro diHohfeld era già stata riconosciuta dai suoi colleghi e allievi: a tal proposito cfr. W.W.Cook, Hohfeld's Contribution to the Science of Law, «The Yale Law Journal», 28-8,1919, e A. Corbin, Jural Relations and their Classifications, «The Yale Law Journal»,30, 1921.6 Perplessità a riguardo si ritrovano in J.J. Thomson, A Realm of Rights, Cambridge(Mass.) Harvard University Press, 1990, e R. Dworkin, Taking Rights Seriously,Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1978. La maggior parte degli autori chesi sono occupati della questione hanno però sostenuto la possibilità di applicare l'analisihohfeldiana anche fuori del campo giuridico: vedi per esempio H. Upton, Right-basedMoralities and Hohfeld's Relations, «The Journal of Ethics», 4, 2000; G. Sreenivasan,Duties and their Direction, «Ethics», 120-3, 2010; G.W. Rainbolt, Rights as NormativeConstraints on Other, «Philosophy and Phenomenological Research», 52-1, (1993); R.Cruft, Beyond Interest Theory and Will Theory?, «Law and Philosophy», 23, 2004; J.B.Brady, Law, Language, and Logic, cit.; con qualche riserva pure M.H. Kramer, RightsWithout Trimmings, cit.
2
di posizioni normative determinate)»7. Il quadro hohfeldiano è assurtosenza dubbio a pietra angolare della comprensione del paradigma statico,nonostante, come è spesso notato8, sia pienamente compatibile con unaconcezione dinamica, e non impegni in quella che sembrerebbe essere unasua conseguenza necessaria: la difesa del formalismo9.
L'obiettivo di questo articolo è quello di portare all'attenzione alcuniproblemi dell'analisi hohfeldiana relativamente negletti dalla letteratura. Sitratta: a) delle modalità attraverso cui è possibile derivare un elementohohfeldiano a partire da altri elementi hohfeldiani; b) della struttura deglielementi hohfeldiani alla base delle norme di competenza; c) del regressoinfinito causato dalle regole di derivazione di correlazione e opposizione.Attraverso la discussione di questi tre problemi cercherò anche di porrel'attenzione sulla necessità di integrare il paradigma statico delineato dalquadro hohfeldiano con una concezione dinamica dei diritti. L'articolo èdiviso in due parti, oltre a questa premessa: nelle sezioni 2-3 esporròsinteticamente l'analisi hohfeldiana nel suo stato dell'arte; nelle sezioni 4-9tratterò i tre problemi citati in precedenza.
2. Il quadro hohfeldiano
Prima di diventare un giurista Hohfeld aveva studiato chimica, e forsenon è un caso che il modus operandi della sua analisi ricordi quello diquesta disciplina: ciò che fa Hohfeld, infatti, è prendere una nozionecomplessa come quella di diritto soggettivo e scinderla nei suoi “elementi”fondamentali. Secondo Hohfeld questi elementi fondamentali sono otto, epossono essere raggruppati in due tetradi. Entro ogni tetrade, ognuno deglielementi è definito e collegato agli altri attraverso relazioni logiche cheHohfeld chiama “correlazione” e “opposizione”.
Prima tetrade hohfeldiana
Elemento Pretesa Libertà10 Dovere Non-pretesa
Correla con: Dovere Non-pretesa dinon
Pretesa Libertà di non
Si oppone a: Non-pretesa11 Dovere di non Libertà di non12 Pretesa
7 B. Celano, I diritti nella Jurisprudence anglosassone contemporanea, in P.Comanducci, R. Guastini (eds.), Analisi e diritto. Ricerche di giurisprudenza analitica,Torino, Giappichelli, 2001, p.6.8 Vedi, per esempio, M. Kramer, Rights Without Trimmings, cit., pp.41-5. 9 Sul rapporto tra l'analisi hohfeldiana e il formalismo vedi l'introduzione di N.Simmonds all'edizione di Fundamental Legal Conceptions citata.10 Hohfeld chiama questo elemento «privilegio» [privilege]. Nel cangiarne il nome inlibertà mi adeguo a una consuetudine entrata in uso nella letteratura.
3
Seconda tetrade hohfeldiana
Elemento: Immunità Potere Incapacità Soggezione
Correla con: Incapacità Soggezione Immunità Potere
Si oppone a: Soggezione Incapacità Potere Immunità
Ogni elemento hohfeldiano definisce una relazione normativa tra untitolare e la sua controparte. Hohfeld non fornisce definizioni formalmenteesatte delle due relazioni di opposizione e correlazione, ma i suoi interpretisono generalmente concordi nell'affermare che la relazione di correlazionecoincida con la doppia implicazione, e l'opposizione con la disgiunzioneesclusiva. In questo modo, per esempio13:
[1]. (A1): X ha la pretesa di φ nei confronti di Y ↔ (A2): Y ha ildovere di φ nei confronti di X.
[2]. (B1): X ha il dovere di φ nei confronti di Y (C⊕ 1): X ha la libertàdi non-φ nei confronti di Y.
Dal punto di vista delle relazioni logiche tra gli otto elementi, nelquadro hohfeldiano standard vige una doppia simmetria perfetta. La primasimmetria è tra le due tetradi: ognuna consta di quattro elementi chepossono essere collocati ai vertici di un quadrato logico dove una coppia dilati paralleli rappresenta le correlazioni, e le diagonali invece leopposizioni. La seconda simmetria è interna alle due tetradi: attraverso lerelazioni di opposizione e correlazione è infatti possibile definire in ogni
11 Anche in questo caso mi permetto di modificare il termine originariamente adoperatoda Hohfeld – che è no-right – in un più pratico e neutrale non-pretesa, come è uso nellaletteratura.12 L'opposto di un dovere è una «libertà di non», e non semplicemente una «libertà»come capita a volte di leggere: se non fosse così, sarebbe possibile ricavare laconclusione erronea che un obbligo è la negazione di un divieto. Hohfeld è in parteresponsabile di questo fraintendimento, poiché nelle tavole presenti nel suo articoloindica non-pretese e libertà come correlati, e doveri e libertà come opposti (W.N.Hohfeld, Fundamental Legal Conceptions, cit., p.12). L'errore non è invece compiutonel testo, dove Hohfeld parla sempre dell'opposto di un dovere come di una libertà dinon. Sulla questione possono essere utili: A.R. Anderson, Logic, Norms, and Roles,«Ratio», 4 (1962); F. Fitch, A Revision of Hohfeld's Theory of Legal Concepts,«Logique et Analyse», 10, 1967; G. Williams, The Concept of Legal Liberty, cit.; P.Mullock, The Hohfeldian Jural Opposite. «Ratio» 13 (1971); D.M. Adams, Hohfeld onRights and Privileges, cit.13 Per definire in modo formale elementi e relazioni hohfeldiane adopererò le seguentivariabili: a) le lettere X, Y, W, Z per indicare i soggetti coinvolti da un elemento o dauna relazione hohfeldiana; b) le lettere φ, χ, ψ per indicare azioni e omissioni oggetto diun elemento o di una relazione hohfeldiana; c) le lettere A, B, C per indicare elementihohfeldiani: tutti gli elementi di una stessa relazione saranno indicati con la stessalettera, e pedici saranno impiegati per distinguere i vari elementi tra loro correlati.
4
tavola tutti e quattro gli elementi adoperandone uno a piacere comeprimitivo14.
Nella seconda parte dell'articolo cercherò di mostrare che le duesimmetrie precedenti non sono così perfette come può sembrare di primoacchito. Per il momento, però, contentiamoci di osservare che la differenzatra le due tetradi non va ricercata nella loro struttura logica generale, ma inaltri due aspetti: nei domini e nelle modalità normative coinvolte.
Il dominio normativo della prima tetrade è infatti costituito da azioni,mentre quello della seconda da altri elementi hohfeldiani. Di per sé isingoli elementi hohfeldiani non possono essere considerati delle norme insenso stretto, bensì dei costituenti elementari di norme: in questo modo glielementi della prima tetrade vanno considerati come costituenti di quelleche nella terminologia di Ross15 sono definite norme di condotta e in quelladi Hart16 regole primarie; gli elementi della seconda tetrade al contrariosono costituenti di norme di competenza o regole secondarie.
Riguardo alla modalità normativa, gli elementi della prima tavolaspecificano (in rapporto a una controparte) se un'azione è permessa,proibita, od obbligatoria. Gli elementi della seconda tetrade invecespecificano (in rapporto a una controparte) se la modifica di un elementohohfeldiano è possibile o impossibile.
3. Gli elementi hohfeldiani
Si è parlato a volte17 dello schema fornito da Hohfeld come di unsistema di logica deontica, ma non vi sono i presupposti formali peraccettare tale giudizio. Ciò nonostante, l'analisi hohfeldiana fornisce unquadro analitico di indubbia potenza ed eleganza. Per evitare di inciamparein falsi problemi, però, è bene tenere a mente due sue caratteristichefondamentali. La prima caratteristica è che le definizioni fornite da Hohfeld
14 Hohfeld riteneva che ognuno degli otto elementi da lui individuati fosse «suigeneris» e in ultima istanza non ulteriormente analizzabile (W.N. Hohfeld,Fundamental Legal Conceptions, cit., p. 12.). Si tratta però di un'affermazionefuorviante, dal momento che egli stesso fornisce, tramite le tavole di correlazione eopposizione, gli strumenti per ricavare da un dato elemento tramite un qualsiasi altroelemento della stessa tavola (sull'argomento vedi G. Rainbolt, The Concept of Rights,cit., pp. 10-19). Ciò che Hohfeld probabilmente intendeva riguardo a questo punto è chenessuno degli otto elementi è “più fondamentale” degli altri – neanche la coppiapretese/doveri, come capita talvolta di leggere (vedi per esempio C. Wellman, A Theoryof Rights, Oxford, Oxford University Press, 1995, p.53 e Real Rights, cit. 18).15 A. Ross, On Law and Justice, London, Stevens & Sons, 1958; A. Ross, Directivesand Norms, Routledge and Kegan Paul, London,196816 H.L.A. Hart, The Concept of Law, Oxford, Clarendon, 1994.17 Una tesi del genere si trova espressa per esempio in K.W. Saunders, A FormalAnalysis of Hohfeldian Relations, «Akron Law Review», 23, 1990.
5
sono stipulative, e come tali il loro valore va misurato contestualmente alloschema generale da esse implicato. Nelle intenzioni di Hohfeld, l'analisidelle relazioni giuridiche fondamentali non aveva, infatti, un interesseesclusivamente filosofico, ma doveva rifondare il linguaggio giuridico. Perquesto motivo, il fine ultimo dell'analisi hohfeldiana è ricostruttivo18, e lasua descrizione delle relazioni giuridiche fondamentali può sembrare avolte controintuitiva o in contraddizione con schemi di ragionamentosedimentati.
Queste contraddizioni sono, però, molto spesso apparenti. Hohfeldprocede isolando e definendo le particelle elementari del linguaggiogiuridico, e, se presi singolarmente, gli otto elementi hohfeldiani nonassomigliano generalmente ai concetti più complessi impiegati dai giuristi.Ciò accade perché ogni elemento implica soltanto il suo correlato, ed ègiocoforza limitato nelle sue funzioni normative. Affiancando diversigeneri di elementi si possono, però, costruire aggregati molecolari di piùelementi primitivi attraverso i quali, in linea teorica, dovrebbe esserepossibile rendere conto dell'intero lessico giuridico. L'utilità del quadrohohfeldiano è, in pratica, quella di mostrare come i concetti giuridicifunzionalmente complessi siano la risultante di un insieme di elementinormativi primitivi, e, come le leghe di metalli, acquisiscano le proprieproprietà dalle caratteristiche specifiche dei materiali di cui sono composti.Tenendo a mente questi due aspetti, nel resto di questa sezione delineerò itratti peculiari di ognuno degli otto elementi hohfeldiani.
Pretese. Il correlato di una pretesa è un dovere, e il suo opposto unanon-pretesa. Attraverso una pretesa il titolare è in grado di imporrecoattivamente un comportamento di tipo attivo od omissivo allacontroparte, sancendo in questo modo un obbligo oppure un divieto. Unapretesa implica un dovere altrui, ma non una libertà propria: è per questologicamente possibile avere, per esempio, un diritto di non interferenza neiconfronti di un'azione che non ci è permessa. Secondo Hohfeld quello dipretesa definisce il significato autentico del concetto di diritti19, quantomeno in quello che dovrebbe essere un uso tecnico del termine.
Libertà. Il correlato di una libertà è una non-pretesa di non, e il suoopposto è un dovere di non. Assieme al potere, la libertà hohfeldiana èforse il più “scivoloso” tra gli otto elementi. Una libertà, così come la
18 Su questo aspetto dell'analisi hohfeldiana ha molto insistito Matthew Kramer: cfr. ilsuo Rights Without Trimmings, cit. pp.22-5.19 La ragione addotta da Hohfeld è la seguente: vi è un'unica intenzione comune daparte di chi adopera il termine diritti che va di là di ogni possibile ambiguità, ed è ilriferimento, per quanto a volte vago e impreciso, alla presenza di doveri correlati. Dalmomento che l'unico elemento che effettivamente fa riferimento alla presenza di dovericorrelati è la pretesa, ne consegue che è opportuno ricostruire il linguaggio dei diritti neitermini di un'identificazione con le pretese. Vedi W.N. Hohfeld, Fundamental LegalConceptions, cit., p.13.
6
intende Hohfeld, indica esclusivamente l'assenza di un dovere diretto versouna controparte. Il possesso di una libertà hohfeldiana nei confronti diun'azione non implica quindi che: a) il suo titolare sia tutelato o possiedagaranzie di realizzare l'azione; b) il suo titolare possa astenersi dalrealizzare l'azione; c) il suo titolare abbia un permesso incondizionato direalizzare l'azione.
A. Il possesso di una libertà non è necessariamente associato agaranzie riguardo alla possibilità di portare a termine un'azione. Questoaccade, anzitutto, perché le libertà, per come sono definite nel quadroHohfeldiano, sono compatibili con libertà dal medesimo contenuto matitolare differente:
[3]. (A1): X ha la libertà di φ nei confronti di Y & (B1): Y ha la libertàdi φ nei confronti di X.
Supponiamo che φ indichi la possibilità di parcheggiare in un'areaprivata, in cui al momento è rimasto soltanto un posto disponibile: purgodendo entrambi della libertà specifica, soltanto uno tra X e Y puòrealizzare questa possibilità.
Allo stesso modo, le libertà, non implicando pretese, non implicanonemmeno doveri di non interferenza: secondo un esempio reso celebre daHart20, la libertà di guardare nel giardino del vicino non è violata da unasiepe che lo impedisca. Le libertà sono quindi elementi “nudi”, privi ditutele riguardo alla realizzazione del proprio contenuto. Le libertàaffiancate da pretese – e quindi da doveri di non interferenza – sono invece“libertà vestite”21.
B. Il possesso di una libertà non è necessariamente associato allapossibilità di astenersi dal compiere un'azione. Ciò accade perché le libertàsono compatibili con doveri dal medesimo contenuto – non implicano,cioè, la libertà dal contenuto contrario. La seguente congiunzione dielementi può infatti essere vera nel quadro hohfeldiano:
[4]. (A1): X ha la libertà di φ nei confronti di Y & (B1): X ha il doveredi φ nei confronti di Y.
Di per sé, quindi, le libertà sono oggetti normativi unilaterali –qualificano strettamente il proprio contenuto, e non il complementare.
20 H.L.A. Hart, Bentham on Legal Rights, in A.W.B. Simpson, a cura di, Oxford Essaysin Jurisprudence, Oxford, Clarendon, 1973.21 La distinzione tra libertà nude e vestite precede Hohfeld, e può essere fatta risalire aBentham: vedi, per esempio, Pannomial Fragments, in J. Bentham, The Works ofJeremy Bentham, Edinburgh, William Tate, 1838-1843, vol. III, pp.388-389. Su questopunto sono utili anche H.L.A. Hart, Bentham on Legal Rights, cit., e H. Steiner, AnEssay on Rights, Oxford, Blackwell, 1994.
7
Quando a una libertà è affiancata la libertà complementare, allora si puòparlare di “libertà bilaterale”22, composto hohfeldiano che sancisce laliceità di compiere o no una determinata azione, come in questo caso:
[5]. (A1): X ha la libertà di φ nei confronti di Y & (B1): X ha la libertàdi non-φ nei confronti di Y.
C. Le libertà sono compatibili con doveri hohfeldiani di contenutocontrario ma controparti diverse. All'interno del quadro hohfeldiano questacongiunzione può essere infatti vera:
[6]. (A1): X ha la libertà di φ nei confronti di Y & (B1): X ha il doveredi non-φ nei confronti di W.
Una libertà semplice quindi non implica necessariamente un permessoincondizionato23. Un permesso incondizionato si ottiene affiancando a unalibertà tutte le libertà possibili che un soggetto può avere riguardo allostesso contenuto, e ottenendo così un composto definibile come “libertàgenerale”24.
Doveri. Il correlato di un dovere è una pretesa, e il suo opposto è unalibertà di non. Un dovere sancisce il carattere obbligatorio (oppure vietato,nel caso dei doveri di non) di un'azione, vincolando in questo modo ilproprio titolare a un comportamento di tipo attivo od omissivo. Lacaratteristica particolare dei doveri hohfeldiani rispetto ad altri generi didoveri è di essere direzionati nei confronti di una controparte. Lacontroparte di un dovere non necessariamente ne è anche il beneficiario.
Non-pretese. Il correlato di una non-pretesa è una libertà di non, e ilsuo opposto è una pretesa. Una non-pretesa stabilisce che il suo titolare nonè oggetto di un dovere da parte della controparte.
Poteri. Il correlato di un potere è una soggezione, e il suo opposto è
22 Sulle libertà bilaterali, anche dette “appaiate”, vedi G. Williams, The Concept ofLegal Liberty, cit.; H.L.A. Hart, Legal Rights, in Essays on Bentham, cit.; D.M. Adams,Hohfeld on Rights and Privilege, cit. 23 Ciò dovrebbe fornire in parte una risposta alla domanda posta da Francesca Poggi(vedi il suo Diritti d'agire, permessi e garanzie, in P. Comanducci, R. Guastini (eds.)Analisi e diritto. Ricerche di giurisprudenza analitica, Torino, Giappichelli, 2002-3): sele libertà hohfeldiane siano forme di permessi deboli o forti. La risposta è che non sononé l'uno né l'altro, perché non sono forme di permesso incondizionato. Si tratta però diuna risposta parziale, poiché, come si vedrà nelle ultime sezioni, ha comunque sensoporsi una domanda contigua alla precedente: se all'interno di un sistema normativohohfeldiano ogni azione sulla quale non grava un dovere debba essere considerataoggetto di una libertà, o se invece debba intervenire una norma di qualche genere perstabilirlo.24 Sulla questione vedi S. van Duffell, The Nature of Rights Debate Rests on a Mistake,«Pacific Philosophical Quarterly», 3, (2012).
8
una incapacità. Un potere permette al titolare di modificare l'assetto deglielementi hohfeldiani della controparte. Come ciò avvenga rimane spessonon ben chiarito nella letteratura hohfeldiana, e uno dei compiti che miporrò in seguito è proprio di gettare un po' di luce sull'argomento. Peradesso possiamo notare alcune caratteristiche generali dei poteri senzaaddentrarci troppo nei particolari.
Anzitutto, l'intervento normativo di un potere può essere descrittocome l'istituzione, la modifica, o l'annullamento di altri25 elementihohfeldiani. Nel quadro hohfeldiano standard il significato di questi treinterventi coincide, in quanto la modifica di un elemento da parte di unpotere consiste nel suo annullamento e nella simultanea istituzione del suoopposto (conseguentemente legiferare implica abrogare, e viceversa). Ilpossesso di un potere all'interno del quadro hohfeldiano non implicanecessariamente che: a) il titolare abbia il permesso di esercitarlo inmaniera legittima; b) il titolare abbia delle garanzie o delle tutele riguardoal suo esercizio; c) il titolare possa rettificarne l'esercizio; d) il titolarepossa astenersi dal suo esercizio.
A. Un potere non implica una libertà, e ciò rende logicamentepossibile, all'interno di un quadro hohfeldiano, la presenza di poteri che nonpossono essere esercitati lecitamente. Un potere, infatti, per essereesercitato, richiede che sia portata a termine una data azione normativa26:
[7]. (A1): Se X compie χ, allora l'elemento B1 di Y è cancellato, e alsuo posto è istituito l'opposto di B1.
La possibilità di esercitare legittimamente un potere dipende quindidall'esistenza di una libertà generale di compiere l'azione normativaassociata: un potere, di per sé, non garantisce la legittimità del suoesercizio, bensì soltanto la sua possibilità, ed è plausibile all'interno di unquadro hohfeldiano l'esistenza di poteri il cui esercizio sia proibito27. Un
25 Se sia un solo elemento o siano più di uno è una questione problematica chediscuterò nelle sezioni successive.26 Sulle azioni normative, G.H. von Wright, Norm and Action, New York, Routledge &Kegan Paul, 1963, pp.75-8. Hohfeld parla più genericamente di “fatti” o di “gruppi difatti”: «un mutamento in una data relazione giuridica può essere il risultato […] diqualche ulteriore fatto o gruppo di fatti posti sotto il controllo della volontà di uno o piùesseri umani», scrive infatti Hohfeld in riferimento ai poteri (Fundamental LegalConceptions, cit., p.21). Rainbolt, che è l'autore ad aver più sviluppato questo lato delquadro hohfeldiano, parla invece di «atti scatenanti» (The Concept of Rights, cit., p.12).27 Può apparire certamente insensato da un punto di vista pratico l'istituzione di poteri ilcui esercizio sia sempre vietato, ma per quanto improbabile nella realtà del diritto,all'interno del quadro hohfeldiano ciò è logicamente possibile. Questa possibilità logicaè negata da Hillel Steiner nel suo Working Rights, cit., pp.242-3, ma il suo argomento sibasa su una confusione tra incapacità e doveri. Steiner inoltre sembra essere sconfessatodallo stesso Hohfeld: vedi Fundamental Legal Conceptions, p.26. Per una discussione
9
“potere esercitabile” è un composto di un potere e di una libertà generalenei confronti di un atto normativo.
B. I poteri esercitabili, così come accade per le libertà, possono essere“nudi” oppure “vestiti”, poiché nude o vestite possono essere le eventualilibertà che rendono lecito l'esercizio del loro atto normativo: l'esercizio diun potere, in pratica, può essere accompagnato da gradi crescenti di doveridi non interferenza, oppure esserne del tutto sprovvisto.
C. Il titolare di un potere non necessariamente è in grado direttificarne l'eventuale esercizio. Ciò accade perché un potere è compatibilecon un'incapacità dal contenuto contrario. Questa congiunzione può essereinfatti vera nel quadro hohfeldiano:
[8]. (A1): X ha il potere nei confronti di C1 di Y & (B1): X non ha ilpotere nei confronti di non-C1 di Y.
Allo stesso modo delle libertà, i poteri sono quindi elementiunilaterali che non qualificano il proprio complementare e nongarantiscono, in questo modo, la propria reversibilità. Questa funzionenormativa si ha quando a un potere è affiancato il potere di contenutocontrario, ottenendo un composto definibile come “potere bilaterale”. Inquesto modo sono quattro le situazioni possibili che si possono venire acreare di fronte alla possibilità di intervento di un soggetto su un datoelemento hohfeldiano:
Per X è possibileintervenire su A1 e
non-A1
Per X è possibileintervenire solo su
A1
Per X è possibileintervenire solo su
non-A1
Per X non è possibile intervenire su A1 e non-A1
X Potere suA1
Potere sunon-A1
Potere suA1
Incapacità su non-
A1
Incapacità su A1
Potere su non-A1
Incapacità su A1
Incapacità su non-A1
Y Soggezione su A1
Soggezione su
non-A1
Soggezione su A1
Immunità su non-
A1
Immunità su non-
A1
Soggezione su non-A1
Immunità su A1
Immunità su A1
D. L'esercizio di un potere può essere reso obbligatorio affiancando aesso un dovere di compiere l'atto normativo associato. La seguentecongiunzione può essere infatti vera all'interno di un quadro hohfeldiano:
[9]. (A1): Se X compie χ, allora l'elemento C1 di Y è cancellato, e alsuo posto è istituito l'opposto di C1 & (B1): X ha il dovere di χ nei confrontidi Y.
della questione vedi L.W. Sumner, The Moral Foundation of Rights, cit., p.29 e G.Rainbolt, The Concept of Rights, cit., pp.9-11.
10
Qualora l'atto normativo sia invece oggetto di una libertà generaleappaiata, l'esercizio è discrezionale.
Immunità. Il correlato di un'immunità è un'incapacità, e il suo oppostoè una soggezione. Il contenuto di un'immunità è sempre un altro elementohohfeldiano. Un'immunità stabilisce l'impossibilità da parte dellacontroparte di modificare il contenuto di questo elemento.
Soggezioni. Il correlato di una soggezione è un potere, e il suo oppostoè una immunità. Il contenuto di una soggezione è un altro elementohohfeldiano. Una soggezione stabilisce la possibilità per la controparte dimodificare il contenuto di questo elemento.
Incapacità. Il correlato di un'incapacità è una immunità, e il suoopposto è un potere. Un'incapacità impedisce di trasformare l'assetto deglielementi hohfeldiani della controparte. Come per il potere anche perl'incapacità vi sono delle problematiche di interpretazione che affronterònelle prossime sezioni.
Hohfeld notava che nel linguaggio giuridico ordinario il termine“diritti” è una scatola vuota che può contenere di volta in volta pretese,libertà, poteri, o immunità28. La tesi di Hohfeld – che di per sé non ha nullaa che vedere con la sostanza del suo quadro analitico – secondo cui insenso stretto soltanto le pretese possono essere considerate diritti è stataampiamente discussa nella letteratura post-hohfeldiana: i suoi fautoril'hanno riformulata adoperando argomenti più convincenti di quello un po'ingenuo addotto da Hohfeld29, mentre altri autori l'hanno messa indiscussione preferendole soluzioni la cui idea di fondo è che i dirittipossano coincidere con diversi generi di elementi hohfeldiani o loroaggregati30. Fortunatamente possiamo evitare di addentrarci in tale
28 W.N. Hohfeld, Fundamental Legal Conceptions, cit., p. 12.29 Sulla questione vedi la nota 19. Tra i fautori dell'identificazione tra diritti e pretesehohfeldiane troviamo alcuni autorevoli esponenti di quella che è conosciuta come teoriadell'interesse, tra cui spicca M. Kramer: vedi a proposito il suo M.H. Kramer, RightsWithout Trimmings, cit.30 Per la teoria della scelta, formulata originariamente da H.L.A. Hart (Are There AnyNatural Rights?, «The Philosophical Review», 64-2, 1955) e successivamente difesa, tragli altri, da H. Steiner (An essay on rights, cit. e Working Rights, cit.) e C. Wellman(Real Rights, cit.), un diritto può essere concepito come un aggregato hohfeldianocomprendente una pretesa (o un'immunità), il potere di annullare questa pretesa (oimmunità), e la libertà bilaterale che rende discrezionale l'esercizio di questo potere; perla teoria del vincolo giustificato di G. Rainbolt (The concept of rights, cit.) i diritti sonopretese o immunità, oppure aggregati hohfeldiani che abbiano al loro centro almeno unapretesa o un'immunità. Per le teorie inclusive di Wenar (The Nature of Rights, cit.) eCruft (Beyond Interest Theory and Will Theory?, cit. e Why Aren't Duties Rights?, «ThePhilosophical Quarterly», 56, 2006) possono essere diritti le pretese, le libertà, i poteri,le immunità, e i loro aggregati – per Cruft anche le soggezioni e i loro aggregati. Perun'analisi più approfondita di queste posizioni mi si permetta di rimandare a P. Biasetti,
11
questione: la bontà degli argomenti che seguono dovrebbe essere del tuttoindipendente da quale soluzione decidiamo di accogliere per questoproblema. E ciò significa anche che i risultati di questa indagine nondipendono dallo sfondo teorico di riferimento: sia esso legato alla teoriadell'interesse, alla teoria della scelta, o a qualche altra proposta sviluppata apartire da queste.
4. Modalità di derivazione
Passiamo adesso a discutere il primo dei problemi oggettodell'articolo, quello delle “regole di derivazione” che possono essereimpiegate nel quadro hohfeldiano: una delle funzioni cui dovrebbeassolvere, infatti, lo schema analitico tracciato da Hohfeld, è quella difornire gli strumenti necessari per “esplorare” o “assemblare”, partendo dauna manciata più o meno grande di elementi, l'ambiente normativo che licirconda. Proprio in questa possibilità ricostruttiva risiede, infatti, uno deicontributi fondamentali alla pratica giuridica garantiti dallo schemahohfeldiano. Tuttavia, l'analisi esplicita dei meccanismi di derivazione nonè mai stata sviluppata sistematicamente, con l'eccezione di un paio di lavorisull'argomento31. In gran parte della letteratura si è preferito piuttosto dareper scontato il problema, senza uscire da un utilizzo implicito egeneralmente non giustificato di meccanismi di derivazione assai diversi traloro, incappando in questo modo spesso in errori32. In questa sezionecercherò di censire le diverse modalità di derivazione possibili che possonoessere associate al quadro hohfeldiano. Due di queste modalità sono“interne” allo schema tracciato da Hohfeld, nel senso che sono le unichemodalità di derivazione che è possibile ricavare dalle regole logiche propriedel quadro analitico hohfeldiano. Le altre tre modalità possono essereimpiegate, invece, quando si applica il quadro analitico hohfeldiano allarealtà di un sistema normativo che contenga regole, pratiche e consuetudiniulteriori rispetto ai rapporti di correlazione e opposizione tra gli elementifondamentali previsti da Hohfeld33.
La riflessione angloamericana sui diritti: oltre la teoria della scelta e dell'interesse?,«Ragion Pratica», 42, 2014. 31 Vedi per esempio A. O'Rourke, Refuge From a Jurisprudence of Doubt. HohfeldianAnalysis of Constitutional Law, manoscritto non pubblicato, 2009, disponibile pressohttp://ssrn.com/abstract=1358336, e G. Pino, Diritti soggettivi. Lineamenti di un'analisiteorica, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2 (2009).32 Buona parte degli errori comuni nella letteratura post-hohfeldiana discussi da M.Kramer nell'appendice del suo Rights Without Trimmings, op. cit., sono causati da unainterpretazione grossolana e approssimativa delle modalità di derivazione.33 Un'altra regola di derivazione sarà presa in esame nella sezione 6, discutendo di unapossibile modifica del quadro hohfeldiano standard.
12
Derivazione per correlazione. La prima modalità di derivazione èquella che fa capo alla relazione logica della correlazione, che, come si èvisto, può essere ricondotta a una implicazione biunivoca. Tramite questamodalità di derivazione è possibile stabilire l'esistenza di un elemento apartire dalla presenza del suo correlativo: così, per esempio, se X ha ildovere di φ nei confronti di Y, è possibile stabilire che Y ha la pretesa cheX φ.
Derivazione per opposizione. Generalmente si è sempre prestatoscarsa attenzione a questa modalità di derivazione, sebbene da alcuni autorisia stata impiegata massicciamente34. Essa fa capo alla relazione diopposizione, che può essere ricondotta a una disgiunzione esclusiva.Tramite questa modalità di derivazione è possibile stabilire l'esistenza di unelemento a partire dall'assenza del suo opposto: così, per esempio, se X nonha il dovere di φ nei confronti di Y, è possibile stabilire che X ha la libertàdi non φ nei confronti di Y. Nell'ultima parte di questo lavoro sarannoesaminate le conseguenze paradossali di questa regola di derivazione.
Derivazione per consistenza. Può sembrare ragionevole sostenere che,se X ha il dovere di φ nei confronti di Y, allora X possieda la libertàgenerale di φ – ovvero abbia tante libertà di φ quante sono le contropartipossibili. Altrimenti potrebbe verificarsi il seguente caso:
[10]. (A1): X ha il dovere di φ nei confronti di Y & (B1): X ha ildovere di non-φ nei confronti di Y (o di W, o di Z, ecc.).
Sembrerebbe, in pratica, che a partire da un dovere, da una pretesa(che per correlazione implica un dovere), da una negazione di una libertà(che per opposizione implica un dovere), o da una negazione di una non-pretesa (che per opposizione implica una pretesa), si possa derivare unalibertà generale. In realtà, com'è stato notato35, in un quadro hohfeldianorigoroso ciò non è possibile, poiché partendo dalle regole di correlazione eopposizione non si può derivare il principio di consistenza deontica. Idoveri hohfeldiani, infatti, sono opposti esclusivamente alle libertà di non,e sono quindi compatibili coi doveri di non. Nel quadro standard sonoquindi quattro le combinazioni di elementi che definiscono, per un datosoggetto X, il carattere normativo di una data azione φ nei confronti di unacontroparte Y:
34 Si tratta, per esempio, della modalità di derivazione alla base dell'argomento portatoavanti da Hillel Steiner nel suo Directed Duties and Inalienable Rights, «Ethics», 1232013.35 Sul punto ha insistito M. Kramer, in Rights Without Trimmings, cit., pp.17-22,discutendo a proposito della tesi opposta sostenuta da L. Sumner, The MoralFoundation of Rights, cit., p.23 e 33.
13
Per X φ èobbligatorio
Per X φ è vietato Per X φ èindifferente
Per X φ è oggetto diun conflitto di
doveri
X Doveredi φ
Libertàdi φ
Doveredi non-φ
Libertàdi non-φ
Libertàdi φ
Libertàdi non-φ
Doveredi φ
Doveredi non-φ
Y Pretesadi φ
Non-pretesa
di non-φ
Pretesadi non-φ
Non-pretesa
di φ
Non-pretesa
di non-φ
Non-pretesa
di φ
Pretesadi φ
Pretesadi non-φ
Un corollario di questa peculiarità del sistema hohfeldiano è che essoè, di per sé, neutrale riguardo alle possibilità di esistenza di dilemmigenuini: non è possibile partendo dalla sua logica di fondo escludere lapossibilità che si verifichino conflitti tra doveri.
Derivazione per implicazione da una regola36. Con questa modalità diderivazione usciamo dal quadro hohfeldiano standard e da una concezioneinteramente statica dei diritti. La logica dietro questa modalità diderivazione è che sia possibile derivare nuovi elementi mettendo inrelazione un elemento preesistente con una regola generale ulteriore aquelle hohfeldiane della correlazione e dell'opposizione. Un esempiopotrebbe essere il seguente: supponiamo che vi sia una regola per cui iminorenni non possono stipulare contratti. X è minorenne: quindi non puòstipulare contratti con Y, il quale è invece maggiorenne. In terminihohfeldiani ciò significa che X possiede un'incapacità nei confronti di Y.Per il funzionamento dell'istituzione del contratto, possiamo derivare cheanche Y ha un'incapacità relativa alla possibilità di stipulare contratti conX.
Tornando alla questione precedente del conflitto tra doveri, seconsideriamo valido il principio di consistenza deontica, possiamoreintrodurre la regola di derivazione per consistenza come caso particolaredi derivazione per implicazione da una regola. In questo modo diventapossibile stabilire che:
[11]. X ha il dovere di φ nei confronti di Y X ha il dovere di non-φ⊕nei confronti di Y.
Derivazione per implicazione dalla prassi. Anche in questo casosiamo fuori del quadro hohfeldiano standard e dentro una concezionedinamica dei diritti. Questa modalità di derivazione mette in relazioneconsuetudini e aspettative di carattere generale con la presenza di unelemento hohfeldiano37. Un esempio di implicazione dalla prassi è quello
36 Giorgio Pino definisce questa regola “implicazione pratica”: vedi il suo Dirittisoggettivi, cit.37 Un esempio di implicazione dalla prassi si trova in N. Simmonds, Rights at the
14
che lega libertà e pretese nella consuetudine, in cui non ci si limita aesplicitare la mera tolleranza di certe azioni, ma se ne sancisce anche laprotezione attraverso garanzie di non interferenza. In questo modo potrebbeessere legittimo, date le circostanze, inferire a partire da una singola libertàfondamentale l'esistenza di una cintura di pretese poste a sua protezione.
5. La struttura degli elementi della seconda tetrade
Il secondo problema che affronterò riguarda la struttura normativadegli elementi della seconda tetrade. Svolgerò la questione principalmentedal lato dei poteri, ma tutto ciò che dirò a proposito di questo elementovarrà anche per le incapacità.
Hohfeld non dà una definizione inequivocabile dei poteri. Si limita aenunciarne correlato (soggezione) e opposto (incapacità), e a fornire unaserie di esempi38. La definizione canonica di questo elemento nellaletteratura è la seguente:
[12]. (A1): X ha il potere rispetto a B1 di Y ↔ (A2): Y ha la soggezionenei confronti di X rispetto a B1.
Si tratta di una definizione insoddisfacente. Poniamo infatti chel'elemento B1 sia un dovere:
[13]. (B1): Y ha il dovere di φ nei confronti di W.
È quindi possibile ricavare da [12] che X ha la possibilità ditrasformare il dovere di φ di Y nei confronti di W nella corrispettiva libertàdi non-φ. Ma ciò significa che X è in grado di trasformare anche la pretesadi φ correlativa a B1 in una non-pretesa di φ? Per correlazione ciòsembrerebbe necessario: quindi è plausibile affermare che l'esercizio di unpotere modifica due elementi hohfeldiani, e non uno soltanto come emergeinvece dalla definizione contenuta in [12]39.
La faccenda si fa ancora più complessa se un potere si riferisce a unelemento della seconda tetrade. Consideriamo per esempio questo potere:
[14]. (C1): Z ha il potere rispetto ad A1 di X ↔ (C2): X ha la
Cutting Edge, cit., p.156.38 W.N. Hohfeld, Fundamental Legal Conceptions, pp.21-7.39 Questo problema è stato per la prima volta avvertito da Carl Wellman nel suo ATheory of Rights, cit., dove si tracciano alcuni esempi di poteri con più di uncontroparte. La discussione di Wellman, così come la successiva di Simmonds (che sitrova racchiusa in una nota a pagina 152 del suo Rights at The Cutting Edge, cit.)scalfiscono, però, appena la superficie della questione.
15
soggezione nei confronti di Z rispetto ad A1.
Poniamo che A1 sia il potere espresso in [12]. Quanti elementipossono essere in realtà cambiati dall'esercizio di C1? Chi sono lecontroparti di questo potere? Se ci si attiene alla formulazione data in [12] èdifficile dare una risposta univoca a queste domande. Per correlazione,infatti, l'esercizio del potere C1 comporterebbe la modifica anche delcorrelato di A1; non è chiaro quindi, se si ci si trovi di fronte a un singolopotere o piuttosto a un insieme di poteri in grado di modificare unaposizione normativa complessa.
Un'analisi completa della struttura relazionale degli elementi dellaseconda tetrade che tenga conto di questi problemi non è mai statacompiuta. A mio avviso è possibile raffinare in almeno tre direzioni ladefinizione ingenua dei poteri e delle incapacità in modo da rendere contodella struttura complessa degli elementi della seconda tetrade.
I. Modello “binario”. Il primo modello può essere definito binariopoiché permette di rimanere fedeli all'idea hohfeldiana per cui le relazionigiuridiche sono esclusivamente binarie – coinvolgono, ovvero, sempre esoltanto due elementi hohfeldiani e due soggetti. Attraverso questomodello, inoltre, è possibile salvaguardare – almeno in parte – l'idea di unasimmetria perfetta tra le due tetradi.
La logica di questo modello è che le definizioni contenute in [12] e[14] non sono ingenue, ma vanno piuttosto prese alla lettera: un singolopotere hohfeldiano modifica un unico elemento e ha quindi soltanto unacontroparte. Ciò significa che, per rispettare la regola della correlatività,una norma che specifichi la possibilità di modificare una relazionehohfeldiana deve contenere più poteri: nello specifico, deve contenere tuttii poteri richiesti per modificare gli elementi hohfeldiani coinvolti nellarelazione40. Quindi, nel caso del potere di modificare la relazione tra ildovere B1 e la pretesa correlata B2, oltre al potere specificato in [12] lanorma conterrà anche il seguente potere “gemello”:
[15]. (A3): X ha il potere rispetto a B2 di W ↔ (A4): W ha lasoggezione nei confronti di X rispetto a B2.
In questo modo, una regola secondaria hohfeldiana è formata da duepoteri e due soggezioni. Una regola di terzo livello – una regola il cuicontenuto è una regola secondaria, come nel caso del potere espresso in[14] – avrà invece 4 poteri e 4 soggezioni.
II. Modello “delle controparti multiple”. Il secondo modello rompecon la tesi hohfeldiana per cui un elemento ha sempre soltanto un correlato,
40 Allo stesso modo, una norma di competenza che impedisce la modifica di unarelazione hofheldiana dovrà contenere due o più immunità.
16
e quindi un'unica controparte. In questa maniera sono abbandonate le ideeche: a) vi sia una simmetria perfetta tra le due tetradi e all'interno di esse(almeno per quanto riguarda la seconda); b) le relazioni giuridichefondamentali siano esclusivamente binarie.
La logica di questo modello è che un singolo potere possa avere piùsoggezioni correlate – e quindi più controparti. In questo modo l'eserciziodi un unico potere è in grado di essere alla base di una regola secondaria, inquando permette di modificare tutti gli elementi coinvolti in una relazionehohfeldiana, per quanto complessa questa possa essere. La giustaformulazione del potere contenuto in [12] è secondo questo modello laseguente:
[16]. (A1): X ha il potere rispetto a B1 di Y e al suo correlato B2 di W↔ (A2): Y ha la soggezione nei confronti di X rispetto a B1 & (A3): W ha lasoggezione nei confronti di X rispetto a B2.
La formulazione corretta del potere contenuto in [14] è invece:
[17]. (C1): Z ha il potere rispetto ad A1 di X e ai suoi correlati A2 di Ye A3 di W ↔ (C2): X ha la soggezione nei confronti di Z rispetto ad A1 &(C3): Y ha la soggezione nei confronti di Z rispetto ad A2 & (C4): W ha lasoggezione nei confronti di Z rispetto ad A3.
In questo modo una regola secondaria è composta sempre da treelementi: un potere e due soggezioni. Una regola di terzo livello, invece, haquattro elementi: un potere, tre soggezioni. Per ogni livello aggiuntivo ilnumero di elementi coinvolti cresce sempre di una soggezione, ma il potererimane sempre unico.
III. Modello “dei titolari multipli”. Il terzo modello rimane fedele allatesi hohfeldiana per cui ogni elemento ha un unico correlato. Come ilmodello precedente, però, anche qui si ridimensionano sia l'idea di unasimmetria perfetta tra gli elementi della seconda tetrade e tra le due tetradi,sia quella che le relazioni giuridiche fondamentali debbano esserenecessariamente binarie.
La logica di questo modello è che poteri e incapacità possono averepiù di una controparte, mentre soggezioni e immunità possono avere più diun titolare. Tutti e quattro gli elementi, però, hanno un unico correlato.Soggezioni e immunità, in pratica, possono essere condivise tra diversititolari, e conseguentemente, poteri e incapacità, pur avendo un unicocorrelato hanno più controparti. Secondo questo modello la giustadefinizione per il potere contenuto in [12] è la seguente:
[18]. (A1): X ha il potere rispetto agli elementi B1 di Y e B2 di W ↔
17
(A2): Y e W hanno la soggezione nei confronti di X rispetto ai loroelementi B1 e B2.
Il potere espresso in [14] va invece così riformulato:
[19]. (C1): Z ha il potere rispetto agli elementi A1 di X e A2 di Y e W↔ (C2): X,Y e W hanno la soggezione nei confronti di Z rispetto ai loroelementi A1 e A2.
In pratica, secondo questo modello una regola secondaria è formata daun unico potere, il quale correla con una sola soggezione che può avere piùdi un titolare. Lo stesso accade per le regole di terzo livello e successivo:ciò che aumenta sono le controparti del potere – e quindi i titolari dellasoggezione.
6. Analisi dei modelli
Prima facie tutti e tre i modelli sembrerebbero in grado di assolvere ilcompito per il quale sono stati formulati: fornire una descrizionelogicamente coerente della struttura relazionale degli elementi dellaseconda tetrade. Ciò non significa però che la scelta tra essi sia indifferente.In questa sezione analizzerò in dettaglio le caratteristiche dei tre modelli,per poi passare nel prossimo a compiere una valutazione comparata.
I. Modello “binario”. Questo modello è probabilmente il più fedeleallo spirito originario del quadro hohfeldiano standard, poiché salvaguardiala struttura binaria della correlazione e dell'asse titolare/controparte41. Ilmodo in cui sono definiti i poteri e gli altri elementi della seconda tetrade èinoltre piuttosto semplice, e rispetta la struttura generale degli elementidella prima tetrade. Pure, il prezzo di questa semplicità è pagato con unagrande quantità di elementi richiesti per costruire le norme di competenza,e con regole ulteriori che è necessario introdurre per evitare inconsistenze.
Cominciamo dalla prima questione. Per costruire una regolasecondaria – una norma di competenza che abbia come contenuto latrasformazione di una coppia di elementi della prima tetrade – sononecessarie due coppie di elementi della seconda tetrade. Per costruire unaregola di terzo livello – una norma di competenza riguardo allatrasformazione degli elementi di una regola secondaria – vi è bisogno diquattro coppie di elementi. Ciò accade perché una regola secondaria èformata da quattro elementi: secondo questo modello è necessario poterli
41 George Rainbolt, l'unico autore che a mia conoscenza ha affrontato questo problema,propende per questo modello, ritenendolo “ortodosso”, ma non formula alcunaalternativa. Vedi il suo The Concept of Rights, cit., pp.19-22.
18
modificare tutti per avere una regola di terzo livello, e conseguentementesaranno necessari quattro poteri e quattro soggezioni; una regola di quartolivello, poi, ne avrà sedici, e così via, secondo una progressione perquadrati di due. Ciò significa, tanto per avere un'idea dell'esplosione dielementi richiesti, che una eventuale regola di decimo livello sarebbeformata da ben 1024 elementi della seconda tetrade.
Secondariamente, questo modello è incompleto senza l'aggiunta diulteriori regole che evitino inconsistenze nel funzionamento dei poteri. Visono due problemi da risolvere a proposito: a) per rendere effettiva latrasformazione di tutti gli elementi parte di una relazione hohfeldiana bastaesercitare un potere relativo a uno di questi elementi, oppure è necessarioesercitarli tutti?; b) i poteri che fanno parte di una stessa regola dicompetenza possono ognuno avere una diversa azione normativa o devonoinvece condividere la stessa? Le due questioni possono essere discusseassieme, partendo dal presupposto che per entrambe non vi è una rispostagiusta in sé, quanto piuttosto delle ragioni pragmatiche per preferire alcunesoluzioni piuttosto che altre. Data la quantità di poteri di cui può esserecomposta una norma di competenza, e le inconsistenze che da qui sipotrebbero venire a creare, la soluzione migliore consiste probabilmentenello scegliere tra due opzioni: a) se non si vuole rinunciare all'idea che perattivare una norma di competenza sia richiesto l'esercizio di tutti i poteriche la formano, allora è necessario accettare la regola per cui vi è un'unicaazione normative condivisa da tutti i poteri di una norma; b) se non si vuolerinunciare invece all'idea che ogni potere di una stessa norma dicompetenza possa avere un'azione normativa diversa, allora è necessarioaccettare la regola per cui per attivare una norma basta l'esercizio di uno deisuoi poteri. Una di queste due regole è necessaria perché altrimentil'esercizio di una norma di competenza rischierebbe di trasformarsi inun'impresa paradossale e realizzabile secondo diversi stadi o gradi.
II. Modello “delle controparti multiple”. Questo modello ha quattroaspetti peculiari. Il primo aspetto è l'asimmetria tra la struttura di poteri eincapacità da una parte, e di soggezioni e immunità dall'altra. Questaasimmetria si ripercuote sul diverso numero di poteri e incapacità rispetto asoggezioni e immunità: l'insieme dei primi è più piccolo di quello deisecondi. Ciò non significa – e veniamo così al terzo aspetto peculiare – chequesto modello debba fronteggiare i problemi riguardanti l'esercizio deipoteri di cui si è discusso a proposito del precedente modello binario. Ilmodello delle controparti multiple, infatti, prevede sempre un solo potereper ogni norma di competenza. La quarta peculiarità di questo modello èl'asimmetria informativa presente tra poteri e incapacità da una parte, esoggezioni e immunità dall'altra. Dalla definizione di un potere (o di unaincapacità) è infatti possibile ricavare per correlazione tutti gli elementiimplicati. Da una singola soggezione (o immunità), invece, il cammino per
19
ricostruire una norma di competenza è più tortuoso, e si può parlare aproposito di una nuova regola di derivazione – derivazione pertriangolazione. Un esempio di derivazione di questo genere è il seguente:supponiamo di dover ricostruire la norma espressa in [17]. Partendo dalpotere C1 non ci sono problemi, poiché questo specifica per correlazionetutte le controparti e le soggezioni implicate. Al contrario, partendo da unadelle soggezioni C2, C3, o C4 l'operazione non è lineare, poiché di per sénessuno di questo elementi, se preso singolarmente, implica direttamente lealtre soggezioni o il potere C1. Partiamo per esempio dalla soggezione C2 eda quelli che sono gli elementi che essa ricapitola nella sua descrizione:
[20]. (C3): Y ha la soggezione nei confronti di Z rispetto ad A2.[21]. (A2): Y ha la soggezione nei confronti di X rispetto a B1.[22]. (B1): Y ha il dovere di φ nei confronti di W.
Da [22] si può ricavare per correlazione che:
[23]. (B2): W ha la pretesa di φ nei confronti di Y.
Mettendo in relazione questo risultato col fatto che A2 è unasoggezione, e che pertanto vi sarà una soggezione analoga sul correlato diB1, si può derivare che:
[24]. (A3): W ha la soggezione nei confronti di X rispetto a B2.
A questo punto ci sono tutti gli elementi (le due soggezioni A2 e A3)per ricostruire il potere A1:
[25]. (A1): X ha il potere rispetto a B1 di Y e al suo correlato B2 di W.
Le due soggezioni mancanti (C2 e C4) possono adesso essere ricavateperché sono diventati noti gli elementi A1 e A3:
[26]. (C2): X ha la soggezione nei confronti di Z rispetto ad A1.[27]. (C4): W ha la soggezione nei confronti di Z rispetto ad A3.
E a questo punto ci sono tutti i tasselli per ricostruire la norma dicompetenza completa:
[28]. (C1): Z ha il potere rispetto ad A1 di X e ai suoi correlati A2 di Ye A3 di W ↔ (C2): X ha la soggezione nei confronti di Z rispetto ad A1 &(C3): Y ha la soggezione nei confronti di Z rispetto ad A2 & (C4): W ha lasoggezione nei confronti di Z rispetto ad A3.
20
Attraverso la regola di derivazione per triangolazione è quindipossibile ricostruire una norma di competenza anche a partire da unasingola soggezione e immunità, nonostante l'asimmetria informativa traquesti due generi di elementi da una parte, e i poteri e le incapacitàdall'altra.
III. Modello dei “titolari multipli”. Invece di moltiplicare gli elementiin seno a una norma di competenza (modello binario) o di distribuirli inmaniera difforme (modello delle controparti multiple), il modello deititolari multipli prevede la possibilità per uno stesso elemento hohfeldianodi avere più controparti (poteri e capacità) o titolari (soggezioni eimmunità). Almeno a prima vista, questo modello sembra essere moltoattraente. Non è ipertrofico per quanto riguarda il numero di elementiimplicati; non richiede regole ulteriori riguardo all'esercizio delle norme dicompetenza; le relazioni tra gli elementi sono perfettamente simmetriche edè così rispettato uno degli architravi su cui Hohfeld ha edificato la suacostruzione.
Come per il modello delle controparti multiple è possibile poiricostruire un'intera relazione hohfeldiana a partire da un suo frammento.Supponiamo per esempio di sapere che:
[29]. Y è soggetto al potere B1 di X nei confronti di A1.
Pur non essendo questo un elemento hohfeldiano, ma soltanto una suaparte (una parte della soggezione B2 correlata al potere B1 di X) siamocomunque nelle condizioni di ricostruire tutta quanta la relazione: da A1
siamo infatti in grado per correlazione di derivare A2, da qui ricostruire poila soggezione B2 e per correlazione derivare poi il potere B1.
Nonostante questi pregi, il modello dei titolari multipli non è esente daproblemi. Spezzando il rapporto esclusivo che nel quadro hohfeldianostandard lega la titolarità di un elemento a un singolo soggetto vengonomeno alcune caratteristiche fondamentali del sistema: caratteristiche dinatura normativa. Questo modello, infatti, deve necessariamente fare ameno dell'idea che gli elementi hohfeldiani siano titoli personali: che aogni elemento corrisponda un singolo soggetto. In questo modo si perdeuna delle caratteristiche più interessanti del quadro hohfeldiano, che èquella di rendere conto di una serie di aspetti cruciali nella definizione delleposizioni normative soggettive.
Uno di questi aspetti è che le posizioni soggettive sono spessogiustificate a partire da determinati tratti della personalità del loro titolare.Questo modello indebolisce (se non abbatte del tutto) la possibilità da partedel quadro hohfeldiano standard di rendere conto di questo aspetto, poichéscardina l'idea che i suoi elementi siano oggetti normativi necessariamente
21
personali. Soggezioni e immunità diventano infatti elementi condivisi, cui isoggetti partecipano, ma per i quali non ci può essere una esclusivatitolarità – e quindi una relazione esclusiva tra il loro possesso e l'essere illocus di un peculiare interesse legale o morale42.
Un secondo aspetto coinvolge invece la stessa logica dei dirittiimplicata da questo modello. Buona parte delle analisi teoriche considera leimmunità – o quantomeno alcune tipologie di immunità – parte integrantedel concetto di diritti43. Accettando questo modello le immunità possonoessere sì considerate dei diritti, ma soltanto in quanto diritti collettivi – ilcui titolare è un gruppo, non un singolo. Diritti individuali e diritti collettivisono categorie molto diverse tra loro, sopratutto per quanto riguarda glieffetti della loro violazione o infrazione, e ciò è particolarmente evidenteproprio nel caso delle immunità, dove il contenuto violato è un'altra normahohfeldiana. Ciò che va perso, infatti, nella logica dei diritti collettivi, è lapossibilità di differenziare il torto subito dai singoli individui che fannoparte del gruppo titolare del diritto. Supponiamo il seguente caso:
[30]. (A1): X ha la pretesa di φ nei confronti di Y ↔ (A2): Y ha il
dovere di φ nei confronti di X.[31]. (B1): W ha l'incapacità nei confronti di Y e X rispetto ai loro
elementi A1 e A2 ↔ (B2): Y e X hanno l'immunità nei confronti di Wrispetto ai loro elementi A1 e A2.
Se adesso W viola l'immunità di Y e X facendo valere un potere che inrealtà non ha, la relazione hohfeldiana espressa in [30] è ingiustamentemodificata in questo modo:
[32]. (A1): X ha la non-pretesa di φ nei confronti di Y ↔ (A2): Y ha lalibertà di non-φ nei confronti di X.
Ma la violazione commessa da W ha effetti diversi su X e su Y:
nonostante entrambi abbiano subito un torto, il genere di questo torto èdiverso: X non è più un grado di rivendicare φ come qualcosa che gli èdovuto, mentre Y ha adesso la facoltà di scegliere se portare avanti l'azioneφ oppure no. Mentre nei due modelli precedenti i diritti violati sono due – ein questo modo è possibile interpretare le violazioni e gli eventuali obblighidi compensazione che ne conseguono in maniera differente – in questo
42 Su questa funzione peculiare della titolarità, vedi P. Jones, Rights, London,Macmillan, 1995, p.93.43 Basti pensare, per esempio, che alcuni diritti fondamentali come il diritto alla parolasono formulati proprio nei termini di una immunità: è il caso per esempiodell'ordinamento statunitense. Sull'argomento cfr. D. Lyons, Correlativity of Rights andDuties. «Nous», 4 (1970).
22
modello la violazione è unica e non si è logicamente costretti a riconoscereuna differenza tra il torto subito da X e quello subito da Y – poiché di fatto,il torto è prima di tutto nei confronti un gruppo, e solo in seconda istanzaeventualmente nei confronti di soggetti diversi. Ciò accade perché in questomodello l'immunità ha come contenuto la relazione tra due elementi, e nongli elementi stessi: ma cancellare una pretesa può dare luce a situazionidiverse dal cancellare un dovere, così come cancellare una libertà non ècancellare una non-pretesa, e così via.
7. Quale modello?
Dall'analisi precedente si può ricavare che, pur non essendoci ragionisoverchianti per adottare un modello piuttosto che un altro, il modello dellecontroparti multiple è probabilmente il più adatto a spiegare la strutturadegli elementi della seconda tetrade. Questo giudizio si basa su unacomparazione che effettuerò in questa sezione adottando tre diversi assi divalutazione: a) un asse su cui è misurata la distanza dalla struttura logicaoriginaria del quadro hohfeldiano; b) un asse su cui sono misurateeleganza, semplicità, e coerenza; c) un asse su cui è misurata la capacità direndere conto delle funzionalità normative legate al discorso sui diritti.
Primo asse. Nessuno dei tre modelli è completamente conservativorispetto al quadro hohfeldiano originale per come lo si è presentato inprecedenza: a) il primo lo è solo apparentemente, poiché richiede regoleaggiuntive sull'esercizio dei poteri per evitare incoerenze; b) il secondoscardina la simmetria perfetta vigente nel quadro hohfeldiano standard, eintroduce una nuova regola di derivazione; c) il terzo modello scardinaanch'esso la simmetria perfetta del quadro hohfeldiano standard, sebbene inuna misura minore rispetto al modello delle controparti multiple.
Secondo asse. Tutti e tre i modelli sono in grado di assolvere alla lorofunzione senza creare inconsistenze col quadro hohfeldiano, ma: a) il primomodello è poco elegante, poiché è molto dispendioso nei termini delnumero di elementi richiesti per costruire le norme di competenza; b) ilsecondo modello è più economico del primo; c) il terzo modello è di granlungo il più economico ed elegante.
Terzo asse. Qui la valutazione non può che propendere verso i primidue modelli, poiché: a) il modello binario è esplicativamente equipollenterispetto alla spiegazione del discorso sui diritti data dal quadro hohfeldianostandard; b) il modello delle controparti multiple è esplicativamenteequipollente rispetto alla spiegazione del discorso sui diritti data dal quadrohohfeldiano standard; c) il modello dei titolari multipli disarticola ilrapporto tra titolarità e personalità.
Dando per scontata la priorità della valutazione lungo il terzo asse
23
rispetto alle altre – poiché il fine ultimo dell'analisi hohfeldiana è quella difornire un quadro esplicativo coerente del discorso sui diritti – la scelta èquindi tra conservatività ed eleganza. In questo caso non vedo ragioni perpreferire la prima alla seconda, ed è a mio avviso col modello dellecontroparti multiple che si dovrebbe integrare il quadro hohfeldianostandard al fine di fornire una spiegazione efficiente della strutturanormativa e relazionale degli elementi della seconda tetrade.
8. Derivazione per opposizione: una deriva infinita
Passiamo adesso al terzo problema. Come ho accennato inprecedenza, alla modalità di derivazione per opposizione è stata dedicatascarsa attenzione, sebbene se ne possano trarre delle conseguenze piuttostointeressanti – ancorché deleterie per la tenuta del quadro hohfeldianostandard.
Un primo aspetto che si può ricavare dalla regola di derivazione peropposizione è che, in un sistema normativo hohfeldiano, non è possibiledistinguere tra permessi deboli e forti44. Avere una libertà generale di φsignifica non avere alcun dovere di φ, e ciò coincide con l'avere il permessoincondizionato di compiere φ. Dato che la relazione di opposizione nelquadro hohfeldiano è simmetrica, non c'è alcuna differenza nel considerarequesto permesso come il frutto di un'assenza di doveri, o come il fruttodella presenza di libertà generali.
Il secondo e più intrigante aspetto che si può ricavare dalla regola diderivazione per opposizione è la necessaria completezza di ogni sistemanormativo hohfeldiano. Ogni azione φ può essere infatti oggetto di unalibertà o di un dovere (così come di una pretesa o di una non-pretesa): epoiché l'opposizione è definita come disgiunzione esclusiva, di fatto, ogniazione φ sarà oggetto di una libertà o di un dovere. Ciò implica che èanaliticamente vero che un sistema hohfeldiano sia saturo di elementi dellaprima tetrade. Per questo motivo, è una proprietà dei sistemi normativihohfeldiani essere necessariamente privi di lacune.
Il vero paradosso che si può ricavare dalla regola di derivazione peropposizione è posto però a un livello di analisi ulteriore. Il sistemanormativo hohfeldiano più grande che si possa pensare è quello che copretutte le azioni possibili – le quali sono di per sé infinite. Conseguentemente,il numero di elementi hohfeldiani della prima tetrade coinvolti in questosistema sarà infinito: e lo stesso varrà anche per gli elementi della seconda
44 Su questa distinzione, vedi G.H. Von Wright, Norm and Action, cit. Per un sinteticoma efficace inquadramento del problema vedi T. Mazzarese, Permesso forte e permessodebole: note a margine, in P. Comanducci, R. Guastini, a cura di, Analisi e diritto.Ricerche di giurisprudenza analitica, Torino, Giappichelli, 2000.
24
tetrade. Ciò accade perché, essendo ogni elemento della prima tetradepotenzialmente oggetto di due elementi della seconda, per la regola diderivazione per opposizione di fatto lo sarà, e una infinità “orizzontale” dielementi della seconda tavola duplicherà l'infinità “orizzontale” deglielementi della prima.
Un sistema del genere sarebbe difficilmente gestibile (come costruireun insieme di regole che presieda a un numero infinito di posizionielementari?), ed è facile pensare che le cose stiano diversamente nel casoinvece in cui il numero di azioni oggetto del sistema sia finito. Ma non ècosì: anche per un sistema circoscritto il numero degli elementi dellaseconda tetrade è comunque infinito. L'estensione di poteri, incapacità,immunità, e soggezioni, infatti, non è soltanto delimitata “orizzontalmente”dal numero di elementi della prima tetrade, ma anche “verticalmente” dallaquantità di livelli di norme di competenza che possono darsi. Gli elementidella seconda tetrade possono accumularsi su se stessi, e, poiché per ognilivello di norme di competenza ve ne può essere un successivo, per laregola di derivazione per opposizione, di fatto, sarà così.
In pratica, dato che ogni elemento hohfeldiano può essere oggetto diun elemento della seconda tetrade, non esiste un limite alla quantità dipoteri, incapacità, ed elementi correlati che si può avere anche in unsistema minimo dove vi sono soltanto due soggetti, un'azione possibile, equattro elementi della prima tetrade. Ciò significa che il numero dei“livelli” delle norme di competenza è infinito: e ciò è vero sia per unsistema hohfeldiano che ha per oggetto un numero infinito di azioni, sia persistemi che hanno invece per oggetto un numero finito di azioni. Puressendo completo, un sistema normativo hohfeldiano è quindinecessariamente aperto, nel senso che non conosce limiti per quantoriguarda il numero di livelli di regole di cui è composto, e questo aspettoderiva dal modo in cui è definita la regola di opposizione.
9. Riformare il quadro hohfeldiano
L'infinità “orizzontale” è una proprietà del sistema normativohohfeldiano più grande che possiamo immaginare, l'infinità “verticale” èinvece una proprietà di tutti i sistemi normativi hohfeldiani. E se l'infinità“orizzontale” rende difficilmente gestibile da un punto di vista pratico edepistemico un sistema normativo, l'infinità “verticale” lo invalida del tutto.Il loop attraverso cui si affastellano l'uno sull'altro sempre nuovi livelli dinorme di competenza rende infatti ingestibile un sistema normativo poichéimpedisce l'identificazione definitiva dei soggetti che sono in grado diintervenire e modificare l'assetto degli elementi – e in questo modoimpedisce di determinare qual è, in ultima istanza, il carattere normativo
25
associato alle azioni. Se, insomma, il problema con l'infinità “orizzontale” èlegato alla impossibilità di acquisire abbastanza informazioni sullavalutazione di infinite azioni, il problema con l'infinità “verticale” è piùradicale, poiché è legato alla impossibilità di raggiungere una valutazionedeterminata delle azioni.
Se le cose stanno così, il quadro hohfeldiano standard non è né unabuona descrizione dei sistemi normativi giuridici, né una cornice logicaefficace per riformarli in maniera ordinata e coerente, perché costringe acostruire sistemi normativi con un numero infinito di norme di competenza.In questo modo, l'intento originale di Hohfeld viene meno, e il suo schemaperde valore. Fortunatamente però, anche in questo caso sembra possibileintervenire per risolvere il problema.
La chiave della questione risiede, come si è visto, nelle regole diderivazione – che sono la causa del regresso all'infinito cui è condannatoogni sistema normativo hohfeldiano standard. Queste regole non sono altroche applicazioni delle due relazioni tramite cui Hohfeld definisce ognunodegli otto elementi giuridici fondamentali: manometterle significa quindimanomettere il cuore pulsante del suo schema. Non a caso, la relazione dicorrelazione sembra da questo punto di vista intoccabile: ciò per almenodue motivi: a) eliminare il rapporto di correlazione significherebbe troncarela connessione tra i diritti e le strutture normative associate; b) senzacorrelazione viene meno la possibilità di interdefinire gli elementi diognuna delle due tavole partendo da un primitivo, e ogni elemento diventaimprovvisamente un'isola a sé. Senza correlazione, in pratica non c'è più ilquadro hohfeldiano: ma soprattutto non c'è più neanche un'analisi dei diritticoerente45.
Riformulare l'opposizione sembra invece fattibile. Una strategia a talproposito potrebbe essere quella di concepirla non più come unadisgiunzione esclusiva, ma come una negazione alternativa. Tramitel'opposizione non si indicherebbe più una relazione di questo tipo:
[33]. X ha un dovere di φ nei confronti di Y1 Y⊕ 1 ha una libertà dinon-φ nei confronti di X.
Bensì:
[34]. X ha un dovere di φ nei confronti di Y1 ↑ Y1 ha una libertà dinon-φ nei confronti di X.
E mentre [33] specifica che è necessario che o vi sia un dovere di φ, o
45 Un esempio di analisi dei diritti che nega ogni rapporto di correlazione necessario tradiritti e altre struttura normative è quella di A. White, Rights, Oxford, Clarendon, 1984.Critiche a questo approccio si ritrovano in M. Kramer, Rights Without Trimmings, cit.
26
la libertà di non-φ, [34] indica invece tre possibilità: che vi sia il dovere diφ, che vi sia la libertà di non-φ, oppure che non vi sia nessuna delle due. Inquesto modo, fermo restando il principio per cui elementi opposti sinegano, la deriva “orizzontale” e “verticale” dei sistemi hohfeldianistandard non è più necessaria.
Vi sono, però, delle ripercussioni. La più evidente è che, sebbene unsistema sia ora chiuso, non può più considerarsi completo. Al suo interno visi potrebbero adesso trovare vasti “spazi” di anomia, in cui le azioni nonsono soggette ad alcuna norma. Ciò non è necessariamente un problema: dauna parte, infatti, le lacune sono una componente normale dei sisteminormativi reali, dall'altra parte un sistema normativo costruito a partire dalquadro emendato non è necessariamente incompleto, ma lo è soltantopotenzialmente – è sempre possibile, infatti, assegnare a ogni azione dellenorme hohfeldiane. E un sistema hohfeldiano così costruito è in ogni casocoerente, dal momento che le relazioni di correlazione e opposizione invigore garantiscono uno sviluppo ordinato delle relazioni hohfeldianepresenti tra i soggetti.
Un'altra possibile soluzione al problema dell'infinità “verticale”potrebbe essere quella di affiancare agli elementi della seconda tetrade altriquattro elementi analoghi che copino tutte le funzioni normative dei primieccetto due caratteristiche: la direzionalità, e la correlatività46. Sarebbeforse possibile in questo modo preservare il significato della relazione diopposizione come disgiunzione esclusiva. In questo modo si potrebbeassicurare la completezza del sistema e allo stesso tempo la sua chiusura.Secondo quelle che sono le nostre esigenze normative sarebbe infattipossibile “sigillare” il sistema normativo con uno strato di incapacità eimmunità non-hohfeldiane che impediscano in questo modo la generazionedi nuovi strati di norme di competenza tramite la derivazione peropposizione. Si tratta questa di una soluzione che, come la precedente,andrebbe sviluppata ulteriormente e analizzata in quelli che sono i suoicosti, ma che potrebbe comunque garantire il risultato che stiamo cercando.
Al di là di quelli che potrebbero essere gli sviluppi, ciò che èinteressante qui è come queste due diverse modifiche del quadrohohfeldiano standard evidenzino quelli che sono dei limiti della concezionestatica. Questi limiti, però, non comportano a mio avviso la necessità di unsuo abbandono in favore di un'adesione a una concezione dinamica, quantouna integrazione tra i due paradigmi. I limiti di una concezioneesclusivamente dinamica dei diritti sono di per sé piuttosto evidenti:soprattutto per quanto riguarda la genericità di un simile approccio, e irischi di incoerenza che porta con sé, dal momento che molto spesso le
46 Oggetti normativi di questo genere, sebbene non adoperati con questo scopo, sonobrevemente presi in considerazione da George Rainbolt nel suo The Concept of Rights,cit.
27
relazioni logiche tra le varie componenti del linguaggio dei diritti non sonospecificate in maniera dettagliata ed esaustiva. La concezione staticahohfeldiana offre gli strumenti per uscire da questi limiti. Ma allo stessotempo ha bisogno di essere affiancata da una concezione di più largorespiro – una concezione dinamica per l'appunto – perché possa esseregiustificata la chiusura e la completezza di un sistema normativo che,adoperando soltanto gli strumenti offerti dal paradigma statico, è destinatoa essere aperto e incoerente.
28