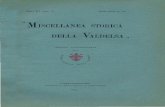Stato economico d'eccezione e teoria della governance: ovvero la fine della politica
L'ospedale di S. Maria della Scala di S. Gimignano nel Quatttrocento. Contributo alla storia...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of L'ospedale di S. Maria della Scala di S. Gimignano nel Quatttrocento. Contributo alla storia...
LOz L,oSPEDALE DI S. MARIA DELLA SCALA DI S. GIMIGNANO
el dì d'Ognissanti )>, << €l dì di Sant'Antonio da Padova, a dì 13 di giu-
gno )> e altre frasi di questo genere, che paiono soddisfare più che undesiderio di precisione, quello di porvi I'accento, secondo le intenzionidi chi aveva portato i bambini.
Fra i mesi, marzo eta il più frequentato e una brusca cadtfia si regi-
sttava, poi, sino a1 pieno dell'estate, quando con luglio, ma specialmente
in agosto e un po' meno ma anche a settembre, i bambini ricomincia-
vano a venire. In autunno gli arrivi languivang ancora, per riprendere,poi, Ientamente, con sempre maggiore vigore a novembre, dicembre, ma
particolarmente in gennaio, che dopo matzo era il mese che ne contava
di più, lasciandone diversi anche a febbraio.Tale distribuzione stagionale degli abbandoni, ci fa intendere come,
se per il periodo novembre-gennaio, il sostenuto aflusso di bambiniportati all'ospedale, può essere attribuito alla concentrazione dei matrimoni in febbraio, avanti la quaresima, e ad un numero maggiore di na-
scite, seguite ai concepimenti primaverili, il notevole stacco di marzo,
rispetto a tutti gli altri mesi e anche di agosto, dipendesse, invece, dallaripresa dei lavori agricoli, favoriti dal buon tempo in pdmaveta e dal-
f intensa stagione dei raccolti, che vedevano impegnati i contadini per
buona parte di luglio, tutto agosto e anche settembre 81. Tutto ciò, sta a
dimostrarci, una volta di più, nel caso ce ne fosse ancota bisogno, che
all'assistenza dell'ospedale facevano ricorso le famiglie contadine più po-
vere, intimamente legate alla terru per il loro sostentamento e la cuivita seguiva pacatamente 1o svolgersi delle stagioni: misera e assopita
nei lunghi inverni, quasi frenetica dal7'alba al tramonto, con pochissimo
tempo da dedicare ai bambini, in primavera e in estate.
Recati da un'umanità varia, le cui caratteristiche, quando era possi-
bile scorgerle, venivano ogni volta fissate dal frate sul suo regisffo e
non di rado a memoria, dato che non sempre, come abbiamo già accen-
nato, chi era stato sorpreso a lasciate i bambini permetteva ulteriori ap-
procci, a meno che, ma in tal caso si davano per intero le generalità, non
fossero consegnati personalmente, i bambini, in genete, si dicevano pot-
tati da << due donne rr, du ., un uomo e una donna rr, d, .. due uomini >>,
da << un forestiere ,r, da ,, un contadilo )> o, come accadeva di frequente,
El Per 1'andamento stagionale delle nascite, si veda A. F. CanpeuoNe, ll ciclostagionale dei ruatrintoni, dàle nascite e dei decessi a Bitonto d,al 1661' al
-7800, .inDimografia storica at., pp. 227-T6 e C. A. ConsrNt, Ricerche di denzografia storicacit., pp. 167-t94.
GLI ESPOSTI
da << un garuone n, du ,, un uomo vecchio »>, da << un fanciullo poveret-to », cui erano stati affidati, probabilmente in cambio di una piccola ri-compensa, dagli interessati, sempre timorosi di dover dare una spiega-zione qualsiasi. Solo il 24 maggio del 1"507, Augusta Domenica, fu por-tata da un << vetturale », ma è l'unico caso e, in genere, l'abbandono nonè mai così impersonale u'; c'è sempre qualcosa, che alTatga iI cuore delrettore a77a speranza e {a aguzzate i suoi occhi nell'oscurità. Per TaddeaIsotta, giunta la notte del 26 ottobre del 1426, fu, ad esempio, notatoche << arecarolla due uomini ed avevano una lanterna accesa >> e perAgnola, ancora, lasciata alle sei di notte del 29 settembre 144L, si scrisseche fu recata anche lei da due uomini, che << avevano uno cagniuolo conloro sé » s.
Uqa ..< pila r>, uso quelle adoprate per l'acqua benedetta nelle chie-se e montata su delle colonne, a giudicare da alcuni riferimenti che vivengono fatti, era il posto dove venivano lasciati i bambini che si vole-vano abbandonare. Niente << buche >> e niente << ruote >>, strumenti pro-pri ai futuri ospedali per bambini della fine del XV e del XVI secoloe, del resto, anche a San Gallo, l'antico ospedale fiorentino, più voltenominato, i barnbini venivano Tasciati << sotto il portico »>, vicino allaporta d'ingresso, dove anche la nostra << pila », pare fosse sistemata &.
_ 32 << Augusta Domenica, ponemo nome alla bambina, ci fu posta nel1a pilaa d\ 2! di maggio a, ore otto. Recò seco una fascia trista e un cenciò Tino per pezzae recolla un vetturale >> (Libro di barnbini e balie segn. E (1487-15L2), 1.6-, c.-Ll4).
83 << Taddeia Isotta, ponemo nome alla fanciulla, che fu posta nella pila sa-bato notte a dl 26 d'ottobre, atecatoTla due uomini ed avevano una lanterna ac-cesa. Aveva la detta fanciulla uno dì o circa, arecò ffe stracci di pezze line e unogherone di gonnella pet pezza Tana>> (Balie e barnbini segn. B (14L3-1454), 14, c.20); « Agnola, ha nome 7a fanciolla, che fu posta ne1la pila venerdì notte, alle sei20); « Agnola, ha nome 7a fanciolTa, che fu posta ne1la pila venerdì notte, alle seiore di notte, arecò questi segni: una scrittolina al collo, legata con refe bianco ediceva: questa fanciulla è battezzata ed ha nome Agnola. Fu a dì 29 di settembre.ore di notte, arecò questi segni: una scrittolina al collo, legata con refe bianco ediceva:_ questa fanciulla è battezzata ed ha nome Agnola. Fu a dì 29 di settembre,anno detto. Arecò una pezza lina ruppezzata e unà {ascia usata e. due uomini Iarecarono ed avevano uoo cagniuolo con loro sé»> (Balie e bambini segn. B (1413-
t03
L454), L4, c. 34).84 D^. C^-Per San Gallo i nosti dati si riferiscono al regismo più volte indicato dis Per San Gallo i nostri dati si riferiscono al regismo più volte indicato di
Balie e barnbini (1.394-1.401), 6, dal quale sappiamo che i bambini venivano lasciatisotto il portico e che vicino alla porta dell'ospedale vi era pure una « pila deLsotto il portico e che vicino alla porta dell'ospedale vi era pure una « pila deLl'acqua benedetta », che, però, evidentemente conservava il suo uso originario el'acqua benedetta », che, però, evir scqua Dcleoerra ]>, cne, pero, evlcrenlemeflIe conselvava il suo uso orlgmallo enon quello proprio alla ptTa sangimignanese. È noto, invece, che l'ospedale degliInnocenti, sorto, come sappiamo, alla metà del XV secolo, aveva una << buca >> e chea partire dal 1500, per l'aumento deeli abbandoni, venoero accettati solo i bam-a partire dal 1500, per l'aumento degli abbandoni, venoero accettati solo i bam-bini in grado di passare attraverso i fori di una << finestrella ferrata »>, che costituivaappunto la cosiddetta << buca », quale ancor oggi possiamo vedere sotto il portico,ma è probabile, come pare fosse ovunque, nonostante Ie varie disposizioni, che an-che i più grandi vi {ossero lasciati ugualmente e di nascosto; ad ogni modo atta-verso i fori delf inferriata, vi passavano i bambini fino ad un anno di età. Perl'ospedale degli Innocenti, dr. L, PessnnrNr, Storia degli stabilimenti cit., pp. 697-698,
104 L OSPEDALE DI S. MARIA. DELLA SCALA DI S. GIMIGNANO
Quasi il 60Vo dei bambini abbandonati, furono detti .< posti nellapila ». L'espressione << fu recato e posto nella piia »>, ci fa intendere,però, che la deposizione nella << pila »>, fosse, oltre che .< necessaria >>,
specie per i bambini piccoli, molti dei quali sappiamo abbandonati infretta e furia e certamente piir sicuri ad una certa altezza dal terreno,proprio << voluta »> per tutti quelli che venivano << recati )>, accompagnati
da genitori, parenti e vicini e poi, solo successivamente, come intendiamo,<< posti nella pila »>, Così fece, il 10 luglio del 7457 , monna Agnola de'Pecci da San Gimignano, che << arecò uno fanciullo a ora di terza etmesselo nella pila >>, fermandosi poi a parlare col rettore e così era stato,per esempio, per Simone Domenico, che << fu posto nella pila >> da tredonne, il 24 marzo 1427 e che vi immaginiamo adagiato mentre tuttee tre spiegayaflo, a turno, << ch'era legittimo »> e che si trattava di unorfano 8s. Non altrimenti si spiega il lasciare nella pila anche bambiniormai grandi, come Elisabetta, di sei anni, che vi fu messa il 21 novem-
bre del L456, e, addirittura, coppie di fratelli, come Francesco e Giovan-ni, di sei e quattro anni, abbandonati anche loro ploprio il medesimogiorno e anno di Elisabetta e come loro tanti altri, per i quali l'età piùnon giustificava il passaggio per la pi7a, adatto, invece, ai più piccolise non alro per sollevarsi da un peso, che, per quanto leggero fosse,
a volte 1o si teneva sulle braccia da ore 86.
Ci pare di capire, cioè, che si abbandonava attravetso la pila e cheessa aveva un significato simbolico. Ma le stesse fonti ci vengono final-mente in aiuto con Bernardo Luca, che l'8 ottobre del 1487, << fu o{fertoe messo nella pila ,, "; con Andrea Filippo, che alle due di notte del 19
novembre di quello stesso anno, fu anche lui, come ebbe a scrivere ilfrate, << ofierto e messo nella pila a71a porta del nostro spedale >> e,
infine, con Mariotto, che il 18 gennaio del 1488, alle undici di notte,
per l'abitudine di depositarli ugualmente di soppiatto e fuggiascamente, cil. O.ANonruccr, Delle ruote o dei trtrni cit., p.2\ e L. Pprrpc«txr, L'esposixioy:e deifanciulli a Milano dal 1860 al L901. in Un problema di storia sociale cit., p. 120.
8s « A dì 10 di luglio 1457, monna Agnola de' Pecci da San Gimigrraao, arecòuno {anciullo ad ora di terza et messelo nel1a pi1a, disse che era nato la mecle-sima mattina, che l'arecò. A dì detto 1o facemmo battezzare e ponemogl,i tomeMenico Francesco >> (Libro di bali seen. L (L156 1.465), L5, c. 11); << Simone Dome'nico, ha nome il fanciullo, che fu posto nelia pila mercoledì matttna, a dì 24 rnarzoe così dissono tre donne, che 1o recarono e dissono ch'era legittimo e ctre gli {umorto il padre » (Balie e bambini segn. B (14L3-7454), 14, c. 22).
86 Libro di bali segn. L (1456-7465), 15, c. 10).87 « Bernardo Ltca, ha nome i1 bambino che fu ofierto e messo nella pila
del nostro spedale, lunedì a dì 8 d'ottobre, anno detto, a due ore di notte. Noneta battezzato, facemolo battezzare a dì 9, ponemogli nome Bernardo e l-uca, tecòseco due pezze line e una fascia >> (Libro di banzbìni e balie segn. E (1,487-14512),L6, c. 3).
GLI ESPOSTI 105
fu recato all'ospedale dal padre che << offerselo >>, si disse, << per la Ver-
gine Maria >> s. La << pila » era dunque il posto dove i bambini venivano
<< ofierti )>, non per niente sappiamo che anche a Napoli, benché in epoca
più tarda, non si esitava ad in6odutre attraverso Ia ruota dell'ospedale
dell'Annunziata, ungendoli, anche bambini già grandi, per porli sotto
il << manto della Madonna »>, che si diceva facesse allatgarc la buca pet
miracolo e che altri più piccoli vi venissero ugualmente messi per poi
essete ripresi, quasi subito, dalle madri, desiderose solo di adempire a
questa << pittotesca superstizione »> e.
Ma se la <<p:Ja>> era tutto questo era, però, principalmente, stru-
mento di abbandono e il porvi il bambino era comunque un gesto, che
aveva del drammatico per essere quasi sempre definitivo e quei fre-
quentissimi << ci fu posto nella pila »>, per l'ospedale non erano alffo che
un modo per indicarne l'awenuto abbandono così come anche << man-
darc alTa pila >>, significava il disfarsi, con l'allontanado dal contesto
familiare, fi un bambino indesiderato. Piero Bernatdino, si annotò il2O maggio del 145L, <( ponemo nome al fanciullo, che ser Agnolo di ser
Bartolomeo Ridolfi da San Gimignano, ci mandò alla pila allo spedale >>,
« ed è figliolo >>, si proseguì, << della schiava del detto ser Agnolo » {.
88 <<Andrea Filippo, ha nome un bambino maschio, che fu-.ofierto e messo
oella pila alla porta àèl-nostro spedale, lunedì sera, a ore due di lotte, a dì 19
di noiembre, Aveva il sale al colb, facemolo battezzare martedì mattina a dì 20 didetto, Ponemogli nome Andrea Filippo, reò seco_ due pezze li!.e--buone, due fasce
use e in un pèzo di gonnella invò1io » (Libro di .barn,bini_ e balie se.en. E (1487-L5L2), L6, c.-3); <<Mariotto, ha nome.uno fanciullo che fu recato al nosffo spe-
dale,'domenica'ieta, ^ ore ventirre a dì 18 di g-ennaio, arno detto..Lrabattezzato
; ".,,"*
nome Mariotto. È di San Gimignano, figlio di Giovanni d'Antonio, dettoPillucchino, morl la madre in parto, i1 padre lo reò qui e ofierselo per |a VergineMaria, Dio 1o faccia buono. Rècò seco una pezza lina e quattro fasce e un gonnel-lino tiisto » (Libro di bambini e balie segn. E (L487-L5L2), 1,6, c. 4)'
8e La ciedenza popolare voleva, infatti, che 1a ssla dgll'osqedale dell'Annun-ziata rendesse tutti I bàmbini figli di Maria, tanto che anche i legittimi venivanoorivati della loro identità. Nella ruota venivano introdotti anche bambini di ottoè più anoi, come testimoniava, per la prima metà del XIX secolo, il De Crescen-
,io', di..tt*. all'epoca de|l'ospedale, chè riguardo alle madri scriveva: << hanno laferoce abilità d'Érodume anche fanciulli -di quell'età, ugendoli d'olio o d'altramateria gfassa per farli scivolare facilmente. Awiene- spesso che qJralchg braccio os^mba né resti slosata ed il corpo malconcio. I1 volgo al contrario spiega questo
t""àÀ"ro con un Ériracolo, la Madonna farebbe in quella circostanza allaryare 7a
Èr"r. o""..ttendo così il passaggio libero al fanciullo ch'ella predilige prendere sot-
1o ii ;; manro » (M. G. GoÀ'ùr, Il problema degli esposti in ltalia dal 1861 al1900, tn [Jn problenta di storia sociale cit., p. 97).'90
« Pierb Bernardino. ponemo nome 'aL
fanciullo, che ser Agnolo di ser Bar-rolomeo Ridolfi da San Giàignano, ci mandò alla pila allo spedale. Atecollo iIMàor.o. chiamato cosl Der sopr-anonme, da San Gimignano ed è figliolo della schiavaa;i lgil" r.r Agnolo, inandoilo giovedì alle quattordici ore, a dì 20 di -maggio, ildì di Santo Bernardino, nell'anno detto di sopra, arecò seco una pezza hna e tuna
pr*^ 1*; ; iÀa tasAa, rutte vecchie e cariìve e rutte totte »> (Balie e barnbinisegn. B (L4D-L454,, t4, c. 55).
106 L,OSPEDALE DI s. MARIA DETLA scALA DI S. GIMIGNANo
La pila eta insomma il punto di passaggio obbligato per f ingresso inun alffo mondo: quello dell'ospedale, a far parte di una singolare cate-goria umana: gli esposti.
La pila, del resto, con quell'essere 1ì predisposta pareva farsi com-plice degli abbandoni ma non tutti intuivano o {orse 1o temevano, ilsuo invito. Vero è che, ad ogni modo, anche se non proprio dentro, ibambini vi venivano lasciati, però, spesso abbastanza vicini: per Si-mone Taddeo, del 27 ottobre del L422, si scrisse che << fu posto allatoalla pila dove si pongono i fanciulli, su una trave, che allora eru ine>>,
mentre Santa e Domenica, di quattro e due anni, giunte a notte del 2lgennaio del L427, si dissero <( poste a' piè della pila de' fanciulli >> e
un bambino di quattro anni, Ottaviano, del 26 aprile del 1505, « fulegato alle colonne deila pila con una corda >>
el.
Da altri, e per la maggior parte i bambini erano di età superioreall'anno, si preferiva scansare la pila, che era pur sempre vicina, e 1a-
sciadi << all'uscio »>, dove i più grandi ce li immaginiamo in piena notte,forse piagnucolanti in attesa e2. Ma, fra gli << usci >>, quello << delle don-ne )> era il più assiduamente preso di mira. Non che non si avesse fiducianegli alui, ma certo, mani femminili parevano più indicate a prendersicura dei bambini e, forse, anche il loro sonno era giudicato più leggeroe poteva awertire meglio il bussare delle mani sul legno, senza contarechi glieli afrdava direttamente. È proprio lì che fu messa Agara, << àl-l'uscio delle donne nostre di casa »>, un sabato sera de1 febbmio del1440 e, in piena notte, il 30 dicembre de7 1445, ci fu lasciata anche
e1 << Simone Taddeo, ponemo nome al fanciullo, che fu posto allato alla piladov-9 9i pg:rgono i fanciulli, in su la trave, che, al7oru, era-ine, lunedì matùna,a dl 27 d'ottobre, quasi al levare dell'alba. Arecò seco una fascia cattiva e unostraccio dt_pezza lana di farsettaccio »> (Balie e bambini segn. B (1473-L454), t4,c.,ll); «Santa e Domenica, hanno nome queste due fanciulle, poste a' piè dellapila dei fanciulli, mercoledì, o vogli dire, mercoledl sera, apprèsso a trè ore dinotte, a d\ 2l di gennaio, anno detto, arecarono queste cosè: ognuoa di per séuna gonnella nuova di panno bigio indosso. Quella che ha nome Domenica, è ditempo di quattro anni o circa e Santa di due anni e sono legittime figliuole »(lalle_ ,g barnbini segn. B (L41,r1454), 14, c. 2L); << A dì 26 d'aprile, fu Àesso a'piè della pila, uno bambino, d'anni quatro circa e fu legato alle ìolonne della pilacon una corda, aveva indosso una gonnella di romagnolo, ftista e un paio di siar-pettacce e una cuffia dolorosa >> (Libro di barnbini e balie segn. E (L487-1,51,2),t6, c. LL9).
e2 Fu _forse così per Agata nel 1490, che << fu posta alTa potta de1 nosffo spe-dale, giovedì rr,attina, due ore innarni dì, era di mèsi diciottò o circa, aveva unapoTizza come aveva nome: Agata. Recò uno gonnellino indosso, tristo e un paiodi calzuole e una camicina. Dio \a facaa buona » e più sotto, Iorse riportandole parole della commessa che l'aveva trovata in piedi vicino a17a porta: « ed eraritta, disse, a dl 24 i febbraio venne >> (Libro di bantbini e balie- segn. E (1457-1512), 16, c. 8).
GLI ESPOSTI
Silvestta Margherita, mentre Gregorio, tanto per citarne alcuni, del 13
marzo del L448, << fu dato »> proprio << a monna Caterita delle nostre
donne di casa »> e3.
Ma se si voleva avere la sicutezza delia fuga e nello stesso tempoqueiia del ricovero dei bambini, se pur non immediato, anche l'usciodella stalla, de1la cantina, il vicino frantoio e 7a << calaia del colto, dinan-zi a casa », potevano andarc bene, per non parlare della chiesa delI'ospe-
dale, luogo riparato e sicuro, dove alla cettezza di vedervi entfare g1i
oblati ad ore determinate e a. brevi interualli, si univa quella di sapere
i1 bambino posto sotto la protezione divina. Posti sulle << panche da
sedere >>, sull'altare, vicino alla << fune della campana )> o, se non si fa-
ceva in tempo ad entare, sul « murello dinanzi alla chiesa », i bambini vierano lasciati proprio a vespro, a terza, a compieta, quando imminenteera f inizio delle funzioni e niente impediva poi, e ce Io immaginiamo,che da lontano se ne seguisse l'esito ea.
h{a in San Gimignano altri luoghi pii, parevano adatti per lasciarvi
i bambini: 1a pieve e il convento di San Francesco, che sappiamo sorgeva
nelle vicinanze dell'ospedale es. Mariuccia di tre anni, fu recata << in su
107
s3 << Agata, ponemo nome a1la fanciulla, che fu posta ali'uscio delle donne no-ste di casa, sabato sera, a dì 4 di {ebbraio. Arecò questi segni in{rascritti, cioè unapezza la.r.a nuova) un pezzo dr gonnella vecchia e trista, ùno pezzo di fodero, unapezza lana rotta, due fasce fatte di pir) pezze line>> (Balie e bambini segn. B(1113-L454), 14, c. 33); « Silvestra Margherita, ponemo nome alla fanciulla, postaal1'uscio delle donne, giovedì notte, a dì l0 di dicembre, anno detto, all'undici oreo circa, recò una pezza lina e una {ascia trista e una camicia tlista e uno poco di{odero » (Balie e barzbini segn. B (1413-1,454), 14, c. 40); « Gregorlo, ponemo nomeal fanciullo, {u dato a monna Caterina de11e noste donne di casa, diedelo serAenolo di ser Bartolomeo di Francesco da San Gimignano, disse era figliuolo de1la
sù schiava. Fu giovedì, a dì 13 di marzo, anno derto. atecò una fascia nuova e
due pezzuole linà. I1 detto fanciullo si disse era fig1iuo1o d'Agnolo di Romeo daSan Gimignano>> (Balie e barnbini segn. B 04L3'L454), 14, c.46).
e1 È il caso di Nanna, recata nel 1410, << una fanciulla, che {u posta inchiesa, in sulla panca da sedere, ai piedi della fune della campana, martedì a ve-spro o circa, a dì 20 di giugno, anno 7430 e mos[rava di tempo di tre mesi o circa,ponemole nome Nanna, areiò questi segni: uno straccio di pez,,a vermiglia e dueiasce cattive e due pezze line cattive >> (Balie e bar,abini segtt. B (1413-1454), 14,c. 23); nel 1450, per fare altri esempi, « À{addalena, ponemo- nome a1la {-anciu11a,
ci fu-'arecata martèdì a sera e ci fu posta in sul murello, dinanzi alla chiesa difuore de1l'uscio. Arecò seco una pezza lir,a cattiva, una pezzuola di panno roma-gnolo, una fasciuola di due pezzi stracliata » (Balie e bambini .segn.. B (1413-L454),i+, c'. >q e il 10 marzo del 1,189, « Bastiano, ha nome uno bambino fu posto inchiesa, a dì 10 di m tzo, a ora dt tetza, venne da Poggibonsi, secondo ci fu detto.Aveva una polizza come aveva cinque mesi ed eta battezzato ed aveva nome Ba'stiano. Dio 1o faccia buono. Recò seèo una pezza Tana e una lina e una fascia, tristeognuna >> (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16,-c.
-6).*
9s Ii convento di San Francesco, come sappiamo da L. Puconr, Stotia cit.,p. 409, sorgeva fuori della porta di San Giovanni, come i1 nostro ospedale.
108 L'OSPEDALE DI S. MARIA DELLA SCALA DI S. GIMIGNANO
la sera » del primo dicembre del 1503, dai fuati di San Francesco %;
Gimignano Piero del 1506, era staro << posto nella pieve »> e7; Cristiano,
fu portato il 6 mar,o del 1507 da ser Tommaso da San Giovanni daLione, membro della Compagnia della Pieve e, agli « avelli di San Fran-cesco )>, era stata lasciata, nella notte dell'11 aprile, Gioiosa Ulivetta,nel 1510 s.
Fuori della città, pet la campagna, erano le pievi i luoghi preferitiper_ abbandonarveli o per raccoglierli se portati da mani pietose, che liavevano trovati chissà dove e inviarli, poi, già battezzati al nostro ospe-
dale. Qualche volta paiono lasciati semplicemente ai tabemacoli., Iungole strade e ai crocevia, come Cassandra, del 14 maggio del 1502, chevenne da Colle ed era stata <( messa alla Madonna del Renaio » e facopa,del 25 luglio del L508, che era stata trovata alla « Vergine Maria diCampaldi »>
e.
Per molti almi abbandonarli significava portarli molto vicino al-l'ospedale e lasciarli magari << alla fonte >> lì presso, come awenne perDomenica di due anni, che vi fu lasciata in un giorno di festa del 1498o come Gimignano Giovanni, abbandonato << in piazza, nel Borghetto,in su una panca di bottega di Agnolo Salucci >>
lm.
<< A dì primo di dicembre,. a ore diciotto, ci fu me[ata una bambina daifrati di San Francesco, d'anni re in circa, era in su la sera in circa » (Libro dibambini e balie segn. E (L487-L512), L6, c. L1,2).
e7 << Mercoledl mattina a ore quindici e a dì 30 di dicembre, fu posto nellapieve questo bambino nor. battezzato, battezzollo ser Matteo da Montecatini e po-segli -nome Gimignano Piero e arecollo qui in casa Castruccio, barcaio, arecò sècouna fascia lina trista pet pezza lana, un pezzo dt pannaccio tinto in neto e una{olgrosa pezza lir,a e un po' di sale al collo >> (Libro di banbini e balie segx. E(L487-1572), t6, c. L261.
98 Della bambina sappiamo che veniva dal « pian di San Bartolo » e che,lasciata << agli avelli di San Francesco »>, era stata portata all'ospedale da ser Gievanni di Paolo Alamanni (Libro di bambini e balie ;egn. E (1487-L512), 16, c.140) e anche di Cristiano, sappiamo che, trovato dalla Compagnia del1a Pieve, erastato tatto battezzare e poi inviato, tramite quel ser Tommaso da San Giovanni daLione, all'ospedùe (Libro di bambini e balie segn. E (1487-L512),16, c.132).e << Cassandra, poflemo nome alla bambina, ci fu posta nella pi1a, a dl 14 dimaggio, a ore due di notte, arecò seco :una pezza lina trista e una lana dolorosae una fascia trista e una pezntola in capo tdsla, la quale venne da Colle, fu messaalla Madonna del Renaio a Colle e i colligiani Ia mandarono qti >> (Libro di barn-bini e,balie segn. E (1,487-15L2),16, c. 104); per lacopa, sappiamo che era stata tro-vata da una donna, che l'aveva pofiata a battezzare alla pieve e che l'aveva rinve-trvta alla << Vergine Maria di Campaldi » (Libro di banzbini e balie segn. E(1487-1512), 16, c. L34).
lffi Libro di barnbini e balie segn. E (L487-L5L2), L6, c. 89; << GimignanoGiovanni, ha nome il bambino ci fu posto nella pila, a dì 14 di luglio, a oie nove,arecollo Mccolò di Pierallo, campanaio, disse che l'aveva aovato in piazza,, relBotghetto, in su una panca di bottega di Agnolo Salucci »> (Libro di barnbini e baliesesn. E (L487-1512), 16, c. Ll5).
I
:l
GII ESPOSTI 109
Molto frequentati e adatti erano anche i ponti e i guadi del fondo-valle, dove i bambini erano lasciati con la sperunza che prima o poiqualcuno li notasse. Mafiq di sei mesi, fu portata dai famigli del pode-stà, che << I'avevano trovata in sul ponte a Piscille >>, il 3 aprile del L497e Agata, di ventidue mesi, fu poftata quello stesso anno da un fanciullo,che l'aveva avuta da un uomo giù al « guatatoio »>
101.
Nessun interesse, invece, per la sorte di Antonio, di ffe anni, chefu raccolto il 10 febbraio del L502, dalla donna di Iacopo da Monte-morli, probabilmente un lavoratore dell'ospedale, dopo che << era statodue notti per un campo ,r "'; .é per Ginevra Iacopa, << ftovata alla pottaal Quercecchio, in una fossa >> 11 23 aprile del 1506 103. né per MatteoRomolo, che a detta del rettore, che pur doveva averne viste tante, << fumandato come una bestia >> e <( posto in su l'uscio di San Matteo »>, un'al-tra delle porte della città, nudo, con << mezzo marcello veneziano sotto ilbraccio >>
r@.
Di fronte a questa totale indifietenza, ci colpiscono benevolmentele pur minime cure rivolte ai bambini in alcune occasioni. Margheritadel 23 maggio del L490, fu trovata con i piedi awolti in un << pezzo dtpelle >> e in una << fodera di pelle strappata >>, era awolto anche MarianoAmbrogio de11'8 dicembre del 1499105. Per Antonio e Ortaviano, i due
101 << Maria, ha nome la fanciulla, ci fu arecata e missa nella pila, a dì jd'aprile 1497, atecolla i famigli del podestà di San Gimignano, dissoÀo che l'ave-vano trovata in sul ponte a Piscille. Portò seco luna pezza lana, una {ascia, unapezza lina, tutti ffisti e una pollzza, è in f,lza e la fanciulla ha mesi sei o circa >>
(Libro di banbini e balie segn. E (1487-7512), 76, c. 76); << Agata, ponemo nomealla fanciulla, ci fu recata e missa nella pila a d\ 25 di {ebbraio. Ha di mesi, ventidue o circa; recolla uno fanciullo poveretto, disse che t'aveva data un uomo, ilquale era al guatatoio. Aveva indosso una gonnella di panno romagnolo, il bava-glio e un paio di calzuole e un paio di scarpette, ogni cosa trista>> (Libro di ban-bini e balie segn. E (t487-15t2), 16, c. 84).
1@ << Antonio, ha nome uno fanciullo, ci fu posto e arecato a casa, a dì L0di febbtaio, dalla donna di Iacopo di Montemorli, abita a Barbiano e dice erastato due notti per uo campo ed è d'anni re o circa »> (Libro di banbini e baliesesn. E (1487-751.2), 16, c. 109).
1G « Giovedì matttna, a d\ 23 d'aprile, a ore dodici, ci fu messa nella pilala sopraddetta bambina, non battezzata; {essi battezzare e ponemole nome e1sopraddetto nome; fu trovata a17a porta al Quercecchio, in una fossa >> (Libro dibambini e balie segn. E (1487-15L2), 16, c. 122).
lG « Giovedì mattina, a d\ 23 di settembre 1507, a ore dodici, ci fu recatoe misso nella pila il sopraddetto bambino, ignudo, e arecollo il Pisano e due don-ne, disseno avetlo battezzato e postogli il sopraddetto nome. Aveva sotto il brac-cino in una poca di pezza on mezzo marcello veneziano, fu mandato come unabestia e posto in su l'uscio di San Matteo >> (Libro di bambini e balie segn. E(1487 1512), 76, c. 132).
I05 << Margherita, recò seco una pezza lina e due {asce assai use e una pezzalana trista e un mantellino azzutro, tutto rotto e un pezzo di pelle awolto aipiedi>> (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 7); << Mariano e Am-
110 L,OSPEDALE DI S. MARIA DEILA SCALA DI S. GIMIGNANo
gemelli del 1501, si ebbe l'accortezza di lasciadi in una paniera16; PieroFrancesco de11'11 marzo del '1.505, era << involto in un poco di copertoiobambagiato »> e Bernardino Iacopo del 4 settembre del 1508, aveva << unpoco di capecchio ai piedi, perché non gli facesse freddo »> mentre perVito Modesto, nel 1509, si ebbe la premura di mettergli un cencio sottoil capo Im.
Un attento esame aspettava i bambini una volta accolti nell'ospe-dale. Si esprimevano pareri sulle loro condizioni fisiche, ma più chealtro si inventariava minuziosamente tutto ciò che avevano con sé.
Particolarc attenzione era dedicata alla descrizione dei << segni >>,
cioè al vestiario e agli almi oggetti rinvenuti addosso al bambino.Fasce e pezze << dolorose », << tristi >>, << cattive », << percosse >>,
<< sciagurate »>, << rotte )>, <( use >>, << logore »>, << vecchie >> << buone a nul-la >>, se non addirittuta << pezzacce lane e line », <( stracci di fascia >>,
<< stracciuoli >>, ricavati in fretta da << camiciacce da far nulla >>, da << ghe-toni di gonnellaccia »>, da << maniche di camicia rr, du ., guanti »>, da pezzidi << caTza da uomo »>, da << tovaglie »>, da << lenzuoli >> e da << asciugatoi >>,
sono le indicazioni più frequenti a meno che non si trattasse di soli<< cenci liai e lani, tutti ffisti cose >> da non meritare nessun rilievo. 'perTaviana, proveniente da Montauto e recata dal padre, Michele, nel1420, il frate scrisse: << recò parecchi stracci di pezza, non ne fo alttadistinzione perché ogni cosa eta da niente » 1§.
<< Bige >>, <( nere )>, mail più delle volte <.< bianche )>, <( rosse >>, << sanguigne )>, e << vermiglie >>,
brogio, ponemo nome al fanciullo, ci {u recato e messo nella pila, a dì di dicembre7499, a ore otto di notte. Era involto in rna pezza di lino tuita sttacciata e in unafascia trista e in una {odera di pelle strappara; a a ai 8 di dicembre, 1.499 >» (Libràdi barnbini e balie segn. E (1487-L5L2), 1,6, c. 96). :
1% Libro d.i banzbini e balie segn. E (L487-15L2), 16, c. 105.107 <( A dì 4 di settembre, a ore dodici o circa, fu posto nella pila il soprad-
detto bambino non battezzato, facemolo battezzate e pònemogli no-me il soirad-detto nome. Recò seco due pezzi di gonnellaccia di romagnolo rista e ufia pezzal"ana doloro_sa, una fascia, b,uona e un poco di capecchio ài pi.di, perché noi gtifacesse freddo >> (Libro di barubini e balie segn. É Gqg-Ot2), 16,- c. 134); « Ve-nerdì sera, a ore due di notte, ci fu misso nella pila uno banibino non battezzatocon un poco di sale al collo »>, che era << rinvolto in un poco di copertoio bamba-giato, ponemogJi nome Piero Francesco, Iddio lo faccia buono » (Libro di barubinie _balie segn. E (1487-1512), 16, c. 122). Per Vito Modesto, sappianro che recòsolo poghi cenci, di cui uno, però, g1i era stato sistemato sotto il- capo, si veda ilLibro di banzbini e balie segn. E (1487-1,51,2), 76, c. L37.
108 « Taviana, ha nome 7a fanciulla, arecò Michele, suo padre, da Montauto,corte di San Gimignano, arecolla giovedì sera al tardi, a dì 8 d'agosto, L420, disseel detto Michele ch'era di tempo di quattordici mesi o circa, arecò parecchi straccidi pezza, non ne fo altra distinzione, perché ogni cosa era da niente » (BaUe e bam-bini segn. B (1413-1454), 14, c. 10).
GLI ESPOSTI
le pezze << a misura comune »>, << mezzane >> o << lunghe )>, potevano es-sete ora di << panno lino grosso ,r, di ., panno nostrale »>, di << pannocontadino ,r, di ., bianchetta )>, di << panno savonese )>, di << panno dabottega ,r, di ., cavonaccio rr, di ., perpignano », di <{ monachino >>, di<( panno San Matteo >> ma, più che altro, di << panno romagnolo » 1e.
La varietà del linguaggio usaro, la descrizione dei colori, del tipodei panni e persino del colore dei rammendi, concorrono a confermarcinell'opinione che al rettore spettasse, disticandola, Ta lettura di una se-rie di « segni >> messi lì appositamente e il cui esser visti ed interpretati,ci pare dipendesse, non tanto dalla sensibilità del singolo, addetto allaregisffazione, quanto al loro rientrare, naturalmente, in una specie dicodice prestabilito, nato dalla consuetudine e dalla ripetizione.
Non altrimenti si spiega la presenaa-J*+'i*«-segni^»*di*tud.ta..una.=,.varietà. di*<< accorgiqgn-ti)a-.che, .apparenrcrrrcnte insignificanti...ci paio.no *invébr: messi-D"-di propositq _ma non_Jante,,-pqr la ,loro semplicità, in vi.sta di un più facile e futuro riconoscimento, quanto per un istintivo e.comprensibile desiderio di diversificare i bambini ed annulla{e così laperdita di identità che I'abbandono inevitabilmente comportava. A que-sta-iiiièrDiòne ci pare di poter atribuire la presenza di nodi nelle fasce,di cordicelle, di nastrini colorati, di cifre ricamate e Io stesso colore dellepezze, abbinate a volte, in una maniera che non pare casuale. sottili esegreti legami venivano a costituirsi così con quel che di << personale >>
lasciato addosso al bambino. Girolama silvesra, posta nella pila la vigi-lia di san silvesmo del 1420, era <<involta in più cenci>> ma <<davanti>>,aveva << legato uno cintolo rosso e uno poco di nastro annodato >>
lto. Co-stanza, pòsta nella pila << domenica seta a d\ 27 d'agosto >>, 1430, recòfua le alfte cose << due fasce che nelI'una era due nodi >>
111. Lorenzo,
, 1, I1 << panno monachino )>, eta un panno dal colore scuro, tendente al rosso,sr veda,.per questo colore, la sp.iegazio_n_e data da N. Tonauaseo - B. Berrnrr,Nuouo dizionario della lingzta ir;lid:na, Napoli-Roma, 1g72, ,òt.- IIt, p.' rclZ; là<< bianchetta » era un << tessuto di Tana groiso da fai camiÉiole o (N.' foo,roras"o _
B. Brr,r.rNr, Nuoao ilizionario cir., vol. I-, p. 958); il << panno .o-àgrrol. , era una<<sorta di--panno grosso *_ leu non tinta,-che serrre pèr uso dei "contadini,
fatioalfuso della lomagna.» (N. Torurnrasso -'8. BeurNr,'Nuoao dizionariò cit., vol.IV, p, 440);. il «-perpignano )> er_a una « _specie di panno ordinario ma sottile, dettocosl dalla .città. di. Perplgnano dove si fabbricava» (N. Tolruasuo - B. BÉr.lrrvr,Nuoao dizionario cit., vol. III, p. 939).
110 <( Era involta in..piit cènci e davanti legato uno cintolo rosso e uno pocodi nastro aanodato »-(Baliè e bambini segn. B (141?-1.414), 14, c. 11,).ttt << Costanza ha nqme la ,lancioTla-, che fu posta nélta prta domenica sera adì 27 d'agosto, anno. detto, arecolla uno che ha noàe Castrucciò, disse ch,ella avevanome Costanza, arecò qu-este cose: d:u.e pezze !1ge e ung pezzooia lana e due fasce,che nell'una era due nodi e una pezza hrra»> (Balie e ba,ubini segn. B (L41,3-l4iq:L4, c. 24).
111
tI2 L]OSPEDALE DI s. ÀARIA DELLA scALA DI S. GIMIGNANO
giunto un << sabato notte, sonate l'ottore>>, del L445, << recò una pezza
Iana e :urna pezza lina e una fascia e nella detta fascia v'era fatto un'o dinefo » 112. Per Menica, del 2 maggio 1456, si notò la presenza di una<< pezza di panno lino con due cordellini di refe >>
1r3. Chiara Girolama,lasciata il 7 febbraio 1461, aveva <<una pezza lina assai buona e sottilecon un segno, cioè una f leziosa »>, icamata sopra 114. Giuliano Bernardino,giunto il 7 agosto 1489, all'oru di cena, <<recò seco :unapezza lina, neracome il carbone » 115. Salvadore Martino, portato alle cinque << di notte »>
del 9 novembte 1489, << recò seco uno cencio, Iegato con una cofda >> 1161
anche Caterina Matiana, messa nella pila << a dì 13 d'agosto a ora dinona >> del 1499, aveva fra le alffe << una fascia trista con un nodo >>
117;
per Quitico facopo, lasciato alle due di notte del 14 luglio del L502,si scrisse anche per lui che aveva << una fascia trista annodata in dueluoghi »> mentre Piero Francesco nel L505, << recò seco :una pezza lana conun tondo nel mezzo, buona >> e <( un cordellino di seta rossa », cingevail collo di Nicola Antonia, giunta 1a notte di Santa Lucia di quello stesso
anno 11E.
112 <( Toreflzo, ha nome il fanciullo fu posto nella pila, sabato notte, sonatel'oftote, arecò queste cose, cioè un peza lana e una pe,za ltna e una fascia e,nella detta fascia, v'era fatto un'o di nero » (Balie e barnbini segn. B (L4L1-1454),14, c, 40),
113 <( Menica, ponemo nome ad una fanciulla, ci fu recata, a dì 2 di marzo,anno detto, eraoo due ore di notte. Arecò seco En pezza di tela di braccia uno,una pez-za lana bianca, una fascia e un guarnello, una pezza di panno lino coo duecordellini di refe »> (Libro d.i bali segn. L (1456-1465\, 15, c. 9).
114 « Arecò seco una pezza lina assai buona e sottile con un segno, cioè unaf leziosa e arecò seco uno straccio di gonnella di romagnolo. Detta fanciulla non erabattezzata, ponemole nome Chiara Gerolama » (Libro di bali segn. L (1456-t465\,t5, c. 77'1.
115 << Giuliano, ha nome un bambino, fu messo in chiesa nosfia, menffe chece[avamo, venerdì a dì 7 d'agosto, aveva rna polizza al collo come era battezzatoe ave.va nome Giuliano e Bernardino e che era figlio di una povera persona, recòseco una pezza ltna, nera come il carbone, e due fasce buone, Dio lo faccia buona »>
(Libro di bambini e balie segn. E (L487-15L2),1.6, c.5).116 <{ Salvadore Martino, ponemo nome a un fanciullo, fu messo nella pila
lunedì seta, a dì 9 di novembre, alle cinque ore di notte. Non era battezz to, face-molo battezzare a dì 1.0 detto, ponemogli nome Salvadore Martino. Dio lo facciabuono. Recò seco uno cencio, legato con una corda »> (Libro d.i barztbini e balie segn.E (1487-1512), 16, c. 6).
117 << Caterina, Mariarn, ponemo nome alla fanciulla, ci fu recata e missa nel-laptTa, a dì L3 d'agosto a ora-nona, era involta inpezze line tristi e due pezle Ianedi romagnolo tiste e una fascia tista con un nodo »> (Librò di banbini e baliesegn. E-(L487-L5L2), 16, c. 93).
rts 3 Quirico Iacopo, ponemo nome al bambiiro, ci fu posto nella pila a dì14 di lugiio 1502, a ore due di notte, arecò seco ùna pezza lana dolorosa e uncencio di lina e una fascia mista annodata in due luoghi >> (Libro di barnbini e baliesegn. E (1,487-15L2), L6, c, 1A7); << Recò seco ufia pezza lana con un tondo ne1mezz.o, baona e un pezzo di fascia dolorosa >> (Libro di barnbini e balie segn. E(L487-1512), 16, c. 122\; Libro d.i baru.bini e balie segn. E (1487-151,2), 16, c. !21.
GLI ESPOSTI 113
Ma i nodi, i nastrini e le cordicelle, specialmente rossi, non erano
gli unici << segni », vi si trovavano anche collanine, messe al collo deipiù grandicelli, medagliette, croci e candele di cera, « brevi »>, cioè sac-
chettini con dentro oggetti o scritte, chicchi di << paternostro », che con-
tribuivano ancota a distinguere il bambino, ma che, certamente, signi-firavano qualcosa di più, messi 1ì per scongiurare, per allontanare dai6gli un pericolo, che, forse, non si sapeva immaginare ma che tuttaviasi intuiva reale. Mattea, nel 1424, aveva con sé un « breve di sciamitonero >>
11e. Costanza, la bambina recata ne1 1430, {ra le cui fasce ne era
stata ttovata una con due nodi, recò in più « fte paternostri neri, infilaticon refe nero »>
120. Giovami Andrea, giunto il 19 luglio del 1434, aveva
con sé <( una crocetta di cera >> 121; non a caso Maddalena, la figlia del
tessitore sangimignanese, recata nel 1452, fra le alfte cose, aveva un« breve di seta rossa, ricamato con certi fiii d'argento, con una pietradi cristallo bianco, fornito d'intorno con un poco d'atgento », con den-tro due << grossi d'argento forestieri )> e << cinque paternostri rossi pic-colini >>
122; << un vangelo di San Giovanni da tenere al collo in un
brel,e », era stato lasciato addosso ad Alessandro Giovanni, giunto al-
l'ora di <<terza » del 21 novembre de1 1460 13. Nicola, una bambina di
ue << Mattea, disse la scrittolina ch'ella aveva nome la {anciu11a, che ci fuposta neila pila domenica sera, alle tre di notte, circa, a dì 2 di luglio, anno 1424.Arecò seco una scrittolina, che ci fosse raccomandata e come aveva nome: lVlattea.Dentrovi uno mezzo picciolo per segnaie e quattro pezze line, due fasce, uno ghe-rone di gonnella romagnola, uno breve di sciamito nero >> (Balie e barubini segn. B(r413-L454), 14, c. 16).
r20 « E più recò tre paternosrri neri, infilati con refe nerc » (Balie e barnbinisegn. B (1413-1454), L4, c. 24).
i2i <( Giovanni, ha nome i1 fanciullo e Andrea, così diceva una scrittolina, cherecò e più una crocetta di cera, \tna pezza lana e tre pezze line cattive e due straccidi fasce. F-u posto lunedì mattina al7'alba de1 dì, a dì 19 luglio, anno detto »(Balie e bambini segn. B (L4É-1454), L4, c. 29).
E << Arecò seco uno mantellino di colore paolazzo, foderato di pelle, biancae nera, si era vecchio e cattivo, u-na pezza rossa vecchia e una bianca e nera. tuttarappezzata, vecchie e cattive, due cenci di pezze line, due culliole piccole, lavoratea reticellc, due {asce vecchie e ve n'è una di due pezze. ltl collo arecò seco unobreve di seta rossa, ricamato con certi Iili d'argenro, con una pietra di cristalLobianco, folnito d'intorno con un poco d'argento, con due grossi d'argento iorestieri,uno grande e uno piccolo, con cinque prternostri rossi piccolirri » (Balie e bo.mbinisegn- B (1413-1454), 14, c. 59).
1a « A dì 21 di novembre, anno detto di sopra, a ora di terza, {u messo nellapila uno fanciullo maschio, non era battezzato, ponemogli nome Alessandro dettoe tecò ulro, che 1o pose nella pila e si andò r,,ia. Non sappiamo il nome di chi 1o
recò e recò seco due pezze nuove lane lunghe e due fasce nuove rosse e due pezzeline buone e due pezzi di fazzoletti usati da tenere in capo, fasciato, e recò unvangelo di San Giovanni da tenere al collo in un breve e recò anche una letteraiscritta, era polizzt, dentrovi messo uno mezzo quattrino coila detta lettera >> (Librodi bali segn. L (1456-1465), 15, c. 75).
Lt4 L,oSPEDALE DI S. MARI,A. DELLA SCALA DI S. GIMIGNANO
quattro anni, lasciata davanti all'uscio, nel dicembre del 1503, aveva
<( un vezzo al collo verde di vetro » e Marietta della medesima età, por-
tata il L2 novembre dell'anno dopo, ne aveva uno .< di coralli nonbuoni >>
124. Ventura, portato nel mese di maggio del 1510, il mese dellaMadonna, aveva al collo << una medaglietta della Vergine Maria, attac-
cata con un po' di filo doppio bianco ,> 1r. E << brevi »>, << medagliette >>
e << collanine >> di vetro, specialmente rosse e azzttte, come testimonianoquelle che vediamo spesso rappresentate dai pittori del XV e XVI secolo
al collo dei Gesù Bambini, ma, in genere, tutto ciò che brilla, specie icristalli, come quello bianco, che abbiamo trovato cucito sul << breve >>
di Maddalena, pate fossero, nella credenza popolare, una protezione vali-dissima contro il malocchio dei bambini, come 1o erano, in generale, an-
che i nastrini, e ne abbiamo trovati tanti, e le cordicelle, che potevanoessere state, per questo appositamente benedette 126.
Più comprensibile, invece, quel « mezzone »>, levato un poco da un
l2a << Giovedì, ci {u posta all'uscio una bambina di anni quattro o circa, c.rrruna polizza al collo, diceva: ha nome Nicola. Arecò una cufia di panno [ino, unacioppettina dolorosa di romagnolo, un paio di calze, :una azzurta e una nera, senzascarpette, ln vezzo al collo verde di vero. Dio la laccia buona r> (Libro di bartbinie balie segn. E (L487-7512), 16, c. 113); «Martedì a notte, a ore otto io circ,r ca d\ 12 di novembre, ci fu posta ne1la pila una bambina d'anni quattro in cilca.Arecò seco una gonnella nuova, con un paio di manichine sagomate e un camiciottobianco senza maniche e un paio di scarpettine, un vezzo a1 collo di coralli non buonie una rete nuova di seta in capo. Dio Ia faccia buona >> (Libro di bantbini e baliesegn. E (1487-L5L2),16, c. Ll6).
125 Ventura, oltre alla medaglietta aveva con sé anche :uoa polizztt che avver-tiva che il bambino era stato battezzato in casa, si veda il Libro di bambini e b,r!,itsegn. E (1487-L51.2), 16, c. 741.
t26 Corde, cordicelle, nastri, erano particolarmente adatti a combattere le stre-ghe e le loro malie, così come tutti i << sacchettini, brevucci o brevi di natura econformazione difietente », contenenti corpi vari e usati per proteggere specialrnentei bambini, si veda, a questo proposito G. Bruuccr, Arnuleti italiani antichi e con^temporanei, Perugia, 7912, p. 19. I1 corallo, ma in particolare que11o grczzo, erausato conuo il malocchio e non di rado era congiunto a collane di veffo, rosse oturchine, sul tipo di quelle come c'informa sempre G. Brrr,uccr, Un capitolo dipsicologia popolare. Gli amuleti, Perugia, 1908, pp. 2931, che cingono il collo e ipolsi dei Gesù Bambini, nelle tavole e negli afireschi de1 XV e XVI secolo. Delresto, anche il vetro, come pure iI « cristallo limpidissimo )> e <( tutto ciò chebrilla », erano potenti nemici del malocchio e della iettatura, cfr. G. Brr,r,uccr,Il leticisno primitir.to in ltalia e le sue lonne di adattarnento, Perugia, L919, p. 53e ancora G. Belruccr, Amuleti italiafii cit., p. 17. Nel 1417, anche Leonardo, pri-mogenito del mercante fiorentino Antonio di Leonardo Rustichi, come sappiamo daF. Boncursr, Antonio di Leonardo Rustichi e le sue ricordanze (1412-11)G), residi laurea discussa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenzeaa. 1976-77, pp.73,74, aveva fra le altre cose nel corredo di cui fu fornito per i1
suo invio a balia, << una branca di corailo con una ghiera d'argento )> e <r uno dentecon detta branca >> e tutti gli alri figli sappiamo ebbero un << breve >> da portareal collo, oggetti questi che G. Bnrruccr, Am'uleti italiani cit., indica quali potentiritrovati contro il malocchio delle steghe, in generale e il dente, favorevole, inparticolare, alla dentizione.
t:
',t:,
t)
GLI ESPOSTI tt5
capo », che fu messo insieme ad Agnola Maria, portaita il 29 luglio del
t504w.voluto ci pare anche il ritrovarvi oggetti denuncianti in qualche
modo l,origine del bambino. Fra i << segni >> di Dionora, posta nella pila
« giovedì notte, innanzi la campana >> del 17 febbraio 1423, il {tate,<< in prima i>, annotò la presenza di « una sportarella da ftati », dentro
.rri ,i trovava la bambina e poi << una candela da dodici denati >> 1r;
anche Gherofrna, portata il primo giugno del 1426, << inviluppata in pa-
recchi stracci »>, era in << una sporta da frati »> e un <( cintolo di panno
nero di saio tutto lotto », fu il « pegno )> lasciato addosso a Lotenza,
che venne il 14 febbraio del 14501D' Elisabetta, del 27 apille del 1'452,
era awolta in un << asciugatoio d'altare di chiesa >> 130; fra le pezze di
Maddalena Fina, vi era una ., fascia a\la veneziana, vetgata di bambagia
nera )> e Maddalena era, per I'appunto, figlia della schiava di Piero Ba-
roncetti, inviata all'ospedale nel L456t3t; nfl mezzo quattrino pisano
era stato il << segno » di Francesca, detta << Pisana », nel 1450, e fta lepoche cose trovate con Donato Lorenzo, lasciato nella pila da << uno che
127 <( Agnola Maria, ponemo nome alla -bambina ci fu posta nella pila, a d\- 29
di luslio. , Ér. ,ou. in èirca. Arecò seco due pezze lane nuove di panno da bot-t.ga é qruttto pezze line buone, sottili e uua fascia buona e un mezzo quattrino,.iàr. . del mèzzone, levato un poco da un capo e chi la recò disse gli si, po-
n.is" il nome detto di sopra. Iddio la faccia buona >> (Libro di banbini e balie
segn. E (1487-L512), 16, c. 116).- '* oDionora,"ponemo nome alla {anciuTla, che fu posta nella pila -giovedì
notte, innanzi la 'caÀpana,
a dì L7 di febbraio,_ anno detto. Arecò questi -segni:in piima era in una iporiarella da fuati e così fu messa nella detta pila ed eravi
"rJ.r"a"ù di dodici àenari e uno poco di sale pesto in uno poco di cartuccia e
a"é rirr..i di pezze lane e due, oui.ro tre, straéci di .pezza li'.a e uno pezzo difascia>> (Balie à banzbini segn. B (1413-1454), L4, c. -L5).12e'<(Gherofìna, potemlo nome alla fanciulla, che fu posta.nella pila, sabato
notte, a dì primo di giug.ro, fu arecata in una sporta da {rati, inviluppaia. in -pa-t".ihi tttr..i e battezàssI domenica mattina a dì 2' detto mese '>
(Balie e bambinisegn. B (L4D-L454), 14, c. 19). <Lorenza,.h,a_ nome la fanciuila, ci fu recata e messa
nila pila, domenica a nona, a dì 14 di febbraio, anno. detto di sopra. Arecò seco
uru pZrru lana bianca, tappezzàt^, vecchia, due -sffacci di pezze.line,. una fascia buo-na, irecò per pegno
'un -pezzuolo di cintolo di panno nero di saio, turro rotio '>
(Balie e bambini segn. B (1413-1454). L4, c. 5)).' 130 « Elisabetta" e Aiessandra, ponemo nome alla fanciulla, ci fu recaia da
Castelfiorentino, giovedì a ora di nona, a dì 27 d'apri1e,.anno detto di sopra; era
Ji t"-p" di due"dì o circa. Arecò -seco due pezze line 6iste, vfi . pezza di coitriceÈir;;;,'vecchia e tutta rotta, una fascia vecChia e ffista, uno sciugatoio con dieci
".inurÉit. cli bambaeia indaco, rotto, con tre bucarelle in mezzo ed era asciugatoio
d'aitare di chiesa ,, \Balie e banbini segn. B (L413-1,454), 14, c' 57)' ,------'tsl «A dì 10 di marzo, fu recata e messa nel1a pila una fanciulla che aveva
uno dì, ,.iiolia monna Lena, donna di Gimignano di,Bartolino, il;"i.*. con Mi-;ÀJ.-di Éottaccio da San Gimignano, disse clie era della schiava di Paolo Baron-
;;tti- À;*ò -;;
pàiu linu e uia lana e una fascia alla veneziana, -vqr-g?ta di bam-
ili; -;;;;.
ir.."i"t, battezzare a dì detto e mettemole nome, Maddalena Fina >>
LTbro d; bali se!.n. L (1456-1465), 15, c' 10).
L,0SPEDALE DI S, MARIA DELLA SCALA DI S. GIMIGNANO
bussò e andò via >>, Ll 5 agosto del L459, {u trovato un << soggolo da
monaca >> 132. Lo stesso frate, capatbiamente, pare, talvolta, cercare an-
che lui ad ogni costo, un indizio qualsiasi. Il 12 maruo del 146L, per
Fina, che aveva veramente poco con sé da fat registrare, i suoi occhi fu-
rono attratti da un unico segno: <( un gherone di gonnellaccia da conta-
dini », mentre per Gimignano Giovanni, portato all'ospedale da Niccolò
di Pierallo, il campanaio, i. 17 luglio del 1,504, il frate appuntò i suoi
sospetti sull'unica <<pezzaccia» che il bambino aveva con sé per fascia,
definendola senza ripensamenti << di trista fanciulla >> 13. Ma anche un
nome poteva essere il << segno >> che la madre voleva afrdate al bam-
bino e fua i tanti quello di Martino Febbraio, dato ad un bambino di tei>*s€ttimane, giunto già battezzato il 10 maruo del. 1488, suona alle nosrev
orecchie come il più insolito 1s.
<<Polizze >>, << poltzzioli >>, << lettere >>, <,r letteruz z€ tt, llscritte >>, << scti-
toline >>, messe << in seno >>, appuntate alle fasce, infilate con del filo e
appese a1 collo o al braccio, spesso unite a dei << conftassegni >>, rappre-
sentati per lo più da monete spezzate a metà, anch'esse infilate per
mezzo di un foro e sistemate allo stesso modo o involtate nelle lettere,
rappresentano tutta una varietà di messaggi, del tutto diversi dai prece-
denti con i quali, talvolta, tuttavia, si accompagnano e che possiamo
senz'alffo indicare come diretti, principalmente, a rendere possibile una
futura identificazione del bambino. Raccomandazioni, promesse di ricom-
pensa, propositi di future tichieste, avvalotati da precise indicazioni sul
132 « Martedì, a dì I d'ottobre 1458, fu messa nella pila una fanciulla fem-mina, non sappiamo il nome, però chi la recò non ce 1o vol1e dire, che tirò- via. Sap-piamo è venuia da Pisa e ha due mesi. Recò seco :una _pezzuola trista e dolorosa e
irna fascia di sacco, trista, fatta ln tre pezzi e una cufiolina da,portare in capo e
per segno recò un mezzo quattrino pisaÀo al collo >> (Libro di bali segn. L (1,456'
iqe»,'tS, c. 13); <<Domenica, a d\ 5 d'agosto, anno detto, fu messo nella pilauno
'fanciullo maschio, non era battezzato, ponemogli nome Donato Lorenzo; -e si
lo recò uno, bussò e'andò via. Recò seco due pezzi di fascia e una pezza biancatrista di più pezzi e ufia pezza lina trista e un Joggolo da mooaca; venne a ora disei ore di noite >> (Libro di bali segn. L (1456'1465), 15, c' 75)..
133 <(Venerdì,'a dl 12 di maizo, fu messa nella pila una-fanciul1a,-a ore. didieci ote; non eta :battezzata, ponemole nome Fina; -non sappiam-o chi la recò e
recò seco- due stracciuoLi di pànÀi lini e uno stracciuolo di panno 1ano, cioè furonoghetone di gonnellaccia da iontadini >> -(Libro d.i bali "segn.-.L
(1'!56-1465),- 15, c'
i7); i.Ar.cò"un poco di pezzaccia per fascia, di trista fanciulla >> (Libro di bambinie balie segn. E (L487-L51.2), 1'6, c. 1.1'5).
raa Ii nomè di ,Martino Febbraio, però, non piacque al trate che, e non è
1,unico.caso, glielo cambiò: ..( Crescenzo,-p-onemo nomè a uno bambino, che fu messo
nella pila déinor6o spedale, di sera, a arre ore di,notte; aveva forse_tre settimane,
eru bà*ezzato, disse cÈi 1o iecò che-aveva nome Martino Febbraio. Non ci piacque
;;f;;a Énemogli nome Crescenzio, a d] L2 di maruo. Recò seco d'g g:ryg-lgS.i à"" iri.à.-olo lo"faccia buono>> (Libro dei barnbini e balie segn. E (1487'L512),
16, c. 4).
Lt6
?
GLI ESPOSTI tt7
« segnaie >>,7'a7tra metà del1a mcneta o r-rn quarsiasi altro oggetto, chesarebbe stato inviato o reso noto al momento opportuno e al quraleavrebbe dovuto {ar seguito 1a restituzione crel furr.iJlo in questione, nerappresentano il contenuto essenziale. Anche 7a lettera di per sé, con osenza l'aggiunta delle monete, poteva essere consicerata un <( contras-segno >>, e si invitava il rettore a conservarle, cosa che del resto il fratediceva di {are ogni volta con i,infilarle nel1a <( coperta >> de1 libro 135.
Promesse e buone intenzioni avevano un maggioi credito se Ia qua-lità delie poche cose recate dai bambini ne dimostrava la concre tezza. U1'4 febbraio dle 1451 , Giovanpiero, aveva ar cono u, borserlino di cuoiobianco nuovo, con den*o un << porizzioìo », che << diceva: Giovanpieroabbi nome, ch'è figliuolo dabbene e dietro, inviluppato, vi era un fio_rino fiorentino stretro, valeva lire quatrro, soldi doàìci. Era reggero » ri6.
Giovanpiero, che recò << ùna pezza lana di romagnolo nuova e di. p.rr.line buone e una fascia di panno rino di <1ue pezzi assai buona », fu dav-vero ripreso , nel L459, da uno zio r37. Brigida sirvestra, ,, m.r.a neil,pila » il primo gennaio del 145g, << recò per segno una lettera di manodi chi era 7a fanciulla, con un nezzo q,.attrino fiorentino )> e anche leiaveva pottato << due pezze Tane e due pezze 1ine buone e due fasce » epiù che al*o << un asciugatoio assai buono, piccolo e gioiosetto »>
r3s. Avolte f intenzione di riprendere il fanciullo era manifestata ancora piùchiaramente, come fu fatto nella 1ettera che venne lasciata con Antonia
.,,t :,* dì primo_ di-maggio, 1459, anno detto, a ora di dieci ore, lu messauna fanciulla nella oila. Non 1ra . batrerzara, Jiis. u.ni, a dal conrado cli pisa emandolla uno che si 'chiama À"i""i" ìì"Érr.roi,.o vorcva avesse ,orre Maria Mad_d,alena, la quale lertera si.trova q"i- i" ;;;r;à pr", iùùir"A'i'o"i) ,rer. r(1456-14651, 15, c. 14): ,anche.piera'n;a;, JJ'faOf , .,.- ,à.o \rni"polirr^, ,h.diceva ch'era figliuola d'uno. che t..', ,"ii. Èi;r;'à;'C"rài, ài'"q#iL'aj pirr, t,quale polizza si troverà in questo ribro. neira .op.r* a; qr.iro-iislà, ."on-.,n -"rro
flYll1lin:,n:i.ltjno» (Libro.di bati sesn. L tù;e-rc6;t:t>.;'Ià)l ij.,,,n, d.11"Iettere, ad ognr modo, è arrivata sino a noi.,36,,« Giovanpiero, ponemo nome al fanciullo. ci [u posto nella pila, Iunedìnotte, alle nove ore o circa, a dì r4 di Éebbraio r+:r.-,t.à-"r.--'ulu"p'.r,, Iurudi romagnolo nuova e due' pezze rine buàne è-
""u Jur.i, "ài ";;;#'1,i. di duepezzi' assai buona e al co1lo arecò seco uno borsellino ;i;"i" 6,u*; .# ie peda_glie di-refe big,rco, el quale si fu {atto ir r."iu, quando il fanciuno dovette na-scere. Il borsellino era ài -cuoio nuouo. d.ni.o-ìr..à ,no p"rìrrl.i.l"a["va: Gio-vanpiero, abbi nome, ch'è..figliuoro dabbene e dietro, inviruppato, vi-'eÀ-un fiorinofiorenrino.srrerro., vateva lire" qrut,ro, Jài d"di;i.;r;"i;;;:I;".à'è i",,'iu ..,,.rrua catta^_46 »> (Balie e bambini iegn. B t1+tl-t+>11, U, c.56i.-137 La restiruzione comparà ner Memoriiri"ai 'riiri-kinute segn. B (1459-1460), 51, c. 3.
r38 <( Recò per segno una lettera di mano di chi era la fanciula, con unomezzo quaftrino 60renrino .e. recò due pezze lane e due p;; iir;,'..b;;ne e duefasfe e uno. sciugatoio,, assai buono, piccoro e gioios.ito]-i1 à"""rà i."ri.rjr'Giovannid'Antonio da Firenzuola »> (Libro d'ibali sesn."L Gq56La65i:lj,;-. ì]1.--
118 L,oSPEDALE DI S. MARIA DEILA SCALA DI S. GIMIGNANO
Cecilia, abbandonata il L9 gennaio del medesimo L458. La lettera, anche
questa << di mano di colui che Ia mandò )>, conteneva on << tae7zo quat-
trino fiorentino »> e diceva che si sarebbe ripresa la {anciulla dopo f inviodel1'altto rnezzo quattrino e che non si sarebbe mancato dt larc << il do-
vere alla casa»,7a banbina, aveva intanto con sé <<una pezza bianca e
una pezza lina e una tascia, tutte queste cose, assai buone cose >> 13e. An-
che per Benedetto, di ue anni, lasciato il 22 maggio del 1463, nel7a
Ietteru che aveva con sé, si diceva che era un « figliuolo dabbene >> e che
si << voleva f.arc il dovere alla casa t) e , à conferma di ciò, recava <( ftegonnelle, una bigia e :una azztrtta e una vetde, buone e due camicie e
cufEe e tte pezze line e un cuscino pieno di pelo >> 10. Non era stato così,
però, per Giovanni Francesco, il 15 luglio del 1460, per il quale il fratelasciò trasparire non poca sfiducia nella sequenza delle annotazioni che
fece sul suo registro: << tecò seco una polizza, che diceva voleva avesse
nome Giovanni >> e, scrisse il rettore, << l'aviamo contento del detto nome,
1a quale polizza dice: sia raccomandato e dice volerlo ripigliare )> ma,
concluse il frate poco convinto, << detto fanciullo, noi non sappiamo chise lo recò >> e, per di più, Giovanni, aveva con sé solo una << fascia e
due pezzuole >> a conferma dei buoni propositi espressi dalla lettera 141.
La stessa cosa si potrebbe dire per Benedetto Filippo, che, i1 2 marzo
del 1462, aveva recato <( per contrassegno vn fnezza bolognino falso >> 142.
13e « A dì 19 di gennaio, anno detto, fu messa a ora d'ore diciassette. Recollauno che fuggl via per nofl essere veduto e recò con seco una pezza bianca e :unapezza hna e una fascia, tutte queste cose, assai buone cose e pet segno recò unalettera di mano di colui che la mandò e il nome suo e donde egli era. Dentro unomezzo qtaltrino fiorentino, diceva in sul1a lettera che quando manderà l'altro mez-zo quatirino se la rivorrà, facendo il dovere alla casa, il quale ha nome Piero diBartòlomeo da Casole e che Ia fanciulla ha nome Antonia Cecilia » (Libro di balisegn. L (1456-1465), L5, c. 1.2).- r40 <( Benedetto, ha nome il fanciuilo, fu recato domenica notte, a dl 22 dimaggio, alle ffe ore e mezzo di notte, Fu tecato uno fanciullo al nostro spedale,fu posto ai piè dell'uscio ed è di tempo di re anni o circa e arecò seco_ più cose,cioè una lettèra, che, dice la lettera, è figliuolo di una persona dabbene, dice volevafare il dovere alla casa e tecò seco tre gonnelle: una bigia e :urra
^zzl7tra e :ur\a
verde, buone e due camicie e cuffie e tte pezze line e un cuscino pieno di pelo »(Libro d.i bali segn. L (1456-1465), 15, c. L8).
141 << Giovedì, a dì 15 di luglio, fu messo ne1la pila uno fanciullo maschio,non era baltezzato e ponemogli nome Giovanni e Francesco e recò seco una tossafascia e due pezzuole ài due teste di camicie e recò seco wa polizza, diceva volevaavesse nome Giovanni e l'aviamo contento del detto nome, la q1uiale polizza dice:e sia raccomandato, dice volerlo ripigliare e detto fanciullo noi non sappiamo chise 1o recò >> (Libro di bali segn. L 0,456-1'465), 15, c. 16).
142 <( Lunedl a d\ Z di marzo 1462, arecò Giovanni di Tommaso Pallaca da
Volterra, uno fanciullo maschio, disse ha nome Benedetto e Filippo e- tecò seco unapezza lana vecchia e una fascia e un mantellino more1lo, vecchio, i.dosso e recòper contrasseglo un mezzo bolognino falso; era battezzato» (Libro di bali segn. L(1456-1465), 15, c. 17).
GLI ESPOSTI
Altri si limitavano ad indicare il nome del bambino, riservandosi,
se mai, di raccomandarlo. I1 28 d'ottobre del L459, Maria Giovanna
non aveva portato nient'al6o che una << lettera piccola; disse del suo
nome )> 143. Maria, del 24 settembre del 1501, nella polizza che aveva al
collo, aveva scritto solo << Matia, Maria, due volte » 14. Antonia, giunta
il 21 febbraio di quello stesso anno, alle quatuo & notte, oltre << al
nome suo )>, recava scritto: << è povera, siavi raccomandata >> 145. I1 con-
trassegno poi, poteva essere rappresentato anche da un oggetto ed Elisabetta, messa nella pila il 24 giugno del L497, la notte di San Gio-
vanni Battista, << avéva una poTuza al collo di catta bambagina e dentro
uno contrassegno d'una mezza rosetta dipinta in cafta bambagina » e
per Caterina, di due anni, abbandonata rl 16 settembre deL L502, ricom-
pare il << breve al collo )>, questa volta, però, con una << lettera strac-
cia »> dentro, con il solo nome: << Catedna, Catetina >> 16.
Raccomandazioni e riihieste aumentaflo nei primi anni del XVIsecolo, limite ultimo del periodo da noi considerato, a dimostrare l'awe-nuta tecessione di quell'antico senso di pudore, che un tempo bloccava
gli animi e ciò lo si nota proprio dalle << polizze>>, sempre più frequenti
nei confronti delle lamentele a voce, dei gesti eloquenti, dei silenzi, cui
una volta ci si afrdava di più; in poche parole si ha la impressione che
si fosse imparuto ad abbandonare con altro stile i propri frdh. Il 22
luglio del 1504, per Sandra, abbandonata con una polizza al collo, col
1a3 « A dì 28 d'ottobre, anno detto, fu messa una faaciulla nella pila, alleventidue ore. disse uno, che-ha nome Giovanna, che la recò da Castelnuovo diVolterra. disie che era Éattezzata, ha nome Maria e Giovanna, recò seco un cenciodi fascia e un cencio di tovaglia, involta dentro un pezzo di gonnella e recò seco
uaa lettera piccola, disse del-suo nome)> (Libro di bali segn. L (7456-1,465), L5'c. 1-5).'t+4
<<Matia', ha nome la bambina, ci fu posta nel1a pila u d\ ?! di settembre,a ore due di notte, arecò seco lna pezza lina trista,e un _pezzo di cenciaccio periezza lana. bieio e- wn fascra doloròsa, coo una poTizza al col1o come ha nome:Mrria- Maiia. Aue volte » (Libro di barnbini e balie segn. E (L487'1'51'2), 16, c. 106).
i+s u l"rroni., ha nome la bambina, ci fu posta nella .pila a dl 2L di febbraio,a ore quat6o di notte, recò una gonnella di verde buio, trista e.una berrettina pao-
"uou i uso di cuIfia, un paio diìalzacce, con,una PoJYa, che d&eva.il nome suo;
É pòrr.rr, siavi raccomandata>> (Libro di bambini e balie segn. E (1487-75L2), L6,
c. 109).- ' 'i« << Elisabetta, aveva nome la fanciulla, fu recata e missa in nella pila, a
dl 24 di giugno, u br. ,rnu di norte, n dì di Sln Giovanni Battista, sabato notte.il di *.ri"doiici o circa, aveva una polizza a1 collo,di cata bambag,ina e.dentto uno;""tr;r"g"; d'una mezza tosetta, diiinta^in cata bambagina» (Libro,di bambini e
Liii-iifi. e icar$1pl, t6, c. st); « Caterina., ha nome la fanciulla ci fu posta
i"'r"fiu'.aau'à.i .otto'dtrlinzi u é^"u, u dì 16 di séttembre !502, a ore undici.er".t,-ì" oo ba.rr" una lettera straccia', che diceva aveva nome Caterina, Caterina
" ^"",
là"".U"i.ia big;a, un paio di é^1l,111e bige e senza scarqe; è d'anni due oiiuur, (t;»ro di banxùin; e bilie segn. E (14s7-15L2), 16, c. 108)'
119
120 L,0SPEDALE DI s. MARIA DELLA SCALA DI s. GIMIGNANo
nome, ci si lasciò andare a dire << non ha né padre né madre ed è abban-
donata da ognuno di noi »>, aggiungendovi un << si raccomanda »> lq
.
Il primo aprile del 1,505,7a polizza di Pasquina, diceva così: << ia pre-sente creatun è battezzata e ha nome Pasquina, per primo, e per se-
condo, Domenica, nata da una miserabile persona, raccomandasi perl'amore di Dio »>
16. Per Antonio, giunto alle due di notte del 7 gennaio1506, con vn <<pezzo di fodera da donna e una gabbanellaccia dilana,con questi insieme un guanto per pezza lana »>, aveva al collo una po-
lizza, in cui si ingiungeva al frate: << governalo bene >>, << metti lui risto-rato, il suo nome è Antonio ed è battezzato. Sia raccomandato >> e an-
cora più avantii << il contrassegno, serbalo, con un mezzo quatrino luc-chese vecchio >> e, in ultimo, vi era un << manteremo detta patri;a »>
18.
Ancora, ma altri ve ne sarebbero, il 13 dicembre del 1506, a rnezza-
notte, con <( un poco di robettaccia, tatta guasta e dolorosa )>, ma conuna <<polizza>>, fu abbandonata una bambina per 7a quale si chiedeva:<( ponete nome Lucia e Lucrezia e sarà fatto il dovere allo spedale.Fatelo per l'amore di Dio »>
1$.
L'esiguo numero di bambini eflettivamente restituiri, ci induce, però,a concludere che invocazioni e proponimenti non fossero che una comunepratica messa in atto per ben disporre, nel caso ce ne fosse stato bisogno,l'ospedale nei confronti dei piccoli assistiti.
147 << Sandra, ha nome la bambina, fu posta nella pila a d\ 22 di luglio, a oreotto, aveva ùna pezza lina dolorosa e una fascia trista e un poco di cencio pet pezzalana e una polizza al collo che diceva il nome: Sandra, e: non ha né padre némadre ed è abbandonata da ognuno di noi. Si raccomanda. Iddio la faccia buona »(Libro di bambini e balie segn. E (1487-L512), 16, c. 115). '
-1+a .,6 61 primo d'aprile, ci fu posta la sopraddetta bambina nella pila, a ore
cinque di notte e recò seco :urla pezza lana dolorosa, bianca e :una pezza lina tristae una fascia dolorosa e ona poTizza, che dice così: frati, come la presente crearuraè battezzata e ha nome Pasquina, per primo, e per secondo, Domenica, nata da lunamiserabile persona, raccomandasi per l'amore di Dio »> (Libro di banbini e baliesegn. E (1487-L512), 16, c. 1i8).
14e « Giovedì sera, a ore due di notte e a dì 7 di gennaio, ci fu posto nel1apila i1 detto bambino, con un pezzo di fodera da donna e una gabbanellaccia dilana, con questi insierne un guanto pet pezza lana e una pezza lina rotta e una fasciafotta, una polizza al coilo che diceva così: frate, questo fanciullo govemalo bene,metti lui ristorato, il suo nome è Antonio ed è battezzato. Sia raccomandato; a dì7 di gennaio, 1506. I1 conrassegno, serbalo, con un mezzo qaattrino lucchese vec-chio. Iddio 1o faccia buono; manterremo detta parola>> (Libro di banbini e baliesegn. E (L487-1"512), 16, c. 127).
1s0 << Domenica seta, a orc di mezza di notte, a d\ ti di dicembre, ci fu postaal nostro in{rantoio, la sopraddetta bambina e recò seco un poco di robettaccia dipanno, tutta guasta e dolorosa, tutti cenci e :una pezza lana e una lina e una fascianon molto buona e .una polizza, che diceva così: la ponete nome Lucia e Lucreziae sarà fatto il dovere allo spedale. Fatelo per I'amore di Dio. Dio la (accia buona »(Libto di bambini e balie segn. E (1487-L5L2), L6, c. 126).
T
GLI ESPOST'I
Ma Ia funzione delle « polizze » e delle << lettere >> era, come ab-biamo visto, anche quella d'informare l'ospedale sul nome già dato o dadare al bambino e quindi sulla necessità o meno di conferire il battesimo.L'alta percentuale di bambini giunti già b^ttezz^ti, quasi il 50Vo e lapremura dimostrata per gran parte dei rimanenti, che furono lasciati conprecise indicazioni sul loro stato, sta a dimostrarci che il conferimentodel battesimo era veramente una srncera preoccupazione per coloro cheabbandonavano i propri frgl| La paura che i piccini morissero prima diessere stati battezzati e che le loro anime fossero costrette a vagare sen-za pace, impressionava i genitori ancor più dell'abbandono stesso e Iirendeva in questo estremamente scrupolosilsr. Ecco il perché dei nomisussurrati, dei << disse che non eru ba"ttezzato », del1e tante << scrittoline >>
col nome desiderato e di quegli involtini di sale, malamente infilati alcollo dei bambini, che tanto spesso contrastano con Ia rimanente nuditàe 7a fuetta di lasciarli. Agata Piera., per esempio, lasciata il 5 febbraiodel 1509, alle tre di notte, aveva solo << un po' di sale in un po, di cartasul petto )> e per Barnaba Giovanni del 1458, per il quale non si erasaputo né << donde si venne >>, né chi Io aveva recato, perché « picchiò eandò via di tata rotto », si seppe, però, che << non era battezzato>>,perché « recò ii sale al col1o >, 152.
rsl I bambini non battezzati, infatti, nella credenza popolare, erano destinatia.vagare lamentandosi, sino al_giorno destinato alla loro morie, insieme a tutti g1ialtri morti anzitempo, come g1i uccisi in gllerra e gli estatici, cioè coloro Ia òuianima_era uscita dal cotpo senza farvi più ritorno e con tutte queste anime andavanoa costituire il cosiddetto << esercito furioso », si veda C. GrNzrunc, I benandanti cit,,p. 86. Sulia preoccupazione per iI battesimo ne1 N{edioevo, rimandiamo a y. B.Rnrsseuo, L'inlanticide cit., pp. 240-241 e a J. Drrurartv, La paura ìn Occidentecit., pp..83-84-,-specialmente per Ie accanite persecuzioni, di cui èrano fatte oggetrole levatici, additate come steghe, quando il numero dei bambini, che dicevanò"natimorti o deceduti subito dopo la nascita, ancor prima di essere stati battezzati cioè,eta ritenuto _troppo. a1to. Ma sull'argomento delle ostetriche, vittime spesso della cre-denza popolare, che 1e voleva ad ogni costo streghe e perciò interessate a
tar- morire i bambini appena nati, prima del battesimo, cfr. ancora C. GrNznunc,I benandanti cit., p. 110.
, ts2 Agata Piera, anivata alle tre di notte, era completamente nuda e aveva9919- u q! po' di sale in un po' di carta su1 petto » (Libro ài barubini e balie segn. E(1487-L512), 16, c. L40); « Martedì a dì 6 di giugno 1458, fu messo uno fanéiuflomaschio nel1a pila a ora di cinque ore di notte, non si sa donde si venne. Non erabattezzato, recò i1 sale al collo e recò una pezza tnsta lina e una fascia trista, chi1o ,recò, picchiò e andò via di tata rotto,
-gli lasciò una polizza addosso, diéeva:
9algano di Lapo »> (Libro di bali segn. L (14561465),15, c.-12). Per L. LerrenaaNo,Histoire, pp. 146-1,49, la presenza del sale addosso ai bambini starebbe a signifi-care l'awenuto conferimento del battesimo, mentre per R. Tnrxran, The foun-dlings cit., p. 269, il sacchetto del sale attesta lo stato di non battezzati dei bambinic-h9 giungevano agli Innocenti e tali venivano considerati anche ne1 nostro ospe-.{rale, dove il sacchetto del sale, trovato al collo del fanciullo eta tenuto << per segnoche non era battezzato » e per certo sappiamo che fosse così anche a Sàn Ga]lo,l'altro antico e più volte nominato, ospedale fiorentino.
L2L
t22 T,OSPEDALE DI s. MARIA DELLA SCALA DI s. GIMIGNANO
Il sale, << grosso )> o <( pesto >>, detto anche << salina »> e << saletta »,rinvoltato nelle fasce, nelle ., pezzuole >> e sistemato, uso sacchettino alcorpo del bambino, era certamente un dono simbolico, vincolante, incambio del quale si chiedeva cioè f impartizione del battesimo, nel qualei1 sale veniva appunto impiegato. Nel 1416, infatti, per un altro Bar-naba, si disse proprio che aveva un « legato di sale in una pezzuola >> e
così fu per Girolama Silvesta del 1420, che si disse giunta anche leicon un << poco di legato di sale al collo », 1s3.
Ma il sale ci pare avesse anche un altro significato. Nel 1435, San-tia, giunta iI giorno d'Ognissanti, aveva a1 collo, proprio come il sale,<,. rna pezzolina con un poco di tera, legata col filo rosso » ls. La terrao la sabbia, come anche il panico, il miglio e 1o stesso sale, sappiamoinfatti che erano posri fra i panni dei bambini per tenere lontana ognipossibile malia, proprio per la loro caratteristica di << indeterminatezza>>,rappresentata appunro dal nr-rmero dei chicchi, dei grani, difficili da con-iare, specie di notte. L'indeterminato era insomma un potente ostacolocontro le streghe, che sempre << aduggiavano » i bambini, specie quellinon battezzati, col costringerle a contare, sbagliare, ricontare e poi girarepef tante volte quanti erano i chicchi o i grani, intorno alla personada danneggiare, prima di poter mettere in atro i loro piani 1s5. Nelle
_ ,t, .o Barnaba, ponemo nome al fanciullo, il dì di San Barnaba, a dì 11 di
giugno. Arecò questi segni: in prima una scritta, che diceva che a1 detto fanciulrofosse posto Barnaba e uno legato di sale in una pezzuola, due pezze line e una{ascia e uno mantellino ovvero due stracci di gonnelfuccia verde, rtiupputa, di pannolino tinto in cilesto e intagliata dai lati >> (Balie e bambìni tego.- B 6qtl-iqSq,14, c. 8);_ « Girolama Silvestra, ponemo nome a1la {anciu11a, che fu posta nellapila, lunedì notte, a dì 30 di dicembre, anno detto, la vigilia di San Silvestro.Arecò questi segni: uno poco di legato di sale al collo » (B;lie e bambini segn. B(t113-14i4), 14, c. 11).
ls4 << Santia, ponemo nome alla fanciulla, che fu posta nella pila, martedì avespro, a dì primo di novembre, el dì d'Ognissanti. Arecò a1 col1o una pezzolina conun poco di tera, legato con un fllo rosso e uno mantellino cattivo, {oderato d'unpezzo di fodero tristo e uno pezzo di gonnelluccia, tLttt^ stracciata di panno roma-gnolo e una fascia buona e una cattiva, due stracci di pezze line » (Balie e bambinisesn. B (I4L3-I451), 14, c. 30).
1ss <( In tutti questi casi la sffega, secondo il concetto popolare, deve nonsolo numerare ad uno ad uno i grani di sabbia o di sale, i sèml di miglio o dipanico, i caniculi deile poliporiti, i fori esistenti nel rravertino, le foglie àghiformiod aculeate del1'asparago, de1 ginepro, de1l'agrifoglio, del pungitopo; mà dopoaverne rilevato il numero preciso, deve {are altrettanti giri intorno alla persona,che vuole aduggiare o danneggiare. Per compiere tutto ciò richiedesi tempo nonbreve, tanto più che la numerazione nel1e ore notturne riesce difiicilmente precisa,e poi dutante la numerazione o la ripetizione incessante di giri attorno ad una per-sona, possono sopravvenire individui, che disturbino le operazioni o si awedanodel maiefizio, che stava per compiersi, rendendo così di nessuna efiìcacia l'arte ma1-vagia, che s'intendeva di adoperare » (G. Brrruccr, Un capitolo di psicologiapopolare, cit., p. 50).
*I.).1
t,l
GLI ESPOSTI t2)
1
)
i
fonti, infatti, si parla sempre di sacchettini << con un poco di sale » e solo inun caso, per Veronica del 7428, giunta la notte del, 24 settembre, si parlòdi << tre granelia di sale grosso )>
1s6. I1 sale, dunque, può darsi adempisseanche alla necessità di << preservare )> e, del resto, come abbiamo giàavuto modo di notare, a proposito di quei segni << particolari >>, lasciatiaddosso ai bambini, l'intenzione di renderli in qualche modo immuni,era frequentemente presente fra i genitori 1s7. Anche il carbone, forse,poteva essere adatto per altri versi al medesimo scopo: Andrea Isotta,giunta il 30 novembre del 1425, aveva tra le fasce <( ue carboni legatiin una pezzuola » (il numero ffe ricorre spesso: « tre granelli >>, << ffecarboni », <( me chicchi di paternosmo >>) e Pollonia, del 72 sertembredel 1136, sempre in una pezzuola aveva << uno poco di sale e uno car-boncino >>, dove il carbone pare avere, al negativo, la medesima efficaciadel sale, se non altro come avvertimento dello stato di non battezzatodel bambino, dato che a entrambe fu conferito il sacramento, contrappo-nendosi, nel secondo caso, anche visivamente, come rappresentazione diciò che doveva essere evitato, al sale, comunque benefico, al quale eraabbinato 1$.
Ad ogni modo, venuti a conoscenza del loro stato, si provvedevaimmediatamente al battesimo: <<battezzossi detto dì »>, << e dì detto, lofacemmo battezzare >>, che avveniva, com'era obbligatorio, presso il vi-cino fonte battesimale nella pieve di San Gimignano. Del resto il batte-
i$<< Veronica, ponemo nome alla fanciulla, che fu posta nella pila, venerdìmattina innanzi dì, a dì 24 di settembre. Arecò questi segni: in prima te granelladi sale grosso e due stracci di sargia e una calzi btanca-da romò . una fàcia diplr) pezzi e due stacci di pezze ltne>> (.Balie e bambini segn. B (1413 1154),74, c. 2J).
157 La proprietà del sale di « preservare » dai male, ci è testimoniata anchedal << sacchettino di sale da appendersi al dorso delle nutrici )>, come galattofugo,per renderie immuni cioè dai danni dello slattamento, cfr. G. Bruuccr, Aruuletiitaliani cit,, p. L6.
1s8 << Andrea e Isotta, ponemo nome alia fanciulla, che fu posta nelia pila,
venerdì mattina, a dì 30 di novembre, anno detto) arecò queste cose, cioè due pèzzeline e una pezza lana e una fascia e ue carboni, legati in una pezzuola >> (Balie ebambini segn. B (1413-L454), 1,1, c. 1B); « Po1lonia, ponemo nome alla fanclulla, chefu posta nella pi1a, mezzo dt- una mattina all'ottore, a d)" 1,2 di sertembre, annodetto. Arecò questi segni; in prima una pezzyola di panno lino, dentro un poco disaie e uno carboncino e più cenci di panno lano e lino, tutti trista cosa >> (Baliee bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 3l). A proposito della composizione dei<< brevi »>, cioè degli oggetti che vi erano messi denuo, G. Bauuccr, Il leticismoprimitiuo cit., pp. 65-69, L30, nota che gli oggetti potevano essere i più disparati eper raggiungere un effetto maggiore, persino in contrasto tra 1oro, come, ad esem-pio, il mettere insieme oggetti sacri con altri rubati e comunque concrtenando edarmanizzando <( oggett.i, che sembrerebbero non avere e non potessero mai averetra loro Ia più lontana relazione ». Al1a {otmazione degii amuleti dunque si appiicavaspesso ii principio di « opposizione o di antipar'ia >> e anche la rappresentazione<< dei caso disgraziato » che potrebbe capitare.
:1
oa
!ì
;:
124 L,0SPEDALE DI S. MARIA DÈLLA SCALA DI S. GIMIGNANO
simo << alle fonti >>, così spesso invocato nelle poltzze, era l'unico validoe se, temendo per la morte del bambino, si er'a provveduto a battezzadoin casa, si cl-riedeva con insistenza cli rcgoiare il sacramento e gli si po-
teva mettere ugualmente il sale al collo per maggiore sicurezza. Gli av-
vertimenti in questi casi suonavano così: << questo fancir-rllo non è bat-
tezzato alle fonti », << è battezzato tn casa e alle fonti no >>, ctli facevano
seguito: << avemolo portato a battezzare a1le fonti ,>, ., facemolo battez'zate >>. Per Girolama Silvestra, recata il lunedì notte de1 30 dicembre
àel I42O e giunta con un po' di sale al col1o, chi la recò disse << ch'era
battezzata in casa e non disse come >>, poi Ia mattina, prosegue il frate,« la facemmo battezzare e ponemmo i detti nomi >>'se.
Il primo dovere da compiere per chi si trovava di fronte ad un
bambino appena nato, era senz'altro quello di portarlo nella chiesa piùvicina affinché gli fosse impartito il battesimo. Così aveva fatto Niccolòdi Pierallo, il campanaio, cor-r il bambino da lui trovato nel « Botghetto ,>
in San Gimignano, che subito « fece battezzare e posegli nome Gimi-gnano e Giovanni to. Ugualmente fu fatto con Verdiana Camilla, tto-vata 17 22 agosto 1453 a Casteifiorentino, nella chiesa di Santa Ver-diana, che « detto dì »>, secondo << monna Lucia, donna di Nanni di Bar-
tolo d'Agostino », del << popolo di San Lorenzo »>, che la recò, << fecero
battezzare >> 16'. Ma va da sé che i bambini abbandonati in chiesa etano
i più fortunati da questo punto di vista ed erano inviati dai vari pie-
vani già in regola con il sacramento, Benedetto Mariano, ad esempio,
giunto 11 23 marzo L489, <<recò una lettera di mano del pievano dellapieve di Coiano, corte di Montaione, che diceva eru battezzato »>
162;
Ventura Maria, venne il 13 maruo 1503, con una « lettera di mano di
ser Paolo di Masino », della pieve a Gambassi, che disse <( come la bam-
bina, trovò in detta pieve in sull'altare e posegli nome el sopraddetto
159 « E quella che la recò, disse ch'era battezzata in casa e non disse comerive nome e poi la mattina la facemmo battezzare>> (Balie e bambini segn. B(14t) 7454), t4, c. 1.L).
10 << E detto Niccolò 7o fece battezzare e posegli nome Gimignano e Giovanni >>
(Libro di bambini e balie segn. E (1487-1.512), 16, c. Ll5).161 <( Verdiana e Cami11a, ha nome la nostra fanciulla, ci fu recata oggi, questo
dì 28 d'agosto, 1a quale ci recò monna Lucia, donna di Nanni di Bartolo d'Ago-stino, popò1o di San Lorenzo, di Castello Fiorentino e disse fu trovata ne1la chiesadi Santa-Verdiana di detto caste11o, a d\ 22 di detto e detto dì la fecelo battez-zare, Arecò seco una pezza lana bianca vecchia e una {ascia trista, re stracciuolidi pezze line >> (Balie e bambini segn. B (l4l)-1'454), L4, c. 63).- 162 §sngd611o e Mariano, ponimo nome a uno fanciullo, {u recato martedìalle tredici ore, a dì 2) di marzo, recò una lettera di mano del pievano-della. pievedi Coiano, corie di Montaione, che dice era batlezzato e posegli nome Benedetto e
Mariano. Recò una pezza lana e una lina, trista ognuno e uno straccio di fascia.Dio el faccia buono » (Libro di banbini e balie segn. E (1487'L512), 16, c. 6).
GLI ESPOSTI 125
nome )> 163. La stessa cosa fece ser Matteo da Montecatini per Gimignano
Piero, che era stato <( posto nel1a pieve >>, cioè <<battezzollo >> e 1o inviòper Casmuccio, barcaio, all'ospedale 1e.
L'accottezza d'informare il frate sull'avvenuto battesimo, era pro-
pria anche cii chi aveva una certa furia, che magari urlava un « è bat-
tezzato >>, sefiza sprecarsi a dire il nome, che poteva essere scelto di
nuovoJ come spesso aweniva, a piacere dell'ospedale. << Non sappiamo
donde venisse, se none disse era battezzata. Dio ia faccia buona >>, sii
scrisse per una bambina chiamata poi Benederta, tecata all'una di notte
del 16 giugno 1488 16s.
Nella piccola percentuale di bambini giunti totalmente privi diqualsiasi informazione sul loro stato di battezzati o meno, solo il 107o,
un buon numero è rappresentato da bambini già grandi per i quali igenitori avevano ritenuto inutile il dare indicazioni in rrrerito. Ciò nono-
stante a qualcuno di loro si lasciava ugualmente luna polizza in mano,
da tenere ben stretta, col nome, come fu per Bartolomea, una bambina
di cinque anni, abbandonata il 10 gennaio del 1508'6. Ma a questa età,
in genere, e anche prima, i più svegli si affrettavano a dirlo <1a soli, come
aveva fatto Antonia, << di tre anni o più >>, nel 1501 che, giuuta << senza
nonle )>, alle due di notte del primo gennaio, insistette a dirlo più volte
al frate che fotse persisteva nel domandarglielo, come intendiamo da
quel << ma lei dice di avere nome Antonia >>167. Per Nlariuccia, invece,
della sua stessa età, Iasciata << in su la sera >> del primo dicembre 1503,
si dovette scrivere: << non sa dire chi sia né il nome >> e quello segnato)
163 Vsn6ula Maria, ci fu posta nella pila a ciì 3 di rnatzo 1503, a ore sedici,arecò seco Ltn pezza lina doloiosa, una {ascia tista, una pezz'a lana,e un,poco dlsrr.accio con una lettera in rnano di ser Paolo di Masino, perché recoila cialla pier.e
a Gambassi, 1a dice come la bambina trovò in detta pieve i.n su11'altare e poseglinonre il sopiaddetto nome>> (Libro di barabini e balie scgt't. E (1187 1r\2)' 16, c. 173).
t& Libro di banzbini e balie segn. E (1487-1512), 1.6, c. 125).165 <§3nsds112, pollemo nome a una bambina, fu messa nelia pìla-cle1 nostro
spedale, venerdì notte] a dì 16 di giugno, a ote una di notte, disse chi 1a. recò che
*o baituzzatu e ha nome Benedettà. Recò seco :una pezza lina, un legaccio buono,non sappiamo donde vclisse se none d.isse era battezzata. Dio 1a faccia buona >>
(Libro-dì barubini e balie segn. E (L487 1512), L6, c. 4).16 « Mercoledì, a dì 1Ò di gennaio, fu lasciata la sopraddetta fanciulla al-
l'uscio del nostro celliere, male in ordine, scalza e ccn un poco di copertuccia incapo di panno lino, azzrttro, rista e dolorosa, un paio di scarpetiine rattacconate e
oia paliàza in mano a detra bambina, che diceva: ha nome Bartolomea E {u a orequatàrdici detto dì, Dio la facci buona ed è secondo me d'anni cinque o circa "('Libro d,i banzbini. e balie segtt. E (1187'1512), L6, c. 136.).
t67 « A dì prirro di gennaio, a ore due .li notte, ci {u posta a1i'uscio di casa,
una bamfuina d'a'nni tre o"pi,l, t"ttzu nome, ma iei dice avere nome Antor-ria, arecò
S..ò ona gonnellaccia e unò guardaluccio di panno lino, tttsto >> (Ltbrc di bazubitie balie segn. E (1487-L512), 16, c. 106).
t26 I-'oSPEDALE DI S. MARIA DELLA SCALA DI S. GIMIGNANO
fu un nome nuovo, postole al momento 16 '
de1le tante volte, accadde per un bambino di
del 1505, al quale, <( non sapendo il nome
La stessa cosa' ma è una
quattro anni, il 26 aPrtle
e lui non 1o sa dite >>, fu
messo quello di Ottaviano 16e.
L,ospedale, in genere, non aveva un,età precisa oltre la quale i bam-
bini fossero ritenuti senz'altro battezzati, come sappiamo fosse' per
"r".pio, all'ospedale fiorentino degli Innocenti, dove per i bambini olme le
tre settimane, si considerava che il sacramento fosse già stato impartito 170'
Qui a San Gimignano, nel dubbio, ma ci pare fosse così anche a San Gallo'
l'altro e più antico ospedale fiorentino, lo si ripeteva' come fu.fatto nel 1488
per Filiipo, trn burnlino di cui, però, non conosciamo l'età' per il quale
il frate annotò: « non sappiu,nÀ di certo se era battezzato' facemolo
battezzare a dì detto r, tt'. Anch. Margherita di tre mesi, de11'11 febbraio
del 1490, <( non sapendo se era battezata '>, fu nuovamente sottopo-
,tu ^lL'i*pu.tizione
à.1 ,u.ru-"nto e così fu fatto per Paola' di << sei
o otto settimane »>, che giunse <( senza segno di battesimo r>' men-
ue il 14 agosto del 1506, ti bambino di << sei mesi o più >>' non fu fatto
battezzare, perché, si disse, << lo stimiamo al tempo battezzato r> e fu
solo ., chiamato >> Ventura 172.
Per i nomi, quasi sempre due, come abbiamo visto' ci si sbizzar-
riva, ma erano ricorenti quelli del santo del giorno' specie se i santi
inquestioneeranoSanPaolo,sant'Antonio,SanGiovanni'SanBene-d.ttà, Sun Silvestro, ma era frequente anche Ulivo o Ulivetta' per i bam-
bini recati proprio la domenica delle Palme; chiara, Girolama e caterina,
,i.orr.uurro p", 1" bambine, mentre Gimignano e Fina erano risetvati
ls « Abbiamole posto nome Mariuccia, Igdio l'aiuti e Nostra Donna t'accom-
nasni» (Libro di banbini e balie segn' e OCsl'.iJil' ià' t rrzr'PdéttL»bs\LtuvrL;
ff;;li;"rf"ràr," i-'fri non Io sa'dire, lo chiamiamo Ottaviano,
stimiamo pure sia ourrrlà^tà'^iiélà"ii,^àà -.gti
moào, chiamiamo Ottavirno » (Libtrt
Ti"uriuì; i bàti, "gr. E (7487'1.5121, 16,. c' 11e)'-' "'110a+;.-R. Tnexi;n, The t'ouillings cit', p' 269't7l << Filippo, po'r.ào'no^.- u-"no'Uu,nt inà, {u n-,.tro nella pila, t'err-'rJì mat-
tina. innanzi dì, a di i§"ai'-.rrÀ,"*n-iupp;r-" di cerro se.rà bartcrra:o. f,tcc-
#àià il;;;;^[' , aì- d;;,.i^p;;;;àsli ';;t'
Filippe, Djo Io raccia buonc L'ra in-
volto in pezzi di prrruiià- lui'r.- e lirie e stracci. d'i'fasce, not erano b-uone a nrrlla'
venne da Castelnuo'o ài'v"ii".à 'r--(tiurl- ài batnbini e balie segn' E (1187-15i2)'
16. c. 3). i ,---^^:'", -' tlz'' rrNon sapendo se era battez zata, facemola battezzare domenica ffìaltlna.
a dì 13 detto, ponemo[ ;-; M;;;r'*r';io1t-la taccia buona>> (Libro di bambini
e balie segn. E \1487'L\i;\"'ie' t'-zl' ;; i'aola' nontto nome alia bambina' sabaro
mattina a d\ 25 di s";;;;. ;'";; '.irr;;;'di.i' .'it.u ci fu posta Ia dette bambina
nella pila. aveva un p;;;;-à' gont'tilino da bambini' tutto straccialo e uil pezzo
ii'L#iJ'ai"ìr"ira'^rii,.-prr-p!rr.^ e una {asciaccia trista e dolorosa:.. scnza sesrno
di battesimo, ^r.rru ,.ì, -otto'
settimane,* thi"*Àoh Paola' petché il dì di San
;*i;;;-(L;b;,-a; or*ù-i,ii--uorie ieso"E $487-1'512)' t6' c' 124)'
il
E!
iGLI ESPOSTI 127
a chi proveniva dall'interoo della città, come Verdiana, era dato alle bam-
bine provenienti da Castelfiorentino. Agli illegittimi, quelli dichiarati,
invece, non era raro vedere imposto, almeno per secondo, se non per
primo, il nome del genitore, forse, chissà, per dare anche a loro la pos-
sibilità di essere facilmente riconosciuti 173.
Un'ultima riflessione. Se i bambini giunti già battezzati e quelliprowisti di polizze e contrassegni, potessero essere considerati tutti dei
legittimi, come altri, per epoche più recenti della nostra, ritengono dipoter sostenere, la nostta percentuale di legittimità lieviterebbe in ma-
niera considerevole, fino a raggiungere e forse superare il 50Vo del to-
tale degli esposti, il che risponderebbe in pieno, per la verità, alla no-
stra intima couvinzione di trovarci di fronte ad una grande maggiotanza
di figli legittimi abbandonati, ma se ciò, come abbiamo già accennato
nel precedente parugrafo, può essere quasi sempre vero per chi recava
un contrassegno o una lettera, e sarebbero già tanti, il battesimo, almeno
nel secolo da noi studiato, era una preoccupazione di tutt'altra natura,
rispondente ad altre esigenze (non a caso, infatti, ma proprio per que-
sta ragione, anche diversi degli illegittimi giungevano già battezzati) e
perciò a qlÌesto fine, come crediamo, poco rilevantelTa.
1?3 Fu così per Maria Giulietta: « Giovedì mattina, a dì 16 di 1ug1io a orenove in circa, ci recò Lorenzo di Piero, la sopraddetta bambina da San Piero,figliola, disse, di ser Giuliano Gamucci e d'una sua serva, disse che gli si ponesse
nòme Maria » cui, il frate aggiunse anche Giulietta, ripetendo i1 nome del padre(Libro di barubini e balie segn. E (1,487'1512), 16, c. l2)); ia medesima cosa
awenne nel 1509, tanto per faie ,n alto esempio, per Angelica Romea, figlia ille-gittima di Romeo.d'Agnolo di Romeo, si veda il Libro d.i banbini e balie segn. E(1487-151.2), L6, c. 1,37.'
174 péi l'XfX secolo, M. G. GonNI, Il problema degli esposti in ltalia dal1861 at 1900, in un Problema di storia sociale cit., p. 12, ritiene che .« con og-ni
probabilità buona parte dei trovatelli che recavano questi segni. qarticola.ri_.erano deiiegittimi, e i genitori, pur abbandonandoli, volevalo garantirsi la possibilità di ri-tir-arli in qualsìasi morriento ». Per 1o stesso periodo è dello stesso parere L. PgL-
LEGRTNT, Liesposizione dei lanciulli a Milano dal 1860 al 1901 , in w,Prablema distoria sociale cit., p. 124, che ritiene legittimi « la maggior parte dei bambini por-tati al toino dopo-cinque giorni dalla nascita, que11i già b^ttezzati, quelli che por-tavano segni di riconosiimento o annotazioni scritte sulla prom-essa 4-t-gg ptg..-t-tgg
ritiro >>; È. Suoxmn, Famiglia cit., p. 168, anche lui per il XVI, XVII e XVIIIsecolo,'è dell,opinione che «ogni iròvatello sopra il mese di età era suscettibile diessere'figlio legittimo (si presume infatti che 7e ragazze madri si sbarazzasseto de1
6elio il pit l" fretta posiibile) e, agli indumenti di molti trovatelli, erano attac-
.à'ti .rr.tii e foglietti cir. p.rm.tt.rano alle autorità di ticonoscere i1 loro stato dilegittimi ,, . ,n.lh. G. Ds Rose, L'errtarginazione sociale in Calabria, ^.r-t',
p. 28, nota,o.". it XVttt secolo che « non tutte lè donne che espongono il figlio, rinuncianoàefinitivamente a riaverlo: ra le fasce del neonato molte volte è inserita la scheda,
un segno di riconoscimento, che può essere Ia me1à, di una medaglia o- un- partico-lare iidumento; sono numetosi anche i casi di afidamento esplicito ad orfanottofi,ma più frequente è l'abbandono vero e proprio, senza segni -di riconoscime-nto, quasiad àttestare una recisa volontà di rifiutò, riflesso di un malinteso senso di colpa odi una radicale disperazione ».
ì
jl
t28 L,OSPEDALE DI S. MARIA DEI,LA SCALA DI S. GIMIGNANo
E per finire ancora un'ipotesi. Una breve indagine, condotta suun centinaio di bambini, recati al1'ospedale fiorentino di San Gallo, ffail 1394 e il 1401, periodo corrispondente al primo dei registri dell'ospe-dale, relativo ai bambini e presente come quelli di San Gimignano, nel-l'archivio degli Innocenti, ci ha rivelato 7a totale assenza o quasi, se sieccettuano due soli bambini giunti col sale al collo, di << segni »> delgenere di quelli da noi trovati, di cui già ampiamente abbiamo parlatoe che ci sono parsi messi appositamente per prcteggere o per distin-guere i bambini. Pura coincideflza o espressione di due diversi mondi,quello cittadino e quello di campagna, in cui credenze e superstizionigiuocavano ruoli di.fierenti? Ci basta, per ora, solo accennarla, ma laprima impressione è che pian piano escluse dal modo di vivere di città,esse vivessero feconde in campagna, dove 7a vita quotidiana ne era an-cota, per necessità, intessuta.
c) ll sesso, l'età e le condizioni fisiche degli esposti al loro ingressoin ospedale
sulla base dei registri relativi alle balie e ai bambini, i trovatelliricoverad all'ospedale della Scala di San Gimignano, negli anni compresidal 14t3 al 1512, sono poco più di 400 ma se tenessimo conto delvuoto di ventidue anni, corrispondente a uno o più libri andati perdutie che coprivano il periodo che va dal 1465 al 1487, ad una media dipoco superiorc ai 5 bambini l'anno accolti dall'istituzione, quale abbiamoricavato dai tre registri esistenti, il numero degli abbandoni supererebbele 500 unità 1?s.
Riguardo al sesso quasi il 60Vo dei trovatelli è rappresentato dabambine.
Che le bambine all'epoca, corressero maggior rischio dei maschi diessere abbandonate o peggio soppresse con l'infanticidio, è cosa ormainota e dovuta, principalmente, a71a loro inutilità o quasi, dal punto divista economico, sia perché più deboli fisicamenre, sia perché prestosarebbero state da matitare e avrebbero avuto bisogno di una dote 176.
17s I1 numero preciso dei bambini accolti dall'ospedale, cosl come risulta daitre registri in. questione, è di 413, .ai qua7i, se ne aggiungessimo altri lL7 (tantisarebbero stati nei ventidue arni d'intervallo alla m.-àia, ai 5,3 bambini l,aàno),otterremmo un numero totale di 530 esposti.
176 Sulla tendenza dell'epoca ad abbandonare e a sopprimere più {emmine chemaschi, ci limitiamo ad indicare le considerazioni di D.-Hsnr,ruy-- C. Kraprscu-Zuazx, Les toscans et leurs larni.lles cit., pp. 326-342, che per la Firenze del Quat-
GLI ESPOSTI t29
.16
i
I
I
II
I
Tale atteggiamento nei confronti dell'abbandono dei bambini, ad ognimodo, parve variare, col tempo, a discapito dei maschi, il cui numero
aumentò notevolmente negli ospedali, in seguito ad una maggiore ofiertadi ricoveri, moltiplicatisi dopo la prima metà del XV secolo, col sorgere
di nuovi ospedali specializzati nell'assistenza dell'infanzia. Richard Trexlerha infatti notato, per Firenze, che con l'apertura, nel L445, del grande
ospedale degli Innocenti, le famiglie, che fino ad allora erano ricorse
all'esposizione delle sole femmine, Ia percentuale delle quali aveva rag-
giunto, tra il 1404 e i\ 14L3, valori notevoli a San Gallo, oltre il 6lVo,furono incoraggiate dalla grande disponibilità di posti del nuovo com-
plesso ospedaTiero, a lasciare anche i maschi lu. Per quanto ci riguarda,pur rimanendo sempre molto alta la percentuale degli abbandoni fem-
minili, anche il nostto ospedale rilevò verso Ia fine del XV secolo e neiprimi anni del XVI, nel generale aumento di assistiti, che dal 1487 inpoi, il periodo relativo all'ultimo dei registri, taggiunsero la media di9 bambini I'anno, un maggior numero di maschi abbandonati rispettoal passato 178.
In definitiva, vna nuova mentalità andava soppiantando l'antica,di un'assistenza cioè non più sporadica e limitata, a vantaggio di pochi,ma ampia e tesa a includere sempre nuove categorie di assistiti e, nel-I'ambito specifico dell'assistenza ai bambini, il considerare, ora, che ce
n'era la possibilità, il loro abbandono negli ospedali, come una valida
trocento, indicano, quale causa dell'alto tasso di mascolinltà, certamente la sotto-registrazione femminile ma anche l'abbandono, come risulta dalle alte percentualidi bambine abbandonate nei due antichi ospedali fiorentini di San Gallo, dove,tra rl L404 e i\ 1413, raggiungeva il 61',2Vo, e di Santa Maria della Scala, dove,nel 1427, ne accoglieva il 70Vo e di E. R. Cornr,ra.N, L'inlanticide cit., pp. 15-335,che, se pure per la Francia e pet un periodo precedente a quello da noi studiato,denuncia un ampio ricorso alf infanticidio delle bambine, specialmente fra i con-tadini dei villaggi più poveri, per i quali allevare i maschi eta un investimentosenz'altro p,ì vàÀtaggioso de1 tirar su deile femmine, che sarebbero costate nonpoco per la dote e avrebbero lavorato per i1 marito.
1, Cfr. R. Tnexrrn, The loundlings cit., pp. 368369.178 Nbl primo periodo, infatti, compreso tra t1 14L3 e il 1,454, corrispondente
al tegistro di Balie e bambini segn. B, la percentuale delle femmine abbandonate,raggiunse il 65Vo; un grosso calo si registrò tra il 1154 e il 1465, gli anni relativial secondo dei nostri libri, il Libro di bali segn. L, nei quali tt del 52Vo, nentrenel terzo, il Libro di balie e bambini segn. E, degli anni 1187'1512,la percentualerisalì, ma molto al di sotto di quella del primo periodo, a1 58,9Vo. T.a niedia degliingressi, sempre in relazione ai tre periodi sopla accennati, passò- dar 2,6 ai 6,8e,1nfine, ai 9 bambini abbandonati afl'ospedale all'anno. C1.re i bambini assistiti da1-
l'ospedale fossero aumentati in questi anni, ci è testimoniato anche dalf insolitoe tèmpestivo rinvio di uno di essi, quel Gior,acchino del 1,491, che fu rimandatonel giro di poche ore, da1la sera alla mattina, a Certaldo da dove era r,/enuto,perché.,la casa>>, disse il ftate, aveva, allora, «troppi infanti>> (Libro di bambinie balie segn. E (1.487-7512), 16, c. 8).
li::iil
::o
710 L,OSPEDALE DI S, MARIA I}ELLA SCALA DI S. GII\4IGNANO
alternativa alla misera routine quotidiana e non più, come una volta,
solo un mezzo di eliminazione sistematicamente messo in atto ogni volta
che se ne aveva la necessità e, per pfimo, nei confronti delle bambine,
le cui bocche erano sempre di troppo in casa.
Nonostante che l'età non compaia ogni volta nel1e descrizioni rela-
tive ai bambini e redatte al momento del loro ingresso in ospedale, la
maggior parte di essi non doveva avere che pochi giorni se non podre
ore, raramente qualche settimana. Che si tratti, in genefe, di barnbini
molto piccoli, ci è dirnostrato, oltre che dallo stesso silenzio ossefvato
sulla loro età, tale cioè da non necessitare di alcuna precisazione, anche
dai pochi stracci che i fanciulli avevano con sé, quasi sempre poche
pezze e poche fasce, adatte a coprire dei neonati e il fatto che, nono-
stante la funzione simbolica della pila, cui abbiamo già accennato, essa
potesse veralnente contenefli per l'esiguità delle loro dimensioni. Ma
anche quando veniva inéicata, I'età era quasi sempre approssimativa:
<< era di tempo di due o tre dì )>, <( era di tempo di parecchi dì >>, << era
di tempo di tre semane o circa »>' <<aveva forse tre mesi »>, << era & tempo
di quattfo mesi o più »>, << di mesi diciotto o circa >> e le cose non anda-
vano meglio neppufe con i più grandi per i quali si continuava a ditet
<< d'anni due o circa >>, << di tte anni passati »>, << d'anni quattro in circa >>,
<< d'anni sei o circa >> e, del resto, neppure i parenti erano sempre molto
ben informati e i bambini avevano I'età che dimostfavano o quella, nel caso
dei più gtandi naturalmente, che gli si era insegnato a dire 17e. << Mostfava
avere, forse, uno mese o più >>, <( mostrava di tempo di parecchi dì >>,
<( secondo noi di casa, ayeya mesi sei o più )>, ma erano le donne quelle
che sapevano giudicame il tempo meglio di chiunque altro, da come
stavano ritti, dalle poche parole che sapevano proferire e da taflte alfte
cose che occhi ormai esperti sapevano subito cogliere: << ed era di tempo
d'uno anno o più, secondo il dire delle nostre donne >>, << disseno, le
donne, che aveva tre dì o circa » e par di vederle [e donne, specie quelle
arfiiane, tutte in cerchio intorno al nuovo venuto, intente a guardare
e a dar sentenze, che sfociavano in un << era, secondo il nostro vedere,
di 6e o quartfo dl >>, zittite, talvolta, da un qualche insindacabile giu-
17e Ad ogni modo I'età non pare fosse un problema pe1 gli uomini del Medio-
"*ro. .h.-àou.'rÀo affidarri soltadto alla memoiia, mancando, naturalmente, i mo-
derii mezzi di censimento e, specialmente per i bambini, cui si dedicava rutto som-
;;; d;-p;;i-ir.it""r,' l'ètà non poè-,a tsstrt che approssimativa' Ma. pitib;."d;. -rfftta, .à" p"iii-iàie riguaido a quelle denunciàie nei catasti del XV
il;6, cfr. E. Coirr , l- catasti agrari cit., pp. 102-106'
GLI ESPOST]
dizio del rettore, che si afiogava, infine, tutto il merito con un « è dimesi trenta o circa, secondo me, perché ha la parcla spedita >>.
Dei bambini per i quali ci si prende Ia briga di precisare l'età (solo
11 30Vo de1 loro totale), più dei due terzi sono olme il mese di vita, didue, tre, quatto, cinque e più mesi e anche di qualche anno, sino ai sei anni,
che è quella massima riscontrata fra i piccoli ricoverati neil'ospedale.
In particolare, abbastanza considerevole è il numero dei bambini abban-
donati dopo i sei mesi, sino ai due anni di età, prirna della fine del-
l'allattamento cioè o proprio a77'inizio dello svezzamento e, in genere,
come le fonti fanno intendere, magari con la ricerca non immediata diuna balia e corne le loro precarie condizioni di salute, talvolta ci testi-moniano, precocemente slattati. Sempre riguardo all'età, ma questa voltain considerazione del sesso dei bambini, notiamo che, mentre ci è dato
trovare non poche bambine abbandonate dopo appena uno, due, tre,quattro, cinque mesi da1la nascita, i maschi cominciano a comparire di piùa partke dal sesto mese, quasi che per quest'ultimi, gli indugi, prima
della drammatica decisione, durassero più a lungo.
1. Età degli esposti al loro ingresso ir't. ospedale secondo il sesso
femmine
13l
ttesx
0 180
L-23-56 -11,12_2418r
anni
1791.)
8B
22
5531
t4221
67
6)
-
3456
totale 244
180 A1 di sotto di un mese sono stati considerati, come riteniamo e abbiamoindicato nel testo, tutti quei ban-rbini per i quali non è espresso nelle fonti alcunsiudizio sul tempo intercorso dalla loro nascita.- tet Si è pràferito il conteggio in mesi anziché in anni, sia perché quasi gene-
ralmente usato ne11e fonti, sia per evidenziare gli abbandoni, che cadevano nelperiodo de1 divezzamento, compreso appunto, ma dipendenva dalla maggiore o mi-i-rore precocità con cui 1o si awiava (e ci riferiamo qui, in particolare ai divezza'menti iniziati prima del tempo), tra i\ 72' e il 24 mese di età.
132 L,OSPEDALE DI S. MARIA DÉLLA SCALA DI S. GIMIGNAN0
Le condizioni di salute dei bambini al loro ingresso in ospedaleerano generalmente buone se si considera che solo poco più de17'8Vo drloro presentò, al momento dell'accettazione, infermità più o meno gravi.
I più piccoli, in particolare, erano i più sani e solo in tre casi leloro condizioni fisiche ebbero, forse, un peso determinante nella con-vinzione di abbandonadi. Si tratta di tre bambine. La prima è Mariana,di tre mesi, <r posta nella pila » il 6 settembre del 1419, alle due dinotte, << inferma e male governa » e con una <( nascenza in su l'anche didietro »>r82; la seconda è Cassandra Marianna, <( messa nella pila » il 1lnovembre dei 1489, << all'alba del dì >>, afritta da un <, enfiato in su lereni »>, per il quale il frate spiega << nacque con esso e sfiatava ché erarotto » ls. Difficile poter dire, alla luce di queste descrizioni, di cosasofirissero le due bambine ma pare che ulcerazioni del genere, fosserofrequenti nei neonati, afretti da sifilide o da erisipela e che tali manife-stazioni comparissero entro pochi giorni dalla nascita le. Conosciuta è in-vece l'anomalia di Piera Paola, <( posta >> a << ora di tetza >>, iI 22 feb-braio del 1509, per la quale si disse <( aveva fesso il labbro di sopradella bocca e l'altro manco >>, che facilmente rafiguriamo nel cosiddetto« labbro leporino >>
r8s.
L'essere << prematuri » era, se mai, io stato più facilmente riscon-trabile nei neonati, poiché tali dovevano essere i bambini definiti « pic-coli e misti >>, che si rifiutavano ostinatamente di poppare e la cui morte,
Ie _« Mariana, ponemo nome alla fanciulla, che fu posta nella pila mercoledì
sera,. a- dì 6 di settembre, a due ore di notte o circa, mostrava di tre mesi o circa,era inlerma e male gor.'erna ed aveva una nascenza in su I'anche di dieuo. Arecòdue pezze line cattive e una fascia e uno straccio dt. pezza lana »> (Balie e bambinisegn. B (l4B-1454), 14, c. 10).
183 <( Cassandra Mar.ianna, ponemo nome a una fanciulla fu messa nella pilavenerdì mattina all'alba del dì, a dì 1J di novembre. Non era battezzara, facemolabattezzare alÌora, non passò tre ore. Ponemo nome Cassandra Marianna, Dio la {ac-cia buona. Recò seco due pezze lane e una lina e una fascia, tutti stracci. Questafanciulla venne con un enfiato e in su 1e reni, perché nacque con esso e tÀatauaché era rotto. Visse cinque dì, morì a dì 18 di nòvembre. Dio la benedica >> (Librodi bambini e balie segn. E (1187-1512), 16, c. 6).
r8a Secondo F. BnuNr, Storia dell'1. e R. spedale di S. Maria degl'lnnocenticit., vol. II, pp. 102, 160, i segni delia sifilide si manifestano nel neonati, come luiin qualità di medico ebbe a osservare tra i trovarelli degli Innoccnti. entro i primi10, 12 giorni dalla nascita e i sintomi r.enerei si presenrano a1le parti genitali eall'ano dei bambini, dove si formano piaghe incancrenite. L'erisipela dei neònati, an-ch'essa, talvolta, conseguenza di in{ezioni veneree, attacca entro il V e il VI giornoda11a nascita, l'ano, l'ombelico e i genitali dei bamb,ini e può suppurare.
18s << Venerdì mattina, a dì 22 di febbraio e a ora di terza, fu posta la dettabambina ne11a pila non battezzata, facemola battezzare e ponemole nome Piera ePaola e aveva fesso il labbro di sopra de11a bocca e 1'aÌtro manco e arccò una pezzalana bianca e una pezza lina dolorosa e una fascia iotra di romagnuolo. Iddio iafaccia buona » (Libro di bambini e balie segn. E (1487 1512), 16, c. 140).
il
GLI ESPOSTI D1
che sopravveniva, in genere, enro pochi giorni dal loro ingresso in ospe-
dale, veniva regolarmente commentata da un << non era il tempo », <( nonvolse mai poppare )>, <( non tirò mai poppa )>. Così ci pare, per esempio,
Caterina Cerbonia, recata \a notte del 10 ottobre del 1438, per la qualesi disse che « era tutta enfiata e livida e mai non volle poppar. ,r t*.
Ma pare che << gonfi e lividi » i bambini, che avevano sofferto nel na-
scere, lo fossero spesso per via della tensione provocata dal cordoneombelicale e che la frequenza dei prematuri, fta i trovatelli, specie ille-gittimi, fosse dovuta alle sofierenze patite dalla madre in gravidanza e,
di riflesso, dal bambino nella vita intrauterina 167. Matteo Romolo, unillegittimo, per l'appunto, mandato << ignudo )> e <( come una bestia >>,
giunse << nero come un monacino )>, pef il freddo, come ci immaginiamo,dato che era la fine del mese di settembre del 1507, ma, forse, anche peri patimenti del parto 1§.
<< Ignudo tutto », << grondante dei segni dellamadre >>, <. col bellico sciolto per più ore )> e « giallo >>, probabilmenteper f itterizia, che fra le tante cause ne annovera anche alcune sempre
dovute alle condizioni non ottimali della gravidanza e del parto, era
giunto nel settembre del 1506, Matteo Giovanni, figlio naturale di Mean-tonio Gamucci l8e. Ancora, neppure a Ginevra Iacopa, la bambina lasciata
1& << Caterina Cerbonia, ponemo nome alla fanciulla, che fu posta nella pilavenerdì notte, a dl 10 d'ottobre, anno suddetto, arecò uno poco di sa1e, Iegato inuna pezzuola lina e alfti stracci. Era tutta enfiata e livida e mai non volle poppare.Morì venerdì sera di notte, seppellimola sabato mattina, a dì 11 detto mese. I)iola benedica >> (Balìe e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 33).
187 Sempre secondo F. Bnullr, Storia dell'l. e R. spedale di S. Maria degl'Inno-centi cit., vol. II, pp. 773-175, il gonfiore e la lividezza di alcuni dei tovatelli,dipendevano, e si trattava di un difetto dovuto al parto laborioso, da1la tensioneprovocata dal cardone ombelicale al momento de11a nascita. Anche i prematuri e igracili erano molto frequenti, come c'informa L. PurtcnrNr, L'esposizione dei fan-ciulli a Milano dal 1860 al 1901, in Un problema di storia sociale cit., p. 208, frai bambini abbandonati, specialmente ra gli illegittimi, << per l'età minore del1a ma-dre nubile, cui cotispondeva una mancanza di maturità nell'organismo per la fun-zione materna, il bisogno di Iavorare per procurarsi da vivere, l'azione degli abor-tivi, la frequenza di malattie croniche e costituzionali (non ultirra la sifilide, assaifrequente nello strato sociale da cui provenivano gli esposti), il parto stesso efiet-tuato spesso senza alcuna assistenza, erano fattori che incidevar-ro sicuramente sulladebole costituzione fisica degli illegittimi, tanto che molti di questi nascevanoprematuri >>.
18§ << Fu mandato come una bestia e posto in su I'uscio di San Mattec ed eranero come un monacino ed è fig1io1o di ser À'latteo di Pietro da Montecatini e dellafigliola di monna Costanza di Giovanni da Calcinaia da Poggibonsi, sì che ancoranon ha altro marito »> (Libro di bambini e balie segn. E (1487-L51.2), 16, c. 130).
18e aq |da11gdi tnattifia, a dl 22 di settembre, rovammo uno bambino nellap7la, aveva sotto un pezzo di camiciaccia fiista, il resto ignudo tutto. Gronda deisegni della madre, stimiamo non {osse battezzato, ponemogli nome Matteo Giovannialle fonti. Matteo innanzi, Iddio e Nostra Donna 1o faccia buono. 11 bellicosciolto per più ore. Mandollo ser Meantonio Gamucci. È giallo »> (Libro di banzbinie balie segn. E (7487-7512), 16, c. 724).
134 L,oSPEDALE DI S. MARIA DELLA SCALA DI S. GIMIGNANO
in una fossa alla potta al Quercecchio, il 23 aprile del 1506, << legaroel bellico >> ed era <( male in ordine >>
1e0.
In queste condizioni, anche se potenzialmente sani, i bambini cor-revano seri rischi di soccombere, specie per via del freddo, come suc-
cesse a Doradeia, di due mesi, inviata la notte de1 9 agosto 1450, che,
awolta solo in una << camiciaccia cattiva da uomo, senza maniche e inuna pezza lina e in una fascia, senza niente in capo >>, << penò parecchi dìa riaversi », tanto <( era morta di freddo >>
1e1.
Frequenti anormalità che possono essere ritenute, per Ia loro gra-
vità, il movente principale dell'esposizione dei bambini, si risconffano,invece, tra quelli abbandonati oltre l'anno di età e, questa volta, sonoi maschi ad essere in maggioranza, forse per Ia medesima ragione, che
li vedeva più a lungo tollerati in famiglia, rispetto a1le femmine che,in analoghe condizioni, riteniamo sarebbero state abbandonate moltotempo prima.
Qualche volta ai difetti propriamenti fisici che, fra l'altro, paionospesso più una conseguenza di ffascuratezza se non proprio di maltrat-tamenti, che non di nascita, si accompagnano dilficoltà di linguaggio,come abbiamo già notato per quei bambini già grandi, di quattro o cin-que anni, che non erano in grado di dire il proprio nome e per i qualisi intuisce I'esistenza di uno stato confusionale, dovuto al trauma psi-
chico che, certamente, l'abbandono doveva aver prodotto in loro. Comenon immaginafe, per esempio, 1o spavento di Antonio, di tre anni, la-sciato vagare in balìa di se stesso per ben due notti nei campi, scalzo e
con una sola gonnelluccia addosso, in pieno febbraio del 1502, dopoessere stato violentemente picchiato, come ebbe a notafe il frate pienodi sdegno: << una gota, si vide, il braccio e la fronte tutte percosse »,
ls << Fu ttovata a71a porta al Quercecchio in una {ossa, nucla. Arecolla quiinvolta i-n una poca di pezzaccia, con una trista e dolorosa fascia e non legaro e1
bellico. È molto male in ordine >> (Libro di barubini e balie segn. E (L487-L51.2),76, c. L22).
lel << Notate, come 1a detta fanciulla ce 1a mandò frate Bartolomeo di Gherar-dino, nostro frate di Poggibonsi, fu posta ine a quello spedale, a lui, e la tenne circadue roesi, poi la mandò a noi di notte tempo, credendo noi nol sapessimo e man-dolla con una camiciaccia cattiva da uomo, senza maniche e in una pezza lina ein una fascia, senza niente in capo, cattive e tutte rotte, per tale segnale che lafanciulla penò parecchi dì a riaversi, eta mezz^ morta di freddo e mandò al collodella detta fanciulla un polizziolo, legato con un liio rosso e diceva così: questafanciulla ha nome Doradeia ed è figliuola di uomo dabbene e stla a mente di Iarlagovernare bene, però è persona che merita questo fatto ed è vostro amico di voi,frate Mariano e domani per agio, vi verò a patlate a bocca, costì a casa vosua.Volsi avere a mente che 1o spedale del1a Scala di Poggibonsi, paghi la balia e ognispesa vi occorresse, perché è ragione che la casa ie sue cose siano sue >> (Balie ebambini segn. B (741.3-1454), 14, c. 5L).
GTI ESPOSTI t35
tanto da aggiungere, a dimostrazione della rabbia a mala pena conte-
nuta: <( al vero non ho potuto secondare Iddio e Nostra Donna >> te2.
La << poca faveTla >> di Mariano, di tre anni e fiiezzo, portato al-
I'ospedale nel !4L7, doveva essere, invece, di ben altra natura e le sue
disgrazie di vecchia data, poiché aveva << un dito della ritta ratarpato,quello ailato al dito mignolo ,> ed era, a detta del frate, che invocò un<< Dio l'aiuti e noi >>, anche « attatto >>1e3, La stessa cosa possiamo direper Andrea, che « mosuava di tempo più di tte anni >> e che già ab-
biamo avuto modo di indicare per l'evidenza dei suoi mali: << cieco e
Tomrnè, « di quattro anni o circa >>, recato da Poggibonsi da Menico diFruosino nel 1449 les; <, scianco >> era N{ichele, di circa ventidue mesi,
legittir:ro figliolo di un << povero uomo >>, lasciato 7a mattina del 22
luglicr del L496te6; << non molto sana »> e con un << braccino appianato
d'inferr:rità >>, era Mariuccia, una bambina di tre anni del primo di dicembre del 1503 e << tutto come lebbroso >>, era Domenico, << d'anni treo circa i>, messo all'uscio dell'ospedale, il 28 agosto del 1505, con una
.. gonnella dolorosa »> addosso e sopra << disteso >> un bavaglino << tristo,cinto con re flli di lana
^zzùrta buia >>'q.
re? << Dice era stato due notti per un campo ed è d'anni re o citca dice hanome Antonio. Arecò seco una gonnellina di romagnuolo, trista e un paio di calzinedolorose, scarpe no, e una gota, si vide, e il braccio e la fronte tutte percosse. A1vero non ho
-potuto secondare Iddio e Nostra Donna >> (Libro di barubini e balie
segn. E (1487-1.512), 16, c. 109).- 193 <( Per la sua persona, il detto fanciullo ha questi segni: uno dito della
ritta raiarpato, quello illato al dito mignolo, è atratto e poco favel1a. Arecò addossodue stracci di gonnelia. Iddio l'aiuti e noi >> (Balie e bambini segn' B (1413'1451),14, c. 9,\.
194 << Mostrava di tempo più di tre anni, cieco e mutolo e atl:atto e pazzo >>
(Balie e barnbini sesn. B (148-1414), 14, c. 20).195 << Tommè, disse aveva nome il fanciullo ci fu recato, disse era di tempo
di quattro anni o circa, arecollo Menico di Fruosino, abitante a Poggibonsi. 11
ianciuilo era infermo, con molti di{etti. Arecollo venerdì, a dì 17 di novembre7499 »> (Balie e bambini segn. B (1473-1454), 14, c. 4B).
t% <r Michele, aveva nòme iI fanciullo, ci {u messo ne11a pila a d\ 22 di lugiio,1a mattina, due ore inoanzi dì. È di mesi ventidue o circa, è scianco e aveva unapolizza a7'co11o, che diceva il detto nome ed è Iìgliuolo di un povero uomo ed è
iegitti:r:o. Ha indosso una camicia e una gonnelluccia bianca, senza maniche; è
t.àlzo,, tI-;bro di barubini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 10).19? « Non sa dire chi sia né il nome, recò seco una gonnellina azzotta e un
cencio di lino bianco e un paio di calzine, una nera e Ltn azzurta, dolorosa e leinon molto sana e iI braccino appianato d'infermità. Iddio la {accia buona, abbia-mole posto nome Mariuccia. Iddiò I'aiuti e Nostra Donna l'accompagni >> (Libro dibanbiti e balie segn. E (1.487-1512), 16, c. ll2); « Mercoledì sera, a ore una dinotte, a dì 28 d'agòsto 1505, ci {u posto all'uscio uno-bambino, d'alni- tre o citcac non aveva poiizia, né segno alcunò e non sapendo il nome 1o chiamiamo Dome-rico. Era turio come lebbròso e arecò una gonnella trista, dolorosa e un bavaglinoJìsteso, tristo, cinto con tte fila di lana azzurra buia. Iddio 1o benedica >> (Libto dicmtbini e balie segn. E (1187'L512),16, c. 120).
l
j
i
I
t36 L-OSPEDALE DI S. MARIA DELLA SCALA DI S. GIMIGNANO
Ma era la consunzione, dovuta a gravi stati di denutrizione, l'<< in-fermità » che più frequentemente portava i bambini, meglio sarebbe direle bambine, dato che sono quasi tutte femmine, all'ospedale, intorno aidieci mesi, due anni di età. Sono questi i casi che ci fanno pensare a
svezzamenti più che frettolosi, avviati per lavorare nei campi più libera-mente (e difatti molti di questi bambini sono recati nei mesi primave-rili ed estivi) o per nuove soprawenure gravidanze e, comunque, a di-spetto delle femmine che pare fossero, di regola, aTlattate per meno temporispetto ai maschi les. Ad ogni modo, leggendo le varie descrizioni fattedal rettore, ci vengono in mente quelle creature cui pian piano le stre-ghe, nella credenza popolare, succhiavano il sangue, fino a farle morire,quei volti pallidi di fanciulli, che si dicevano in preda alle malie, mache, realmente, erano forse lasciati morire lentamente di fame e le cuisoffetenze erano ben preseati nella mente di ognunore. Agostina, del-l'agosto del 1426, che << mostrava di tempo di diciotto mesi >>, << eramolto scaduta d'essere male governata>>2ffi; Bartolomea, del luglio del1433,legittima figliuola di Giuliano Salucci, di dieci mesi, <r era infermae male in ordine di ogni cosa ,, ar; Fina, del marzo del 1488, « di dueanni o circa », << recò I'infermità, che pareva morta di fame t e <( avevaflusso >>
a2; Bartolo Domenico, di << mesi dieci in circa »>, messo nella
. res S_gcon{g_ gli. studi di E. R. CorarraN, L'inlanticide cit., p. 330, condottisui contadini del7'abbazia di Saint-Germain-des-Prés, per il secolo' IX, i maschi, venivano svezzati a due anni e le femmine a un anno sòiamente e anche c. KrlpiscH-Zvxt*., Genitori naturali e genitori di latte nella Firenze del Quattrocento, <<eva,derni storici », 44 (t980), p. tlt, sostiene la medesima cosa.
^ lee A p,roposito della. strega, così come appare ne1la credenza popolare, C.
GrNzrunuc, I benandanti_ cit., pp. 142, l6i, rileva che è alla strega ilrà rl "ttiuri-vano,.in genere, quelle lunghe infermità, che ranto spesso affligglvano i barnbini,e di lei si diceva: <rva suàzando il sangue alle creature ,-rrrJ,- massimamente a;fanciulli )> e ancora: << fanno consumare 1è creature a poco a poco, e a16n le {annomorire >>. sono proprio questi sfinimenti, che ci ricoìdano i^ tanii trovatelli detti<< scaduti >>, << malgovernati », << consunti » e che ci confermano nell'idea che allastrega-^si addebitassero, in realtà, solo gli stenti patiti per la {ame.
2m Agostina_, ponemo nome alla fanciulla, che fu -posta
nella pila mercoledìnotte, a dì 28 d'ag_osto, anno 1426. À{ostrava di tempo di diciotto mesi e più.Era molto scaduta d'essere male governata>> (Bdlie e bàmbini segn. B (141i-r454),14, c. l9).
« Bartolomea, ha nome la fanciulla, che ci recò monna Dovizia, madre diGiuliano Salucci e la detta fanciulla è Églitrola del detto Giuliano ed É legittima.Arecoll,a domenica, a dì 19 di luglio, anno-detto. È inferma e male in ordine'd'ognicosa...È. di tempo di dieci mesi-o
.circa, arecò aicuno srraccio di pezzat (.Balii e
banbini segn. B (l4B-1,451), 14, c. 27).
- .?' -«Fina, ponemo nome a una bambina, che fu recata al nostro spedale,lunedì al'le quattordici ore, a dì 9 di matzo, non sapevamo donde venisse, avevadue anni o circa. Recò f infermità che pareva morta di fame, involta in uno sffac-cio et aveva flusso. Non sapemmo il suo nome, ponemole Fina. Dio la farà sanae buona >> (Libro di bambini e balie segn. E (7187-1512), 16, c. 4).
137
.i
,d
c
GLI ESPOSTI
pila il 27 maggio L496, << era magro, il corpo enfiato »>, tanto che non si
<< afierrò la pelle e l'ossa >> m3; Margherita, del 3 maggio del 1497, << morta
era e consunta »> e Diamante, del medesimo anno e mese, <( era magra )>
ed era « stata maltenuta >> ru; Mariano, del luglio del 1499, di tre anni,
« era magro e secco in modo che non sta ritto >> e, aggiunse il frate, for-se infastidito, <( non fa se non piagnere »> e anche Lucia, << di dieci mesi
o più >>, del 19 novembre del 1508, << eta malata grave e maltenuta ,, m5.
Per questi bambini l'abbandono era un brusco epilogo per affret-tare una morte, che data lentamente, tardava troppo a venire.
La precarietà delle condizioni di vita delle madri prima, l'assolutamalcartza di confoto e cure durante il parto poi, il trauma fisico (i lun-ghi viaggi, il freddo, gii sballottamenti) e psichico (lo choc dei più gran-di) dell'abbandono, insieme ad una alimentazione scarsa e gtossolana,
per i bambini da divezzare, e una crudele ttascur?;tezza, se non propriouna totale spazientita indifletenza per le lunghe sofierenze dei piùgtandi, erano, riassumendo, le cause principali delle « infermità »> riscon-trate nei bambini al momento del loro ricovero in ospedale.
Per finire, conservando il linguaggio delle fonti e riferendoci ad unnumero di casi ritrovati, che se pur molto lontano dalla realtà, è comun-que indicativo, ecco quelle che ci sono parse come le più ricorrenti ra le
imputazioni di malattia, che abbiamo inteso così classificare ed inter-pretafe:
nascita prernatura (<< non era il tempo >, << non tirò mai poppa »,<< piccolo e tristo ») I 1
truami deriuati dalla nascita e dall'abbandono (<< non legarono il be1-
lico r>, << bellico sciolto per più ore )>, <( morta di freddo », « gronda
à3 << Bartolo e Domenico, ponemo nome al fanciullo, fu messo nel1a pi1a, adì 27 di maggio, a ore otto ed era magro, il corpo enfiato e non afferrò Ia pelle eI'ossa. È di mesi dieci o circa. Arecò seco ùfia pezza romagnola, trista e una fascia,buona »> (Libro di bambini e balie segn. E (1487-L5L2), 16, c. 69).
I « Margherita, ponemo nome alla fanciulla, ci {u recata e messa nella pila,a dì 3 di maggio 1,497, mo.rta era e consunta, intessi ch'era di Volterra >> (Libro d.ibarnbini e balie segn. E (1487-1512), 76, c. 79; << Diamante, aveva nome la fan-ciulla, ci {u recata e messa nella pila, a dì 18 di maggio 1497; eru magra, è statamaltenuta, intessi che l'era di quello di Pisar> (Libro d.i bambini e balie segn. E(1487-1512), 16, c. 78).
as << Mariano, ponemo nome al fanciullo, ci fu recato e messo nel1a pila, a dì9 di luglio t499, a ore sei di notte. È d'anni re o circa e non sappiamo comeavesse nome, ponemogli nome Mariano. Aveva indosso una gonnella e un paio discarpine con una calza e l'altra no ed era magro e secco in modo che non sta rittoe non fa se non piagnete»> (Libro di barnbini e balie segn. E (1487-151.2), 1.6, c.92);« A dì 19 di novembre, in domenica, a ore due di notte, fu messa nella pila lasopraddetta bambina, con una polizza a\ collo, che diceva: Lucia. Arecò una fasciatrista, una pezza Tara dolorosa e un poco di cenciaccio pet pezza. lina ed era malatagrave e maltenuta >> (Libro di banbini e balie segn. E (1487-L512), 16, c. L35).
a
ri
t
a
ta
'À.
;
I
138 L,OSPEDAIE DI S. MARIA DETLA SCALA DI S. GIMIGNANO
dei segni della madre »>, << mandato come una bestia »>, << enfiata e li-vida »>, << nero come un monacino », ., grallo >>, <( una gota, il braccio ela fronte tutte percosse)>) L52lrstati di malnutuizione («scaduti»>, <<malgovernati>>, <<magro, il cotpoenfiato>>, <<malata gfave e maltenuta)>, /.(magro e secco in modo chenon sta ritto »>, << inferma e male in ordine », <i morta di fame >>,
<< motta e consunta >>, << aveva flusso ») 8201
dileUi fisici (<< con molti difetti >>, << scianco », <( atatto », << poca {a-ve1la >>, << non molto sana, il braccino appianato d'infermità >>, << cieco emutolo e atratto epazzo>>, <<aveva fesso i1 labbro di sopra della bocca e
l'altro manco )>, << con una nascenza in su l'anche di dietro ,>, << con unenfiato in su le reni >>)
altre nalattie (<< come lebbroso »)B
1
26 Naturalmente, 1, è un riumero puramente simbolico, dato che si riferisceai casi più eclatanti, poiché più o meno :.ravmatizzati daIl'abbandono, sarebbero daconsiderarsi tutti i bambini ricoverati nell'ospedale.
a7 La stessa cosa può dirsi per i bambini <<scaduti» e <(malgovernati»>, an-che per loro, infatti, si tratta di un numero esclusivamente indicativo e limitatoa quei casi, sui quali le fonti pongotro particolarmente l'accento.
Ceprroro V
IL BATIATICO DEGLI ESPOSTI:LE BALIE E I SALARI LORO CORRISPOSTI
L:ospedale della Scala di San Qimignano, secondo L'asatza propriaagli antichi ospedali per ffovatelli, non disponeva di un servizio di balieinterne e i bambini venivano dati a balia fuori.
La ricerca delle balie, farÉrmente afrdata ai « messi » e ai << bandi,tori » comunali, che nei giomi di fiera e di mercato, davano voce a « chiyol€sse dei fanciulli a balra », pare awenisse più che altto attraverso
comuni conoscenze e si concludeva, in genere, entro pochi giorni se nonin quello stesso dell'arrivo del bambino 1. Guerre ed epidemie, ad ognimodo, potevano avere tagione su questa facile reperibilità di nuffici e;
in tal caso, il sostentaments dei bambini era assicurato dal latte di ca-
pra, colne awenne per Doradeia, che recata nell'agosto del 1450, anno& peste,.fu tenuta <<in casa parecchi dì a1le capre)>, perché non si riu-sciva ( a rovare balia per venmo modo » 2. Dificoltà di ordine diverso,
1 Nel 1413 rrel Memoriale ili spese mixute segn. A (L4L3-L4l5), 42, c. 8, leg-giamo: « A Masillo, banditore del comune di San Gimignano, per due volte chebandì chi volesse de' nostri fanciulli a balia, soldi sei »; nel 1414, proprio i1 giornodella Pentecoste, si dettero « Ad Antonio di Lanca, b-anditore déf comune & SanGioigaano, a'di Zt dr maggio, soldi due, perché bandì uno nostro fanciullo, ch'ilvrolessì a ba\ia»> (Metnoriale di spese neinute segn. A (L4L3-L4L5),42, c. 17); nel1415, mercoJedì primo maggio, troviamo ancora bandita la « balitura >> di un bam-biao propri,o il giorno del mercato a Poggibonsi nel Mentoriale di spese ruinuteseg?r. G è H (L4L5-t420), 4), c. 2. Al bando probabilmente si ricorreva quandoCera una. certa scarsità di balie; i1 7 l,glio del L422, ad esempio, fu fatta bandireIa « balituta » di Giuliana, giunta proprio quel giorno, ma ciò noRostante, la baliafu tovata solo sei giorni dopo in monna Caterina, donna d'Andtea di Giacomo,cùiamato Ragio per soprannome e abitante a Monteacuto (Memori,ale di spese Tuinutexen. K (1422-1425), 45, c.7 e Balie e bambini segn. B (L4L3-1454), 14, c. 14).- 2 « Monna Agostina di Meio di Paolo della Capaccina da San Gimignano,venerdì a seta, a & L4 d'agosto, aono detto di soprà, ne portò a ballia Doradeia;
- ensiulla ci fu posta nella pila domenica a rorte, alle due ore innanzi dì e si fu cheper iosino a dì d'agosto, là tenemmo in casa parecchi dì alle capre; non potevammoaovr balia per vèruno modo » (Balie e barnbini segn. B (1'4L3-1454), 14, c. 5t).Sappiamo,.invece, che nell'ospedale degli Innocenti di Firenze, ai bambini, in man-
140 L,0SPEDALE DI s. MARIA DELLA SCALA DI S. GIMIGNANO
potevano poi saltar fuori quando si trattava di collocare bambini giuntiin precarie condizioni di salute, che, regolarmente, venivano rifiutatidalle balie, per le troppe cure di cui avrebbero avuto bisogno e, credi-bilmente, anche per il timore di perdere, con la precoce morte del bam-
bino, altre vantaggiose richieste. Il 19 novembre del 1509, per Lucia,
di dieci mesi, che morì nell'ospedale solo cinque giorni dopo il suo
arrivo, tanto erano gravi le sue condizioni, << non si trovava balia Ia
volesse >> e altri, anch'essi gravemente ammalati, attesero a lungo, primadi trovare una sistemazione 3.
Esclusi dal baliatico erano, di norma, i bambini già svezzatir « nons'è data a balia, perché è spoppata >>, si disse, per esempio, di Maddalena,una bambina di diciassette mesi, messa nella pila 1'11 febbraio del 1497
e la stessa cosa intendiamo fosse per tutti quei bambini, più o meno diquesta età, che furono trattenuti in casa e affidati alle cure delle donnedella famiglia ospedalieraa. Ma non esisteva una regola fissa e noo era
raro il caso di veder cercare delle balie anche per bambini già svezzati
o in età di esserlo e l'ospedale pareva preferire di gran lunga, anche peri più grandicelli, la soluzione del baliatico esterno a quello dentro casa,
specie se i bambini avevano difetti tali da renderli incapaci di una lorocompleta autonomia. È il caso di Mariano, di tre anni e mezzo, recato
nel l4l7 e che definito <( atratto ,> dal rettore, fu affidato a monna Cate-
rina donna di Cristofano di Matteo da Cellole, per 30 soldi il mese e diAndrea, di più di tre anni, che per i suoi tanti malanni, fu consegnatoa monna Piera di Mignano del Gesso nel 1426, che per il compenso men-
sile di 25 soldi e uno staio di grano alla misura sangimignanese, avrebbe
dovuto tenerlo, a detta del frate << a nosffo piacimento e arrche suo rr,
cioè più che poteva 5,
canza di baiie (ma ci riferiamo al XVI secolo), r,eniva somministrato il latte dimucca, si veda E. Corunnt, L'ospedale di Santa Maria degli Innocenti di Firenze,«Ospedali d'Italia - chirurgia» (1960), 6, p. $6.
3 « Ed era malata grave e maltenuta in modo non si trovava balia la volesse,era di mesi dieci o più, secondo me>> (Libro di bambini e balie segn. E (1487-151,2),t6, c. 735).
a « Maddalena, ha nome 1a fanciulla, ci fu recata e messa nella pila, a dì l1di febbraio. È di mesi diciassette o circa, ha indosso una camicia, una gonneiia cliromagnolo, un paio di scarpette triste, un paio di calze triste. Non s'è dara a baliaperché è spoppata >> (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512,\, 16, c. 84).
5 << Monna Caterina, donna di Cristofano che sta a Ccllole, portò a balia t\Ia-riano, fanciullo sopraddetto, mercoledì a dì 16 di febbraio, e <leve avere ii mesesoldi trenta » (Balie e bambini segn. B (l4D-L454), 14, c.9); <,Monna Piera, donnadi Mignano del Gesso, portò a balia Andrea detto, domenica a dì 2 di marzo,anno L426 e deve avere il mese soldi 25 e staia uno di grano, allo staio di SanGimignano. Dèllo tenere a nostro piacimento e anche suo>> (Balie e bambini segn.B (1413-1454), 74, c. 20). Il grano dato alla balia fu valutato a 12 soldi 1o staio
IL BALIATICO DEGLI ESPOSTT: LE BALIE E I §ALABI... 141
a da 4 a 10 balie
O ou tr a 3o balie
I aa rso a t5o balie
Fie. 2
742 L,OSPEDALE DI S. MARIA DELLA SCALA DI S. GIMIGNANO
Fer questi motivi, più de11'807o dei bambini accolti dall'ospedale,usu{ruì di un baliatico e gran parte di coloro che non ne ebbero la pos-
sibilità, è rappresentata da un nutrito numero di fanciulli molto pic-coli, che morirono prima che la balia fosse stata tto\tata) nei terminedi pochi giorni dal ioro ricovero.
Le balie, provenienti dalla stessa San Gimignano) ma più frequen-temente dalle vicine pievi e, via via, a raggio sempre più largo, c{a tuttele altre località della Valdelsa ma, specialmente, da Castelfiotentino,Certaldo, Montaione, Gambassi, Poggibonsi, Col1e, Barberino, Casole,
Volterra e anche Siena, erano nel1a stragrande maggioranza appartenentia1 ceto contadino e, in particolare, mogli di mezzadti e, talvolta, del1o
stesso ospedale. Così intendiaino da quei <( monna Margherita, donnad'Antonio di Francesco, che sta a Torre, in sul podere di Giovanni delMezzetta )>, <( monna Lucia, donna di Meio di Lucchese, oggi lavoratoredi ser Ambrogio di Francesco di Brogio da San Gimignano a Yilla Ca-
stello >>, << monna Antonia, donna di Checco di Gallo, oggi abita al po-
dere di ser Agnolo dei Becci da San Gimignano, luogo detto al Piano >>,
<< monna Caterina, donna di Fruosino d'Antonio, nostro lavoratore a
Montemorli >>, che precedevano un sempre uguale <( portò a balia il dettofanciullo >>, seguito dalla data e dali'indicazione del salario mensile pat-tuito << per la poppa )> o, secondo i casi, per 1o << spoppato ».
Erano ie stesse balie, infatti, che si recavano all'ospedale a pren-dere i bambini da allattarc o da divezzare e spesso erano accompagnaredal marito, come fu per Piero Bernardino nel 145L, che fu preso da<< Meio d'Antonio, abitante nel popolo della pieve a San Gersolè, cor-te di Certaldo e monna Giacoma, sua donna >>
6. Ma anche ii maritosolo, il « balio >>, poteva presentarsi a ritirare il fanciullo; nel 1452, nelmese di giugno, << Giovanni di Fede da Gambassi, contado di Firenze, neportò a balia » Giovanpiero, che << per 1o passato » era stato tenuto da
un altro « balio >>, Piero di Nanni di Buonanni e, sempre in queil'annoe in quello stesso mese) 11 2l , <<Giovanni di Michele da Santa Lucia,
<< piccolo » (quello sangimignanese era infatti di litri I5,2 conrro i 24,36 di quellofiorentino, cfr. E. Frurrrt, Storia economica cit., p. 1,28), raggiungendc cosi i 37soidi al mese, 7 in più, rispetto a quelli comunemente pagati aIle balie in questianni per 1o « spoppato ».
6 « Meio d'Antonio, abitante nel popolo de11a pieve a San Gersolè, corte diCertaldo e monna Giacoma, sua donna, ne portò a balia eI detto Piero Bernardino,nostro fanciullo, come soitto qui sopra, lunedì, a dì 31 di maggio, anno detto,7451 >> (Balie e bambini segn. B (1413 1454), 1.4, c.55\.
.F
IL BALIATICO DEGLI ESPOSTI: LE BALIE E I SALAR1... t1)
comune di Catignano, contado di Fiorenza, ne portò a balia >>, Elisabetta
Alessandra, << per darle la poppa e governarla bene d'ogni suo bisogno >> ?.
Alla consegna, veniva dato ai bali anche i1 corredo, quasi com-
pletamente fornito daIl'ospedale, dato che, raramente, poter/ano es-
sere vtllizzate quelle poche cose cl:re i bambini avevano con sé al
momento deli'abbandono. 11 numero e la qualità dei panni non varia-
vano sensibilmente da un bambino all'altro e, in genere, consistevanoin una decina di << pezze line », in tre o quattro << pezze lane >>, in tre o
qllattro fasce, cui potevano aggiungersi, secondo l'età dei barnbini, << cu-
scini >>, <, gonnelle », << cuffiette »>, <( scarpette )>, « bavagli >>, << mantel-
Iini >>, << felftelli >> e << camicine >>.
I1 corredo, in parte nuovo e in patte useto, \/eniva reintegrato viavia che si consumava e man mano che il barnbino cresceva e, se si cam-
biavano più balie, i panni passavano a quella successiva, ma poteva anche
capitare che tutto si riducesse a rendere un mucchio di smacci e si dice-
va, a'rlora, che i1 bambino era stato reso col « pannimento tutto rotto ».
Nel 1ri49, per Francesca, resa morta all'ospedale da « Maffio, suo ba-
lio >>, sappiamo che l'uomo « rendé tutte le sue pezze e fasce »>, mentfemonna Ginevra, donna di Biagro di Paolo da Bagnano, corte di Cer-
taldo, balia di Bartolomea, nel 145A, e poi di Giovanna Domenica, nel1451, non ebbe nessun panno per la seconda bambina, perché << si era
ritenuti tutti i pannicelli del1'a1tra fanciulla, che morì >> 8. Solo nel L489,
due bambini di circa cinque mesi di età, Bastiano e Benedetto Mariano,ebbero oltre alle pezze e alle fasce anche una << zafia con guanciale >>
e.
Le balie stesse, qualche volta, acquistavano, puntualmente rimborsate,scarpe o cucivano vestiti ai bambini col panno avuto dall'ospedale, come
7 << Giovanni di Fede da Gambassi, contado di Fiorenza, ne portò a balia ildetto nostro fanciullo, come di sopra, sabato a dì 9 di giugno, 1152, 1l quale per 1o
:assato si l'ha tenuto a balia Piero di Nanni di Buonanni, come appare in questoi cata 56, in qr.rello medesimo modo a lire ue a1 mese >> (Balie e bambini seg:r. B1113-t154), 14, c. 57); « Giovanni di Michele da Santa Lucia, ccmune di Cati
:nano, contado di F.iorenza, ne port., a balir Ia detta nostra [anciul]1. come scritta:i sopra, si fu mezzo di una sera a ora di vespro, a dì 21 di giugno, anno L452 e
i:ve avere a1 mese lire ffe, per darle ia poppa e governarla bene d'ogni suo biso-
-o,> (Balie e bambini segn. B (7473'1451), 14, c. 58).- 8 <( l'Jota come la dètta Francesca, nostra fanciuila, lunedì mattina, a dì 2
-:.- rratzo 1449,llafro suo balio, come scritto di sopra, ce la recò morta, Iddio la,-,=aedica e ci rendé tutte le sue pezze e fasce >> (Balie e bambini seen. B (\413''-151), L4, c. 49); « Notate come essa ba1ia, si sia ritenuti tutti i pannicelli deI1'a1ua::rciulla che morì >> (Balie e bambini segn. B (14L3 L454), 14, c. 55).
e Monna Agnola di Guaspi di Nanni di San Gimignano, terza balia di Bene-::rto À ariano, ebbe 9 pezze line, ) pezze lane, 3 fasce, una zana con guanciale e un-:rte11ino; monna Bartolomea di Giovanni da Remignolle, anche 1ei, ebbe 10 pezze
-,:e. 2 fasce, 2 pezze lane, 1 mantellino e una z^n^ con guanciale, si veda il Libro:: b:trubini e balie segn. E (L487'L512), 16, cc. 50, 5L'
l
il!
iII
144 LbSPEDALE DI S. MARIA DELLA SCALA DI S, GIMIGNAN0
{ece nel 1452, Ia moglie di Giovanni di Fede da Gambassi, seconda baliadi Giovanpiero, che, ricevuto del << panno San Matteo », per una <( gon-nelluccia che non era ancora cucita >>, vi prowedette personalmente 10.
La cantattazione del salario, a giudicare da alcune annotazioni delrettore, scritte accanto alla cika da corrispondere, doveva dar luogo avivaci discussioni, che vi vedevano impegnato in prima persona il « ba-lio >> e più pacatamente Ia balia, alla quale si finiva anche col togliere,seppure, ne siamo certi, solo verbalmente, e per un gioco di parole, ancheil merito dell'allattamento del bambino, dato che, come {u detto perMichele di Lorenzo, chiamato Calandriello, lavoratore dell'ospedale aMontemorli, «balio» di Maria Agostina, nel 1449, era a lui che si dove-vano corispondere << al mese lire tre per darle la poppa e governarlabene »> e anche Giovanni di Luparello, tèrzo << balio » della medesimabambina, nel 1450, ebbe « per 1o suo salado e {.atica d,allevare » liretre al mese 1r. La « fatica »> del « balio >> era insomma, principalmente,quella di « fargli darc la poppa >>, era lui cioè che s'impegnava a c.he tuttoprocedesse secondo le regole e che doveva {ar fronte per il bambino a<( tutto il suo bisogno ».
<< E così rimanemmo d'accordo con la sopraddetta balia e balio »,si scriveva poi in {ondo dopo che tutto era andato per il meglio. Nel1448, con Piero di Meio da Santa Margherita, << in luogo detto Sciano,nella corte di Certaldo >>, anzi <( con esso e la sua donna >>, si scrisse chesi era << rimasti d'accotdo che dovesse averc soldi ffenta il mese per lasli,a f.atica D e, d testimonianza di ciò, alludendo a Fiore, Ia bambina inquestione, il rettore, come liberatosi finalmente da un peso, scrisse bre-vemente solo un <( se ne portò con seco ,> 12.
Qualche volta per troncafe
r0 <( A dì 24 di novembte, _!457.,, ne portò una gonnelluccia nuova di pannosan Matteo, ,no', era ancora. cucita, disse Ià cucirebbe- la balia proprio e pottoneuna camiciuola bqona y (BaJie e barnbini segn. B (1413-t4j4), L4, ;. j7).
11 ,« Maria 4gostina, ha nome Ia fanéiulla, ne portò a"balia Michele di Lo
renzo, _chiamato calandriello,_ nostro lavotatore a Montemodi, a dì 19 di novembre,anno detto {i sopra, e la detta fanciulla l'ha tenuta a balia per 1o passato Pierodi Luca da San Quirico, come appare indiemo in questo a {ogiio 47 è deve avereit, f:rS.ItS tre, per darle !. ponpa 9. e_overnarla bene» (Baliè e barnbìni segn. B(L4L1-L454),. 14, c. 49_'t; << Giovanni _di Lup_ar"llo e_ Ia sua donna, da Monreacuto,lavoratore di_ser Agnolo di ser Bartolomeo da San Gimignano, a di primo di luslio,anno-detto di sopl_a,_ qe por$ a balta_ Maria Agostina, àostra fanciulla, per lo -pas-
sato l'ha tenuta Michele di Lorenzo di Calandriello, come appare iscriito in questoindietro g foglio 49 e deve avere per 1o suo salario e fatiia- d'allevare, Iire t-re almese »_ (Balie e barubini segn. B (1413-1.454), 14, c. 50).
12 << Piero di Meio da Santa Margherita, in'Iuogo detto Sciano, nella corte diCerqaldo, esso e la sua donna, a d\ 29 d'agosto, 1449, ne portò a balia Fiote, nostra{anciulla di casa per ispoppata, pet ptezzo, è rimasto-d'accordo di avere soldi trentael m9sg, per Ia sua fatica; se ne portò con seco >> (Balie e bambini segn. B (t413-1454), t4, c. 47).
I
lì
I1
I
i
l
.
I
l
IT BAUATICO DEGLI ESPOSTI: LE BALIE E I SALARI...
ulteriori divagazioni sul prezzo del baliatico, si stabiliva una determinataricompensa suscettibile, però, di variaziori future a favote della balia,come fu per monna Giacoma, donna di Mariotto, abitante « di là dal-l'Elsa, presso aile mulina del comune di San Gimignano », che il 19 lu-glio del 1434, probabilmente non contenta dei 50 soldi al mese, che leerano stati ofierti per allattare Giovanni Andrea, fu accomiatata con un<< è vero ch'io le accennai di dade qualcosa di più »>
13. Il rettore, ad ognimodo, era sempre restio a promettere aumenti e si limitava a non esclu-dere tale possibilità, rimettendo tutto ad un secondo momento in cui,cnnsiderato il servizio reso dalla balia, forse si sarebbe potuto prenderein considerazione tale eventualità da un ipotetico e probabile suo suc-cessore. Tuttavia, se nel 1440, monna Giacoma, donna di Giuliano diGazerone, che portò a balia Agata per 50 soldi il mese, si accontentò diun <( e quello più che parrà al f.rate che ci sarà >>
14, non fu così,nel t445, per monna Nanna, donna di Giacomo di Macallo, baliadi Apollonia, alla quale, il solito <, quello più che parrà al frate che pe'tempi ci fosse ,r, non parve una sufficiente garanzia e, ma pare fosse ilbalio ad insistere, << perché non era contento per 1o detto pregio >>, ot-tenne subito 6 soldi in più al mese, da aggiungere ai 50 già pattuiti ls.
Solo particolari condizioni della balia, poi, potevano indurre il rettore adun trattamento di favore anche se di breve durata, come si fece permonna Bartolomea, di Giovanni di Gimignano da Remignoile, che baliadi Bastiano nel 1490, otrenne 3 the al mese anziché le solite 2 lire emezzo, corrisposte, allora, per allattare, ma solo per quel primo mese,che era per lei << ffistacello » e perché, disse il rettore, << fatica a
campare »> 16.
Per le mogli di fte mezzadri, però, 7a paga non fu contrattata, comeal solito, tra il marito e il rertore ma fu lasciata decidere al padrone del
13 <. Monna Giacoma, donna di Mariotto, che sta di 1à dalt'Elsa, presso allemulina del comune di San ,Gimignano, portò a balia Giovanni Andréa, fanciullo,lunedì sela_,. a dì 19 di luglio, anno detto di sopra e deve aveLe il mese per lapoppar. soldi cinquanta e co_sì le promissi. È vero ch'io le accennai di darle- qual-cosa di più>> (Balie e bambini segn. B (1413-1454),74, c,29).
i4 <, Monna Giacoma, donna di Giuliano di Gazerone, portò a balia la dettafanciulla, domenica a dì 9 di febbraio, anno derto e deve avere i1 mese per la poppasoldi cinquanta e quello più che parrà al frate che ci sarà » (Balie e iatnbini- sà[n.B (t413-1454), 14, c. 33).
Gimignano, portò a balia Niccolò detto, martedì a dì 8 di fèbbraio, anno detto edeve avere il mese per la poppa soldi cinquanta e quello che più panà. al frate chepe' tempi ci fosse. Perché non era contento per 1o detto pregio, dàgli più soldi seiel mese, sono lire due e soldi sedici » (Balie e Barubini segn. B (t+iJ.1,4'Sq), U,c. .{0).
16 Libro di bambini e balie segn. E (1,487-1512), 16, c. 50).
r45
i1
L46 L,OSPEDALE DI S. MARIA DELLA SCA.LA DI S. GIMIGNANO
fondo, o quantomeno si attese un suo cenno di assenso e in tutti e tre,i casi di nostra conoscenza, si trattò di balie, mogli di mezzadri de77a
famiglia Ghesi, ricchi lanaioli sangimignanesi 17. Nel 1445, per monnaAgnola, << donna di Nanni, lavoratore di ser Giovanni di Michele diGhese, al podere del poggio di Pieuafitta »>, si disse che avrebbe dovutoavere <( per Ia poppa »>, da dare a Benedetta Bernarda, << quello che diràser Giovanni detto, oggi suo oste )> e ser Giovanni, volle che le fosserodati 55 soldi il mese, cinque in più cioè, rispetto ai 50 pagati alle ,balieper allattare in questi anni 18. Nel 1448, anche per monna Ginevra,prima balia di ulivetta, << donna di Lorenzo di Naccio, chiamato Rama*oper soprannome »>, abitante a Signano, nel contado di San Gimignanoe << lavotatore d'Agnolo di Michele di Ghese >>, si disse che le si sarebbecorrisposto << quello che dirà Michele del Massaio, che sta a Pieftafrtta >>
e Ia stessa cosa fu detta per monna Nanna, << donna di Giusto di Mar-tino da Linafi >>, seconda balia della medesima Ulivetta, mogiie àn-che 1ei di un mezzadro detla famiglia Ghesi e i1 salario che fudeciso, dovette essere all'incirca sui 55 soldi al mese se in poco più didue mesi (due mesi e sette giorni) di baliatico (monna Ginevra, la primabalia aveva tenuto la bambina solo pochi giorni e non era stata pagata),ricevette 5 lire e L5 soldi, ivi comprese le spese per Ia sepoltura diUlivetta 1e.
Nel lungo arco di tempo da noi considerato, i salari co*ispostialle balie, e ci riferiamo a quelli pagati per l'allattamento, furono, salvopochissime eccezioni che vedremo, contenuti ta i 50 e i 60 soldi men-sili. Un primo periodo di atti salari, 60 soldi, si regis*ò sino ù l41Z;scesa poi sui 50 soldi sino al 1.445,1a paga risalì ancora a 60 nei diecianni successivi, per oscillare tra i 55 e i 60 sino al 1465. Niente pos-
17 Per Ia famiglia Ghesi, cfr. E,. Frunrr, Storia economica cit., pp. 2r7-2jg._ 18 <, Monna Agnola, donna di Nanni, lavoratore <ii ser Giovanni'
'di Michele
d].§he9e al..podere del poggio di Pietraf,tta, portò a balia Benedetta Betnaxla, fan"ciulla, lunedì rlattina, a dl ^L4 di giugno, anno detto e deve avere il rnese per 1apoppa quello che, dirà ser Giovanni detto, oggi suo oste. Ebbe soldi cinquaitacin-que il^mese_ per la_poppa >> (Balie e bantbini ign. B (14L3-1454), 1,4, c. 3:B).le
<< Monna Ginevra, donna di T,orenzo di Naccio, chiamato Ràmaro per so-p!?!ngme, oggi abita a Signano, contado di San Gimignano e lavorarore d'AgÀo1o diMichele di Ghese, pòrtolla giovedì a dì 19 di setembre, anno 1448, e deve avereiI mese quello dirà Michele del Massaio, che sta a Piettafrtta»> (Balie e barubinisegn. B (L4L3-1.454), 14, c. 45); << Monna Nanna, donna di Giusto di Martino daLinari, portò a balia Ulivetta fancittTla, a df 2 d'ottobre, anno detto e deve avereil mese, quello dirà Michele del Massaio, che sta a Pietrafitta>> (Balie e banbinisegn. B (L4L3-L454), 1.4, c. 45); << Anne a!'uto, a d\ 22 di dicembre, anno detto,per suo salario e per la sepoltura della detta fanciulla, lire cinque, soldi quindici;a uscita detto frate, detto Iibro, a cafia' 29 >> (Balie e bambini segn. B (1,413-t454),1.4, c. 45).
F
IL BALIATICO DEGLI ESPOSTI: LE BALIE E I SALARI..
siamo dire deI suo andamento per il periodo successivo, mancando i rela-
tivi registri di balie e bambini, sino al L487 , ma da alloru al !512, si
stabilizzò sui 50 soldi al mese.
2. Salari mensili espressi in soldi, conisposti alle baiie dal 1113 al 1512
75
147
s. 40 50
7413-t$27433-1445t446-t4551456-1t487-15t2
L'andamento del salario, molto contenuto, se consideriamo che loscarto fra il salario minimo e quello massimo pagato dall'ospedale allesue balie in questi anni, raramente superò i 10 soldi, e su valori che
potremmo definire senza esitazione bassi, specie se messi in relazione allalenta ma progressiva svalutazione del soldo, la moneta spicciola, in cui,in genere, i salari venivano fissati e pag ti, ci fa intendere come tuttociò dipendesse da due tattori: l'abbondante oflerta di balie nelie cam-
pagne dei dintorni sangimignanesi e il costante e naturale riferirsi del-
l'ospedale a balie contadine, notoriamente poco esigenti in fatto di com-
pensi 20. Del resto sappiamo che anche a Firenze, gli ospedali cittadinipreferivano, per motivi economici Ie balie di campagna, pagate sempre
meno via via che aumentava la loro distafizr- dalla città, secondo quantoprescrivevano gli statuti del comune fiorentino e anche i privati ci ri-sulta seguissero, per gli stessi motivi, ia medesima usanza, unendo così
il vantaggio della minore spesa a quello della maggiore salubrità del-
l'aùa dei campi 21. Ci pare questo il caso di Antonio di Leonardo Rusti-
20 Dai libri amministrativi deIl'ospedale, quali quelli di Entrila e uscita, iGiornali e i Mernorial,i e anche dagli stessi libri di Balie e banzbini, il cal'rbio deliiotino d'oro (quello cui si riferiscono le fonti pare esseÌe più frequentemente quel-1o << nuovo » in lire, soldi e denari di Firenze, ma non mancano quel1i « stretti »
e neppure quelli pisani, senesi, veneziani e genovesi), negli anni che ci interessano,passò dagii 82 soldi del 7413 ai 108 del L455 e ai 114 del L5l2 (per quest'ultimoperiodo à causa della frarnrnentarietà dei dati ricavati dalle fonti, ci siamo ri,eritià M. BsnNoccur, Le nxofiete d.ella Repubblica fiorentina, Firenze, 1976, r,ot. III,pp. 81-88), rosicchiando vistosamente i salari delle nostre balie, che _non si a4egua-ròno, come abbiamo già avuto modo di notare, a proposito della loro rigidiià, a
questa progressiva svalutazione de1 soldo.21 Di questo ce ne dà conferma per l'ospedale fiorentino di San Gallo, G.
PrNro, f/ personale cit., pp. L29-130, che nota appunto la preferenza dell'ospedaleper 1e balie della campagna, sia per motivi economici che per ragioni di salute, datoche anche allora si riteneva che l'abitare in campagna fosse più sano dello stale incittà.
55 56 57 58 60 65
1
34L
t67
1
27
67
322
43i0
l
I
l
I
148
!É
E
ÈÉ
E
rrE
É
ItF
IrtIgIEE!tp
E
$
I!
E
EE
tII
rEItFIrE§ÉÈ
rBÈE
È
FEEE
E
E!E
E
rIà
ÈE
fF5FIE
EÉt&
tfi
È'
trELi:ttiI
i
.
L,OSPEDALE DI S. MARIA DELLA SCALA DI S. GIMIGNANO
chi, mercante fiorentino e padre, fta il L417 e il 1437 di ben quindicifigli, che, dopo aver assicurato ai primi re figli, ottime balie contadine,vicine e facilmente conmollabili, che pretesero dai 110 agli 80 soldi almese, con l'aumentare della famiglia, si diede a cercare, per i nuovivenuti, balie del1a campagna i cui salari di 7 5, 65, 60 ma anche 58 soldial mese, come ebbe Antonia di Giovanni Dacani, del popolo di SantoStefano a Pitiana, balia del suo tredicesimo figlio, nel l4)1, si awici-r,ano a quelli corrisposti dal nostro ospedale alle sue balie nel medesimoperiodo 22.
Solo in poche occasioni, infine, i salari percepiti dalle balie al ser-
vizio dell'ospedale sangimignanese, risentirono sensibilmente degli awe-nimenti che sconvolsero il mercato dei prezzi nel corso del secolo e,precisamente, nel 1411, rcl 14t4 e nel 1419, quando il salario superòi 60 soldi mensili allora corrisposti, per arivarc a 65 e a 70 soldi, forse,per via delle ripercussioni che, certamente, le crisi epidemiche, che
tartassarono la Toscana nei primi trent'anni del Quatrocento, ebberosulla normalmente abbondante ofierta di ba1ie, Ma i salari più alti inassoluto che l'ospedale ebbe a corrispondere, furono quello di 75 soldi,dato a monna Apollonia, donna di Giacomo del Sunera, balia di Melanel L444 e un almo, della medesima entità, pagato nel 1446 a monnaLisa, donna di Pippo d'Andrea da Vico, balia di Fiore, quando già inquesta seconda metà del secolo, si era in preda ad una nuova crisi dicprdemie, che si abbatterono in tempi diversi e a ondate successive daluogo a luogo su tutto il territorio toscano a.
2 L'opportunità de1l'osservazione latta a proposito delle balie al servizio delmercante fiorentino Leonardo Rustichi, è stata resa possibile dallo studio di F.Boncur,sa, Antonio di Leonardo Rustichi cit., pp. 210-222. Per i salari corrispostidai privati alle balie, si veda anche G. CurnurrNr, Signori, contadini, borgbesi cit.,pp. 4L0-412, a proposito di quelli p^g ti tra il 1381 e il 1390 dal notaio senese,ser Cristofano di Gano di Guidino, alle balie dei suoi 1ig1i, anch'esse de1la campa-gna e con un salario tra i 44 e i 60 soldi mensili, corrispondente più o meno,fatte le debite considerazioni f.ra la diversità del cambio del fiorino senese e quello6orentino (ma la di.fferenza ci pate minima e cfr. M. BpnNoccnr, Le monete cit.,pp. 92-98), ai salari pagati da San Ga11o, in un periodo di poco posteriore, ua ilJ395 e il 1406, per l'esattezza, alle balie dei suoi rovatelli, che ricevettero, come ciinforma G. PrNro, ll personale cit., pp. 129-130, salari compresi tra i l0 e i 60soldi. 3 << Monna Apollonia, donna di Giacomo di Menico del Sunera, portò a baliala detta fanciulla, a dì 5 di novembre, anno detto e deve avere i1 mese per lapoppa, lire tre, soldi quindici » (Balie e banzbini segn. B (l4B-1454), 14, c. i7);<< Monna Lisa, donna di Pippo d'Andrea da Vico, oggi abita a Porretta, portò abalia Fiore, fanciulla detta di sopra, a dì 2 d'aprile, anno 1447 e deve avere i1 meseper la poppa lire tre, soldi quindici »> {Balie e banzbini segn. B (1413-1454), 14,41). Per le guerre e le crisi epidemiche, si veda L. Peconr, Storia crt., pp. 279-229e L. Der PrNre,, Cronologia e difusione delle crisi di mortalità cit., pp. 306-)07.
rL BALIATICO DEGLI ESPOSTI: LE BALIE E I SALARI... 149
Solo il 20Vo dei bambini dati a balia concluse l'intero baliatico.allattamento più svezzamento, presso un'unica nutrice, e se varie eranoIe cause, come vedremo, di queste continue restituzioni di bambini al-I'ospedale, il cambiamento di balia che interveniva proprio alla fine del-l'alTattamento) verso i 18-24 mesi di età, pare dovuto, per la regolaritàdel suo ripetersi, esclusivamente all'alternarsi di due diverse categoriedi donne, dedite, una al solo allattamento e I'altra (le balie asciutte)al solo svezzamento dei bambini.
La diversità dei salari percepiti dalle une e dalle alme, quello cor-risposto per l'allattamento era precisamente il doppio di quello dato persyezzare, è facilmente comprensibile se si pensa solo un po' alla diffe-rente offerta sul mercato di balie che allattavano, nei confronti dellecosiddette balie asciutte. Il numero delle prime, poi, veniva ad essere ri-dotto ancor più dalla ricerca, comune a tutti gli ospedali del tempo, diquelle sole madri, cui fosse deceduto il figlio o ne fossero comunqueprive e che anche il nostro ospedale si attenesse a questa regola, ci è
confermato da un'indagiae pottata avanti sul catasto del L427, dove,nelle famiglie di alcune balie, otto in rutto, che ci è stato possibile tro-vare e che allattarono gli esposti dell'ospedale in epoca precedente al-l'anno del catasto, mancano proprio quei figli 1'età dei quali, awebbedovuto coincidere con f intervallo intercorrente ra 7a data dell'iniziodel baliatico e i\ 1427 , I'anno della dichiarazione fiscale 2a. Ma non erasolo questo, della minore ofierta cioè di balie che potevano alTattare itrovatelli, il motivo della notevole difierenza tra le due retribuzioni e,a nosffo parere, vi doveva influire non poco, il considerare le balie de-dite all'allattamento come obbligate ad una pressoché totale inattività,
_ 24 C. A. Consrrvr, Ricercbe di demografia stoica cit., p. 391, ci conferma cheanche l'ospedale fiorentino di Santa N{aria degli Innocenti, si riferiva esclusiva-mente a questo tipo di madri, non ammettendo il contemporaneo allattamento dipiù neonati. L'attenzione alla composizione familiare, al numero dei fig1i e, comevedremo all'età delle balie, è scaturita quale frutto di un'lndagine collàterale, por-tata avanti sul catasto, relativo ai campioni del distetto, dove sono state ritrovatetra i contribuenti di quell'anno, iI 1427, alcune famiglie dei nostri ba1i. Le baliein questione sono: Margherita, donna di Antonio di Francesco, balia nel 1425;Caterina, donna di Cristofano di Matteo da Cellole, balia nel 1414; Nanna, donnadi Cencio di Buono, balia nel 1423; A1nola, donna di Meo di Biagio, balia nel1.425; Giovanna, donna di Michele di Bartolo, balia nel 1424; Biasra, donna diNanni di Bartolo, balia nel 7421; Fina, donna di Piero di Nanni del Castagna, balianel 1423; Cristofana, donna di Piero di Biagiotto, balia nel 1414 (A.S.F., Catasto,266, cc. 64, 173, 183, 443, 465, 520, 606, 6L7). E. CoNrr, I catasti agrari cit., pp.L02-I06, distingue, a proposito dell'età dichiarata dai contribuenti, errori di naturafiscale, quale I'abbassamento dell'età per i maschi ed emori di natura psicologica,quali la preferenza per alcuni numeri anziché per altri e 1a scarsa attenzione all'etàin genere. In questo caso però l'assoluta mancanza di coincidenza, nell'età dei figli,pef tutte le famiglie osservate ci pare abbastanza provante.
150 L,oSPEDALE DI S. N'IARIA DELLA SCALA DI S. GIMIGNANO
per via del loro maggiore impegno accanto al bambino, che ceftamente
veniva a distoglierle da1 normale lavoro nei campi, senza contafe, ma
certo anche questo influiva sulla paga, l'alto valore, nutritivo e tefapeu-
tico, attribuito al latte matefno, tanto da vedervi ricorrere persone di
ogni età 5.
Recenti e sfortunate matefnità, f,niyano così col costituire favore-
voli ccngiunture per i vantaggi economici che se ne potevano trarle e
-Lron è lafo trovxfe donne, che si dedicarono ripetutamente all'allatta-
menio degli esposti in più di r-rna di queste disgraziate circostanze'
Monna Lisa, ad esempio, donna di Donato di Biagio da certaldo, allattò
e svezzò, ne1 1424, Dionora e 1a riffoviarno ne1 L$2 ad ailattare Ago-
stino Ulivo 26; Marghetita, donna di Paolo di Bartolo da Catignano, al'
lattò e svezzò Pollonia, nel t436 e poi Agata, nel L44t 27; anche Gine-
vfa, ma tante altre se ne potrebbero citare, donna di Lorenzo di Naccio
da Signano, allattò Niccolò nel l4ti6 e, due anni dopo, nel 1448,
Ulivetta 28.
Tutte le balie cercavano di a7lattarc, per i vantaggi economici che
gliene dedvavano, il più a lungo possibile, non esitando a prendere, nel
caso di precoci decessi, un bambino die6o l'altro finché ne avevano la
possibilità2'. Nel 1423, Fina, donna di Piero di Nanni de1 Castagna,
2s G. PrNto, ll personale cit., p. 131, attribuisce _il maggior saiario. co_rrispo-
sto per I'a11attaÉnto,' rispetto a que_llo dato _ per ll éivezzamento plincipalmente
al t6to che ci si 6ovava-di fronte a1la << cessione di un bene », ii latte matefno,uttnÀ.",. valutato per le sue « virtù taumaturgiche »: << accade talvolta che {an-
.i"tti Àutrti, già di quattro o cinque anni, _siano n'randati di nuovo a baiia con
l^ $rrun u lhé g.ruriròarro. E addirittura si dà i1 caso, di per.sone adulte che ricor-rond al 1atte maÉrno: ser Niccolò di Nlangone, cappellano del1'ospedale, caduio ma-
irto, pr.nd. una balia e si nutre del suo latte sperando invano dl guarire ».% Balie e bambini segn. B (1473'1454), ll, cc. 17,26.n Balie e banzbini segn. B (7413 1154), cc. 31, 31.
^ Balie e bambini seln. B (l4l)-I154), cc. 40, 45.2e A proposito de1le
-balie che si dedicnvano ali'a1]attamento. degli esposti, è
"str"n a-..ri. irt.r.ssant. ciò che dice C. A. ConsrNr, Ricerche di r.!.emogtafia sto-
rica cit., p. 397, per quelle che allattarono i trovatelli degli Innocenti r-re1 xVII e
XVIII Jeòio: ,irèsta ij problema dei motivi per cui certe donne anziché altre pren-
àerzno bambini a balia,'a seguito del decesso de1 Iìg1io iegittimo. Si tlatta dunque
Ji uru prnti.a conrraccetLiya,-l.gura fr.r l'alLro anche cll'asLinenza da. rapporti ìe>-
suali cui erano chiamale le balie per lton perdere ia ret ribuzioni che rice','evano
p.r -f,"frttr-..rto,
dato che_ si togÉeva aIla talia incinta il bambino consegnatole?
tlpp"r" intervenivano solo fattori "economici di iotegrazione cii reddito -.
dato cl-re
t,*i,àad. pagavu abbuttanza bene - per cui i1 « beliatico )2 era un contributo non
i"aig..."t. a"l bilancio familiare? >r. Pur non escludendo, specialmente per i secoli
cui si riferisce il Corsini, f ipotesi del ricorso all'ailattamento come conttaccezione,
iii."iu"1o che i motivi economici superassero, specie per i magri bilanci contadini,;,ri;li altri. Ma va da sé che p-oi,-ploprio in virtù de11'allattamento,_1e contadine
ne avessero veramenre come benéijcio-lunghi periodi di sterilità, che ad -ogni modo,
..*à ".,, J. L. FraNonrx, La lamiglia cit., pp. 250-251, non erano uguali da donna
II SALIATICO DEGLI ESPOSTI: LE BALIE E I SALARI... L5L
mezzadra del proposto deila pieve & San Gimignano, allattò Maffia per
venti cresi, sino al novembre del 1425. Resa Maffia per 1o << spoppato >>,
il 4 dicembre successivo, prese a balia Giovanni, che tenne al seno per
altri quindici mesi, sino al maggio del 7427 e, solo da questa data, si
decise a dedicarsi, a metà salario, allo svezzamento dei bambino 30. NelL442, anche Meia, donna di Andrea di Lobo, mezzadro sul podere della
Badia a Cerreto, portato a termine l'allattamento di Agnola, proseguì,
prendendoio il giorno stesso della restituzione della bambina, quello diBasilio Frediano, sino al maggio del 1443, per complessivi dodici mesi31.
Nel 1446, ancora per fare un esempio, Checca, donna di Meio di Gra-zia, abitante ad Anchiano, <( presso a Linari >>, completato in sette mesi
l'allattamento di Carlo, iniziò e portò a termine quello di Pasqua, dando
latte sino al gennaio del 1448 32.
Evidentemente l'ospedale, per quanto gli era possibile, si rivolgeva
a balie, che potevano garantirgli un'abbondante Tattazione, legata, come
è noto, all'età e al numero dei parti e, se potessimo generalizzarc i datiricavati dal solito catasto, ne concluderemmo che le balie al suo servi-
zio, avevano un'età media superiore ai trent'anni e con almeno due, trefigli viventi 33.
I-'allattamento era insomma un'importante fonte di guadagno per
1e giovani donne, che vi si dedicavano probabiimente più volentieri che
ad altre attività più faticose e meno remunerative, quali ad esempio
quella di Tavandaia, di stacciatrice di farina, di raccoglitrice di ulive, di<< curatrice >>, filatrice e tessitrice di 1ino, occupazioni queste che tro-viamo sovente menzionate ne1le fonti come svolte da1le contadine, moglidei mez-zadri del1'ospedale e sovente balie esse stesse34 .
a donna e certamente non coincidevano co1 periodo de1l'allattamento, quando que-sto si prolungava, come eta la norma neI1e società preindustiali, per due anni opiù, anzi pare che già al sesto mese la balia potesse rimanere incinta.
30 Balie e bambini segn. B (1.4LJ-L454), 1.1, cc. 16, 18.3t Balie e bambini segn. B (1413-L454), 74, cc. 31-35.32 Balie e bambini segn. B (1413-7454), 74, cc. 41, 43.33 Per la lattazione, legata all'età delle balie e al numeto dei parti, si veda
C. A. ConsrNr, La fécondité cit., mentre per quanto riguarda i dati ricavati da1
catasto, si tratta sempre del catasto del 1427 (A.S.F., Catasto,266) e \e baiie sonoquelle indicate dettagliatamente a1la nora 24 del presente capitolo.
s Frequenti sono le poste a credito di donne che prestano ripetutamente iloio servizi all'ospedale, ecco alcune de1le prestazioni più ricorrenti: << A monnaDomenica di Piero, owero monna Nanna di Piero, infino a dì 20 di marzo, anno1-114, per libbre quattro) once quattro di lino fiIato per soldi tre la libbra, soldirredicii> (.l[eruoria[e di spese nzinute segt'r. G e H (7475-L420),43, c.7; nel 1'475:<< A monna Caterina da' Fosci, lavandaia, a dì 11 di maggio per accia cotta e irrbu-cata e per panni lini imbucatati, in tutto soldi dieci, denari otto >> (Memoriale ditprt, ,ninutè segn. G e H (L415-1420), 43, c. 3); «A monna Nanna di.Bruno, a
dì 24 d'aprile 1479, per uno bucato che fece in casa nostta e riasciacquò, owero
ln,ir
:ià1.
;1.'
r52 L,oSPEDALE DI s. MARIA DELLA SCALA DI s. GIMIGNANo
Ma non sono assenti neppure quei casi in cui si ricorreva all'ab-bandono del proprio figlio per avere la possibilità di alTattarne almi apagamento o per richiederlo, dieto compenso, a ba7ia, dopo che erastato accolto all'ospedale. Nel 1431, monna Bartolomea, rimasta vedovadi Nencio di Mignano del Gesso e abbandonata per povertà l'unica fi-glia, Pieru, si ofirì ella stessa come balia del1a bambina ma, ottenuti soli40 soldi al mese di compenso, il più basso riscontrato tra le nostre ba-lie, forse per scoraggiare iniziative del genere, la rese all'ospedale doposoli quarantatre giorni, dedicandosi, forse, e senz'altro con maggior pro-fitto, all'alTattamento di qualche altro bambino 3s. Nel 1500, anche Da-miano, che aveva avuro come prima balia monna Elisabetta di San Gimignano, si vide alTattare per quasi un mese, per il compenso di 50soldi, dalla madre, certa monna Dionora che, però, anche lei, poco dopo,ne lasciò ultimare l'allattamento a monna Pasqua, donna di Lucchese diGiovanni da Calcinaia da Poggibonsi to.
lavò, pldi rre>> (Mem_oriale di spese minute segn. G e H (1415-1420),44, c.5l);nel 1418: <<A monna Lisa, che sta in San Gimignano, a dì 1à di dicemÉre, per setedì che stette in casa a governare lino, cioè a lcapeichiare, scotolare e corìciare ditutto suo bisogno, -da porre a tocca, ebbe soldi- ventidue >> (Memoriale di speseminute segn. G e H lL4l5-1420t, 44. c. )9\; <, A monna Simona, che ci aiuia afare ìl pane,. a dì 7 di dicembre (1419), per otanta sraia di farina, che ci stacciòper la limosina delia prima domenica de1- detto mese, che fu a dì' 3 detto mese,p$941 p9I moggia re, soldi dodici >> (Memoriale di spese minute segn. G e Li(1415 1420), 44,, c. 71); << A monna Caterina, donna d'Agostino di CatzÉtta da SanGimignano, a di_ 2 d'aprile (1,422), per una tela di sacò e venticinque tonacuzzi,fu braccia 1'12 che ci ressé, per soldi 1 il braccio, monra lire cinque ìoldi dodici »(.Entruta e uscita segn._l e K 0420-1422), 68. c.' 22t: « A monna Lapa donna diT,uciano, curandaia da Poggibonsi . a d\ 7 di dicembre (14D1, per cr.aiuru di brac-cia _lI7 di panno lino, ebbe soldi trentacinque>> (Entrata 'e-uscita
segn. I e K(14|0 1,122),69, c. 16); <<A monna Nicolosa di Cessone, tessitore, a dì"25 di sertembre (1423), per tessitura di braccia 124 di panno 1ino, che ii tessé per soldiuno, -denati due il braccio, ebbe lire sette soldi quartro >>' (Entrata , usiitu segn.I_ e K (1,420-1.422), 69, c. 16). A proposito del lavàro femminile, E. SuuBnor, Zadonna e il laooro, Milano, 1,969, pp. 48-57, parla del Medioevo come dell,eti incui 1e donne hanno lavorato di più e in condizioni se non di uguaglianza con g1iuomini, certamente migliori non solo rispetto a1le precedenti ma aÀchè ale seguen-ti,come contadjne, domestiche, tessitrici, filamici ecc., senza contare che spesso
"le vel
dove erano_in grado di rilevare il mestiere del marito dopo la rra mori..35
<< Monna Bartolomea. donna {u di Nencio di Migìano del Gesso. detto disgpra e madre della detta fanciulla, a dì 8 d'aprile, le- promisi lire due il mese(Balie,e bambini segl. B (7413-1454), 14, c. 27). A questo proposito, E. Suonron,Famiglia cit., -pp. 198-172, nota che nel XVI, XVII -e
anche ÌVIU. secolo, ne11aFrancia preindustriale, << 1e campagnole povere, per esempio, usavano dare a baliai propri figli a chi chiedeva prezzi esrremamentè bassi, così da poter fare esse dabaTia a neonati foranei a prezzt migliori » e cita anche il caso di^rugazze madri chesi.facevano. ingravidare per poter alrattare « e quindi vendersi r. Anche R. Tnrxren,!_be loundlings cit., pp. 264-261, rrova diversi^casi di madri che abbandonu.,o, ,r.iXV se^co1o,,per il_medesimo motivo, i propri figli all'ospedale degli Innocenti.
36 << Monna Dionora, madre del sopràddetto fanciuilo, sta in" San Gimignano »,to_ p,1ese .a baLia dal 4 al 30 agosto 1.500 (Libro di bambini e balie segn. È GqU-1.512), 16, c, 100).
,t
!
t
IL BALIATICO DEGII ESPOSTI: LE BÀLIE E I SALARI...
Tutto ciò dava il via ad una lunga serie di abusi, che vedevano
i bambini trattenuti presso le balie anche quando il latte diventava scat-
so, <( cattivo )> o <( non si confaceva >> seflza contare quel1i rimandati con
tutto comodo all'ospedale quando 7a balia sapeva da tempo di essere
<< gravida )>, << grossa »>, << grande »> condizione questa che avrebbe dovuto
obbligarle, invece, a rinunziare subito al baliatico, secondo le severe di-
sposizioni generalmente seguite dagli ospedali, per via delf impoveri-
mento nutritivo che il latte avrebbe subito con l'awio della nuova gra-
vidanza3T.
Con le balie poteva succedere di tutto, anche f inspiegabile ritornodei bambini nel giro di una notte, perché, all'improvviso, e si' trattava
di balie oneste, ci si accorgeva che non si aveva latte o che non piaceva
in nessun modo al bambino. Agata, per esempio, presa la sera del 17
febbraio t490, da monna Benedetta di Bartolo di Matteo, abitante a
Buonriposo, venne riportata all'ospedale la mattina dopo, « a dì 18 difebbraio >», perché la donna <( non aveva latte >>
s; Benedetto Mariano,preso il 25 luglio 1489, da monna Agnola di Bartolino, lavoratore di set
Tommaso Cortesi a17a Casetta, e sua seconda balia, venne reso il giorno
stesso alla prima balia, monna Elisabetta di Giovanni di Gimignano da
Remignolle, perché << non volse pigliare mai Ia sua poppa >> e, Mariano,
dovette essere un bambino dai gusti difficili, dato che anche monna
Agnola di Guaspi di Nanni da San Gimignano, sua terza balia, lo rese
dopo soli due giorni perché, disse, << non lo poté tenere >> 3e' Vere o no
erano queste le ragioni, che vedevano le balie rinunziare all'allattamento,spesso in tempi brevissimi dalla consegna del bambino e se, invece, nono-
stante tutto, si tirava avanti, mancando all'ospedale ogni possibilità dicontrollo intermedio, per via della residenza delle balie, spesso molto
distante da San Gimignano, non rimaneva al rettore che la riduzione
o il rifiuto del salario, allorché si aveva l'occasione di constatare le con-
dizioni di salute del bambino e cioè solo al momento della sua riconse-
gna, sempre che si riuscisse in qualche modo a farlo soprawivere. NelL414, monna Caterina, donna di Meio d'Andrca da San Lorenzo' balia
37 Cfr. C. A. ConsrNr, Ricercbe di demografia storica cit., p. 397, che neparla per Ie balie degli Innocenti, cui veniva immediatamente tolto il bambino datoloro ad allattate se
-di nuovo incinta. Si credeva, infatti, dice J' L. FlaNonrN, Ialamiglia cit, p. 255, che i rapporti sessuali potessero <( corrompere » il latte dellanutrice, rendeilo meno abbondante e farlo sparire del tutto, qualora questa si tro-vasse ancora una volta incinta.
§ Libro di bambini e balie segn. E (1487-L512), 76, c. 57.3e << Rendé il detto Mariano che non volse pigliare mai la sua poppa » (Lib'ro
di barnbini e balie segn. E (1487-L512), 16, cc. 49, 51-52).
t53
)
154 L,oSPEDALE DI S. I\{ARIA DELLA SCALA DI S. GIMIGNANo
di Alessandro, si vide scalare due mesi e otto dì di paga, perché << nondiede buono latte al detto fanciullo alcuno poco di tempo » {. Sempre
in quello stesso anno, Margherita, donna di Neri di Lapaccio, chiamatoCompare, abitante a San Marttno a Cozzr, ne1la corte di San Donatoin Poggio, contado di Firenze, balia di Filippo, secondo un nuovo accordofatto col marito, ebbe il salario dimezzato da 3 lire a l0 soldi il mese,
perché, si disse, « gli ha dato cattivo latte >> 41.
Se 1o svezzamento non era ablrastanza remunefativo, in genere, co-
me abbiamo visto, per le giovani ma-dri, che raramente vi si dedicavano,lo era, invece, per Ie più anziane e ancor più per le vedove. È alla loroesperienza che ci si rivoigeva quando si avevano esposti da svezzare e so-
vente si ffattava di donne che già avevano avuto dall'ospedale, in gio-
ventrì, bambini da allattare o che erano frequentemente in contatto conla {amiglia ospedaliera per via di tanti altri servigi, che andavano dallalavatuta dei panni, alla stacciatura della farina per le elemosine, ai lavorinell'orto, chiamate a raccogliere le olive, a fat fieno, a vendemmiate ma,principalmente, a <( scapecchiare )>, << rompere )>, <( curare >>, filare e tes-
sele il lino per farire poi tovaglie. lenzuola. pezze e « asciugatoi » perIa casaa2.
È fra queste donne non più giovani, che vediamo continuamentecorrere ai bisogni dell'ospedale, che venivano reclutate le balie per 1o
s << Nota che per ristotamento ché non diede buono latte al detto fanciullo aI-cuno poco di ternpo, lascia due mesi e oito dì>> (Balie e bambini segn. B (7411,-1154), 74, c.5).
41 << Monna Margherita, donna di Neri di Lapaccio, chiamato Comparc, oggi
abita a San Martino a Cozzi, ne1la corte di San Donato in Poggio, contado di Fi-renze, balia di Pippo fanciullo, deve avere a dì 28 di marzo, anno detto, lire di-ciotto per uno anno ha tenuto a balia i1 cletto, a ragione di soldi trenta 11 mesee così dissi a Neri sopraddetto, suo marito. Fugli promesso lire tre il mese, nondiede buono iatte e perciò feci questa concordia con 1ui detto. Rendé il sopraddetto{anciullo giovedì a dì 7 c1i giugno, anno sopraddetto e deve essere pagato a ragionedi soidi trenta il mese, tlltto il tempo che I'ha tenuto, perché g1i ha dato cattivoTatte>> (Balie e bantbini segn. B (1473-1.454), 74, c. 4).
a2 Si tratta, per 1o pir), come abbiamo detto di vedove, eccone anche quialcr,rni eserrpi: nel 1473, troviamo dati <<a n'ronna Nanna, donna fu di Giorgio daSan Gimignano, a dì detto, per stacciaiura di due moggla di farina per 1a limosinadi gennaio, solcii undici >> (Memoriale di spese minute segn. A (111r? 1115), 42, c. 8);nel 1,422: << A monna Caterina, dr:nna che rimase d'Antonio Ci Lecchiata da SanGinrignano, a dì 10 di gennaio, per l)6 braccia di fasce che ci tessé, per denari quat-ro i1 braccio, montano soldi quarantacinque, denari quattro, ebbe soldi quarantaduee l'avanzo disse che lasciava per l'amor di Dio >> (Entrata e uscita segn. I e K(1,420 1422),69, c. I3); nel 1125: <<A monna Papera, donna fu di Sar.ro, tessitore,a di 17 di giugno, per braccia 76 di panno che ci tessé per soldi uno, denari tre ilbraccio, monta lire quatto, soldi quindici >> (Entrata e uscita segn. I e K (1.420-1422),69, c.23); nel 1,443: <<A monna Margher;ita, donna fu di Paolo, che tessétovagliuzzi grossi da uomo, soldi dodici » (Quaderruuccio di spese (14)9-1444),7J7, c. 72).
IL BALIATICO DEGLI ESPOSTI: LE BALIE E I SALARI... t55
svezzaorento dei bambini e, in genere, ogni loro abituale attività conti-
nuava ad essere svolta regolarmente, contempofaneamente allo sYezza'
mento, senza intertuzioni. Una di queste è monna Caterina, donna diCristofano di Matteo da Cellole, mezzadto, come veniamo a sapere dal
catasto del 1.427, delle monache di Santa Maria Maddalena di San Gimignano, che, dopo un'ultima esperienza di allattamento nel 1413, anno incui allattò e svezzò, per complessivi trentuno mesi, Dionora Checca,
ali'età di circa quatant'anni, continuò, ad intervalli, a svezzare i bam-
bini dell'ospedale sino al 1422. In questi anni, Caterina, svolse per
1'ospedale anche il servizio di lavandaia, facendo, in media, un grosso
bucato al mese, cui, di regola, si associava Ia << cottura >> e la << imbuca-
tatura )> de11'<< accia >>, cioè del fi1o greggio del lino, percependo dai 15
ai 18 soldi per volta (ma a volte lavava anche due volte in un mese)
che, aggiunti ai 30 che riceveva per << spoppare >>, le permettevano cer-
tamente di arrotondare i magri bilanci familiari *3. Un caso analogo loritroviamo in Agnese, donna di I'Janni di Pepo Birocci, del popoio diSan Gersolè << in luogo detto a Graticcio >>, abitante dal 1425 alla Badiaa Cerreto, che, dopo avet alTattato Simone Taddeo, svezzò Mafia nel
1425 e Dionora nel L428, per i1 solito compenso di l0 soldi, pari alla
metà precisa de1le 3 lire, corrisposte dall'ospedale per allattare in que-, .M
st1 annl .
Fra le vedove, neI 1418, toviamo Margherita, « donna che fu diGiannino >>, calzolaio sangimignanese, già da tempo filatrice e sarta del-
l'ospedale, che si dedicò in quell'anno, subito dopo la morte del marito,al divezzamento di Antonia e che, nel 1424, risposatasi con un altro cal-
zolaio, un certo Giacomo, troviamo ancora a riscuotere 5 lire e 17 soldi<< per panni cuciti a' nosri fanciugli rr". Dal 1418 al L423, è presente
a3 Nel 1418, troviamo una delle tante poste intestate a monna Caterina di Cri-stofano da Cellole: <r A monna Caterina sopraddetta, a dì 16 di febbraio, per sedicilenzuola imbucatate e per libbre sedici d'accia cotta e altri panni, in tutto soldidiciannove >> (Memoriale di spese mi?xute segn. G e H (7415-1420), c. 7) e proprioquel giorno prese a balia Maiano, uno dei quei cinque bambini che l'ospedale afidòulla donnu in questi anni: << Monna Caterina, donna di Cristofano di Matteo daCellole, portò a balia Mariano, {anciu11o sopradcietto, mercoledì a dì- i6-c1i febbraio-ut no d"ito di sopra e deve avere al mese soldi renta >> (Balie e bambini segn. B(1413-1454). 14, c.9).
M Balie e bambini segn. B (1,41.3-1454), 14, cc. 13, L9,22'4s I1 16 giugno del L415, troviamo: «A monna Margherita di -Giannilo, ca1-
zolaio, per cuciluà del1a gonnella di Antonia e per 1a cioppa <ii A,ndrea, soldi tre-dici>>'(i\emoriale di spese-minute segn. G e H (I4L5-L420), 13, c.2) e aqcora alffeo gonrrèlir... >> etano itate cucite da lei negli anni precedenti 11 sua vedovanza, come
sappiamo dal Menoriale segn. D (1.4L1-L41"4),41' cc.7,25 e dal Menzoriale. Q!.spesg.nniute segn. A (14L3-1415),42, cc.8,17,25. Ne1 1418, come appare nel libro diBalie e bambini segn. B (14D-1454), 14, c.9, prese a balia r\ntonia per 1o svez-
156 I,OSPEDÀLE DI S. MARIA. DE,LLA SCALA DI S. GIMIGNANo
fuale altte, Fiore, << donna che fu di Bartolo, chiamato Batacchio >>,baliaanche lei di Antonia e di Girolama Silvestra che, all'epoca del catasro,ormai molto in 1à con gli anni, quelli dichiarati sono <( sessantasei ocirca »>, sappiamo essere ridotta in grande povertà con a disposizione unasola rendita annua di sei lire, proveniente da una sua casa affittata, men-tre lei sta <( per I'amore di Dio )>, << con una poca di masserizia », in unacasa di ser Roberto di ser Santino in San Gimignano e. Nel 1,438, è lavolta di un'altra vedova, monna Caterina, donna di Michele di Cam-bio, che tenne con sé, sino al 1441, Benedetto, alternandosi, nel frat-tempo, fra le stracciatrici di f.arina chiamate ad aiotarc in occasione dellefrequenti elemosine a7.
Le balie che divezzavano, quindi, potevano agevolmente potareavanti più impegni di lavoro, mentre per una sola de1le balie che al-lattavano sappiamo che si dedicò anche ad alte attività, come ebbe a
fare Cristofana, donna di Bartolo di MattarozzoTo, abitante nella cortedi colle, balia di Iacopo Filippo nel L415, che comparve in quello stessoperiodo fua le filatrici di stoppa dell'ospedale {. Anche fra le balieasciutte, infine, abbiamo il caso di una bambina di un anno, Piera, che,abbandonata nel 1431., insieme alla sorella, Checca, di quatro anni,venne presa a balia, per il divezzamento, dalla nonna, monna Caterina,donna di Geri da Camporbiano, che ricevette al mese, ma eta un annodi guerre e di disagi, 35 soldi, 5 soldi in più cioè della normale pagacorrisposta allora per 1o « spoppato >>
ae.
L'intero baliatico durava in media 24-30 mesi, con un periodo diallattamento non inferiore ai 15-18 mesi, ma non esistevano regole fissee Leonardo Domenico, nel 1.413, per esempio, {o aTlattato per ben 25
z?.mento tna eta- già vedova e l'anno dopo, << monna Margherita, donna che rimasedi Giannino, calzolaio>>, la troviamo a cimprare grano dàll'ospéd,are (Memoriale dispese minute segn.,G e H (1415-1,420),44, c.75).-Ne1 1424, §assata a nuove nozzecon un. ahro calzolaio, che {orse aveva rilevato il lavoro e la llientela di quello de-funto. la troviamo ancora a cucire p_er I'ospedale: o A monna Margherita. oggi donnadi Giacomo, calzoraio e donna che fu di Giannino, detto dì lire cìnque, roiài di.ias-sette per panni cuciti a' nostri fanciulli >> (Entrata e ascita segn. I i X (tCZOlqZ4,69, c. I8).
& Balie e bambini segn. B (1413-1454), t4, cc.9, 14 e A.S.F., Catasto,266,c. 267.
a7 Balie e bambini segn. B (1,4D-1454), 14, c. 32 e Quadernuccio di spese(1.439-7444), 137, c. 10.4 << A monna Cristofana, donna di Bartolo di Mattarozzolo, nosta balia, adì d'agosto, libbre trentasette di stoppa a frlare a mezzo, neita di sàcco >> (Mernorialedi spese tzinute segn. G e H (14I5:L420), 43, c. l4).
4e << Monna Caterina, donna di Geri da Camporbiano, portò a balia Pierasopraddetta, .1 {ì primo di maggio, anno 1432, per soldi uenùcinque iI mese perispoppata >> (Balie e barnbini segn. B (1413-1454), 74, c. 25).
157
i
I
IL BAI,IATICO DEGLI ESPOSTI: LE BALIE E I SALARI...
mesi e la permanenza a balia poteva prolungarsi anche sino ai tre, quat-
tro anni di età e dar luogo, talvolta, ad un nuovo tipo di rapporto trabalia e ospedaleso. Nel 14t3, a monna Battola, vedova di Martino da
Colle, un commesso di casa, cui era stato afidato Pippo, un bambino già
svezzato di più di due anni di età, si decise di corrisponderle solo ottostaia di grano e un barile di vino I'anno << pet 1o detto fanciullo »>, invecedel solito salario, perché << ogni altra f.atica »>, si disse, la donna volevafare <.< pet l'amote di Dio >> ed è probabile che Pippo restasse presso dilei in quanto non si hanno più notizie sulla sua restituzione all'ospe-dalesl. Un lungo baliatico fu assicurato, il 2l agosto del 1438, anche aBenedetto, un bambino & due anni, già syezzato, allorché si confermòla prosecuzione della sua permanenza presso monna Caterina, << donnache {u di Michele di Cambio », per 30 soldi il mese, <( per quello tempopiacerà alla detta balia e al frate che pe' tempi fosse al governo del dettospedale>> e Benedetto sarà reso, infatti, solo nel 1441, a quasi cinqueanni di età 52. Nel 1449, con Lisa, donna d'Agostino di Maso, quartabalia di Carlo, che 1o aveva già tenuto due anni << spoppato » a 30 soldiil rnese, si rimase d'accordo che << non dicesse avere più salario di balireil detto fanciullo, perché era grande da ricogliere >> e Ia balia 1o tennecon sé quasi altri due anni, senza percepire nessun compenso, sino a che
il bambino non ebbe sei anni s3. Soluzioni di questo tipo, che tenevanocioè a lungo il bambino fuori dall'ospedale erano senz'altro le preferite,non solo perché si alleviava la tatica delle donne di casa, addette, comesappiamo, anche alla sorveglianza dei fanciulli, ma, principalmente, per-ché si sperava che sfociassero per i bambini, ed erano i maschi che piùgodevano di queste lunghe permanenze, in una loro definitiva sistema-zione, awiati, dai medesimi bali, ai lavori della campagna.
s Anche agli Innocenti di Firenze, l'allattamento durava 18 mesi e solo nelXVIII secolo lo si ridusse a 15 mesi, cfr. C. A. ConsrNr, La lecondité cit. e ancheJ. L. Fr.aNonrx, La lamiglia cit., p. 250, riferisce che la norma del1a società me-dioevale e preindustriale era che l'allattamento durasse due anni o più.
sl << E deve avere l'anno otto staia di grano e uno barile di vino, per lo dettofanciullo e ogni alua fatica vuole fate per l'amore di Dio (Balie e barnbini segn. B(141,3-t454), 14, c. 6).fl
<< Nota, raffermossi il detto fanciullo per soldi trenta ^1
mese, a dì 21 d'ago-sto, anno 1440, per quello tempo piacerà alla detta balia e al frate che pe' tempifosse aI governo del detto spedale » (Balie e banzbini segn. B (141J-1454), 14,c. 32).
s3 « A dì primo di luglio, 1449, rimanemmo d'accordo insieme, non dicesseavere più salatio di balire il detto fanciullo, perché era grande da ricogliete >> (Baliee banbini segx. B (1413-t454), t4, c. 42).
158 L,oSpEDALE DI s. MARIA DELLA SCALA DI S. GIMIGNANO
I salari, nel cui conteggio non si teneva conto né del << primo dì »né del << postaio ,>, l'ultimo, venivano corrisposti su richiesta de1le balie,
secondo 1a solita usaflza seguita dall'ospedale nei pagamenti ai dipen-
denti e, sebbene il loro importo fosse fissato in lire e soldi, 1e « pattite ,pagate, regisffate volta per volta, avevano per oggetto, quasi sernpre
beni in natuta, come grano, vino, olio, carne di porco, noci, miglio,panico, fichi secchi e alti beni di cui l'ospedale poteva dispome, pro-
traendosi, sovente, a lungo, oltre Ia fine del baliatico.In più di un'occasione i familiari stessi dei bambini a balia, si
fecero avanti di loro volontà per pagare personalmente tutto o in parte
il baliatico del bambino; monna Verdiana, donna di Giacomo di l,{ignano,del popolo di Santa Lucia a Catignano, terza balia di Antonio nel 1436,figlio legittimo di Lazzaro di Giacomo da Mumialla del contado di Fi-renze, ricevette, nel '1437 , << da Lazzato, padre del detto fanciullo, lireqlrattro »>, che, precisò i7 ftate, essendo state date direttamente alla ba-
lia, << no' sono né a entrata né a uscira >r 54. Nel 1449, già sappiamo di
Santi di Cione da Castelfiorentino che, rimasto vedovo, si ofirì come
fante della casa per pagare .< del suo salario la balitura della fanciulla »,
cioè di Maria Agostina e nel 1497, anche il padre di Maria, una barnbinadi circa sei mesi, invano cercò di convincete 7a balia, che caparbiamente,e forse a ragione, << non volse stare a lui >>, della serietà delle sr-re
promesse s5.
Ma accesi diverbi potevano ancora verificarsi alla riconsegna deibambini all'ospedale da parte dei bali. quando i1 frate, resosi finalmenteconto delle efiettive condizioni di salute del bambino, poteva, se nongli parevano, come spesso accadeva, soddisfacenti, rifiutarsi di pagate ilsaldo finale del salario che i bali, invece, pretencievano. Nel 1,415, ad
Antonio, chiamato Cagnano, abitante a Vico Fiorentino, marito di Mar-gherita, balia di Leonarda Checca, venuto a riscuotere gli Lrltimi 15
soldi, << no' se gli volle dare niente per 1o cattivo servigio che ci fece >> s.
Al contrario, se la baTia aveva reso un << buon servigio »>, ma eiano sem-
pre poche in confronto alTe altre, si pror,'vedeva a pagatla qr-ralche soldoin più, come capitò nel 1411, a monna Giacoma, moglie di Giuliano dj
s <. Anne avuto da Lazzaro, padre del detto fanciullo, lire quattro, nc' sononé a entrata né a uscita (Balie e bambini segn. B (1413 1454), 14, c. 32).
5s Balie e bazabini segn. B (1,413-L454), 14, c.47; Libro di bambini e baliesegn. E (1487-1512), 1.6, c.76.
-56 << Resterebbe avere lire dodici, soldi due, avendo fatto buono ser-rigio, no'se gli volle dare niente, per 1o cattivo servigio che ci fece e perciò l'ho cancellata "(Balie e banbini segn. B (14D-L454\, 14, c. B).
IL BAIIATICO DEGLI ESPOSTI: LE BALIE E I SALARI... t59
Gazerone e balia di Agata, che fu pagata^ « per più alcuno dì non la ten-
ne »> e non mancavano neppure quelle che rifiutavano << per l'amore diDio » il rimborso di piccole spese fatte per i bambini durante il balia-
tico, come fece Giovanna, nel 1413, moglie di Giano d'Agnolo, abitante
a Vico Fiorentino, che non volle i 5 soldi spesi in un paio di scarpette
comprate per Veronica o che rifiutavano di essere pagate per qualche
giorno di baliatico in più ed è il caso di un'altra Giovanna, donna diMiclrele di Bartolo, del contado di San Gimignano, che, nel L424,lasciòall'ospedale gli ultimi undici giorni in cui si era presa cura di Tommaso
Alessandro 57. Né i mariti, quando volevano, erano da meno; nel 1437,
« fatto conto )> con Antonio di Rolla, della villa di Petrognano, balio diBiagia Agheta, << iI sopraddetto »>, che l'aveva tenuta << un anno e quat-
tro mesi per la poppa e per due mesi senza PoPPa, ebbe lire 3 e l'avanzo
del tempo l'ha tenuta >>, si disse, << lassa per l'amore di Dio » s8.
fr Balie e banzbini segn. B (14$-1454), 14, c. l; Balie e barnbini segn. B(14$-1454), t4, c. 17.' 58 o Rendé Biagia e Agheta, fanciulla sop-raddetta, gioveciì. a dì 28 di novembre7$7, |'ha tenuta un anno e quattro mesi per la poppa e per due mesi senza poppa,
ebbe'lire tre e l'avanzo del tempo l'ha tenuta, lassa per l'amore di Dio. Fatto contocon Antonio sopraddetto, detto dì 28 di novembre, anno detto. Resta avere lirequindici, soldi dodici » (Balie e bambini segn. B (1413 1'454), 14, c. 30).
Caprroro VI
LA SORTE DEGLI ESPOSTI
a) I decessi e le loro cause
Più del 60Vo dei bambini risulta, all'esame delle fonti, decedutoirr uno spazio di tempo più o meno lungo dal suo ingresso in ospedale.Per il 25%o di loro la morte sopravvenne nei primi renta giorni divita; il 40Vo non raggiunse un anno di età; più del 22%o non arrivò aiue anni e solo il 13Vo ne compì sei. La percentuale dei decessi, ad ognimodo, sarebbe ancota maggiore, se si tenesse conto di un altto 10Vo,circa, di esposti le cui notizie e, in genere, ne è spia l'improwisa inter-ruzione dei pagamenti alle balie, terminano bruscamente prima dellanormale conclusione del baliatico, senza contare una percentuale ancorapiù cospicua di tovatelli che, resi tegolarmente alTa frne dello svezza-mento all'ospedale, sparirono nel nulla dopo averne yarcata la sogliacel ritorno e 1a cui sorte da quel momento ci è, al pari dei precedenti,
Un « Iddio la benedica, riposasi nel nostro spedale >> o << Iddio lo-senedica e Nosfta Donna gli perdoni )>, accompagnavano quasi sempre
'l solito << morì a dì detto, anno sopraddetto >>, scritto minutamente, nonJ,i rado tra un pagamento e l'alro fatta alla balia e chiuso alla fine da'rra croce altrettanto piccola, conficcata qualche volta, in un nudo tu-r::lo di pochi sassi disegnati a penna, posti uno su l'alto a mo' di,=goii. Solo di tanto in tanto si pensava di porre in evidenza il tutto
1 Esposti di sorte nota e ignota secondo il sesso
maschi
::ceduti!ì:ia notar:::e ignota
1052251.
178
t62 L OSPEDAIE Di S. MARIA DELLA SCALA DI S. GIMIGNANO
con un << nota, morì la detta fanciulla a dì detto, anno detto >>, ln cuiquel « nota >> poteva avere una <( n )> più grande del normaie, corne graf-frata a fatica s,alla carta o con vicinissimo un indice iungo e scarno, che
sbucava fuori da un pugno chiuso, venuto fuori da chissà dove ai mar-gini clei {ogiio. Tutto qui, rfla et^ ii massimo di attenzione che si po-tesse pretendere per la morte di barnbini così piccoii, che si sapeva giàin anticipo, per via de1la grande mortalità infantile deIl'epoca, segnatidalla cattiva sorte e per di più privi di parenti, cui render conto del-l'evento con un po' di fammarico.
À4o1ti erano i bambini che n-rorivano il giorno stesso del loro arrivoin ospedale o in quelii immediatamente seguenti, spesso anccr primache ci si fosse dati a cercate la balu. Le precarie condizioni di saiute didiversi di loro, a1 morrento del ricovero, sono certamente la causa prin-cipale di questi repentini decessi, ma non è da escludere, e in qualchecaso se ne ha la certezza, che anche il mancato superamento del traumapsichico e fisico dell'abbandono, ne arlesse ragione in gran parte, speciedei più piccoli, recati spesso nudi ne1le ore e nelle stagioni più varie,senza il mioimo riguardo, per non considerare quello della nascita, cer-tamente non avvenuta, in Datticolare per gli illegittimi, nelle rniglioricondizioni 2.
Mai dati a balia e deceduti a poca distanza di tempo dal loro arrivo,furono tutti quei bambini, che abbiamo segnalato come giunti grave-mente ammalati, pet 1o più sfiniti da lunghe consunzioni, i più grandie con particolari imperfezioni fisiche, i più piccoli, senza contate i tantiprematuri che senza poppare o quasi, riuscirono a sopravvivere da unoa undici giorni, privati per il loro ostlnato rifiuto anche del conforro diun po' di latte di capra che, tuttavia. somministrato intero, secoildo l'usodel tempo, doveva ii più del1e volte piuttosta aggravare che non solle-vare Ie condizioni degli esposti 3.
2 Non dimentichiamo infatti che erano proprio gli iilegittimi ad essere abban-donati .nelle peggiori condizioni e, a questo pròposito, ricòrdiamo i casi pùr ecla-t^rtti, di cui già abbiamo parlato nel paragrafo c dei IV capitolo e cioè <li MatteoGiovanni del 15C6 (vedi nota 189) e di Matteo Romolo dei 1507 (vedi nota 188)(Libro di bambini e ba.lie segn. E (1487-1512), 16, cc. 124, L30).
3 Solo in tempi recenii è stata capita 1a necessità d:i diluire i1 latte di muccaprima di somminismarlo ai bambini, per renderlo pi,ì dieeribile ed evitare le nr-rme-rose complicazioni intestinali, che erano una delle plincipali cause di morte degliesposti negli ospedali, nei qua1i, frequentemente, vi si ricorreva in alternativa aquello delle balie, cfr. E. Corunnr, L'ospedale cit., p.837, dove leggiamo che ancoranel 1742, per gli Innocenti di Firenze, Antonio Cocchi raccomandava: « si scelgaper I'allattamento artificiale dei neonati, de1 latte buono, di vacca, che abbia avuioa disposizione degli ottimi pascoli di erba fresca, munto da pochissime ore, due otre al massimo e che sia raccolto in recipienti pulitissimi. In questo latte va versata
LA SORTE DEGII ESPOSTI t6)
NIorti precocissime che colpivano i bambini appena pochi giornidopo ia loro consegna alTe balie, stanno a testimoniarci quanto colpevolifossero in questo, g1i ulteriori colpi di fteddo e i nuovi disagi sofferd dalbaiabino per il suo invio a balia, sopportati, talvolta, seflza respiro al-
cuno, subito dopo quelli già gravi deli'esposizione, poiché non di radoerano le contadine stesse che ii trovavano e li recavanc all'ospedale, a
riprencierli subito indietro per far loro da balia, coprendo così, magariin un sol giorno, chilomeffi e chilometri consecutivamente fra andare evenire e ci si immagina, da.ta Ia tempestività dei rientri dei piccoli già
cadaveri, che neanche si facesse in tempo a portadi a casa.
Sebbene solo rararnente i bali sapessero indicare con una qualcheesattezza la causa della morte del bambino, né l'ospedale stesso, forse,chiedeva particolari specificazioni in merito, qualcosa di tanto in tantoveniva regismato accanto alTa data del decesso ed è in virtù di questeprezicse annotazioni che sappiamo, per esempio, che quei veloci rientria distanza di pochi giorni dalf inizio del baLiatico, erano abbastanza fre-quentemente da attribuire al sol{ocamento dei bambini nel letto dei bali.
La morte per soffocarnento, però, compare indicata nei nostri regi-sri, solo sul finire del XV secolo, proprio quando Ia chiesa per il tropponumeroso verificarsi, vero o no, di questo genere di morti, aveva as-
sunto un rigido atteggiamento di riprovazione e di attento controllo,ginngendo a proibire a genitori e bali, i1 coricarsi nel medesimo lettocon i bambini, specie se molto piccoli, per i quali si consigliava l'usodi una speciale ctila ad << arcuccio » e, a testimonianza di ciò, fu proprioin questo periodo che l'ospedale provvedette a fornire, oltre al corredo,anche una << zata con guanciale >> a due dei suoi assistiti, Bastiano e Bene-
detto nel L489 4. Afiogato éalla balia, fu Piero Antonio, di quattro mesi,nel 14925; ii i5 febbraio é,el 1498, Giovanna, di cinque mesi, fu ripor-tata all'ospedale << ché la balia l'afiogò 1a notte a letto >> e anche Ia baliadi Roraolo Utrarsilio, un bambino di un anno e rnezza, << 1o affogò e tro-
poi deii'acqua di fonte, bollita, neila proporzione di circa una quinta parte e nonpiù, per non indebolire troppo i1 latte >>. Secondo F. BnuNr, Storia dell'L e R.spedale di S. Maria degl'lnruocenti cit., vo1. II, pp. 33-37, i1 latte di asina è il piùsimile a quello di donna, patticolarmente denso e caseoso quello di capra e moltonutriente quello di vacca e pecora.
a R. Tnexrpn, Inlanticide cit., pp. 98-LL6, avanza f ipotesi che il sofiocamentodei bambini nel letto, e quelio in questione è que1lo dei genitori della Fiesole de1
Cinquecento, ncn fosse proprio sempre dovuto a1 caso ma ad una ben precisa inten-zione di eliminazione dei bambini e che si trattasse quindi non di incider,ti bensìdi infanticidi. Per Bastiano e Benedetto, che ebbero la cul1a nel 1489, si veda ilLibro di barubini e balie segn. E (1487-1512), L6, c. 6.
s Libro di batnbini e balie segn. E (1487-L5L2), L6, c. 77.
1& L OSPED.ILE DI S. N{ARIA DELLA SCALA DI S. GIMIGNANO
rollc': noito allato , ii 28 luglio del 1r0B 6. Ma anche per i1 periodo pre-re.ienre il rrovare alcuni decessi di bambini molto piccoli, attribuiti ad-n; scnerica « mala guardia » delra balia, ci fa pensare che i1 motivopiu probabile fosse ancora quelro sorito der soflocamento ner retto deibali: nel marzo del 14'421, dopo appena'enrisei giorr-ri cli bariatico Agnese.per esempio, fu riportata all'ospedale perché « trovolla morta Ia clettabalia per mala guardia » e anche per Lorenzo, reso dopo soli tredicigiorni' iI 15 ottobre de1 1.145, si scrisse: << morto per ra mala guardia,Dio el benedica , ?. Ma non è da escludere cl-re la « iala grardia >>, indi_casse anche incidenti diversi che pare spesso capitassero ai bambinilasciati soli in casa da1le balie per criverse ore der gio.rro 8. polronia, unabanrbina di tre anni, fu trovata morta clalla balia nel 1422, <<perchéalTogòr in una fossa » e Ia baria in questione, certa monna caterina dicristofano di Matteo di cellole, terminò in questa occasione e, ci imma-giniamo per provvedimento del rettore, ogni suo .rapporto con l,ospe-dale, non solo come balia ma anche come Lvanclaia, n,riura questa, cheda tempo svolgeva per conto der]a casa e. Nessuna punizione, invece,sappiamo venne data alle balie colpevoli clei sofiocamento dei bambinie ciò crediamo per via der suo troppo frequente ripetersi, come ci è te-stimoniato anche dall'assoluta mancanza cli provvedimenti presi, in uncaso simile, da Antonio di Leonardo Rustichi, il mercante iorentino al-*e volte nominato che, padre di quindici figli, di cui solo otro sopravvis-sero) ne ebbe uno, il settimo, Rustico, di due mesi, << aiTogato ne, lettodalla balia >> neil'agosto del 1423 e che, ,onostante il doiore e ro sdegno,fece avere ugualmente ai bali i solcli spesi ,el << mortorio » del bambino r0.
6 « A dì 15 di febbraio, morì la derta fanciulla chc Ia balia Ì,afioeò la nottea lcrro » rLibru Ji bonbini , qrrii ,.gr' À= iiiÀi:iirii.'rc .. to,,""Lt arTogò e,rouollo..T.pj,,.o allato»n(^Libro di banb'ini i i)iii sesn. E (1487_til2 t, 16. c. t))t., .i .L\ota, morr Agnese sopradderta, luncdì no1te, a dì primo ,di
marzo; èseppellita marrcdì rnatriia. a tlì'2 a.tto'^..". r;;,ì,ii.;ài:,."ì1"ì1,,; baria pcrmala rlrrar,lia , r Barie c b.ombiryi ,rgr. É iì+l-i-r+:+,. 1{, c. Jgrr . Nor,r, Lorenzt.r11]::rll:.lcrto_di soprr. ci [u recaro n,orro .,enerdì -.,,1nr.ì ii ìr'a"ì,IL..., on,,oc.erro, morro pcr mala {uardia, Dio e1 ber.redica>> (Bttlie c' banbiii ,ìòi'.' s't.iÀiiIlsl), 14. c. -{Ur.
o.{ derra di E. Srronrrn. .Fanigli,t cir.. pp. 165. ll2. agli srcs>i r,.nitori poreracapitare di trovare ifir'li. lascia-ri p?. lrr."t'i"n.po >oJi,,rrroraLi dai r.,ai,rri ,r bru-ciati tlalle fiamme del'vicino locolar.. -n,.n,,.."^l1r"ili
drr; a bali,r. .,ricmrrri jircampasna e, co"i isolari dr ogni spc,cic di .o,.r"giirnr.,,,, ,liu..,,rìr.,n,, ,o,..ro . ,.,Ienrieri ..^virrinrc d,,tl'isnoranrà. d.il, .,,pi,r;gi, .',1ì.ii;' ;,ì;.:,ì,;;'ii ",,,5"r,o,.,
,* -\lorr |or,onra sopradrÌcrra. mercortdì rnatrira. t ,r't 22 di .<rrcmhre. rJ2 i.
f:. .-rli, guardia, che affogò in una fossa " éoiil, ,'tr,,,ii;,ri- ,ig,,"-n"i-i'+t; ll;."+t,
tu «A dì 11 d'agosto^i."121, mi mancrò a diic i'aerro Bartolo per Domeniccrsuo vlclno, come monna..Salvcstra, suir clonna e b..rlia .li lìrrsriuo ',,r,io -ngli,iÀlo,m'avea affogato ne' letto i' detto Rustico. che ili tutto sia lodato raai,,, tr,. gon
LA SORTE DEGLI ESPOSTI
Ad ogni modo è certo che le giustificazioni dei bali, tese a dar r'a'
gione al rettore sulla causa della mote dei bambini, aumentafono su1
finire del periodo da noi considerato, forse proprio per via di quella mag-
giore attenzione, cui abbiamo prima accennato, anche se non ne guada-
gnarono, il più delle volte, in chiarczza, poiché non di rado gli esposti
venivano semplicemente detti morti d'<( infermità >> o, più evasivamente
ancora, si diceva che il bambino era << morto di sua morte )> ed è sempre
in quest'epoca, che compaiono le prime fedi di morte, fatte apposita-
mente compilare (e forse era divenuto un obbligo) dai bali ai ptopriparroci, per presentarle al rettore deIl'ospedale.
Tuttavia, chi, soprawissuto al trauma dell'abbandono, ai successivi
colpi di freddo e agli aitri disagi necessari per raggiungere il domicilio
della balia e a1 rischio del soffocamento nell'afiollato letto dei bali, riu-
sciva in qualche modo ad iniziare il baliatico, non di rado finiva col
vedersi spedito, con le conseguenze che è facile immaginare, da una
pa*e all'altra della Valdelsa, per via dei frequenti cambiamenti delle
balie che, incinta o no, senza latte o con << latte cattivo )>, pafe cercas-
sero ogni pretesto per levarselo di casa e, forse, solo per via di nuove e
più vantaggiose offerte di guadagno. Bernardo Luca, per esempio, del
1487, cambiò cinque balie in quindici mesi: recato dalTa prima balia a
Cellole, fu portato a Certaldo dalla seconda, a Gambassi dalla terua, dinuovo a San Gimignano dalla qoatta dopo un intervallo di appena ottogiorni e, infine, a Villa Castello dalla quinta, dove morì il L5 gennaio
1488 11. Ma il primato dei cambiamenti di balia, spetta senz'almo ad
Agata che, in poco più di un anno, dal 30 gennaio 1490 al23 {.ebbraia L491",
éata della sua morte, cambiò ben otto ba1ie, facendo la spola tta Bar-
biano, Buonriposo, Montaione, Barbiano di nuovo, Gambassi, San Gimi-gnano, CasagTia e, in ultimo , ancota San Gimignano, talvolta magari solo
per restare dodici, quindici giorni e, in un caso, addirittura una sola
notte per una improvvisa mancanza di latte della balial2.A giudicare dai tanti bambini riportati in fretta all'ospedale dove
morivano nel giro di pochi giorni se non di poche ore, le balie aspetta-
vano proprio l'ultimo momento prima di decidersi a restituirli per non
perdere, come crediamo, la corresponsione del salario ftoppo in anti
Guosr., Antonio d.i Leonardo Rustichi at., p. 77). <( In questa situazione viene fuoritotto io sdegno di Antonio che si rifiutò di prendere contatti diretti con i << colpe-voli »> e incàricò l,amico Vanni Castellani e ìua moglie di dare alla balia i soldispesi nel <( mortorio » del bambino « ché no' volli gli chiedesse a me )> (F. Bon-euosz, Antonio di Leonardo Rustichi cit., p' 77).
it Libro di bambini e balie segn. E (1487'1,51,2), L6, cc. ),31,33,34' 37,47.12 Libro di bambini e balie sàgn. E (L487-I512), 16, cc- 7,52,56,5V,60.
165
166 L,CSj?EDALE DI S, MARIA DELLA SCALA DI S. GIMIGNANO
cipo. Si trattava spesso di bambini che Ie balie stesse dicevano « infer-
mi >>, qualcuno anche « da più settimane » ma che al fuate parevano
tr-rtti, senza distinzione, << mal stagiofiati>>, « rnale in ordlne >>, << mal-
governati r> e << rnale in punto » e il loio appartenere in gran pane alla
categoria dei bambini da divezzare, oltte l'anno di età, ci {a pensare che
queste generiche infermità, altro non fossero che stati di malnutrizione,
dovuti all'errata e ta'rvoTta troppo precoce somministrazione di nuovi
alimenti che, invece, si sarebbero dovuti assumere gradualmente 13.
Ma non erano solo gii sbagli alimentari de1le baiie a determinarne
Ia morte e poteva anche datsi che i bambini soccom'bessero all'incutiase non proprio ai maTttattamenti de1le donne, che ii avevano presi ad
alTattare o a divezzare. Ne1 1447, un bambino di tre mesi, Bartolomeo,
che era stato reso la mattina del 20 di diceilbre, da monna Caterina,
donna cii Niccolò di Bambi, << morì venerdì sera a d\ 29 dr dicembre,
anno suddetto >>, perché la balia, si disse, « tenello molto male e per
male goveino si morì >> 1a. Bernardo Luca, di un anno e tre mesi, morì
iL 15 gennaio, presso Ia sua quinta balia, << ma non per suo difetto >>,
bensì, si disse, per « difetto della balia prima >>, certa monna Antonia diPiero di monna Fiore, abitante in Certaldo, che 1o aveva teso il 24 giu'
gno di quell'anno, << rrtezzo morto daila fame e di stento e di malgo-
verno », tanto che il fuate si lasciò scappare un << sì bene ci ha servito
che metiterebbe d'essere lapidata, ché da lei non è rimasto non sia
morto » e, probabilmente, invocava LÌna delle tante severissime pene
inflitte all'epoca, a1le colpe,roli d'infantlcidi.o 1s. Ftancesco, nel dicembre
del 1,495, reso dal1a pdma balia perché il « latte non si confaceva »> e
dato a monna Paola, donna di Donato, lavoratore del1'ospedale a Ca-
sole, {u restituito alla casa il 22 ottobte 1498, in condizioni tali <( che
il cietto bambino non aveva se non la peiie >>, tanto che, benché già
grande, dovette essere dato ancora a balia a moirna Fulisena, donna diBartolomeo del Bene da Certaldo, dove, nonostante tutto, morì il 7 ago'
13 Sull'alimentazione dei bambini, lattanti e non, si veda ancora E. Corunnr,L'ospedale cit., pp. 834-BJ9 e O. Aronrucct, I-a rnortalità ilei bar,qb-ini cit., pp. l4-L5.- ta «Notà,-irorì Bartolomeo detto di sopra, venerdì sera a dì 29 di dicembre,anno suddetto'e tenello molto male e per male governo si m.orì >> (Balie e batnbittisegn. B (1.413-1454), 1.4, c. 44)." 1s .ì Morì il éetto
'Bernardo, che recò morlo la balia detta a dì detto. Non
era per suo di{etto, fu per difetio delLa balia prima. Dio e1 benedica >> (Libro dibam-bini e balie segn. E i1,487-1.5L2), 16, c. 41); la balia precedente, tnfatti,- « rendéel detto Bernardo Luca, a d\ 24 di giugno, ch'era rr,ezzo morto di fame e di stentoe di rnalgoverno, sì bene ci ha serviio ihe rneriterebbe d'essere l1Oidat1, ché da leinon è riàasto non sia morto » (Libro di barubini e baiie segn. E (1487 1512)' L6,c. 31). Fer 1e pene inflitte ne1 À{edioevo a1le colpevoli d'infanticidio, si veda Y. B.BussAuo, L'infanticide cit., pp. 229-256"
LA SORTE DEGLI ESPOSTI
sto dei 7499 16. Lorenzo Alessandro, del febbraio del 1496, fu riportato
il 5 maggio da1la prima balia, monna Sandra, donna di Guglielmo di
Piero di Iacopo, lavoratore di ser Nicolaio Caciotti a71a viLla di Paterno,
<< maltenuto, magro e tristo >> tanto che in poco tempo, dopo essete stato
dato a monna Leonarda, donna di Geio di Santino, lavoraiote di Piero
di Antonio da Gamba.ssi, il 28 giugno di queil'anno, a poco più di quat-
tro nresi, morì17. Sempre a quattro mesi morì'anche Francesca nel 1499,
presso Ia sua terua balia, dopo che eta stata resa << maltenuta >> dalla
precedente, certa monna Giacoma, donna di Giovanni d'Andrea, abitan-
te a Filli e lavoratore di << ser Paolo prete >> 18. « lr{olto maltenuto e
peggio ttàttato >>, fu reso nell'agosio àel 1504, dopo un solo mese di
baliatico, anche Gimignano Gioyanni, che morirà il 27 dello stesso mese
presso tra sua seconàabalia, monna Dionora di Bernardo da Poggibonsile'
Dove non affivavano le balie, {acevano il resto 1e malattie intesti-
nali, caratterizzate da violente diartee e indicate col nome di << pondi >>,
« bachi » e << flusso >>, che colpivano i bambini, specie quelli molto pic-
coli, in manieta letaie e che erano pur sempre da attibuire alle poche
cure e alie poche attenzroni, per non parlare deli'igiene, che doveva
mancare dappertutto 20. lrlel 1488, il 4 di dicembre, Benedetta, di ap-
pena tie mesi, fu ùpartata da monna Nofria di Antonio di Lorenzo da
I$azzalÀa, << in quel di Volterra >>: << recolla quasi morta, aveva flusso inmodo non si poté aiutare >>
21. Niccolò Girnignano del 1489, di appena
venti giorni, venne reso « malato di bachi ovl/ero >>, si disse, << gli aveva
queilo cattivo male )> e << morte di bachi >> ebbe anche Margherita di tremesi, i-l 23 maggio del 1490. Per Cristiana di ventisei giorni, il' 19 ago-
sto del 1489, <<venne il balio con un suo vicinc e disseno come era
nrotta di pcndi e che non la poterono più aiutare, tanto 7a soprafiece il
16 « Ch'el detto bambino non aveva se non la pelle >> (Libro di bambini e baliesesn. E (1487-1.512), 16, c. 70).- r7 Libro di bar,tbini e balie segn. E (1487'L512),76, c.73.
18 Libro di balie e barnbini segn. E (L487-1512), L6, c. 96.1e « Rendé detto bambino a dì 15 d'agosto, àiio moito maltenuto e peggio
trattato >> (Libro di bambini e balie segn. E (I1Bl-7r72), t6, c. 175).20 << ir{aie del pondi », ., fu chiamàta volgarmente la dissent-eria, per.quel grave
oeso che ralvolia èssa fa sentire al['infermo irell'estlen:ità dell'intestino retto >>
iN. Tonore,s.o - B. Brrr,rNr, Nuouo d.izionario cit., vol' III, p-. 1098) e del mede-
àimo awiso sono anche D. 'HBnrruy - C. Ki-aprsCA-ZUeav,, Les tascdns et leurs
llanilles cit.. uo. 464-467, che a proposito delle cause di morte di barnbini e adulti. Ie
oiù f..,ju.nii-iella Toscana del Quàttrocento, indicano per i bambini i disordini inte-itinali, iuali il o pondi ,r, ,pp,rnto, il << flusso » (diaffea) e i « bachi >>, quest'ultimia loro awiso conseguenza di una sottoalirnentazione cronica.
2l o Rendette Benedetta, a dì 4 di settentbre. anno detto. recoila qu,asi morta,aveva flusso in modo non si poté aiutare. Morì a dì 5 detto. Dio la benedica »
(Libro di barnbini. e balie segn. E (1487-15L2), 16, c. 4).
167
i
168 L,OSPEDALE DI S. IVIARIA DELLA SCALA DI S' GIMIGNANO
male » 2. Di <, pondi >>, morì anche conticino Alberto dell'ottobre del
medesimo anno, a poco più di undici mesi e nel 1509, per Vito Mode-
sto, di due mesi, si scrisse ancl-re per lui: << el detto bambino morì cli
pondi >> a.
In un solo caso, quello di Domenico Lapo del 1502, di un 'rnno di
età, Ia causa della morte fu indicata da monna checca, donna di Nic-
colò, << sta a Paterno, su quello di Matteo d'Agnolo >>, nelia violenza
di una cattiva febbre e, si disse, che il bambino era morto di '<
male
di febbre >> 2a.
Ma grandi e piccoli, a balia o no, gli esposti soccombevano alle
malattie epidemiche, i cui focolai si riattivavano particolarmente nelle
stagioni estive. Nel 1420, << l'anno della moria » più volte ricorclato nel-
le fonti, fra il luglio e il novembre, morirono cinque dei bambini pre-
senti nell'ospedale e il conta.gio poteva venire anche da fuori, con I'im-
provviso rienffo di bambini già ammalati. I1 19 agosto del 1419, ad
esempio, Aibiera Maddalena, che morì poi il 30 di quello stesso mese,
fu riportata dal balio, Biagio di Donato da Casole, perché, spiegò, « arn-
malò la detta monna Checca >>, sua donna's. Nel 1449, i decessi dei
bambini, che continuarono per tutto il L450, altta aflnata di epidemie,
iniziarono con que11o di Antonia, di poco più di cinque mesi, che morì
insieme alla sua balia il 14 di luglio di quell'anno e, nella ptimaveta
successiva, in piena crisi, Fiore, di tre anni passati, fu resa con << un
enfiato sotto il braccio )>, segno che sappiamo caratteristico de|l'awe-
nuto contagio e, queli'anno, nel solo mese di settembre, motirono hen
sei degli esposti fra i due e i tredici anni di età x
2 << Rendette il detto Niccolò, a d\ 24 d'aprile, che I'ha tenuto .lc.iotLo dì,monta il servito soldi tfenta. EIa maiato di baclli ovvero gli aveva q,"rcllo cattivornàl..-lrlorl àetto bambino a d\ 26 d'aprile. Dio 1o benedica,> (Libro,di b*whini e
iit;i ,i5". E (1487-ti72), 16, c. 4i); " Morì 1a detta- Margherita, l*ncJì sera a
Ai b a7 *uggà, ebbe morte'di bachi " (Libro di bambini e balie segn. E (1.1E7
ti{il, ie , i.'iSi "Morì 1a detta Cris.tiana, _a dì 19 d'agosto, venne il balio ccn trn
;;;-;.i"; . dis.no che era morta di pondi, non la potcrono piìr aiut:re tarito la.opr"gÉi. iL male, che in pochi. dì morlsse. Dio 1a bencdicar, (Libro ,!i lldml:hi tbilie segn. E (1487-1512\, 16, c. 45)."-"- i'L;bro'di bambini'e b:alie segn E 114s7"1572),76, c. 17); Libro di bontbini
e batie i:-(;"5,(i1?,';"Jilirl"u; i l?'rr di seLrembrc. r50r e si morì dj m:r'!u rr
febbre>> (Libro di bambini e balie segn. E (1487-L512), 16, c'-.111)'----'1i.ìRendé 1a detta fanciulla sÀato mattina, a dì 19 d'agosto, anno detio,
p.r.hé u*Àr16 U a.tt^ monna Checca>> (Bulie e b*nbini segn. B (1411'1454),
14, c. 10).26 « Morì la detta Antonia, nosffa fanciulla, ch'era a -b/ia, -lunedì. a dl 14 di
l"suo fì+r.-iàaio l^'ir"nàai.^ é morì la detta sua bclia, Iddio.le peldoni » (pal!1
;-ir*bir; trei. n G4ù-1,454), 14, c. 46); « Lunedì mattina di buon'ora, a dì 17
ii
LA SORTE DEGLI I,SPOSTI 169
Di una « mala infermità »>, << incurabile, era specie di cancro », rno-
rì all'età di quasi nove anni, Agata, nell'agosto del L449, all'ospedaledi Santa Matia Nuova cli Firenze, dove era stata appositamente inviataper curarsi, ma può darsi che ancl-re in questo caso fosse ancora la peste
la vera responsabile, così come ci pare per Tommasino, di nove anni,che, inviato anche lui ne1 dicembre del 1450 all'ospedale fiorentino,<< perché esso si fusse medicato )>, di << una certa infermità >>, consi-
stente, come intendiamo, in una brutta piaga, « buco assai scuro ,r, che
i1 bambino ayeva, a detta del frate « dietro tulo (sic) >>, non fece piùritorno 27. Anche per Bartolomea, di sette mesi, che si disse << morì divaiuolo, sabato a ora di terza, a dì 18 di settembre, L45l >> e che vennefatta seppellire dai bali a Certaldo, contrariamente alla regola comlrne,che vedeva ritornare i piccoli molti all'ospedale, per essere seppellitinella chiesa, dove sappiamo esisteva un llrogo, « la sepoltura dei fan-ciulli >>, a loro esclusivamente destinato, ci pare da atribuire, più che
ad un veto e proprio caso di vaiolo, forse ancora una volta ad ultimamanifestazione della peste che, probabilmente, tardava a spengersi a.
Verso Ia fine del secolo, infine, fra le cause di morte degli esposti,
{a la sua comparsa il « rnal francioso )>, l-ìome questo col quale veniva,a11ora, comunemente chiamata la sifilide, che in questo periodo afflisseparticolarmente 1'Europa intera n. È a questo male che si può forse at-
tribuire, per le implicazioni morali che gli venivano imputate, la mortedi Fina, avvenllta nel marzo del 1488, per la quale il {rate accanto alladata della morte scrisse: « era mal seme >> e, sicnramente, que11a di
Nicola, una bambina di tre mesi, per la quale nel 1496, invece, si pre-
di maggio 1450, ne recò Fiore, la detta nostra fanciulla, conre scritta tii sopra.Aveva male ed era enfiato sotto i1 braccio » (Balie e barubini segn. B (18-1454),L4, c. 47).
27 << Morì Agata, nosta fanciulla, comc scritta di sopla, a dì d'agosto 1449.Ilorì a1lo spedale di Santa Maria Nuova di Firenze. Ve la mandammo per farlamedicare ché la guarisse; aveva una mala infermità ne11a sua persona) inculabile,era specie di cancro. La novella ci recò che essa bambina era morta, ftate Barto-lomea di Gherardino, nostro frate di Poggibonsi. Iddio 1a benedica » (Bolie e bam-oini segn. B (1173-1.454), 14, c. 31); << A dì I di dicembre 1450, Iranclaninro Tommè,come scritto di sopra, a1lo spedale di Santa Maria Nuova di Fitenze. perché essor-i fusse medicato. Aveva certa in{ermità, dietro tulo (sic), buco assai scul'o >>
Balie e bambini segn. B (L4B-L454), 14, c. 44).a << Notate, come Bartolomea, nostra fanciulla, come scritta cli sopra, morìLi vaiuolo sabato, a ora di terza, a dì 18 di settembre 1451 e dissc el detto suobalio ch'era morta. Iddio la benedica >> (Balie e bantbini segn. B (l4D-1454),'"1, c. 52).a Cfr. A. Pazzrur, Sciltti di storia delle malattie, Roma, 1969, p. 248 e
l.l. S. Mezzr, Salute e società nel Medioeao, Firenze, 1978, p. 78.
170 L,OSPEIìA.LE DI S. M,{RIA DELLA SCALA DI S. GIMIGNANO
cisò: << nota ch'ebbe il mal francioso >> e anche queila di Raffaello che
morì di << mal francioso >> neil'ospedatre, a quasi tre anni di età 30.
In conclusione, a parte le malattie epidemiche, che sempre pote-
vano mietere numerose viitime, il rischio più grosso per i bambini era
rappresentato dal loro essere dati a baTie senza scrupoli, che a giudicare
dai tanti esposti resi « scaduti >> e << malgovernati >>, poco ci si dedica-
vano o erano, più spesso di quanto ncn si pensi << ascilltte >> invece che
<< bagnate )>, tanto da anticipare, proprio per questa tagione, il lorosvezzamento e provocare così quei disturbi intestinali particolarmentepeiicoiosi nei lattanti specie nel1e stagioni calde, nelle quali, pet quanto
ci risuiia, erano di{atti più frequenti.I1 prospetto che segue, ,.,uole essere principalmente utile per una
sonrmaria e riepilogativa indrcazione di quelle che potevano essere le
cause di morte degli esposti e non tanto, anche questa volta, per il nu-
mero dei casi. ritrovati, che non rispondono, se non ptoporzionalmente,alTa rca7tà,, certamente ben più tragica ma, per la natvra stessa delle
fcnti, poco quantificabile. Ad ogni modo, riassumendo, i decessi erano
dovuti a:
nascita prematura (<< non era il tempo >>, <( non tirò mai poppa ») 11
mallontzazioni dalla nascita (<< aveva fesso il labbro di sopra de1la boccae I'altro manco », <( aveva una nascenza in su i'anche di dietro »,<( con un enfiato in su le reni, nacque con esso e sfiatava ché erarotto >>)
malattie intestinali (« bachi >>, << pondi », « flusso »)incuria delle balie (<< scaduti >>, << malgovernati »>, << male stagionati »,<< magri e tristi >>, << consunti »>, << maltenuti », « infermi :>, << rnale inordine >>)
incidenti (« mala guardia »>, << l'afiogò 1a notte a letto »)
3
1
b) Le rcstituzioni
Notevolmente inferiori come numero a quanto i vari << segni » e
<( contrassegni >> titrovati addosso ai bambini avevano lasciato supporre,
1e restituzioni dei piccoli abbandonati ai genitori o, nel caso si ttattasse
30 Libro ù bambini e balie segn. E (1487-1512),76, c. 33; Libro di barnbinie balie segn. E (L487-1512), 16, c. 72; Libro d,i barnbini e balie seen. E (1487'151.2), 16, c. 80. Del resto sappiamo che le morti per sifilide congenita o acquisita(dalla balia), etano molto frequenti anche agli Innocenti, come ci confermano pertempi più recenti F. BauNr, Storia dell'l. e R. spedale di S. Maria degli Innocenticit., voI. II, p. L02 e U. Cnsnrcr, L'assistenza all'inlanzia e il regio ospedale deglìInnocenti d.i Firenze, Firenze, 1932, p. l4l.
306
LA SORTE DEGLI ESPOSTI L7L
di orfani, ai nonni o agli zii, riguardano pur sempre un buon numero
di esposti, più della metà, la cui sorte ci è nota.Riservate più ai maschi che alle femmine, le restituzioni potevano
verificarsi anche dopo pochi mesi dall'abbandono, spontaneamente su ri-chiesta dei parenti, ad awenuta risoluzione cli temporanee necessità, osu preciso interessamento dello stesso ospedale, come ci pare di capireper Giovanni Piero, che abbandonato il 27 giugno del 1463, << da uno
che bussò e andò via e non volle essere conosciuto »>, fu reso poi dopo
soli cinque mesi, il 9 dicembre di quello stesso anno, su iniziativa de1-
l'allora rettore, a7 padre, al quale fu chiesto, e anche questo rientravanella normale prassi deIla restituzione, f intero rimborso delle spese &baLiatico, ammontanti, in questo caso, a 17 lire 3I. Anche Gabriello Ber-
nardino, lasciato la mattina de11'8 aprile 1489, fu restituito dopo appena
un rrìese e venti giorni al genitore che, venuto apposta, di sua volontà,da << quel di Siena >> e fattosi riconoscere << per più segni >>, « pregò »> ilfrate << glielo rendesse >>, come difatti awenne e, questa volta, senza al-
cuna richiesta di denaro, dato che << per quanto si potesse vedefe, eta
povero uomo )> 32. Il 24 aprile L492, invece, il padre di Agata, una bam-
bina che eta stata abbandonata l'anno prima, << la prese d'accordo >> ma
solo d.opo che l'ospedale gliel'aveva ùmandata a casa e, nel 1505, « senza
pagamento >> alcuno, anzi, << riportollo quello che 1o recò »>, {u reso allamadre dopo appena due mesi, Fiero Francesco e, allo stesso modo, ne1
1506, dopo soli venti giorni, fu ricondotta a casa À,{aria Ginevra, trna
barnbina appena nata*. Nel 1512, infine, ma altti ve ne sarebbero, dopotre mesi di permanenza nell'ospedale, Caterina anche lei, fu restituitaalla madre, vedova, abitante a Ponffernoli 34.
Casi di questo genere, però, erano abbastanza poco frequenti e i
31 Il padre di Giovanni Piero s'impegnò a pagare i cinque mesi di baliaticodel figlio a << calen di maggio L464 >> (Libro di bali tegn. L (L456-1,465), 15, cc. 18,94). 11 rimborso delle spese di baTiatico eru intatti, chiesto regolarmente ai {amiliaridei bamtrrini che si presentavarTo a richiederli, anche se poi, in realtà, non awenivache rararoente e ci si limitava a chiedere un'ofierta qualsiasi, a discrezione de1beneficato.
32 Recato 1'8 aprile L489, tl 30 maggio successitro << venne qui i1 padre didetto Gabriello, era di quel di Siena e per quanto si potesse vedere era poverouomo e, per più segni che ci diè conoscemmo di vero era suo 6g1io, pregò glielorendessi >> (Libro di barubini e balie segn. E (1487-L51'2), 1'6, cc. 5, 43).
s « A dì 24 d'apile, rimandammo 7a detta bambina al padre e a lui Iarendernmo, 1a prese d'accordo »> (Libro di banzbini e balie segn. E (L487-L512), 76,c. 8); << Eendeìsi detto bambino alla madre e riportoll-o quel1o che 1o recò a dìprimo di giugno 1506, senza pagamento »> (Libro di bambini e balie segn. E (L487'15tz), L6, c. I22); Libro di bambini e balie segn. E (L487-1.512),76, c._127.
s <<-Rendessi detta fanciulla alla madre propria, 1a quale era da Ponffemoli,a dì 5 d'aprile L5L3 (Libro di barubini e balie segn. E (L487-1512), 16, c. 155).
t72 L,OSPEDALE DI S. MARIA DELLÀ SCALA DI S. GIMIGNANO
bambini erano ripresi più facilmente almeno dopo l'intero allattamentose non proprio a conclusione di tutto il baliatico ed erano ricorrenti {raquesti gli orfani di madre, che i padti vedovi avevano portato ad aliat-tare all'ospedale per non dover pagarc una balia. Nel 146.1, GiovanniBattista, fu riportato dalla stessa balia, certa monna Maria di Luca diGiovanni << da Santo Olivieri, corte di Colle >>, al padre, con ogni pro-babilità un vedovo, dopo quattordici mesi, a conclusione deli'allatta-mento e anche Mariotto del 1488, come abbiamo già avuto modo ¬are, a proposito degli orfani di madre recati all'ospedale, fu reso,
dopo quindici mesi di baliatico, su preciso intervento del frate, a Pilluc-chino, suo padre che, formatosi una nuova famiglia, poteva, ora, a suo
giudizio, badargii 3s. Ancora a conclusione dell'allattamento, ma richie-sto espressamente dal padre, << che lo domandò di grazia r>, fu reso
Giovanbattista Lodovico, fig1io di Meino, fornaio sangimignanese 36-
Ma non era raro veder genitori cercare i propri figli dopo cinque,sei, sette e anche otto anni dall'esposizione e, in questo caso, si ttattavadi soli maschi, già in grado, secondo il costume del tempo, che Ii ve-
deva avviati precocemente al lavoro, di aiutare in famigiia. Questo tipodi restituzioni, che contemplavano cioè bambini ormai grarldi e forse inprocinto di lasciare definitivamente l'ospedale, per essere collocàti pres-
so qualche afiigiaoo o contadino dei luogo, disposto a prenderii con sé
ad impatare il mestiere, compare frequentemente nelle fonti per tutta laprima metà del XV secoio, rlentre le alre, quelle che abbiamo esaminatoin precedenza e che awenivano entro breve tempo dall'abbandono o, alpir) tardi, dopo I'allattamento, paiono di preferenza disribuirsi verso lafine del secolo. Da ciò deduciamo che anche l'ospedale delia Scala diSan Gimignano, fosse sempre meno disposto ad allevare dei legirtimiper vederseli portar via dalle {amiglie appena giunti ad un'età lavora-tiva, quando cioè anche l'ospedale poteva in parte rifarsi delle spese
sostenute, prima del definitivo distacco che, per i maschi, avven.iva in-torno ai tredici, quattordici anni. È del 1438, per esempio, l:r resriru-
3s Librc di bali segn. L (1456-1465), 15, c. 106; << Rendessi il detto &{ariottcal padre, Giovanni, detto Pillucchino, a dì 2 di marzo 1.190, perché ha ripreso don-ne e puol1o tenere 1ui )> e ancora << a dì detto, rendemmo il detto N{ariotto a Gio-vanni d'Antonio, detto Pillucchino di San Gimignano, perché era suo iigììo, fzrce-molo balire quindici mesi. Se vuole fare bene alla casa sta a iui >> (Libro tli bambinie balie segn. E (L487-1.5L2), 16, cc. 4, 42, 45). Per le ofierte, infatti, ci si rimettevaalle possibilità delle famiglie, lasciando perdere ogni volta che si trattava di poveragente.
s « E dessi rendere al padre detto dì, che 1o domandò di grazia e ptr meglios'è fatto, accetto sia a Dio e Nostra Doirna >> (Libro di bambini e balie resn. E(1487-1512), 1,6, c. t28).
LA SORTE DEGLI ESPOSTI
zione di Agostino Ulivo, di più di sei anni, che fu reso un <( sabato a
vespro », <( a dì 2 d'agosto >>, aI padre, un certo Niccolò dt Lazzarc diSan Gimignano, che venne a riprenderselo ormai cresciuto e che in cam-bio << non diede niente, se non buone promesse »>
37. Nel 1459, all'etàdi sette e nove anni, furono resi ad un certo Attaccabrighe da Canneto,che ii aveva abbandonati tre anni prima come ortani, Francesco e Gio-vanni per una somma di 8 fiorini, a 4 7ke e 2 soldi per fiorino, di cui13 trire spettarono, secondo ie disposizioni del rettore, ad un certo Ga-briello clel Barba da Volterra, che aveva condotto a termine felicementela restituzione dei fanciulii 38. A otto anni, nel l5O7 , << per I'amore diDio, perché povero uomo », fu reso al padre, Antonio, che forse nonaveva ancora dimenticato che quello stesso padre, che ora premuroso 1o
chiedeva, lo aveva abbandonato cinque anni prima, in pieno inverno egonfio di botte, in un campo 3e.
A qtresto proposito è da notare che << l'afietto >> dei genitori, si di-mostrava in uno sffano modo, nel senso che si potevano abbandonareimpunemente i figli, dimenticarii in un ospizio per più anni e rifarsivivi improvvisamente con pieno diritto in ogni momento e specialmenteogni volta che l'ospedale, per l'età del bambino e la necessità di diminuirne il numero in casa, tefltava in un modo o nell'altro di sistemadipresso terze persone, quasi che le famiglie tenessero costantemente d'oc-chio i figii per richiederli solo quando rischiavano di perderli <( econo-micamente >>
4.
i7 << Nota, rendei Agostino, sabato a vespro, a d\ 2 d'agosto, anno 14j8, a
Niccolò di Lazzaro da San Gimignano. Non ci diede niente se non buone promesse )) (Balie e barnbini segn. B (1413-1454), 14, c. 26).s La restituzione di questi due bambini avvenne tramite una te.rza personaalla quale l'ospedale s'impegnò a dare un compenso, consistente in una parte del-l'ofierta cos\ reaLizzata. Curioso particolare, che fa riflettere sulla realtà delle moti-vazioni portate a giustifrcazione dell'abbandono dei bambini, è che non si rrattavadi or{ani di entrambi i genitori, come era stato detto, poiché è proprio il padre,« Attaccabrighe da Canneto » dei dintorni di Volterra, a richiederli dopo te anni.Ma 1e sorprese non finiscono qui perché i due bambini registrati al loro ingressoin ospedale con i nomi di Francesco e Giovanni, paiono ora invece chiamarsi N{ichele e Bartolomeo: « Da Gabriello del Barba da Volterra, a dì 19 d'agosto, fioriniuno largo, il quale fiorino si è avuto per parte di fiofini otto, a lire quattro, soldidue per fiorino; i quali denari sono per due {anciu11i, si renderono a uno che hanome Attaccabrighe da Canneto e detto Gabriello ci promise 1a detta quantità, cioè6orini otto. Nota che detto Gabriello aveva avere da noi, cioè dailo spedale, per larendita di Michele e di Bartolomeo della casa, lire tledici, soldi sedici deila^detrarendita» (Meruoriale di spese rninute segn. B (1459-1460),5I, c.28).
3e Libro di barubini e balie segn. E (1487-1512), 1,6, c. 10c).m Un comportamento de1 genere, di famiglie cioè che si facevano vive soio a1
mofirenio in cui l'ospedale decideva, in un modo o ne1l'a1tro, di sistemare i bambini(e ci riferiamo in particolare ai maschi), è stato notato anche e frequentemente pressoI'cspedale fiorentino di San Ga11o. Nel 1397, per esempio, Michele e Lorenzo, due
rt)
174 L'OSPED^LE DI S. MARIA DEI-LA SCALA DI S. GIIv{IGNANO
Eccezionale 7'età" alla restitrizione di Caterino, che ne1 1a,26, a
quindici anni, Iu accompagnato << la mattina cleila Pasqua di Befana, a
dì 6 di genna.io >>, << a Colle a' eredi di Riccio, sr'lo zio » ma Caterino,ci pare, insieme aé a7xi, di cui parieremo, uno di quegli esposti illegit-timi che, allontanati da11a famigiia immediatamente alla nascita, vi ve-
nivano r;oi reinseliti quando il tempo aveva atteftuato se non cancetriato
i rnotivi dei ioro abbandono 41. Anche ia cura con la quale venne rirnan-dato a casa propria Carlo, un esposto di sei anni, che se ne << andò benvestito di panno bianco, di gonnelletto e cioppa >>, sL1 ordine del rettoresenese, Piero Bolgherini, che 1o fece restituire al padre, un certo filesser
Giovanni di Bernardo da Volterra, che non mancò di usare << cortesiaa.77a casa>>, inviando i00 lire di ofierta, ci fa credere con ragione che
si trattasse di un illegittimo di qualche benestante famiglia volterrana 42.
Giovanpietro stesso, reso a otto anni, nel 1,159, a <( uno suo zio )>, certoAntonio di Giovanni da fuIassa di Maremma, che ofirì a77a casa 6 fiorinidi eiemosina, pari
^ 32 7ke e 8 soldi, ci pare anche lui appartenere a
questa categoria, tanto più che Giovanpietro, sappiamo che era statodefinito « figliuo1o dabbene >> in un << polizziolo >>, che ave-v-a recato consé al momento del suo abbandono e aveva portato anche un cotredinoche, insieme all'o#erta di un fiorino, a suo tempo, aveva colpito l'aiten-
bambini di sei e ciieci anni, figli di un cerro Lcrenzone da Poggibonsi ai Valcicisa,Iurono posti da1 priore di San Gallo a servizio pressc un suo n:poie ma ciopo ap-pena sedici giorni, <r venne a San Ga11o Nanni di Lorenzone soprascritto e riebbei sopiascritti fanciuili perché, disse, essere loLo padre, come detto cii soprà e r:te-nosseli ccn seco>> (Balie e banzbini (fi94L401), 6, c. 163).
a1 « Fartissi Caterino sopraddetto, la matiina cielia Pasqua di Be{ana, a Jì 6di gennaio 1126, con nostra iicenza e andonne a Co1le a' eredi di i{iccic. ;-.- -io,al tenrpo di me frate Checco» (Balie e bdntbini segn. B (14L3L451),1,tr, c, 1).
42 << Notate come CarJo, nostro fanciuiio, come di sop;:a, giovedì maitila ai-
l'avem*ria, a dì 6 d'otto'ore, anno 1151, il padie suc il menò pel co1ì'ìari:..i,r:r.iodi messer Pietro Bolgherini, nostro rettore e usò cortesia a'rla casa, colne al,parea1 libro de11e ricordanze, segnato d'una * a {oglio 9. 11 dettc fanciullo anciò benvestito di panno bianco, di gonnelletto e cioppa » (Balie e banzbini segn. B (14i3-1.4t4), 14, c. 4l). Nel libro di Entrdid e uscira segn. A (L418 1$)), 71, c. .{é, tro-vian'ro inviata all'ospedale in due tempi successivi, ne1 12151 e nx| 74)2, ia sommadi cento lire, che fu 1a << cortesia » usata <ìa1 padre di Carlo a\ia casa per avergliallevato il figlio: << Da set Giovannl cii Giusto, piovano della pieve di Sal llalto-lomeo a Egoii, contado di Pisa, oggi in questo dì 6 d'ottobre, ricevetti da lui lileotrarìta contanti, come appare a1 -libro ricordanze, segnato + a carta 9, per ioscritto di rnesser Giovanni di Bernardo da Volterra. Sono tiscosse per GiovanniCario, ncstro fanciullo, l'aveva allevato 1a cesa, disse e mostò ogni chiattzze erasuo fig1io1o e così g1ie1o detti per lettera e comandamento di messer Pietro Bol-gherini, nostro rettore e signore deilo spedaie cii Siena » e ancora iln po' più sotto:<< Da ser Giovanni di Glusto, della pieve di Santo Bartolomeo a Egoli, coi-rtado diPisa, a dì 25 di febbraio, 1452, ricevetti da 1ul, iire venti contanti e li recòBiagio di Bartolo da Racciano, corte di San Giaignano e si sol-ro posti a ragione deldetto messer Giovannl, che n'abbi dato a1 libro delle ricoidanze, segnato + acarta 9 >>,
1
!itIù
If!*. È
LA SORTE DSGLI ES?OST] t75
zror,e del fe.itore per la bucna qualità di alcuni dei panni a3. È del 1505,
infine, tra restituzione di Damiano di cinque anni, a messer Giovanni
Garaucci, esponente di gna nota famiglia sangimignanese, <( perché suo
fig1io1o >> dal quale il frate si propose fetmamente, con un cefto asiio,
di pretendere tutta 1a spesa « per averlo allevato e tenuto da dl 2
d'agosto 1500 per insino a dì Cetto, sono anni cinqu,e a circa>>aa.
Nessr-rn accenno, invece, alla restituzione di « iiiegittime >>, ma ilvotrerlo sarebbe stato forse un coqtrosenso, data la scarsa richiesta da
parte dei parenti delle bambine in generale che, manne alcune eccezioni,
corne, ad esem.pio quella di Santa e Domenica, due sorelle, che vennero
rinviate per « Agnolo di Ravenna, lato palerte >>, clopo due anni di per-
mane!7za neii'ospedale, ai genitcri , ne1 1429, e quella di Costanza, resa
<( per l'amor di Dio >>, nel L434, agli zlt, che ia « rivollono >>, si preferiva
saperle definitivamente affidate a1le cute deli'ospedale as.
c)" Il lauoro, le uacaziani religiose e i matrirttani
Di ritorno da1 baliatico, verso i tre anni, gii esposti rimanevano
affidati alle cr-ire de1le donne di casa, 1e « commesse », le << serviziali >> e
qualcuna delle fanciulle più grané-i. |Jella famiglia ospedaliera, ad ogni
modo, l'elemento femminile doveva essere i1 più numeroso, sia per lamaggior affiuenza di bambine fra i piccoli assistiti, che per la loro minore
richiesta da parte delie farniglie e pef il loro piìi lungo indugiare in casa
in attesa- di un'emancipazione che, se tatdaYa a venire, avreLtbe finito
col conf;narle 1ì dentro per sempre.
Maschi e femmine venivano resi utili con l'a{fidare loro dei pic-
a3 << Ricordo come a dì 3 d'agosto, anno detto di sopra, rendemmo Giovan-pietro nostto a uno suo zio, il qr-ra'ie ha nome Antonio di Giovanni da Massa d.i
il{rr.--u, disse, detto Antoirio, éh" .ra suo nipote e. detteci per elemosina fiorinisei cioè sono liie trentadue, soldi otto. Nota che i detti denari sono messi a en-
trata>> (Memoriale di spese mintLte segn. B (.7459-1460),-5!, c.3);- per- come era
iiutà t".uto, si veda il^1ibro di Batie-e ban,bini seql.. B (1,413 1454), l4-,.c' 49)'aa « A' dì 17 di novembre, si renCé a messer Giovanni Gamucci,- ché è suo
figliolo e ayemoci a cav^te 1a bavetta (sic) e.dire ia merce d'ave11o allevato e te-
"i-,,o ao dì 2 d'agosto 1500, per iusino a dì detto, f91o ltti cinq';e o circa »
(LiOro a; bantbini-e balie segn. E tl4B7-17121.16. cc. 100. 102)'' 4s . Rendemmo Ie sopràdderLe {anciulie cioò Santa e Dornenica {anciulle. gio-
vedì a dì 7 di luglio, anno 1429, al padre e a1la ma<lre, portolle_Agnolo di Ravenna,
ttÀ puiènt" ,i (Èatie e bambini' sestt B (l4lJ !454), 14,. c.--21);. « X'{onna Checca
a""ri ai dr.r.. a-.rdre zli di Costanza sopr'addetta, rivollono la detta {anciulla
ù";;A ; dì 29 'di marzo 14J4 e si la rendé ioro io, {rate Checco, per l'amore diiior, (Boli, e banabini segn. B (L4L3-1454), L4, c. 24)'
I
$
§II
176 L,oSPEDAIE DI S. MARIA DELLA SCALA DI S. GIMIGNANO
coli incarichi che, se si esautivano tutti, come è ptobabile, nelle fac-
cende domestiche per quanto riguarda 1e bambine, mai menzionate nelle{onti, se non per qualche loro civettuola richiesta, come l'acquisto dipettini o di << sapone da capo >>, che il rettore bonariamente soddisfa-
ceva nei suoi viaggi a Siena o a Firenze, per i maschi, invece, forse im-
piegati normalmente nella vigna o nell'orto, potevano articolarsi anche
in piccoli servizi da sbrigare fuori dall'ospedale, inviati, come sappiamo,
presso le balie, Ie più vicine, o mandati qua e là per San Gimignano
a portare ambasciate o alfio, secondo le necessità 6.
Erano soltanto i maschi, poi, ma si ttaltava di un'altra regola
comune alla società del tempo, che potevano frequentare la scuola, an-
che sino ai medici, quattordici anni di età, come ci è testimoniato dalle
scritture relative agli acquisti di libri ed altto materiale scolastico, effet-
tuati per Checco e Caterino, due esposti rimasti a lungo nell'ospedale,
dal l41l al 1426, e i cui movimenti ci sono meglio conosciuti, grazie
alla presenza di varie scritture che li riguardano nei Memoriali e nei
ft Nei 142i, per esempio, toviamo Caterino a pagarc il notaio per Ia << roga-tura >> delie elemosine: « A ier Giovanni di set Matteo dei Becci da San Gimignano,a dì 5 di 1uglio, lire quattro Per sua {atica, ché ha togato le limosine che {a lospedale l'annò. Portò Caterino, nosffo fanciullo di cqsa >> (Entrata e uscita segn.I e K (1420-1422), 68, c. 18); nel L422, ttoviamo Checco inviato presso monnaCristofana, donna di Piero d'Agostino di Calzetta,-abitante -<<-denuo
in -San Gimi-gnano, n.i-lu contrada di San Gibvanni », balia di Girolama Silvestra: << Anne avuto, ai fO d'ottobre, lire due, portò Checco, nostro fanciullo di casa, messi a uscitadetto frate, libro B a c tta L4>> (Balie e bambini s-egn. B (L41'3'L454), 14' c.-.L4),.Interessanti per la composizione della famiglia ospedaliera sono poi le maoce dis6i-buite dal réttore per 1e ricorrenze religiose, da11e quali appare come lospedaleavesse in casa sempre un discreto numero di {anciulli resi dalle balie. Ne1 1422,veniamo a sapere c1ìe i bambini in casa erano cinque: « Alla famiglia di casa, p--er lamancia per 1à Pasqua di Natale, a di 24 di dicembre: a Giovanni, nostro-pellegri-niere, sò1di cinqug a Chelino,' nostro famiglio, soldi cinque,- a monna. Piera diBiancalana, nostra servigiale in casa, soldi cinque, a Checco, fanciullo di casa e a
Caterino e Lionatda e Giacomo e Taviana, tutti fanciulli di casa, a questi cinquefanciulli, soldi sette, sono in tutto soldi ventiduer> (Entrata e uscita.segn. I e K(1420-L424,69, c.'t3). La mancia, ad ogni modo, veniva data anche alle balie,òhe si fori".o iecate all'ospedale con i bàmbini loro altrdati, come sappiamo dalMeruoriale segn. D (141'l-1,-4L4), 41, c. 62, dove -leggiamo: « A -tre altri fanciulliche vennero ir, .uru con le balie de' detti {anciulli di sopra, soldi uno per uno,dessi in tutto soldi tre >>. Qualche anno prima ne1 1418 nel Meruoriale di spese
rninute segn. G e H (1'415-i420), 44, c. 48, i bambini presenti-erano sette: <<A'
nostri fanòiuli di casa e alle famiglie, a dì 24 di dicembie, per Ia mancia al fami-glio, soidi cinque, a 6e nostri {a.-nciulli maggiori, soldi tre, a quattro nostri fan-éiulii minori, denari otto per uno, in tutto soldi dieci, denari otto-»;- nove) come
intendiamo éal Catasto, l8i, c. 570, erano i bambini nel 1428 (ci _ri{eriamo natural-mente solo a quelli presenti in casa), dodici furono quelii trova_ti dal nuovo rettole,frate BartolouÈo di- Gherardino, ne1 L455 e indicati nel Libro d,i bali sg1n.. L(7456-L465), 1.5, c. L, menue dal' Cardsto, 997, c. 1.41 de1 1478 le presenze dei fan-ciulli nel1'ospedale sono sedici.
LA SORTE DEGLI ESPOSTI t77
libri di Entrata e uscita di quegli anniq. Nel 1419, per esempio, Checco
e Caterino, che allora avevano circa otto anni, ebbero due grossi d'ar-gento << per 1o dono che si dà al maestro della scuola >>
a8; nel L424, Lrettore prowedette ad acquistare per i medesimi d.u;e ragazzi, evidente-
mente allora gli unici in età scolare, << un paio di regole >> da ser Meo diPietro, il maestro ae; in quello stesso anno fu cohprato anche un<< ]ibro di grammatica, che si chiama Dottinale >>, da Piero, cartolaio,che stava << al palagio del podestà in Firenze >> e il medesimo giotno,<< da uno che vende libri in porta San Piero »>, si spesero ventiduesoldi per un alffo libro, << che si chiama Prospero >>
$; nel 1425, tn oc-
casione di un'altra del1e tante andate a Firenze, un alffo libro « chia-
masi Jsopo >>, fu venduto a1 rettore da un altro cartolaio, forse il solitodell'anno prima, che stava anche lui << in sul canto del palagio del pode-
stà »>, anzi << dirimpetto al detto palagio >> e, nel 1426, ancora delle<< regole da imparate grammatica >>, furono acquistate da ser Giacomo
di Cristofano dei Vecchi, cappellano dell'ospedale 51. Ma non sappiamo
vefamente se 1a scolarizzazione fosse riservata a tutti i bambini maschipresenti o se ci si limitasse a far seguire le lezioni ai più dotati, sta difatto che l'ospedale, forse per via delle troppe spese e per l'aumentodegli abbandoni, dovette col tempo in qualche modo owiare perché nei
a7 Particolarmente uascurata era, infatti, nel Medioevo, I'istruzione femmi-nile, poiché era opinione comune che non era bene che una donna {osse moltoistruita a meno che non avesse dovuto farsi monaca, cfr. E. Frulrr, Economia e oitaprioata dei f.orentini nelle rileuazioni statisticbe di Giouanni Villani, tn Storia del-J'econornia italiana, a cura di C. M. Cipolla, vol. I, Torino, L95?, pp. 126-36Ù,dove, nel particolare, si riferisce agli insegnamenti di Paolo da Certaldo.4 « A Checco e Caterino, nostri fanciulli di casa, a dì L6 di dicembre, per1o dono che si dà al maestro delta scuola, due grossi d'argento, portarono e dettifanciulli, soldi undici >> (Memoriale di spese nzinute segn. G e H {1.415-1420), 44,c. 71.).
4e << A ser Meo di Piero, oggi maestro della scuola, a d\ 29 di giugno, perun paio di regole owero verbagli, comperai da lui pe' nosmi fanciulli, cioi pe1Checco e Caterino, costarono quattro grossi d'argento (Entruta e uscita segn. I e K(1420-t422\, 69, c. 19).
s0 << A Piero, cartolaio, che sta aI paiagio del podestà in Firenze, a d) 22 digennaio, per uno libro di gtatnmatica, che si chiama Dottinale, comperai per inostri fanciulli, costò lire otto, soldi sette >> (Eatrata e uscita segn. I e K (1420't422),69, c. 21); <<A Firenze, detto dì, a uno che vende libri in porta San Pie1o,per uno libro che si chiama Prospero, pe' nosui fanciulli che vanno 411a scuola,èostò soldi ventidue >> (Entrata e uscita segn. I e K (1420-1422), 69, c. 21\.
51 << A uno cartolaio, che sta in sul canto dei palagio del podestà di Fiteoze,cioè dirimpetto al detto palagio, a dì 11 di luglio, per uno libro pe' nostri {anciulliche vanno alla scuola, chiamasi Jsopo, costò soldi venti >> (Entrata e uscita segn. Ie K (L420-1.422),69, c.24); <<A ser Giacomo di Cristofano dei Vecchi, rosro !ap-pellano, detto dì pér uno paio di. regole da imparare grafirr;,atica, pe' nostri fan-iiuUl <ii casa, cosiarono liré tre >> (Entrata e uscita segn. I e K (142A'L422), 69,c. 27).
178 L,oSPEDALE DI S. MARIA DEI,LA SCALA DI S. GIMIGNANO
libri di entrata e uscita successivi, le spese per la scuola cornpaiono
sempre più rare tra le voci di uscita e, forse, si prowedeva in casa, da
parte del medesimo rettore, ad una sommaria istruzione, awiandoli poi,prima possibile, all'apprendimento di un mestiere.
La migliore soluzione per i rovatelli era senz'altro quella del rirna-
nere presso le famiglie contadine che ii avevano presi a balia ma, nel pe-
riodo di cui noi ci occupiamo, il XV secolo, non è questa la sistemazione
più ricorrente, anche se le {onti ce 1a lasciano qualche volta sospettate,
come abbiamo più avanti accennato a proposito di quei lunghi baliatici
che non sappiamo quando si concludessero e i cui pagamenti si esau-
rivano oltre i tre anni, quando è probabile che il bambino in qualche
modo cominciasse ad avete anche lui i suoi piccoli incarichi nella fami-glia dei bali. Certo è che il tenere un trovatello in casa, ed erano ancora
i maschi i preferiti, per via del loro essere più adatti alle fatiche dei
campi, era pur sempre una benedizione e {u infatti << per l'amote diDio >> che monna Bartola, vedova di Martino, un <( commesso >> abi-
tante a Colle, si tenne con sé Pippo di cinque anni, ottenendo dall'ospe-
dale, ma solo per i primi tempi, otto staia di grano e un badle di vinoall'anno s2.
Più consueto è invece, e ci riferiamo sempre ai maschi, il ritro-varli inviati fuori a lavorare ma più spesso mandati presso qualche pie-
vano, fotse come chierici ma anche semplicemente come sacrestani o
sistemati come fanti presso qualche famiglia. San Gallo, ad esempio,
I'ospedale fiorentino per trovatelli al quale più volte ci siamo ormai rife-riti, eta un vero e proprio vivaio per i pievani in generale ma, in parti-
colare, per l'ordine dei vallombrosani, che vi si recavano a prender fan-
ciulli da iniziare alla vita religiosa s3. Certo è che, in ogni caso, non
doveva essere facile inserire questi ragazzi in una realtà quotidiana a
loro sconosciuta, dopo i lunghi anni passati fra le sottane delle donne
e le tonache dei frati sa. Pet Iacopo Filippo, per esempio, partito dal-
s2 Balie e barubini segn. B (1,413-1454), 14, c. 6.53 Era forse questa la sistemazione che si riteneva più adatta e conveniente
per i trovatelli e all'ospedale di San Gallo di Firenze, non sono pochi- i bambiniawiati al convento o posti presso qualche pievano e, particolarmente interessanteci è sembrato il rirovarvi a cèrcare nuovi adepti per il loro ordine, i vallombrosani.Per queste notizie, facciamo ancora una volta riferimento al libro di Balie e baru-bini (1394-1401), 6, cc. 224-225 (le carte indicate si riferiscono ai bambini dati a1-
l'ordine dei vallombrosani), ptesente nel fondo relativo all'ospedale di San Gallonell'Archivio dell'Ospedale degli Innocenti di Firenze.
54 C. A. Consrxr,, Materiali per lo studio della t'arnigli.a in Toscana q],:2_p.999,a proposito degli esposti degli IÀnocenti di Firenze per i- secoli XVII-XIX,--nota:« leggèndo infaiti le-singole storie individuali (narrate in forma sringata nelle pa-
LA SORTE DEGLI ESPOSTI 179
I'ospedale il L2 ma,,o del 1429, all'età di quindici anni, per una nonprecisata destinazione ma, forse, data 1'età, al servizio di una qualchefamiglia del posto, si dovette registrare clopo appe,a dodici giorni dallapartenza il suo rientro, commentato da un « fecici poco onore, conven-ne che fosse accomiatato » e la sua vicenda si compì dopo appena cin-que mesi, forse, chissà, vittima di una di quelle tante epidemie che mie-tevano i rug,azzi in casa durante i mesi estivi, con un << mcrì domenicanotte, a dì t7 di settembre anno 1.430. È seppellito nella nostrachiesa i> ss' Anche Tommè, Lln esposto di dieci ,*i, .h. era stato ac-colto << infermo e con molti difetti >> sei anni prima, inviato nel 1455,<' su preghieta dello zio e della zia >>, presso ser Giovanni, cappellanodi ser Ftancesco, << piovano di Santo Apprano >>, che gli diede subito,come dono, venticinque lire, promettendo <, sulla sua càrcienza >>, << chefacendo bene gli farebbe altro »>, dopo pochi mesi, << tornò a casa daPoggibonsi e disse che I'aveva cacciato ser Giovanni, al quale l,avevadato ftate Bartolomeo »>
$.
Niente di tutto qllesto successe invece a Giovanni, chiamato incasa Sandro che, nel L438, a quasi tredici anni, maturò Ia decisione,la più tranq*illa e comoda per tutti, di farsi <<frate di santo Francesco »>,
passando così da una comunità all'altra e neppure tanto lontano dal-I'ospedale e pirì confortanti sarebbero state anche le notizie sulla collo-cazione dei bambini allevati dalla casa ner xIV secolo, come veniamoa sapere dal Libro di dioerse materie, ,no dei pochi recanti testimo-nianze del tempo 57. Nel r34r, troviamo infatti nominato Agostino, << un
flin:,.{.i registri; si tenga presente che si trarra comunque di rcsistrazioni avenriunarlta ammrnrstrativa) non. si può non essere colpiti dalla tragiòa vita a, Àoiridi quegli « Innocenri " Molti-pei t pir't*"i',n^r.rii. nr-ari piirii-r"ri'à"nuncianocomportamenti devianti: irrequieti, in, fuga continua, .frrttu'ti; iporo ìorr,rno ,Firenze.per essere ricoverari ià ospedale, 6enchc i_ tiÉ.ruÀ"nti-'r,,;;;;;;r.'piuttostoduri nei confronti di chi non aveise buona .".o à.gfi-;;;;i- .ÀAudt;ss << Partissi il detto Giacomo, a di r.2 di màrzo,
'aano 1429 "e fecici pocoonore, convenne che fosse accomiatato e ritornò a dì'2) di matzo, anno detto
1429 »_.(Balie e barubini segn. B (1413-141,4), 14, c. 7).,56 <<Ricordo come ogg:, questo dì r0 di setiembr'e, r 55, noi rendernmo Tom-mè di Pasquino a ser Gig.vangi, caqp,eilano di-Àesser rrrn..i.o,"plài^no ai sun,o
$nn;*"' còn preghiera. delto zio " àètt" iìà..àrt ,i di*;-;;;r";'^;io'i"o r.na.rri.Ser Giovanni detto sli {o.nò {i suo,_lire venticinque e disse, s"lla lua-coscienz_a,..L.^-f,.-d: !-.ne gli-farebbe.rtt.
".'O.p9. p-o.tì"ri.rl. n.flà ,i.rro'.rrii. i.gd.n,o,: tol.l" a casa da Poggibonsi, dis_se che l'aveva cacciato ser Giovanni, rrieiàno diSant'Appiano, al qrrale I'aveva dato frate Bartolomeo,, (Libro di iafi- ,rgr. i(1456-1465\, 15, c.7).
57 << Nota sandro sopraddetto, nostro di casa, si fece frate di santo Francesco,a.dì 4 di maggio. 1438, Iddio gli conceda grazia'che rrrui iàniÀr,r'(Èot), , bn*-bini segn. B (14D-1454\, 14, c,- 20\.
180 L,oSPEDALE DI S. MARIA DELLA SCALA DI S. GIMIGNANO
fanciuilo allevato in casa »>, mandato presso Vanni, pellicciaio, per unfiorino 1'anno e poi presso Petruccio e Cotso, anch'essi pellicciai, per
8 lire, l'anno successivo e poi via via riconfermato, sino al 7346, men-
tre Niccolò, un altro trovatello, nominato ua le memorie del 1343,appare inviato presso Antonio di Vigo, calzolaio, dapprima per 40 soldi
arurui più iI << calzamento )> e poi anche lui a 8 lire l'anno, riscosse, inentrambi i casi, regolarmente, dal rettore delI'ospedale e ciò, probabil-mente, almeno fino a quando i ragazzi continuavano ad abitatvi s8.
Definitivamente licenziati dalI'ospedale non doveva esser raro poiche i più finissero col condurre un'esistenza rr.iseta se non proprioquella dei vagabondi, che li vedeva talvolta tornare a bussare a1la portadelf istituzione come un qualsiasi altro povero o pellegrino di passag-
giose. Nel 7425, Andrea di Sacchetto, << uno dei {anciulli allevati incasa )> ma già andato via da tempo, fu accolto per parecchi giorni, << per-
ché povero gafione »> e utiTizzato nella stacciatura della farina per Ieelemosine e l'anno dopo, sofierente di un dolore ad una spalla, lo tro-viamo di nuovo presente in casa e 1o sappiamo inviato a curarsi al<< bagno >>, a spese dell'ospedale @.
La ricerca di una casa onorata, che si assumesse f impegno della
s Dopo un primo anno di lavoro con Vanni, « pellicciaro r>, per un fiorinod'oro all'anno, si legge: << Ponemo Agostino, nostro allevato, con Masuccio e Corso,pellicciai. Comincia l'anno per calende di settembre >> e la paga era ota di otto lireannue. Sempre per questa paga ne1 1346 ffoviamo: << Riponemo Agostino con MasoPellicciaro, per prezzo d'otto lire l'anno, comincia l'anno in caiende di dicembre,anno L346>> (Libro di diaerse nxdterie (1394-1490),10, cc. 14-15). Nel 1343:<< Ponemo Niccolò, nostro fanciullo, con Antonio di Vigo, calzolaio, e diegli dareI'anr-ro il calzamento e quaranta so1di. Comincia l'anno in calende di novembre1343 »> (Libro di diuerse tndterie (1394-1490), 10, c. i4). Per quanto riguarda lapaga, intendiamo che fosse riscossa dai rettore e che questi abitassero nell'ospedaieàlmeno sino ad un'età di uedici, quattordici anni: << Ave dato Antonio di Vigo, perNiccolò, nosro fanciullo, quaranta soldi per l'anno passato >> (Libro di diuersematerie (1.394-1490), 10, c. 14).
5e Anche J. P. GuttoN, La società e i. poueri cit., pp. 11-73, a proposito cieldestino riservato ai movatel1l, riferendosi alTa Francia dei XVIII secolo afierma che« gii atchivi ospedalieri ci dicono che numerosi sono quelli che {uggono, si arruo-larrc nel1'esercito, o più semplicemente si danno ai vagabondaggio. Quando rie-scono a fermarsi in una parrocchia, ne costitu.iscono sempre la parte piir misera, lamanovalanza >> pet cui continua I'autore « il fenomeno dell'abbandono dei neonaticonftibuisce dunque ad aumentare il numero dei poveri e anche dei vagabondi ».
6 « Ad Anarea di Sacchetto, dei nosti fanciulli allevati iu casa, a dì 20 didicernbre, venne a starsi parecchi dì in casa con esso uoi e stacciocci parecchi sac-
chetti di'farina e poi, allà partita, gli diedi soldi sei, perché povero gatzone>> (Me'noriale di spese rninute segn. K (1422-L425),45, c.91); «Ad Andrea di Sacchettoda Colle, déi nosti fanciulli allevati in casa, a dì 9 d'aprile, grossi quindici d'ar-gento per l'amore di Dio, petché povero e perché potesse andare a1-baggo per gua-
iire diuna doglia ch'egli ha nel1a spalla. Valsono lire quattro, soldi due, denarisei>> (Entrata e uscita segn. I e K (1420-1422),69, c.2r-).
LA SORTE DEGLI ES?OSTI
educazione delle bambine in cambio, come crediamo, del loro aiuto nellefaccende domestiche, era uno degli scopi che l'ospedale si proponevauna volta che se Ie vedeva riportare dalle balie ad accrescere il numeroe il dafiare di quelle già presenti in casa. Dall'altra parte, doveva essereprincipalmente il desiderio di ben operare a spingere Ie {amiglie a pren-dere con sé una di queste fanciulle che, se è vero che venivano awiatepresto ai lavori di casa, erano pllr sempre, per la giovanissima età, daguidare e assistere in tutti i loro bisogni, cioè da << governare »>, <( comeloro figliole >> e più che altro da maritate « a1 tempo >>, il che compor-tava la costituzione di una dote, alla quale le bambine avevano dirittoanche quando la famiglia, pentitasi, le avesse rimandate all'ospedale. Inun caso, tuttavia, per l'età molto bassa della bambina, che aveva pocopiù di due anni, furono di sicuro i forti legami afiettivi instauratisi a fardecidere i bali, monna Lena e Agnolo di Giuliano di Bernacca di SanGimignano, a prendere << per loro figliuola Pietra >>, il L6 gennaio del1500, impegnandosi << al tempo a maùtarla >> e a darle di dote << fioriniventicinque di loro proprio )>, secondo 7'usanza della casa, senza contare,come si volle specificare, << nella detta somma di fiorini venticinque )>,
<< i panni lini e lani »>, che avrebbero dovuto fornirle a pafte e stabilendoche se << pef caso »>, << di qui a quatfto o cinque anni », si << rendessela detta fanciulla, abbi a ogni modo a darc la dote >>
61. Monna Lena,intatti, aveva alTattato la barnbina per più di un anno e datala poi adun'alta balia, monna Pulisena di Bartolomeo del Bene di Certaldo, peraltri quattro mesi, si era afrtettata a richiederla subito dopo per 1o svezza-mento, tenendola con sé un altro anno e, infine, awicinandosi il mo-mento del distacco definitivo, si era decisa col marito a teneda persempre 62. Quasi otto anni aveva invece Marietta, il 10 giugno del1508, allorché venne data a Zanobi di Piero d'Antonio Bisoci da Prato,<< per sua figliuola >>, con l'obbligo di maritafla << in capo d'anni dodici >>,
con una dote, questa volta, di 50 fiorini << a uso di Prato »>, da corrispon-dere, come al solito, in ogni caso all'ospedale anche << quando mai la
61 << Nota come a dì 16 di gennaio, 1550, demmo al sopraddetto Agnolo e a
moma Lena, sua donna, la sopraddetta fanciulla per loro figliubla, ta qualé hanno atenere e governare come loro figliola e al tempo maritarla e devole di dote fioriniventicinque di loro proprio, com'è della casa e non gli contare panni lini e laninella somma di fiodni venticinque a lire quatuo e soldi due per fiorino e quandoper caso nessuno di qui a quatro o cinque anni rendesse detta fanciulla, abbi a ognimodo a dare la dote e diritto e consenso di ser Giovanni Battista di Francesco daSan Gimignano, presente Benedetto Ridolfi, Iacopo di Bernardo Bardelli da SanQimignano >> (Libro di barnbini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 97).
62 Libro di barubini e balie segn. E (L487-L512),'1.6, cc.85,95.
181
182 L-OSPEDALE DI S. MARIA DEILA SCALA DI S. GIMIGNANO
rimandasse >>63. La restituzione delle bambine all'ospedale poteva infattirealmente avvenire, come era capitato vari anni prima, nel 1,443, a Bar-tolomea, figlia legittima di Giuliano Salucci da San Gimignano, che furesa all'età di undici anni, da Lrna cetta monna Margherita di Guargua-g1ia, che la teneva ormai da quasi sei presso di sé e. Non conosciamo
le ragioni della restituzione ma tre anni dopo, ne1 1446, probabiimentematurata l'età minima consentita per entrare in convento, la bambina,come ebbe a scrivete per l'occasione il rettore, <( con sua volontà e no-
stro consentimento >>, << entrò nei monastero di Santa Caterina di San
Gimignano »>, fornita deila dote di cento lire, probabilmente quella stessa
che Ie era stata costituita dalla famiglia presso la quale eta rimastacosì a lungo 65.
Ma se queila di Sandro, che si fece frate francescano nel 1438 equesta di Bartolomea, possono considerarsi per quanto le {onti faccianocapire delle libere scelte e forse delle vere vocazioni religiose, non cipate che così sia stato per Antonia, un'esposta di diciassette anni che,ormai promessa sposa dal 5 settembre del 1490 ad un certo Giovannidei << maestro Giusto da Cortona >>, abitante a Poggibonsi, dopo remesi, << sprrata da Dio, deliberò non voler servire al mondo >> e, << di sua
volontà, volse farsi religiosa e entrare in uno monasterio », che fu poique1la di Santa Maria Maddalena di San Gimignano, posto sotto la dire-zione di suor Elisabetta, << fr.glia di Agnolo de' Becci >>, che era << aI pre-sente abadessa detto monastero »>
66.
63 Marietta, venne data, il 10 giugno de1 1508, a Zanobi di Piero d'AntonioBisoci da Prato << per sua 6g1io1a e debba maritare in capo d'anni dodici e debbiledi dote fiorini cinquanta, a :uso di Prato, di quattro 1ire, quatto soldi per fiorino.Di tutto è rogato ser Antonio, nostro procurxtore, detto ciì e quando mai 1a riman-dasse l'ha a dare a ogni modo e fiorini cinquanta per la sua dote, d'accordo tutto »>
(Libro di barubini e balie segn. E (7487-L5L2), 16, c. L16).s << Riavem.rno Bartolomea sopraddetta, domenica sera a dì 6 d'ottobre, annoL443, rimenolla monna Maddalena, nosffa commessa, àlia tenuta monna Margheritadi Guarguaglia, cinque anni o circa >> (Balie e barubini segn. B (1.413-1454), 14, c.27). Nel 1128, sappiamo che i Guarguaglia erano ricchi lanaioli e possidenti, cata-stati per 1297,8 froini, cfr. E. Frurrr, Storia econonzica cit., p,175.
65 << Nbta, Bartolomea, figliuola di Giuliano Salucci da San Gimignano, intròne1 monastero di Santa Caterina da San Gimignano, a dì 8 d'agc,sto, amrc 1446,con sua volontà e nostro consentimento, cioè di me {rate Checco d'Agostino, oggisindaco e procuratore dello spedale e deve avete di dote, per l'amore di Dio, lirecento>> (Libro dì diaerse materie lJ94-1490), 10, c. XIII).
66 << Memoria sia come oggi, a dì 5 di settembre 1"49A, abbiamo maritato unadelle nostre fanciulle di casa, demola a Giovanni di maestro Giusto da Cortona,abitante oggi in Pogglbonsi e ì detto che fu in Ccmenica, 1e diè l'anello, cioè a
dl , di settembre e noi 1e dobbiamo dare per ia sua dcte iire cento di denari,delie quali lire cento ce ne fa tempo tre anni, cioè 1493, fin.endo a dì detto disopra, come di tutto ne fu rogato ser Giovanni di Mariotto di Bartolo Casini, no-taio, che prese rogo di tutto il sopraddetto a1 tempo di flate Arcangelo, priore a1
LA SORTE DEGLI ESPOSTI 181
La vita claustrale, tutto sommato, a giudicare dalle poche ade-
sioni, pirì o meno tagionate, riscontrate fra i nostri esposti, non allet-tava. gran che né i ragazzi né le fanciulle, forse per quel suo troppoassomigliare a1 tipo di vita da sempre condotto nelI'ospedatre che, come
sappiamo, era retto da oblati che segu.ivano 1a regola degli agostiniani.I rugazzi si allontavano più volentieri dalla casa col dedicarsi ad un me-
stiere e le ragazze preferivano di gran lunga rifugiarsi nell'istituzionedel mamimonio che in quella del convento, né bisogna dimenticare che,
male, male, potevano sempre anche loro vestire I'abito delle oblate e vivere nell'ospedale sangimignanese o in alri dipendenti da Siena, al
modo dei religiosi, dedite ad aivtare il prossimo.
L'ospedale stesso, ad ogni modo, pateya più propenso a sposarle
che a monacatle e nessun problema si ebbe mai per trovar loro un ma-
dto che, quasi regolarmente, a volte magari con l'aiuto di terze persone,
veniva reperito tra i tanti contadini di San Gimignano e dei dintorni e,
talvolta fra i mezzadti dello stesso ospedale, desiderosi di aocasarsi eforse in difficoltà per la ristretta scelta deile fanciulle disponibili ma,più probabilmente, invogliati dalla dote messa a disposizione da1la casa
per le sue assistite che, fotse, rappresentavano anche, con l'essere delletrovatelle, una sorta di buon augurio per la famiglia che s'intendevaIotmare che, certo, avrebbe attirato su di sé la divina ptotezionen. Lacampagna, insomma, {.avoriva la sistemazione delle trovatelle, anche diquelie accolte negli ospedaii cittadini, che convolavano per ia maggiorpafie a nozze con giovani del contado 6.
Comunque fosse, le esposte si sposavano pfesto, secondo i1 costu-me detr tempo, che vedeva le donne prender marito molto giovani ad
presente di questa casa>> (Libro di diaerse rnaterie (L394-L490\, 10, c. CXI); << Nota,come la sopraddetta fanciulla, spirata da Dio, deliberò non voler servire al mondoe serv.ire Dio. Di sua volontà volse farsi religiosa e entrare in uno monasterio ecosì enrò ne1 monastero di Santa Maria Maddalena di San Gimignano a dì 5 didicembre, anno 1490, al tempo di suor Elisabetta, 6glia di Agnoio de' Becci diSan Gimignano, a1 presente abadessa detto monastero e a dì 15, detto mese, fe' perfral Mone, con ogni debito modo che si richiede »> (Libro di diaerse materie (139'4-1490), 10, c. CXI).
0t 1, L. Fr.axnnrN, Atnori contad.ini, MILano, 1980, pp. L9-20, afrerma che<< esistevano nelle campagne d'una volta forti tendenze all'endogamia geografica, chespingevano a prender mogiie nel raggio di qualche chilometro. In queste condizionigli impedimenti di parentela limitavano fortemente ia possibiiità di scegliere unaprima moglie, e ancora di più una seconda >>.
68 È questo il caso riscontrato agli Innocenti di Firenze da C. A. ConsrNr,Materiali per lo stud.io d.ella lamiglia in Toscana cit., p. 1000, per il XVII e XIXsecolo e, personalmente, nell'ospedale fiorentino di San Gallo, dove i matrimoniritrovati nel solito registro di Balie e bambini (1394-1.401.), 6, cc. 214-21.5, dove siconservano le memorie di queili avvenuti tra il 1303 e 11 1,404, ebbero come ricirie-denti tutti giovani della campagna intorno a1la città.
-/
t84 r OSPEDALE DI S. MARIA DELLA SCALA DI S. GIMIGNANO
una età media intorno ai quindici anni e forse a meno che oltre. Vermi-glia, ad esempio, << delle fanciulle di casa >>, figliuola di un certo pinod'Agnolo di ser Pino, fu rnafitata il 28 aprile del 1.443, a soli tredicianni a Biagio d'Agnolo di Bartolomeo da Vico Fiorentino, abitante aCertaldo 6e. Vittoria, << fanciulla di casa, figliuola di una schiava di Ste-{ano Moronti di San Gimignano »>, fu matitata anche lei, il 12 febbraiodel 1446, ad un cerro Bartolomeo di Giovanni, abitante a Uliveto, << vi-cino a Montespertoli » nel << contado di Firenze », a quattordici anninon ancora compiuti 70.
Probabilmente dovuto al caso, ma tuttavia da sottolineare, è poi ilfatto che particolarmente le illegittime delle ricche famiglie sangimigna-nesi trovavano tutte, come abbiamo visto anche negli esempi prece-denti, abbastanza alla svelta un marito anche se, come sappiamo, talvolta,con l'intervento di mediatori. Fu grazie a Marco di Meo di Marco, baliodi Verdiana in quell'anno, mezzadto dell'ospedale e <<tnezzano >>, che sisposò infatti, il 18 febbraio del 1458, a soli quattordici anni, Melania,« fanciulla di casa »>, << figliuola di don Agnolo di Macherone degli squar-
@ « Vermiglia_ delle noste fanciulle di casa e figliuola di pino d,Agnolo di serPino, secondo mi fu detto, madtata a Biagio d'Agno'io di BarLolonreo d-a Vrco Fio-ry-nti1o, oggi abitano a Certaldo, contado
-di Firenze, ebbe l,anello domenica a dì
28 d'aprile,_ anno ,'1443,, rogato ser Ambrogio di Francesco di Brogio da San Gimi-gnano. Debb.egli dare-di dote,lire- cento in questo modo cioè in denari lire cinquantae tutte que11e cose .che noi Ie dessimo, panni lini e lani, stimarle e fare la
-stima
sopra le ,cinquanta lire e se la stima di detti panni è appresso a1la somma di lirecento, $ebbogli. Arnai per insino nella sopraddètta sommi di lire cento. Il soprad-detto Pino oggi abita_a Certaldo. AndonnJa marito giovedì, a d\ 20 di giugno annodetto. Iddio le dia buona ventura. Anne avuto detto dì, Biagio, suJ mlrito, incontanti Iire sessantaquattro, messe a uscita di frate checco d,Agostino, libro B,c. 19,. sono,per parte di pagamento. Anne avuto a d\ 27 d'ottobre, anno 1.443,Lireundici, soldi quindici per compiemento di pagamento per infino nella somma dilire cento. Queste due partite sono tutte contànii, -.s. i uscita detto frate checcod'Agostino,,a detto libro a car_ta. 19. Nota, le donagioni ebbe in panni lini e lani,montarono. lire ventiquattro, s-oldi cinque, stimati pei placito di Fràncesco di Brogioda San G-imignano >> (Libro di diuerse ruateùe (1394-1,490), 10, c. XIII).. ^
70 <<Nota, goqe a dì 12 di febbraio anno 1-446, io"ftate Checco'd,Agostino,da_-san Donato -in Poggio, oggi sindaco e procuratore
'dello spedale di santa" Maria
de1la Scala ^di -
San _Gimignano, maritai Vittoria, fanciulla di ^casa,
6gliuo1a di unaschiava di Stefano Moronti da San Gimignano, non so chi fu il padie, maritamoladetto dì 4i ryp., a Barrolomeo di Giovanni, abita a Uliveto, pr..ro- a Montespertoli,contado di Firenze e debboli dare fiorini venricinque, a ràgione di iire quatmo,soldj due. per _fiorino. Rogato ser_ Oddo di ser Ambiogio da -San
Gimignano e piùa dì 9 di luglio, anno 14-{7, sodò la dote Cesare e Bartolomeo, maritò detta f'an-ciulla e il fratell-o, nipote detto cesare. Rogato ser oddo, detto di sopra. Anne avutodetto mese di luglio, anno 1447, fiorini-venticinque, iom. upp"r.^ a uscita detroffate, libro-.segnato P, catta 27, valsono lire centòdue, soldi 1b, rogato detto serQd{o.. Fu 4.prtto co_n Cesare, zio di Bartolomeo, ch'io non dessi più"niente, se nonfiorini venticinque. Ebbe una cioppa come nuova e uno guarnello usato. due cami-cie nuove. Andonne a marito martedì, a dì 25 di luglio, anno detto, sia al nomedi Dio e di buona ventura >> (Libro di diuerse ruaterià 6j94-L490), 10, c. XIII).
T
LA SORTE DEGLI ESPOSTI
cialupi di Poggibonsi >>, che {u data a Mafiano di Iacopo di Lioncinoda Bibbiano e fu da Andrea di Buonanni, ex balio di Tommasa nel 1456,e da Piero << chiamato per soprannome Pelasuo, amendui da San Gimi-gnano )>, che fu combinato nel 1464, i1 5 novembre, il mamimonio diBiagina, di sedici anni, << figliola d'Antonio di ser Polito dei Brogi diSan Gimignano )>, con Domenico di Bartolo dal Palagetto e abbiamo ra-gione di credere che i due sposi fossero dei mezzadri dell'ospedale, siaperclré le memorie dei mauimoni sono presenti ne7 Libro delle posses-siot't.i segn. D awiché, come di consueto, nel Libro di diuerse rnateriema, più che almo, perché la liquidazione della dote non avvenne con-temporaneamente al matrimonio o, al massimo, entro pochi mesi dalladata di questo, bensì in tante piccole rate in più anni, secondo la solitaprassi adottata dall'ospedale nei pagamenti ai dipendenti 71. Melania,infatti, ne vide ultimare il pagamento dopo otto anni, nel 1464, annoin cui fu costretta a chiedere 11 lire e 9 soldi per una << cioppa >>, forseuna di quelle cornprese nei « panni » della dote, data in pegno al << giu-deo >> e Biagina, ancota nel 1,466,1a troviamo anche lei a chiedere 4lire e 3soldi « per resto de1la dote >>
72.
La dote corrisposta dall'ospedale alle fanciulle che si sposarono neglianni da noi presi in esame, ammontò a 100 lire, date secondo l,usanza,metà in panni e metà in contanti; solo verso la fine del secolo alle 100
71 «.Mrclania, ,nosra fanciulla di casa, figliuola fu di don Agnolo di Mache-rone_degli squarcialupi da,Poggibonsi, maritamola a Mariano di Iaòpo di Lioncinoda Bibbiano, a dì i8 di febbraio 1458 e de' avere per la sua dotè, fra panni edenari contanti, lire cento contando detti panni, e così-ebbe l'ane1lo a-dì 18-di feb-braiq anno detto 1458. 17 mezzano {u Marco di Meo di Marco e così n,è rogatoser Francesco di Francesco Salucci da San Gimignano, lire cento »> (Libro delle
"pos-
se-ssioni .segn. D (1453-1602), L, c. 32); « Biagina, nosrra fanciulla di casa, figliuolad'Antonio di ser Polito de' Brogi di San Gimignano, maritamola lunedì matlinu adì 5 di novemòre, anno detto, 1,464, e così ebbe l'anello a dì detto di sopra. Lamatitammo a Domenico di Bartolo dal Palagetto, oggi abita a San Gimigìano edeve avere per la sua dote, fiorini venticinque, cioè lire cento di denari co-ntanti epanni com'è ad usanza e questo matrimonio fece Andrea di Buonanni e Piero, chia-mato pet s_oprannome Pelasuo, amendui da San Gimignano, rogato ser Francesco diFrancesco Salucci da San Gimignano, lire cento »> (Libro dellà possessioni segn. D(1453-1602), I, c. 56). Per i precedenti rapporti di baliatico inteicorsi fra l'ospedalee i «mezzani»> in questione, rimandiamo al Libro di bali segn. L (1456-1465), 15,cc" 41, 49, 60,64.._ n Le partite de1la dote pagate a Melania e al marito, compresa quella relativa
alla necessità di richiedere la «cioppa>>, compaiono sempre nel-Libro- delle posses-sioni segn. D (L4fi-1602), 1, cc. 59-60 e il giorno in cui andò sposa ebbe sòlo 11lite: « Alla Mela, _nostra di casa, a dì 28 di luglio, lire undici, quando la mandam-mo a marito >>, che leggiamo però, questa volta, nelr Memor:ialè di spese minutesegn. B. ,(145_9 L4_60), 5L,_c. 71. La pattita a favore di Biagina, Ia troviàmo, invece,nel 1466 nel Libro di En_trata e uscita segn. B (1465), 76, c. 100, dove si legge:'« A Biagina, nostra fanciulla, lire quattro, soldi tre, sono per resto della dote, comeappare al libro dare e avere giallo, c. 57 >>.
185
186 L,oSPEDALE DI S. MARIA DEI,LA SCALA DI S, GIMIGNANO
lire, iiquidate ora tutte in contanti, si aggiunsero i panni, sino ad un
valore complessivo di 130 lire circal3. Maffia, afldata sposa ne1 luglioàel 1439, a quindici anni, a N{eio di Niccolò, abitante a Pogna ne1
contado di Firenze, << ebbe di dote lire cinquanta di denari e in dona-
gione iire cento, in questo modo: cioè tutti panni lini e lani, tovaglie,
sciugatoi >>, il valore dei quali, secondo 7a stirna fatta da ser Placito diBrogio, ammontò a 42 lire e 2 soldi e <<7'avanzo ebbe di contanti >>74.
Caterina, invece, andata sposa il 21 luglio del 1482 ad Agostino di Bar-
naba di Meo da Tettazzano, << lavoratore >> dell'ospedale alla Croce, ebbe 32
fiorini (a 4 lire e 2 soldi per fiorino, cambio costantemente indicato nelle
{onti per Taliquidazione delle doti), di cui25 in contanti e il resto in panni
e cioè: << due cappotti usati, un gonnellino, quattro camicie nuove, quat-
tro sciugatoi e due tazzoletti, cinque benducce, uno sciugatoio grosso,
tre f.azzoletti tra nuovi e usati, tre giubbini, due nuovi e uno usato, tretele, un camiciotto usato, due cintole di cuoio nere >>
7s. Anche il pagamento
della dote Ci Caterina avvenne, a confermare f ipotesi {ormulata per Me-
lania e Biagina, le cui memorie dei matrimoni abbiamo ritrovato, come
anche questa di Catetina nel Libro delle possessioni segn. D, in piùvolte e, precisamente, in sei tate, una del1e quali fu richiesta dalla gio-
vane sposa per acquistate « due cintole di seta pura fornite d'argento >> 76.
73 Nel XIV secolo, come sappiamo daile solite memorie conservat. nel Librodi diuerse tnaterie (7394-1490), 10, cc. VIII, XII, 1'ospedale corrispondeva 50, 60lire ffa contanti e << donamenta )> mentre in quegli stessi anni, l'ospedale fiorentinodi San Gailo, corrispondeva già cento lire di dote alle sue assisti[e, date però ailostesso modo di San Gimignano cioè << secondo L'usanza >>, metà in contanti e metàin << altre cose )>, come sappiamo dal registro di San Gallo, intitolato alle Bo"lie e
barnbini (7394-1407), 6, cc. 214-215.7a <<I,tIaffia, fanciuila nostra di casa, maritammo a Meic di Niccolò, oggi abita
a Pogna, contado di Firenze, etrbe l'anello a dì 19 di luglio, anno detto, 1439, ebbedi dote lire cinquanta di denari e in donagione lire cento in questo modo, cioètutti paru e lini e lani, tovaglie sciugatoi e ogni altro che avesse avuto, fu sdmatoper Placito di Francesco di Brogio, lire quarantadue, soldi due e 7'avanzo ebbe dicontanti da me frate Checco sopraddetto e di donazione 1e fece Meio, suo marito,lire dieci. È per tutto la sua dote lire centodieci, rogato ser Ambrogio di Francescodi Brogio da San Gimignano, oggi procuratore dello spedaie. È a dì 27 di settem-bre, anno detto, andò a marito col nome di Dio amen >> (Libro di diuerse ilxatelie(1J94-1490), 10, c. XIIi).
7s <<Caterina, nosta fanciulla di casa, maritata ad Agostino di tsetnaba diMeo da Tettazzano e deve avere per 1a sua dote fiorini trentadue, a soli ottantadueper ciascuno fiorino, che così 1a promise Irate Arcangelo, priore del1a casa a1 pre-iente, cioè fiorini venticinque contanti, più sette monterà al loro conto e debito con7a casa, d'accordo con Barnaba, suo padre, con Gostino, marito de1la Caterina, lirecentotrentuno, soldi quatuo >> (Libro delle possessioni segn. D (1453-L602), 1, c.78).I1 corredo è descritto, invece, nel Libro di diaerse rnaterie (1394-1490),10, c. CVII.
76 Ad assicurarci che i matimoni gegismati sti, Libro delle possessionisegn. D, fossero quelli riguardanti sposi reclutati tra i mezzadtt de11'osp,edale,
sappiamo per certo che Agostino era all'epoca << lavoratore alla Croce >> e anche in
LA SORTE,DEGLI ESPOSTI L87
Maritate, a parte i normali rapporti intercorrenti a volte ancora per
lungo tempo per via del pagamento della dote, le << fanciulle allevate incasa )> e i loro mariti, i << generi >>, rimanevano costantemente in contatto
con I'ospedale al quale si rivolgevano per gli acquisti di vino, grano,
carne di porco ed altro che potesse loro occorrere e anche per averne
lana, lino e stoppa da filarc e da tessete ma più spesso per chiedere an-
ehe loro bambini da alTattare e da divezzsre. Nel 1454, Gfuolama Silve-
stra, una delle << fanciulle allevate in casa >> e moglie dal 1435 di Paolo
di Meo da Petrognano, mezzadro di Antonio di Vannozzo Sertagli, com-
parc ffa le balie di Elisabetta, una bambina datale a svezzatez; nel
1490, anche Piera, maritatasi l'anno prima con Lorenzo fi Catone da
Gambassi, Ia troviamo intenta aà allattarc e curare Pollonia, un'espo-
sta dell'ospedale, rimasta << inferma più settimane >> e, nel 1497, è lavolta di Meia, donna di Michele di Poggibonsi, << figliola de1la casa »>,
balia di Ftancesca Piera, che le era stata data ad allattareTs.
Se, come abbiamo visto, per i maschi la porta dell'ospedale era
sempre pronta ad aprirsi nel caso vi ricorressero per bisogno, una volta
licenziati, per le fanciulle pare esistesse invece addirittura un obbligo
ben preciso a seguirne le vicende de1la vita famtTiarc in modo da poter
intervenire tempestivamente qualora se ne ptesentasse la necessità. Inpoche parole, non era consentito alle << ex fanciulle di casa »> di vivere
in situazioni che in qualche modo, per la loro ambiguità, potessero dare
adito a chiacche.re e sospetti e, se rimanevano vedove o sole, f inter-vento era anche in questo caso immediato. Fu così per Caterina di Chi-
mento, << delle nostre donne s'allevò nello spedale >> che, nel 1449, i-masta sola, forse vedova ma più probabilmente abbandonata dal marito, fuaccompagnata all'ospedale di Siena per entrarui come oblata, sistema-
zione che però la donna rifiutò col dire di << voler esser cefta >>, prima diprendere i voti, della scomparsa del maritoTe.
questo caso la dote, per la quaie si era specificato che rimaneva << a loro conlo e
debito con la casa>>, ienne liquidata come già per Melania e Biagina in più volte,come dal Libro dellb possessioni segn. D (L453'L602), L, c.79,-dove co-mpare anchela motivazione per l'aèquisto delle i< due cintole di seta puta, {ornite d'argento >>.
77 Libro di bali sesn. L (1456'L465),'1,5, cc.2,4.78 Libro di bambini e balie segn. E (I487-L5t2\, L6, cc. 5L,74.7e Cateina di Chimento fi rc[ata all'ospedale senese, a1la presenza del rettore
di,là, al quale « Caterina detta di sopta, disse non si voleva legare, se prima nonparlava al suo figliuolo e non era cert, se il suo marito eta vivo o morto >> (Libro d.i
Vioerse ruaterie (1394-L490), 10, c. CV).
_:) _ .!
-
188 L'OSPEDALE DI s. MARIA DELLA scALA DI S, GIMIGNANo
3. Sorte d,egli esposti secondo il sesso
decedutilto:ltcorestituitill9lllentratiinconoefito I 1 I 2aftdati alle larniglie (sewe) | - I Imandati a lauorare (fanti, chierici, sacrestani) I 2n I -sposati. l l 15sorte ignota I 51 I 58
25t30
1
2t5
80 In realtà Pippo e Tommè, gli unici maschi che abbiamo trovato per il XVsecolo, inviati fuori a lavorare, fecero enffambi ritorno nell'ospedale e, come sal>piamo, Pippo vi morì pochi mesi dopo, meotre la sorte di Tommè ci è ignota. .
APPENDICE
L) Le fanigli.e di alcune balie
La stragrande maggsoranza delle balie appafreneva, come abbiamo
già avuto modo di dire altre volte, alle famiglie contadine dei dintorni
di san Gimignano, specie a qtelle mezzadrili alcune delle quali al lavoro
sui poderi dello stesso ospedale. Pochi erano nfatti i bali che esercita-
vano al6i mestieri e fra quelli accennati nelle fonti ricordiamo alcuni
tessitori, dei mugnai, dei fornai e solo un calzolaio, uf, ( ffombettiere >>,
un <( messo >> del comune e un funaiolo.11 ritrovamento sul carasto del 1427, telativo ai Carupioni del
d.istretto, di cui San Gimignano faceva parte, di alcuni dei bali dello
ospedale, dichiatanti catastalt in quell'anno, ci ha ofierto la possibilità
di conoscere ol6e a1la composizione familiare (il numero delle << boc-
che », quello dei 6g1i in particolare, |',età, il sesso e il grado di parentela
di tutti i presenti in casa), la situazione economica di queste {amiglie,
che ricorrevano al << baliatico » degli esposti dell'ospedale per integrare
il proprio bilancio mensile.
Su ventiquattro bali rinvenuti, venti appartengono al mondo con-
tadino, di cui nove sono dei mezzadri, dieci dei piccoli proprietari, fra
i quali sette esercitanti anche la mezzadtia e uno solo è un fittavolo; dei
q,.urrro rimanenti, pef tre di loro le notizie fiscali non sono sufficienti
ad identificarne il mestiere, uno è un mugnaio'
T.a loro situazione economica, rilevabile dall'imponibile segnato alla
fine di ogni dichiar azione dagli uficiali del catasto, ci {a intendere come
ci si tro;i di fronte, per la maggior parte dei bali conosciuti (circa due
terzi), a poveri 'mezzadri sprowisti di sovrabbondante o con un imponi-
bile minimo compreso, ka i 3 e i 50 fiorini (ma più del1a metà non
arivano a 2A) e che solo un terzo, tutti i mezzadti- proprietari cioè,
190 L'OSPEDAIE DI S, MARIA DELLA SCALA DI S. GIMIGNANO
ad eccezione di due, e tutti i piccoli proprietari coltivatori, arrivi sinoa 100, 200, 300 e anche più fiorini di sovrabbondante 1.
È evidente, nonostante la modesta campionatura delle testimonianzea disposizione, che all'allattanento e allo svezzamento degli esposti ricor-revano in gran parte le più povere ta le famiglie contadine (tra i dueterzi sprowisti o quasi d'imponibile compare però anche un mugnaio,l'unico, e tte bali con un mestiere non identificato) ma ci sembra ancheinteressante notare che a prendere i bambini dell'ospedale a balia vi sirecavano anche famiglie, quelle dei piccoli proprietari di tereni, perintenderci che, se non è il caso di definire << agqate )>, certamente erano,rispetto alle altre, in condizioni economiche nettamente migliori e nonè da escludere, infine, che proprio a quest'ultimo tipo di bali, più so-lidi economicamente, l'ospedale afi.dasse più volentieri i bambini, pervia delle maggiori garunzie ofierte per una buona riuscita del baliatico,che, come ci immaginiamo, oggettivamente, in condizioni di estrcrna mi-seria, non doveva dar luogo a conclusioni sempre soddisfacenti2. Mavediamo da vicino, procedendo nell'ordine crescente dell,imponibile, lefamiglie di questi bali, che il catasto, se pur con le deformazioni fiscaliche tutti conosciamo, ci dà l'insperata opportunità di considerare.
<< Una casa con suo abitarc con le sue masserizie >>, è l,unico beneposseduto da Piero di Biagiotto << di detro comune >>, il primo dei no-
1 Bali secondo il mestiere e l'imponibile
imponibile espresso in fiorini
3C1j400
mezzadrimezzadri prop.prop. coltivatorifittavolimugnainon identificato
2 D. Hrnlrny - C. Kr.eprscrr-Zutr]*., Les toscans et leurs farnilles, pp.2g2-2g7,399-432, -notano che a san Gimignano la mezzadria era moko' .rt.ru'.^^i mezzadrieccezionalmelte,_prosperi, molti dèi quaii possedevano buoi e allevavano u.riirÀ..$quqdo poi aua <<ricchezza» dei dichiarànti, a loro parere, famiglie con 100-200fiorini e ancor più quelle con 200-400 fiorini d'imponibil.,' pot.u"Ào
-considerarsi
<< agiate >> e- senz'alffo ., ricche » quelle oltre gli 800 forini. Gl cnuot;urnri , §iiiroii,contadini, borghesi _cit., p. 731, nell'estendcre, come egli sresso precisa, aija monta-gga <( compresa nel1o Stato fiorentino i criteri di clasiificazione
-socialé adottati da
Ilio c.onti per il solo co:rtado di Firenze neila sua indagi,e su1 cataiio àii tÀhi,ci indica nel << miserabile »>, << l'iscritto ,a catasto ..n à ,r.ss,rn imponibile », neil poveri )>, g[ <i iscritti co.a ut' imponibilg fino a 50 fiorini », nei << mediani », gliiscritti <<con un- imponibile da 5l- a 200 fiorini>>, e negli <iagiati>>, gli «isériiticglr ul imponibile al di sopra dei 200 fiorini>>. se adattaisimo ànche'n6i tale clas-sificazione, i aostri bali, « poveri »> e << miserabili » per Ia metà, conterebbero fra lorosei <<mediani>> e due <<agiati»>.
APPENDICE
sui bali senza imponibile e con un mestiere non identificabile. Piero diBiagiotto, che conta tra i suoi numerosi creditori (Piero ha infatti unsaldo passivo di 48,12 fiorini) Simone e Taddeo di Michele di Ghese,che sappiamo essere ricchi lanaioli e proprietari terieri sangimignanesi,i frati di San Domenico e un certo << Vitone e Paolo, suo compagno >>,
tanto per nominarne alcuni che ci fanno venire in mente probabili rap-porti di prestito e di lavoro, ha sulle spa1le una {amiglia composta daquattro << bocche >> e cioè oltre alla sua, quella della moglie, Cristofanadi ttentaquattro anni (Piero ne ha quatanta), di Giovanna, sua figlioladi dodici e di Antonio, l'altro figlio, di cinque 3. Monna Cristofana, lamoglie, tredici anni prima, ora siamo ne7 1427, a17a etàr di ventunoanni, circa, aveva avuto quella che sarà la sua unica esperienza di balia-tico con l'ospedale, allattando per 65 soldi il mese, probabilmente inoccasione della morte di un figlio, forse il primo, Bartolomeo Giovanni,dal primo di giugno del I4l4 al 14 novembre di quello stesso anno,giorno in cui i1 bambino in questione, che aveva cinque mesi, fu fattosapere all'ospedale da Piero e Cristofana, suoi bali, che era morto 4.
Piero di Nanni del Casragna « della villa di Piscille >>, mezzadrodel « proposto di san Gimignano >>, è un alro dei nosti bali iscrittisul catasto senza un fiodno d'imponibile. Piero, che << non ha sostanze »>,
compare debitore di prccole somme, fra gli a7tri, a pietro di Nofrioe Domenico, << fittavoli del1a pieve >> e ad un certo facopo, calzolaio.Le << bocche » a suo carico sono quelle della moglie, Fina, di ffent,anni(lui ne ha quatunta), di Mignano, suo figliolo di otto e di Domenico,I'ultimo nato, di cinque s. Nel 1423, a ventisei anni circa, monna Fina,la moglie, la uoviamo occupata, probabilmente dopo aver ultimato oquasi quello del figlio Domenico, nell'allattamento di Mafr,a, avuta dal-l'ospedale per 60 soldi a1 mese, dal marzo del 1423 al novembre del1.425 e, dal dicembre successivo, quando 7a famiglia sappiamo dai libridell'ospedale, abitava ora << sul podere di Matteo di Capaccia >>, anche diGiovanni, sino al maggio del 1427, proprio I'anno del catasto, e poi in-
3 A.S.F., Catasto, 266, c. 617.a Balie e bambini segn.-B (l4Lil4i4\ 14, c.4. Evidentemente la famiglia dei
Ghesi, ricchi lanaioli sangig'ign_anesi (cfr. É. Ftvrvn, Storia ,roro*iro or-., "p. ZSlllaceua pagare di più. lg 6alie- dei ,suoi mezzadri, e iale doveva essere, to.ri rierddi Biagiotto, come ci fa pensare il suo debito di cinque fiorini nei loro confronii.Del resto-, 1o sappiamo, anche nel 1445 e nel 1448, tre-balie, mogli di tre loro lavo-ratori ebbero, come in questa occasione cinque soldi in più al"mese, rispetto allaggqq ordjn1riamente dara alle altre balie in quel periodo -(Balie e oainolii segn. B(L413-1454), 74, cc. 38, 45).
s A.S.F., Catasto, 266, c. 606.
191
I
)
192 L,oSPEDALE DI S. MARIA DELLA SCALA DI s. GIMIGNANo
tenta per altri due anni, a metà salario, alTo svezzamento di quest'ul-timo esposto, sino al maggio del L429 6.
Ancora senza imponibile e senza un mestiere riconoscibile è Fruo-sino di Michele, detto << Ferraccio da Linari >>, << abitante al presente inSan Gimignano >>, in una casa posta alla << Incrociata >>, nella conffadadi San Matteo, che tiene a pigione per 5 lire l'anno, da un certo Dome-nico Cialdieri e prowista di masserizie di sua proprietà. Fra i tantidebiti di Ferraccio ne compare uno di 7 fiorini con un certo Nencio daPoggibonsi, fotse suo genero, <( per uno resto di dote >> di una sua fi-gliuola. La famiglia è abbastanza numerosa, sei << bocche >> in tutto,compreso Ferraccio, di quarantacinque anni, la vecchia madre, monnaFilippa, di ottanta, monna Bartolomea, << donna del detto Fruosino >>, diquaranta, un figlio, Stefano, di otto, un altro, Giovanni, di cinque e,
infine Domenico, di tre anni7. Bartolomea, detta Meia, nel 1430, dueanni dopo la dichiarazione catastale, quando la famiglia abita ormai a
Santa Ctoce, <( corte di San Gimignano )>, compare balia dell'ospedaleper 60 soldi il mese di Costanza, una rovatella che tenne al seno dal28 agosto di quell'anno aI maggio del 143L, per complessivi otto mesidi allattamento, dopo di che la bambina, ma non ne conosciamo la ru-gione, fu dportata all'ospedale e data ad un'alra balias.
Pietro di Niccolò di maschio anche lui senza imponibile e con unmestiere non identificablle, abita a pigione, per 8 lire l'anno, in una casa
posta nella << contrada di San Matteo »> in San Gimignano. Proprietario diuna cavalla, stimata 8 fiorini e dt 1.2 fiorini di << denari contanri >>, Piemoha al suo passivo un debito con un certo Goro di Piero da Linari, del-l'importo &, 23 lire. Le << bocche >> in famiglia sono olte alla sua (e anchePietro è sui quarant'anni), quella di monna Betta, sua donna, di trentaseianni e di Mariano, suo figliuolo, di quattro e. Monna Betta, la moglie,quattro anni dopo il catasto, nel L431, all'età di quarant'anni, la tro-viamo intenta per 60 soldi il mese ad allattare Piera per circa dieci mesidal 6 luglio L43L al primo maggio L43210.
6 Balie e banubini segn. B (1413-1454), cc. 16, 18, 19.7 A.S.F., Catasto, 233, c. 515 (si tratta in questo caso del catasto relativo alle
portate del distetto del 1428, anziché di queIlo generalmenre consultato per Iaricerca dei nostti bali e relativo, invece, ai campioni del disuetto del 1427).
8 Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 24.e A.S.F., Catasto, 266, c. 597.r0 Balie e bambini segn. B (1413-1,454), t4, c. 25.
APPENDICE
Biagio di Polito, << altimenti detto Biagino >> anche lui sprowistodi sovrabbondante, possiede venti <( tra pecore e agneili >> e undici capreper 32 iire di stima. Biagio, quasi sicuramente mezzadro di ser Tommè,prete delia chiesa di San Benedetto nei confronti del quale vanta uncredito <ii ventisei staia di gtauo, a 10 soldi lo staio e che deve avereanche E soldi da un certo Biagio d'Antonio di Guido, ha ha i suoi<< incarichi >> un grosso debito con Girolamo di Laro, fratello di serTommè e suo altro probabile padrone, << per imposte e stimi pagati per1ui e per panno »> che << tolse da lui e per perdita di buoi )>, per untotaie di 52 lire e 16 soldi, più altre 8 lire da darc a Pieraccio, << fabbroda Certatrdo ». La {amiglia di Biagio, che sappiamo << riene un fanticelloal quale dà l'anno lire tredici e 1l calzarc e il vestire >>, si compone (masi tratta di un vedovo passato a seconde nozze) di ben otto <( bocche >>
e cioè oitre al cinquantenne Biagio, monna Lisa, sua donna, di trent'anni,Francesco, suo figliolo, di ventidue, con 1a moglie, anche lei di nomeLisa, di diciassette anni e due loro figli: Menica di due anni e Polito diuno, più aitri due figli piccoli di Biagio e precisamente Michele di ottoanni e h4archione di me 11. Monna Lisa, << donna di Biagino di Polito >>,
compare nel 7436, ben nove anni dopo la dichiaruzione fiscale, a quasiquarant'anni, fra le balie dell'ospedale, intenta ad allattare per 50 soldiil rnese, Antonio, da11'8 febbraio aI quatto aprile t$7 e sappiamo chela famiglia abita, ota, a Sant'Andrea, <( corte di San Gimignano >>
12.
Checco di Gallo da Monteacuto, ancora uno dei nostri bali senzaimponibile è però con sicurezza mezzadro di un certo Giuliano di Mar-tino sul cui podere abita con i familiari in una casa <( con loro masseri-zie >> e da1 quale « ha di prcstanza fiorini venti e moggia due di grano )>
e più due paia di buoi, stimati 39 fiorini e 15 soldi, « un altro (paio)di fiorini diciannove e porci per stima di fiorini quattordici >>. Checco,che, corne abbiamo detto, << non ha sostanze »> è a capo di una f.amigliadi ben dieci persone composta da lui di tentadue anni, da suo fratelloBartolo di ventitre, dalla madre, monna Catetina, di sessanta, da suamogtrie, monna Antonia di ventidue, dalla cognata, monna Nanna, diventi, da tre suoi figli e cioè Domenica, Giovanni e Niccolò di quattro,ire e un anno e da Simone, fig1io di Bartolo, suo fratello, anche lui diun anno 13, Monna Antonia, donna di Checco, la troviamo ad allattarcBasilio, un esposto dell'ospedale ne7 144L, per 50 soldi iI mese dal 22
li A.S.F., Catasto, 266, c. 1,11.12 Balie e banzbini segn. B (141,3-1454), L1, c. 32.13 A.S.F., Catastu, 266, c. 187.
193
194 L,oSPEDATE DI S. MARIA DELIA SCALA DI S. GIMIGNANO
novembre al 17 marzo di quell'anno e sappiamo che allora la f.amiglia,
almeno queila di Checco, abitava << al Piano >> sul podere di ser Agnolo
dei Becci di San Gimignano 14.
Meo di Picchio da San Gimignano, mezzadro di set Piemo di Nic-
colò di Lindo dal qtaTe ha & << ptestanza »> 2 moggia di grano, 12 staia
tra orzo, fave e speita, L oncia di zafrerano, 100 libbre dt catne, 25
barili di vino e I" orcio d'o1io è anche lui privo di imponibile. IJn paio
di buoi, I asina, 2 porci, 25 pecorc e un ctedito di 3 fiorini nei con-
fronti di Andrea di Becco, il tutto per un totale di 32 fiorini, costitui-
scono le sue <( sostanze >>, cui corrispondono pet il medesimo valote una
lunga serie di debiti nei confronti di ser Pietro di Niccolò, << suo oste >>,
delle monache di Santa Maria Maddalena, di Leonardo & Cecco Fiche-
rel1i, di Fabiano, fabbro, di Checco dal Gesso, cli Biagio di Antonio diGuido, di Pieto di Nanni e, infine, di un certo Bartolino. Sei, compresa
quelia di Meo, che ha quarantesi anni, sono le << bocche >> a suo carico
e cioè di monna Mattea, sua donna, di trent'anni, di Antonia, sua fr-gliola di sette, di Giovanni e Lorenzo, anche loro suoi figlioli, di quat-
tro e due anni mentre l'ultima Pieru, ha appena quattro mesi 15. MonnaMattea, ha al suo attivo solo un'esperienza di allattamento di trovatellie, precisamente, di Agnese Agata, per 50 soldi il mese, dal 7 febbraio
al 2 maruo 1,444, che fu resa morta <, per mala guatdia »>, all'ospedale16.
Domenico di Bartolone, << da Vi1la Castello >>, r'aezzadro di ser Am-
brogio di ser Ftancesco, da1 quale ha << uno paio di. buoi >>, << .un'asina
con una putredrina », « pecore e capre »> e << una troia e porcellini >> e
che annovera tra i suoi creditoti Checco del maesmo Iacopo, Torello diDore, spedaliere di Santa Fina, il « giudeio )>, ser Bartolomeo, prete del-
la chiesa di Ulignano e il medesimo ser Ambrogio, suo << oste )>, per un
totale di 10 fiorini, è il padre di Antonio, che sarà uno dei bali dell'ospe-
dale della Scaia nel 1449. Priva d'imponibile la tamiglia si compone dicinque bocche, quella di Domenico, il padre, di cinquant'anni, di monna
Caterina, sua moglie di qrtarunta, di Antonio, il nostro futuro balio disedici, di Maddalena, un'altra figliola di dodici e, infine, di monna Ghe-
mrdina, sorella del capo di casa, di ottanta annil7. Dal 29 ottobre 1,449
al 3 novembre di q,.ie11'anno, per soli diciannove giorni, Antonio che
ra Balie e banbini segn. B (L41.3-1,454), L4, c. 35.ls A.S.F., Catasto, 266, c. 473.t6 Balie e banzbini segn. B (14L3-1454), 74, c. 38.17 A.S.F,, Catasto, 266, c. 238.
APPENDICE
al7oru abita a Sant'Andrea, << corte di San Gimignano », è balio per 3lire al mese di Agata Pollonia, che fu resa morta, ma non ne conosciamola ragione, all'ospedale i8.
Antonio di Sarchiello, il mugnaio, proprietario di una casa, posranel1a strada di San Giovanni, affittata a Luca di Panerata per 4 lire l,annoe abitante in un mulino << chiarnato al Caggio >>, << nel popolo di Gam-boccio » e di proprietà di un certo Antonio da Racciano, nel quale sta<( con masserizie »> a suo <( uso >>, è il primo dei nostri bali con un sovrab-bondante di 3,9 fiorini. OIte a\la casa, due cavalli concludono Ie sueproprietà mentre i debiti denunciati sono que1li nei confronti di Nannid'Antonio di ser Gino per 11 fiorini, di Ventura di Fabiano per 4 fio-rini e di Leonardo di Cecco Ficarelli per 3 lire e 10 soldi. Monna Cate-riqa, « madre del detto Antonio », di sessant'anni, Antonio medesimodi ventitre, sua moglie, monna Lucia, di venti e Lotenza, loro figliola,di appena un mese, compongono Ia {arniglia 1e. Nel 1436, monna Lucia,allora ventinovenne, è balia per 50 soldi it mese di Benedetto, dal 14novembre al -1,2 maruo di quell'anno 20.
Nanni di Bartolo di San Giovanni a Pulicciano è proprietario dellametà di una casa per suo << uso )>, << posta nel detto popolo », di un<< pezzo di terra non diviso >>, sempre << posto in detto luogo >> e dellametà di un altro <<pezzo di tena >> anche questo in << detto popolo »>,
<< luogo detto il Caduco >>. Casa e terra << sopraddetta >> sono << per nondiviso >> di Antonio R.idolfi e << lavorala Lorenzo e Antonio di Michele,lavoratori di detto Antonio Ridolfi >>. La rendita annua che gli provienedalla terca è di due staia di grano e un barile di vino. Fra gli incarichil3L the da dare ad Antonio e Gregorio di Giovanni, barbieri di SanGimignano, di cui il nostro Nanni lavora un podere , e L2 lire da darea Checco di Iacopo da Fancole. Sette figli di sedici, quattordici, undici,dieci, nove, cinque e un anno, più Nanni di Bartolo « detto »>, di cin-quant'anni e monna Biagia, << sua donna >>, di quaranta, sono le << boc-che »> a suo carico e 5,18 fiorini sono ii suo valsente 21. Nel 1427, all,etàdi trentatre anni, circa, monna Biagia aveva tenuto dal 27 ottobre al10 maggio L422, Pollonia, della quale aveva completato l,allattamentoa 3 lfue iI mese e iniziato per 30 soldi mensili lo svezzamento2z.
18 Balie e bambini segn. B (141.3-L454), 14, c. 48.le A.S.F., Catasto, 266, c. 17.20 Balie e bambini segn. B (1413-1.454), 1.4, cc. 31-32.21 A.S.F., Catasto, 266, c. 520.» Balie e barubini segn. B (1413-1.454), 14, c. 12.
195
L96 L,0SPEDÀLS DI S. MARIA DELLA SCAL,{ DI S. GIMIGNÀNO
Nanni del castagna da Piscille, mezzadro di un certo Giusto << nella
vi1la di Piscille >>, dove abita in una casa <( con sue masserizie per suo
uso )> e dal quale ha 15 fiorini, staia 26 di grano, 2 orci d'olio, 1 paio
di buoi, 1 asino, 20 tra << capre e capretti >>, << due ftoie con sei porcel-
lini >>, è il padre di Lorenzo e Meio, futuri bali dell'ospedale. Iscritto
nel catasto per 6,1 fiorini di sovrabbondante, Nanni ha fra i suoi inca-
richi vari debiti con vanni di corino, con Lippo di Pecioiino, co1 << giu-
deo >>, col comune & San Gimignano, con Bartolo, chiamato Buto, con
un certo Checco, con Iacopo di Paolo, col prete, al quale dà << l'anno di
decima staia due di grano )> e con Giusto, suo <( oste >>, Pef 15 fiorini,
staia trentasei di gtano e undici orci d'olio. Le << bocche >> in casa sono
sei e cioè Nanni del Castagna, di cinquantotto anni, monna Piera, << sua
donna >>, di cinquanta, Meo, << suo figliuo1o >> di anni ventidue, Lotenzo,
altro << suo figliuolo >> di diciassette, monna Miche, sua madre, << cieca
e atratta >> di ottanta anni e monna Lisa (forse una sua sorella) anch'essa
<<airatta>>, di cinquaflt'annia. Ne1 1452, <<Lorenzo del Castagna e lasua donna, abitante oru al sambuco, corte di san Gimignano >> è il ba-
lio di Maddalena per 3 lire al mese da1 26 luglio ai 28 settembre, giorno
in cui la bambina è resa morta all'ospedale e Meo, suo fratello maggiore,
che sta a santa chiara, è il balio di Piero Maria ne1 L46), per due lire
e quindici soldi al mese, da1 6 a17'8 gennaio, quando, dopo due soli
giorni, ii bambino fu reso anch'esso morto al rettore 24.
cencio di Buono da casaglia, mezzadro di Nicola di Gualtieri
<< nella detta villa >>, dal quale « ha di presta », 1L lire, 4 soldi e 4 denari
e una << troia con quattro porcellini », mentre << a mezzo con l'ossa sue
ha tfentotto tfa pecofe e capre >> è iscritto nel catasto pet 15,4 fiorini.
Suoi « debitori >> sono set Lazzaro di Lorenzo da San Gimignano e Meo
di checco di Nanni. I suoi << incarichi )> per un totale di 5 fiorini sono
nei confronti di Taddeo e Agnolo di Michele di Ghese, di Paolo di For-
mica e Meo di Piero da Linari e di un certo Giovanni di Gimignano.
Solo tre sono le << bocche » in famiglia, quella di Cencio di cinquanta-
cinque anni, di monna Nanna, << sua donna >> di quarantasei e di Rica,
« sua figliola » di quindici 2s. Quatffo anni prima, sua moglie monna
Nanna, era stgrta per due soli giorni dal 19 al 2L febbraio L423, la balia
di Dionota, che venne riportata morta all'ospedale %'
z A.S.F., Catasto, 266, c. 518.,n'Bolir'r-OiàUl'ol se'gn. B (L413't454), 14, c. 59; Libro di bali segtt' L
(1456-1465), L5, cc. 18,95.25 A.S.F., Catasto, 266, c. L83.% Balie e bambini segn. B (1413-7454), 14, c. 15.
APPENDICE 197
Cristofano di Matteo da Cellole, contado di San Gimignano, pro-prietario di una casa posta al Quercecchio e di « una massedzia >> a
<( uso » suo e della sua famiglia, vanta un credito di 10 fiorini nei con-
fronti delle monache di Santa Maria Maddalena, di cui forse è il mez-
zadro, e possiede un'asina e sedici pecore. Cristofano, che viene segnato
sul catasto con un imponibile di 18,4 fiorini, ha un solo debito di 17
lire col << giudeo >>. La lamiglia è composta da otto pefsone: il r"edesimoCristofano di sessanta anni, il fratello Gino, anche lui di sessanta antli,moana Caterina, sua moglie, di cinquanta, Biagio, suo figliuolo, di ffen-tadue anni, la moglie di lui, monna Menica, di venticinque, e quattoloro bambini, fra cui una coppia di gemelli di me anni, uno & sei e I'ul-tima di otto mesi 3. Monna Caterina, la moglie di Cristofano serve l'ospe-dale come baTia e lavandaia dal 1414 al 1422. Come balia, dopo averalTattato Dionora Checca a 3 lke il mese nel 141.3 per ben diciannovemesi ed avetta svezzata p$ altri dodici a 30 soldi, ne svezzò pef que-
st'ultimo compenso altri quattro e cioè Leonarda Checca per diciassettemesi nel 1416, Matiano per sei mesi nel l4L7-14L8, Taviano per quasitre anni nel 1419 e l'ultima, Poilonia nel 1422, che Ie morì afiogata inuna << fossa >> e mise fine a questa sua attività,8.
Nardo d'Orso del « popolo di Remignolle », proprietario di << unamasserizia >> ad << uso » suo e della sua famiglia forse mezzadro dei fratidi Sant'Agostino e << fittavolo »> di ser Bartolomeo di Giovanni, prete,ha fua i suoi << debitori >> i medesimi frati per 8 fiorini, Nanni d'Anto,nio, beccaio, Andrea di Bartolo di Paolo <( per resto di dota », Filippinoda Casole, Michele di Maschio, Nanni di Cottone, Camillo da Racciano
e un certo Bor:j;f.azio, per un totale di 33 fiofini. GIi << iacarichi )> am-montanti a 15 fiorini contemplano alcune somme da dare a ser Giovannida1 quale tiene in affitto un podere e 31 lire e 10 soldi da dare << al giu-deo »>. Cinque << bocche >> formano la tamiglia di Nardo, con tutta pro-babilità un vedovo passato a seconde nozze. Oltre a lui di'quarant'aild,la giovane moglie, monna Silvestra di diciotto, Santino, un suo figliolodi dieci, Menico di tre anni e Antonio di sei mesi D. 11 suo valsente èpati a 18,14 fiorini. Monna Silvestra, donna di Nardo d'Orso comparetra Ie balie dell'ospedale nel L434, intenta ad ollattarc per 50 soldi ilmese Vittoria, che pare restare a lungo presso di lei s.
27 A.S.F,, Catasto, 266, c, t71.a Balie e banbini sega. B (L413-1454), L4, cc. 3, 5, 8,9, t0, tL, L2.29 A,S.F,, Catasto, 266, c, 55L,§ Balie e barubini segn. B (14L1-14 4), L4, c. 28.
__--J
r98 L,OS?EDALE DI s. MARIA DELLA SCALA DI S. GIMIGNANo
Giacomo d'Andrea da San Lorenzo, contado di San Gimignano,proprietario di un paio di buoi, di un'asina e di quatrro porci è mezzadtosu un podere dello stesso ospedale della Scala. Ismitto nel catasto per20 fiorini di sovrabbondante, fra i suoi incarichi compare un debito di32 fiorini con l'ospedale e di L fiorino col fabbro << da Certaldo >>. Anche1ui è un vedovo di quarant'anni, risposatosi con monna Margherita diventi, dato che Nanna, una sua figliuola ha glìL quattordici anni. La fami-glia composta da quatffo << bocche >> si conclude con Tommè di due anni 31.
À4onna Margherita nel 1428 è la balia di simone Domenico per 3 lire almese, che tiene presso di lei dal marzo al settembre di quell'anno 32.
Agostino di Maso, proprietario di una casa nel1a contrada di SanGiovanni, <<in luogo detto Berignano)>, <<con masserizie>> ad <<uso)>suo e della sua famiglia, dichiaru anche la proprietà di un << orticello »>,
<< nella detta contrada >>, probabilmente corredato a77a casa, di un << pez-zo di tena soda, posta a Pignano, contado di Volterra >>, << in sullaquale non si ricoglie cosa alcuna >>, di un bue col quale lavora più ter-reni di un certo Filippo e di un asino. Fra i suoi << debitori >> compaionoNanni di Lorenzo di Ciaco da Casaglia, Giusto d,Antonio da Volterra<< per una dota di monna Bartolomea )>, sua madre, e << più persone inpoche somme e piccole )>, per un totale di 38 fiorini. Fra i creditoriRosso di Nannino da casaglia, Leonardo di Tenco Ficarelli e il comunedi San Gimignano, il tutto per 2 fiorini. Con un sovrabbondante dt 36fiorini, Agostino è a capo di tre persone e cioè lui di trent,anni, la vec-chia madre, monna Bartolomea di settanta e la moglie, monna Lisa didiciotto 33.
<< Monna Lisa, donna d'Agostino di maso di San Gimignano >>,
la troviarno a svezzate nel 1447, ben venti anni dopo, per 30 soldi ilmese, Carlo, che tenne a lungo, sino al 1451, senza che Ie venisse cor-risposto, negli ultimi rempi, più niente, perché ormai il bambino era inetà << da ricogliere i> 3.
Chelino d'Andrea di Paolo, << sta in San Gimignano >>, conta fra isuoi << debitori >> ser Francesco di Bartolomeo di Firenze, cancelliere delcomune per una somma di 40 fiorini e Bartolo di Drea da Colle per 10fiorini. chelino, un ex famiglio deil'ospedale della scala, iscritto al cata-sto per 37 fiotini conta fra i suoi << incarichi >> solo un affitto di 3 lircl'anno da corrispondere a Michele di Donato e due sole << bocche >>, la
31 A.S.F., Catasto, 266, c. 388.§ Balie e barubini segn. B (t413-1.454), 1.4, cc.22,23.33 A.S.F., Catasto, 266, c. t.u Balie e bambini segn. B (14$-L454), 14, cc. 41, 43.
APPENDlCE L99
sua (Chelino ha ventisei anni) e quella di monna Verdiana, sua moglie,
di appena sedici anni 3s. Monna Verdiana è balia di Santia nel 1,435 dal2 novembre al 18 maggio 1437, per 50 soldi il mese 36.
Mignano di Piero del Gesso, iscritto con un valsente di 51,,2 fiorini,si dichiara proprietario di << uno pezzo di terra vignata e albetata, po-
sto nel1a vi11a di Cellole >>, afrttata a Lippo di Peciolino per 6 lire l'annoe di un altro << pezzo di terra alberata, posto nella detta villa >>, afrttatoa Nanni di Berto per 2 lite l'anno. Mezzadro dell'ospedale di Santa
Fina, Mignano conta fra i suoi crediti una somma di 25 frotini da avere
da Giuliano di Martino, che li ha << in deposito, per cagione di un ob-biigo di una dote »> di una sua cognata, il cui « frutto >> viene messo << so-
pra la detta dote >>. Fra i debiti, << per prestanze »> e << perdita di bestie >>,
deve dare 50 fiorini all'ospedale di Santa Fina, di cui lavora un podere
a Llbbiano e 10 lire a Urbano, fabbro, << per femi avuti da lui ». Le<, bocche >> in casa sono cinque e cioè quella di Mignano << sopraddetto >>
di sessantacinque anni, di monna Pieta, << sua donna » di cinquanta, diLorenzo, loro figliolo, di quarunt'anni anche lui un ex famiglio dell'ospe-dale delia Scala, di monna Bartolomea, sua moglie di venticinque anni,più un loro bambino, Checco, di. un annc e di Piera, figliuola di Mi-gnano, di venti anni37. Monna Piera, donna di Mignano, era stata baliadel nostro ospedale dal2 maruo del1426 all'1l maggio 1427, di Andrea,per 25 soldi più uno staio di grano a1 mese e, ne1, 1,433, monna Barto-
lomea, la nuora, dopo la morte di Lotenzo, il marito, sappiamo che ab-
bandonò l'ultima nata Pieru al medesimo ospedale, per riprendetla a
balia dietro il compenso ofiertole dal rettore di 4O soldi al mese, che
però come sappiamo soddisfece per poco tempo la famigTia tanto da co-
sttingerla di nuovo ad abbandonare Ia bambina 38.
Antonio di Francesco, proprietario col fratello Piero di << un pezzo
di terra con una vigna dispartita da7la terra, con una casa >> nella villadi Montemorli a ioro <( uso )>, nel contado di Poggibonsi e di un << orti-cello appiccato alTa casa >>, è iscritto al catastc con 60,16 fiorini di val-sente. La terra, f.atta lavorare da Meo di Peffino, ,<, frutta l'uno anno perl'altro »> L2 staia di grano, i0 barili di vino e oltre ad un credito di 6
lire nei confronti di un cerio Piero di Lotenzo, compaiono fra le sostanze
dei due fratelli un paio di buoi, un'asina, un puledro, sei porci, dician-
35 A.S.F., Catasto, 266, c. 176.« Balie e barubini segn. B (1.41.3-1454), 14, c. 30.37 A.S.F., Catasto, 266, c. 440.§ Balie e bar,tbini segn. B (L41,3-1454), 14, c. 20.
-/