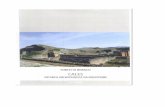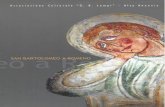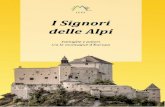Bartolomeo Cavarozzi. 'Sacre Famiglie' a confronto, a cura di D. Sanguineti, catalogo della mostra...
Transcript of Bartolomeo Cavarozzi. 'Sacre Famiglie' a confronto, a cura di D. Sanguineti, catalogo della mostra...
Bartolomeo Cavarozzi‘Sacre Famiglie’ a confronto
Accademia Albertina delle Belle Arti, Torino
Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artisticoed Etnoantropologico del Piemonte, Torino
a cura diDaniele Sanguineti
In copertinaBartolomeo Cavarozzi, Sacra Famiglia, particolareTorino, Pinacoteca dell’Accademia Albertina
Progetto graficoMarcello Francone
RedazioneEmanuela Di Lallo
ImpaginazioneSerena Parini
Nessuna parte di questo libro puòessere riprodotta o trasmessa inqualsiasi forma o con qualsiasimezzo elettronico, meccanico oaltro senza l’autorizzazione scrit-ta dei proprietari dei diritti e del-l’editore
© 2005 Skira editore, Milano© 2005 Accademia Albertinadelle Belle Arti, Torino© 2005 Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artisticoed Etnoantropologico del Piemonte, TorinoTutti i diritti riservati
Finito di stampare nel mese disettembre 2005a cura di Skira, Ginevra-MilanoPrinted in Italy
ISBN: 88-762-457-82
www.skira.net
Con il contributo di
Si ringraziano
Progetto e cura della mostraDaniele Sanguineti,Soprintendenza
Coordinamento organizzativoAngela Griseri, Consulta
Segreteria e Relazioni esterneTiziana Calabrese,Soprintendenza
Progetto dell’allestimentoe grafica della mostraGiugiaro Design
Realizzazione allestimentoMusiquarium
Progetto illuminotecnicoFulvio Michelazzi
Stampa della graficaCentro copie, Torino
Ufficio StampaTiziana Calabrese,SoprintendenzaAnna Sarotto con Paola Assom, Compagnia di San PaoloMara Vitali Comunicazioni,Skira editore
Attività didatticaCristina Giudice,Accademia Albertina
Selezione sonoraDiego Mirenghi
Accoglienza e custodiaREAR s.c.a.r.l.
Catalogo a cura diDaniele Sanguineti
Testi diDaniele SanguinetiGianluca Zanelli
Campagna fotograficaGiacomo Lovera, Torino (cat. n. 3)Luigino Visconti, Genova(cat. n. 2)Archivio Fotograficodella Soprintendenza, TorinoFototeca ICCD, Roma
Campagna diagnosticaPanArt, Firenze (cat. n. 3)
RestauriNicola Restauri, Aramengo (At)Barbara Rinetti s.r.l., Torino
AssicurazioneReale Mutua Assicurazioni
TrasportiZüst Ambrosetti Settore Opered’arte, Trofarello, Torino
Assistenza movimentazioneopereAmalia Bottino, Soprintendenza
Uffici mostre ed esportazioneMario Lamparelli,SoprintendenzaFilippo Lanzoni,Soprintendenza
Apparati didatticiTesti di Daniele Sanguineti
Si desidera porgere un sinceroringraziamento alle dueistituzioni che hanno volutosostenere questo evento,Compagnia di San Paolo eConsulta per la Valorizzazionedei Beni Artistici e Culturalidi Torino, nelle persone deirispettivi Presidenti, FranzoGrande Stevens e LuigiGarosci. Naturalmente idirigenti e i funzionari dientrambe sono risultaticollaboratori fondamentali:Dario Disegni, Rosaria Cigliano,Laura Fornara, Anna Sarotto(Compagnia di San Paolo)e Angela Griseri (Consulta).
Un vivo ringraziamentoai musei, alle istituzioni e aicollezionisti che hannogenerosamente concesso ilprestito delle tre opere da porreaccanto alla tela dell’Albertina,rendendo possibile il confronto.In particolare si vuolesottolineare la disponibilità diGianmaria Berchialla e FrancoRevello, direttori del FondoPensioni del Gruppo San PaoloImi, di Marzia Cataldi Gallo,Soprintendente per ilPatrimonio Storico Artisticoed Etnoantropologico dellaLiguria, di Farida Simonettie Gianluca Zanelli,rispettivamente direttore econservatore della GalleriaNazionale di Palazzo Spinolaa Genova, e di Marietta Corsinidella galleria Maison d’art diMontecarlo per l’indispensabileaiuto in merito al prestitodella Sacra Famiglia consan Giovannino (cat. n. 4).
Si ringrazia inoltre tuttoil personale dell’AccademiaAlbertina, in particolareFranco Nocito, Bruno Pantano,Anna Lisa Guida.
Bartolomeo Cavarozzi‘Sacre Famiglie’ a confronto
Torino, Pinacoteca dell’Accademia Albertina6 ottobre 2005 – 26 febbraio 2006
Un grande debito nei confrontidi tutti i colleghi dellaSoprintendenza per ilPatrimonio Storico Artistico edEtnoantropologico delPiemonte e, in particolare, diGiovanna Abruzzese, AntonellaAffronti, Anna Aimone, AnnaMaria Bava, Gianluigi Belfiore,Massimiliano Caldera, RenzaCerchio, Antonio Consuele,Antonietta Cratere, DomenicaD’Ambrosio, Marina dell’Olmo,Giovanna Fanelli, Adele Forte,Alessandra Guerrini, LoredanaInnocenti, Michela Labartino,Lucia Massafra, Carla Mastella,Diego Mirenghi, OliviaMontaruli, Irene Nascivera,Giovanni Olivieri, FabioOlivieri, Daniela Patrignani,Vincenzo Piccione, MarioPirarba, Giorgio Sacchi,Ornella Savarino, MariaSeverino, Simona Schiattarella,Giuseppe Spadafora, RossanaVitiello.
A Piero Boccardo, Clario DiFabio, Alberto Fumagalli, IlariaSirotti, Maria Lucrezia Vicini,Marieke von Bernstorff e AldoZerbone un ringraziamentoparticolare per la lorodisponibilità e generosità.
Infine si ringrazia il personaledi Skira (in particolareAlessandro Degnoni e VincenzaRusso), il personale di GiugiaroDesign (in particolareEmanuela Gagino e ClaudiaGilardi), il personale del Centrodi Documentazione per laStoria, l’Arte, l’Immagine diGenova (in particolare ladirigente, Elisabetta Papone,e Rosalia Franco con ValentinaGallo), il personale dellaFototeca Nazionale delMinistero per i Beni e leAttività Culturali (PaolaCallegari), il personale di
Christie’s Roma (ValentinaCiancio) e l’Ufficio per l’ArteSacra e i Beni Culturali dellaDiocesi di Ventimiglia –Sanremo (in particolareValentina Zunino).E ancora Angela Acordon,Paolo Arduino, MassimoBartoletti, Paolo Braggio, MariaCastellino, MaddalenaD’Angelo, Emanuela Di Lallo,Giuseppe Fragalà, MarcelloFrancone, Paola Lamanna,Miranda Miranda, MatteoMoretti, padre PietroMillefiorini, Elisabetta Papone,Serena Parini, TeobaldoPasquali, Loredana Peirano,Marie Luce Repetto, RobertoSantamaria, Paola Traversone,don Giorgio Venzano.
Ammettiamolo, tante volte, troppe volte, entrare nella Pinacoteca annessa all’AccademiaAlbertina, prendeva il cuore, perché metteva a disagio vedere quelle sale stracolme di capolavori,tutte desolatamente e inesorabilmente vuote. Eppure proprio lì accanto decine e decine, anzi perl’esattezza circa 800 studenti, aspiranti artisti, stavano dipingendo, disegnando, scolpendo,frequentando le scuole e i tanti corsi dell’Accademia di Belle Arti. Perché nessuno di questistudenti sentiva l’urgenza di confrontarsi con i cartoni gaudenziani, i dipinti caravaggeschi e letele dei maestri fiamminghi?La mostra che l’Accademia Albertina e la Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico edEtnoantropologico del Piemonte dedica a quattro splendide ‘Madonne col Bambino’ diBartolomeo Carvarozzi è un nuovo atto di un tentativo di rilancio di questo museo che perquantità e qualità di opere conservate è secondo in Piemonte soltanto alla Galleria Sabauda.Come direttore neo eletto dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, cui compete anchel’onore e l’onere di dirigere la Pinacoteca Albertina, ho il piacere di presentare una mostra di siapur ridotte dimensioni, tuttavia estremamente significativa, perché vuole indicare un rigorosometodo di lavoro e costituire il primo passo di una politica museale che intende valorizzare leopere della collezione permanente ricreando ben precisi contesti storico-artistici e riportando ilmuseo alla sua originaria funzione didattica, strettamente correlata ai corsi dell’Accademia diBelle Arti, nell’ambito di una strategia che oggi si definirebbe strutturale e non congiunturale.Un grazie sentito va quindi e anzitutto alla Soprintendenza che, nella persona del suo gentilesoprintendente, Carla Enrica Spantigati, ha favorito il rilancio complessivo della Pinacoteca conun ringraziamento particolare a Daniele Sanguineti, il valente storico dell’arte che in qualità difunzionario di suddetta Soprintendenza segue ormai da tre anni la Pinacoteca Albertina e ha inprima persona ideato e curato questa splendida mostra. Con non minore slancio devo ringraziarela Compagnia di San Paolo e la Consulta per la Valorizzazione delle opere d’arte del Piemonte(che già dieci anni fa aveva consentito la completa ristrutturazione degli spazi espositivi dellaPinacoteca) che hanno dato le risorse economiche per realizzare questa mostra; a questoproposito un ringraziamento personale e intensissimo va all’attuale Presidente della Consulta,Luigi Garosci, e alla insostituibile Angela Griseri, storica dell’arte valente e “segretaria”efficientissima della Consulta. Un grazie a Giorgetto Giugiario, che ha offerto la suaprofessionalità e la creatività del suo staff guidato da Alberto Fumagalli per realizzare unallestimento accattivante e accogliente. Last but not least, un mai abbastanza ribadito grazie allaRegione Piemonte che attraverso il suo Assessorato alla Cultura, fino alla scorsa legislaturarappresentato da Gianpiero Leo e oggi da Gianni Oliva, con il trait d’union determinante delDirettore dei Beni Culturali Alberto Vanelli, da sempre finanzia la Pinacoteca Albertina. Unriconoscente pensiero va infine, mi si consenta, ad alcuni professori, miei colleghi dell’AccademiaAlbertina, che mi hanno sostenuto nel progetto di rilancio del museo in un’ottica didattica:Gianfranco Rizzi, titolare della prima cattedra di pittura dell’Accademia Albertina, che ha giàdato la sua disponibilità a far tornare di attualità tra i nostri studenti il gusto e la capacità diesercitarsi dipingendo copie fedeli di quadri antichi della Pinacoteca, le professoresse (e careamiche) Cristina Giudice, Monica Saccomandi e Maria Grazia Lazzarini, che stanno giàelaborando un progetto “educativo” dedicato alle scuole di ogni ordine e grado, ma anche agliadulti, finalizzato a una nuova più stimolante e approfondita fruizione delle opere esposte nelmuseo, a cominciare dai dipinti del Cavarozzi, un Caravaggio dal realismo dolceed emotivamente vibrante.
Guido CurtoDirettore dell’Accademia Albertina
Nel corso degli anni venti dell’Ottocento l’arcivescovo Vincenzo Maria Mossi di Morano, erededella raffinata quadreria radunata dall’importante famiglia casalese a partire dal Cinquecento,riuscì a incrementare il già cospicuo nucleo di opere destinate a essere legate all’AccademiaAlbertina di Torino (1828) con alcuni capolavori provenienti dalla collezione genovese diCostantino Balbi. Fra questi spiccava la celeberrima Sacra Famiglia di Bartolomeo Cavarozzi, lacui altissima qualità esecutiva, pur ritenuta in un primo tempo imputabile alle capacitàdell’emiliano Bartolomeo Schedoni e solo agli inizi del secolo scorso restituita al suo legittimoartefice, venne costantemente annoverata fra i grandi richiami della Pinacoteca, come dimostra ilposto d’onore riservato dall’attuale allestimento.Intorno al 1990 il Fondo Pensioni del Gruppo San Paolo Imi, nel contesto di una mirata politicadi investimenti in opere d’arte, riusciva ad acquistare un’altra importante Sacra Famiglia diCavarozzi, assicurando alla città di Torino un secondo dipinto cavarozziano, di identico temaiconografico. Un tema che l’artista caravaggesco reiterò numerose volte offrendo magnificiprototipi e interessanti repliche autografe destinati a moltiplicarsi tramite un numero sterminatodi copie che si diffusero in una vasta area geografica, dalla Spagna alla Francia, oltre all’Italia ein particolare Genova, dove i ricchi patrizi mostrarono di gradire particolarmente quellatradizionale composizione rinnovata da un linguaggio di straordinario impatto iperrealistico.Dunque dalla volontà di valorizzare attraverso mostre tematiche i dipinti della Pinacoteca e direalizzare ciò che non è mai stato fatto fino a ora, ossia l’accostamento delle due tele torinesi,nasce questa nuova esposizione. Il confronto ha coinvolto altri due strepitosi autografi diCavarozzi, l’uno attualmente in deposito presso la Galleria Nazionale della Liguria in PalazzoSpinola di Pellicceria, l’altro per la prima volta presentato al pubblico da una collezione privata.Il fascino, nel contempo magico e magnetico, che muove dai quattro dipinti restituisceefficacemente il misterioso approccio di Cavarozzi nei confronti di un tema condotto con minuziaquasi fiamminga, assimilabile a un esercizio dell’anima, e divulgato in un ampio raggioterritoriale dando corso a una complessa “congiuntura caravaggesca”, che Daniele Sanguineti,responsabile delle collezioni d’arte dell’Accademia Albertina per conto della Soprintendenza, hatentato in questa occasione di dipanare.Un museo come la Pinacoteca dell’Accademia Albertina, che non dissimula le colte origini e lemunifiche volontà di lasciti e donazioni, non ha vita facile tra le occasioni culturali offerte algrande pubblico dei visitatori d’arte. Il piccolo gioiello riallestito nel 1996 e destinato, proprioalla fine di questa esposizione, a una revisione finalizzata a porre in atto adeguamenticonservativi e a dar spazio a nuove opere ora custodite nei depositi, necessita di un continuorichiamo d’attenzione tramite una valorizzazione degli stessi capolavori di cui è composto.Il successo riscosso lo scorso anno dalla ricomposizione del trittico di Filippo Lippi (“FilippoLippi. Un trittico ricongiunto”, 7 settembre – 7 ottobre 2004) ha indicato la giusta via, giàcostellata da future occasioni di progettualità, naturalmente realizzabili all’insegna di unasinergia in questo caso facilmente e piacevolmente praticabile grazie al sostegno, davveroindispensabile, degli sponsor e all’intesa, fondamentale, arricchente e ormai tradizionale, fra laSoprintendenza e l’Accademia stessa.
Carla Enrica SpantigatiSoprintendente per il Patrimonio Storico Artisticoed Etnoantropologico del Piemonte
La Compagnia di San Paolo ha scelto di intervenire a sostegno di eventi espositivi di eccellenza,consapevole della necessità di attrarre un numero sempre crescente di visitatori con mostre che,svelando capolavori d’arte, possano rappresentare un momento di crescita culturale e diavanzamento della ricerca storico-artistica.La mostra sul confronto tra le ‘Sacre Famiglie’ di Bartolomeo Cavarozzi, curata dall’AccademiaAlbertina delle Belle Arti di Torino – custode di una delle opere che costituiscono l’eventoespositivo – e dalla Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologicodel Piemonte, coniuga al piacere di mostrare al pubblico quattro celebri dipinti del pittoreviterbese l’approfondimento critico e le più recenti scoperte sull’influenza che i maestri di ambitoligure ebbero sull’opera dell’artista. La mostra rappresenta dunque l’occasione per divulgare ilrisultato di indagini scrupolose che andranno ad arricchire gli studi sulla vita e l’opera delCavarozzi e sul tema del collezionismo genovese del Seicento.L’evento ha inoltre un significato importante per il patrimonio culturale della Città di Torino.Esso infatti è un’opportunità per rendere nota ai visitatori la pregevole collezione permanentedell’Accademia Albertina, che ospita oltre trecento opere tra dipinti, sculture e disegni.Con questo evento la Compagnia desidera proseguire il suo impegno rivolto alla valorizzazionedel patrimonio artistico custodito nelle collezioni cittadine, che può realizzarsi soltanto attraversola collaborazione tra le Istituzioni che lavorano per promuovere Torino città della Culturae dell’Arte.
Franzo Grande StevensPresidente della Compagnia di San Paolo
1995-1996: la Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino sponsorizzala ristrutturazione e il riallestimento della Pinacoteca dell’Accademia Albertina.Due anni di lavoro e di ricerca e un notevole impegno di risorse economiche e intellettualihanno permesso di esporre in modo sistematico e permanente le opere di pittura, di sculturae di grafica che da tempo erano infruibili sia al grande pubblico che agli stessi allievidell’Accademia, e ciò anche grazie alla stretta collaborazione con la Soprintendenzaper il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico del Piemonte e con l’Assessoratoalla Cultura della Regione Piemonte.Una particolare attenzione è stata dedicata alla sala che espone i sessanta cartoni di GaudenzioFerrari, donati da Carlo Alberto nel 1832, straordinario documento delle botteghecinquecentesche.L’impegno profuso dalla nostra associazione ha dovuto confrontarsi sul piano della museografiacon temi e problemi non facili, che imponevano di rendere percepibile il sottile equilibrioesistente tra la storia dell’Istituzione, la rara connotazione delle collezioni e la straordinariaqualità delle singole opere da accogliersi in un nucleo museale nato, cresciuto e finalizzato perl’Accademia di Belle Arti.In questi anni si è cercato di promuovere l’Accademia non solo come scuola ma anche comeluogo di attività culturali rivolte a conquistare un maggior numero di visitatori, attraversol’organizzazione di conferenze e di esposizioni temporanee. Tra le iniziative recenti, nel 2004,la mostra incentrata sulla temporanea ricomposizione del trittico di Filippo Lippi, con la tavolacentrale della Madonna con il Bambino giunta dal Metropolitan Museum di New Yorkaffiancata alle tavole laterali raffiguranti i Padri della Chiesa conservate appunto nelle collezionidell’Accademia.Ancora su questa linea si colloca la mostra: “Bartolomeo Cavarozzi. Sacre Famiglie a confronto”finanziata dalla Consulta e dalla Compagnia di San Paolo su richiesta della Soprintendenza alPatrimonio Storico Artistico, in cui il prezioso dipinto riproducente la Sacra Famiglia,proveniente anch’esso dal cospicuo nucleo di opere donate nel 1830 dall’arcivescovo VincenzoMaria Mossi di Morano all’Accademia Albertina, viene esposto accanto ad altre significativeopere dello stesso pittore.La Consulta con questo contributo desidera confermare il suo concreto impegno a favoredell’Accademia e del patrimonio culturale della Città valendosi anche dell’apporto edell’esperienza imprenditoriale dei soci aderenti; un particolare ringraziamento va rivolto al socioGiugiaro Design che ha donato il progetto d’allestimento, illuminazione e grafica della mostra.
Luigi GarosciPresidente Consulta
Sommario
17
45
85
87
89
Bartolomeo Cavarozzi e le ‘Sacre Famiglie’:tracce per una congiuntura caravaggesca tra Genova e la SpagnaDaniele Sanguineti
Catalogo
Apparati
Cronologia
Bibliografia
13
Le ‘Sacre Famiglie’ di Bartolomeo Cavarozzi, il loro legame con Genova e il supposto tran-sito dell’artista nel capoluogo ligure sulla via di Spagna: coordinate tanto affascinanti quan-to ancora misteriose e complesse che si desidera in questa occasione tentare, almeno in par-te, di dipanare all’insegna di una più ampia diffusione del caravaggismo. Cavarozzi, che aRoma trasse soprattutto dal Caravaggio il necessario per mutare lo stile, si trovò, forse alritorno dal suo viaggio spagnolo, a transitare in una città dove era in corso una vera e pro-pria rivoluzione pittorica scaturita da turbamenti artistici a lui già noti. Dalla metà del se-condo decennio infatti i pittori genovesi, fomentati da pochi illuminati collezionisti, prati-cavano la restituzione della realtà per mezzo dell’immagine dipinta in chiave caravaggesca.Non è dato sapere se, proprio in quel momento, Bartolomeo forgiò una delle sue rutilanti‘Sacre Famiglie’, mentre è certo che alcune giunsero in città precocemente grazie alle rot-te del collezionismo. Le tracce, fondate sulle ipotesi pionieristiche avanzate da RobertoLonghi e, più recentemente, da Gianni Papi1, tessitori davvero raffinati di una completa elucida congiuntura caravaggesca, sono tangibili, pur gravando su di esse l’assenza di docu-menti necessari per gettare luce su cronologie, committenti e relazioni.
Confrontando le quattro magnifiche ‘Sacre Famiglie’ cavarozziane, che si offrono perla prima volta all’ammirazione congiunta presso la Pinacoteca Albertina, si può oggi evo-care solo parzialmente quella che dovette essere una fortuna compositiva davvero clamo-rosa calata in un’ampia area geografica di cui uno degli indiscutibili epicentri fu proprioGenova. Nella lettura delle opere qui riunite è tentante creare percorsi multipli, addentrandosinel momento più interessante e vigoroso del percorso di Cavarozzi, per certi versi ancorada chiarire, caratterizzato da un esercizio lento e minuzioso su un tema ricorrente nel qua-le si può misurare tutto il fascino e la distanza verso il nume caravaggesco.
Bartolomeo Cavarozzi pittoreL’artista nacque a Viterbo il 15 febbraio 1587. L’esatta data di nascita, individuata di re-cente2, va a circostanziare non solo l’estremo anagrafico iniziale fornito implicitamente dalbiografo del pittore, Giulio Mancini, che, scrivendo verso il 1617-1620, lo definiva “d’etàdi 30 anni incirca” (e quindi nato tra il 1588 e il 1590)3, ma anche il prezioso contributoapportato da Gianni Papi che, rinvenendo la notizia della sepoltura nella chiesa romana diSanta Maria del Popolo il 21 settembre 1625 all’età di 39 anni, aveva giustamente ritenutodi situare la nascita nel corso del 15864. Oltre a Mancini, che scrisse dunque in prossimitàdell’avvio dell’ultimo lustro della vicenda terrena di Bartolomeo, anche Giovanni Baglionegli riservò una breve biografia nelle sue Vite pubblicate nel 16425: fino agli studi moderni,inaugurati da Longhi e via via portati a maturazione con l’apporto di nuove opere e docu-menti6, le notizie del pittore erano sostanzialmente fondate sulle fonti seicentesche secon-do le quali fu davvero determinante, per la fase formativa, la decisione di trasferirsi “fan-ciulletto” a Roma. Là, certo in virtù di relazioni predisposte in patria, affiancò il viterbeseTarquinio Ligustri7 che, intorno al 1600, aveva ricevuto l’incarico dalla famiglia Mattei dieseguire decorazioni per il palazzo romano. Era supervisore di quel cantiere CristoforoRoncalli, detto il Pomarancio, conosciuto sicuramente in quell’occasione da Cavarozzi: co-
Bartolomeo Cavarozzi e le ‘Sacre Famiglie’:tracce per una congiuntura caravaggescatra Genova e la Spagna
Daniele Sanguineti
Bartolomeo CavarozziSacra Famiglia, particolare(cat. n. 3)
15Bartolomeo Cavarozzi e le ‘Sacre Famiglie’14 Daniele Sanguineti
stui, maestro d’arte in casa dei marchesi Crescenzi, non solo accolse come allievo il pro-mettente giovane ma dovette coinvolgerlo in quel colto cenacolo, mentre, dal canto loro, i“signori Crescentij” giunsero a “tratten(erlo) et alleva(rlo) come dei loro” conferendogli lafacoltà di raggiungere pittoricamente una “gran perfettione” e agevolandogli la stipula dicommissioni8. I rapporti tra Roncalli e Virgilio Crescenzi presero avvio verso il 1590, in oc-casione dell’impiego del pittore nel palazzo di famiglia al Pantheon, e proseguirono, dopola morte di questi (1592), con i suoi figli, in particolare con Giovanni Battista, di cui il Po-marancio divenne maestro e consulente artistico9. Il frutto di questo incontro fu la costitu-zione di un’accademia in palazzo Crescenzi, dove Giovanni Battista, egli stesso pittore, po-tente collezionista e mercante d’arte, “continuamente vi facea studiare a diversi giovani chealla pittura erano inclinati”10. È assai probabile che tale accademia si basasse sulla trasfor-mazione della provvisoria bottega lasciata da Roncalli in seguito alla sua partenza da Romain un’impresa gestita da Crescenzi e frequentata dai numerosi artisti già collegati al Poma-rancio11. Il risultato fu una “grande scuola naturalista”12, una “scuola di virtù”13 nella qua-le confluivano le numerose sollecitazioni culturali di quel colto primo decennio di secoloall’insegna sia dello studio della tradizione che della riproduzione artificiosa della realtà.Fu questo l’ambito culturale nel quale Cavarozzi, “che di Bartolomeo del Crescenzi il no-me acquistossi”14 per la predilezione mostrata verso di lui da Giovanni Battista, si formò ea cui improntò i suoi primi dipinti, fra i quali “molti quadri” per casa Crescenzi15. La fedeverso il verbo roncalliano è tangibile nella prima opera nota, datata 1608 e collocata in ori-gine sull’altare maggiore della distrutta chiesa di Sant’Orsola in piazza del Popolo16. LaSant’Orsola e le sue compagne (Roma, chiesa di San Marco; fig. 1)17 evidenzia, per la classi-ca postura della protagonista e per la simmetria compositiva, l’utilizzo di modelli tratti daRaffaello – in particolare la Santa Cecilia – e dallo stesso Roncalli – la pala d’altare di San-ta Domitilla – addolciti da un suggestivo contrasto chiaroscurale che aleggia sui morbidipanneggi e sui volti finemente modellati, lasciando intendere un’evoluzione in chiave at-mosferica del monumentale linguaggio del maestro. Tuttavia è innegabile che l’opera, agliocchi di Baglione18, dovesse rappresentare, rispetto all’evolversi della maniera matura di Ca-varozzi, il manifesto del debito formativo verso il Pomarancio. La datazione della secondapala ricordata da Baglione fra quelle della fase roncalliana, già custodita nella cappella Cre-scenzi in Sant’Andrea della Valle e raffigurante “San Carlo orante e angioli e puttini”19, ècompresa fra il 1610, allorquando avvenne la canonizzazione del santo, e il 1613, anno diconclusione dell’edificazione di quella porzione di chiesa20. Pur non disponendo dell’ope-ra, il giudizio del biografo sommato agli indizi cronologici consentono dunque di conside-rare in quegli anni ancora vivo e attuale l’interesse verso le modalità roncalliane. Mancini,a proposito di quest’ultima pala, osservava che il “colorito et disegno” erano bastati per ri-scuotere successo in città21. È evidente, da questo giudizio e dall’analisi della Sant’Orsola,che la progressione formativa prescelta dal pittore riservava una cura particolare alla fasedisegnativa, allo studio dei classici e all’osservazione ‘metabolizzante’ dei suoi geniali con-temporanei, da Guido Reni a Domenichino, da Gentileschi a Caravaggio. Corre su questobinario l’esegesi proposta da Luigi Spezzaferro22, che vide nel Martirio di santo Stefano(Monterotondo, duomo) – già citato nel 1624 come lavoro del “Crescentio”23, assegnato daalcuni a Giovanni Battista Crescenzi e a detta di Gianni Papi del tutto ingiudicabile a cau-sa dello stato conservativo24 – uno dei primi testi, databile fra il 1614 e il 1615, della speri-mentazione naturalistica in direzione reniano-gentileschiana25. È ormai tuttavia acquisito l’i-ter di sviluppo proposto da Papi, dove la conversione ai modi di Reni e Domenichino è col-locabile assai più avanti, verso il 162026. Certamente dall’esordio del nuovo decennio, in-torno al 1612-161327, avvenne il progressivo approdo a esiti di totale rinnovo linguistico:
“Dapoi cangiò gusto, e diedesi a ritrarre dal naturale con gran diligenza, e con finimenti dagrand’amore accompagnati”28. Naturalmente è necessario considerare l’estrema sintesi nar-rativa applicata all’impostazione cronologica della biografia cavarozziana: in virtù delle sva-riate componenti dello stile del pittore, il cambiamento di gusto che avvenne “dapoi” larealizzazione delle pale per la chiesa di Sant’Orsola e per Sant’Andrea della Valle dovreb-be essere valutato al di fuori della serrata successione temporale che caratterizza la biogra-fia29. Notizie d’archivio hanno permesso di ridurre sensibilmente un lasso di tempo trop-po vasto, se si pensa che lo Schleier andava a situare la conversione di Cavarozzi al natu-ralismo tra la morte del Caravaggio (1610) e il viaggio in Spagna (1617)30. Innanzitutto lacitazione del Lamento di Aminta (fig. 2), ovvero di “due putti, che uno suona un flauto, etl’altro ha posato un violino”, contenuta in una lettera datata 11 marzo 1615 con la quale ilconte di Villamediana, Juan de Tassis y Peralta, richiedeva al granduca Cosimo II de’ Me-dici il permesso di esportare alcuni dipinti dal Granducato di Toscana31. Quel dipinto, dicui la critica riconosce almeno due versioni autografe32, si potrebbe dunque sistemare cro-nologicamente tra marzo 1614 e febbraio 161533 – ovvero negli anni in cui il conte di Vil-lamediana si trovava a Roma – oppure in un momento più arretrato, se si dà credito alleosservazioni di Papi34 giustamente preoccupato di giustificare l’attribuzione a Caravaggionel documento citato (che però potrebbe anche celare ragioni commerciali)35 con un pas-saggio di proprietà dell’opera prima di approdare a Siena. Lo straordinario testo restitui-sce perfettamente lo spirito che doveva circolare all’interno del cenacolo di Giovanni Bat-tista Crescenzi36, il quale “talvolta havea gusto di far ritrarre dal naturale, e andava a pren-der qualche cosa di bello e di curioso, che per Roma ritrovavasi di frutti, d’animali, e d’al-tre bizzarrie, e consegnavala a quei giovani, che la disegnassero, solo perché divenisser va-lenti, e buoni Maestri, si come veramente adivenne”37. Emerge lampante il fascino eserci-tato dal colto tema musicale diffuso dal Caravaggio nelle opere degli anni novanta, e la vo-lontà di Cavarozzi, intento a modulare la luce per esaltare i volumi e per restituire con vo-
1. Bartolomeo Cavarozzi,Sant’Orsola e le sue compagne,Roma, chiesa di San Marco
2. Bartolomeo Cavarozzi, Lamentodi Aminta, collezione privata
17Bartolomeo Cavarozzi e le ‘Sacre Famiglie’
l’anno “Bartolomeo Pacarozzi da Viterbo” ricevette in ottemperanza alla disposizione delgranduca, Cosimo II de’ Medici45. Per primo Longhi lo restituì a Cavarozzi46, dopo che ingioventù, vedendovi un lavoro di Orazio Gentileschi, aveva dedicato al dipinto una pagi-na descrittiva davvero calzante anche per il suo vero autore47. Basata sui raffronti stilisticicon Caravaggio, evocato non a caso anche per lo schema iconografico, l’esegesi longhianadell’opera è tutta rivolta a mettere in rilievo che “v’è per tutto indugio e condotta eccessi-va di particolari”48. L’angelo frontale è direttamente caravaggesco, insieme all’ombra get-tata trasversalmente sul muro, mentre il “vecchio santo è […] più molle, più ricercato, grin-zoso […] che mai in Caravaggio”. Inoltre “panni troppo svolti e preparati, tavolo accura-
16 Daniele Sanguineti
lontà quasi scientifica gli effetti luministici sugli incarnati e sui tessuti, di operare attraver-so un’assoluta ripresa dal naturale e “in un’aura di caravaggismo accademizzante generica-mente baglionesco”38.
La Disputa di santo Stefano (collezione privata; fig. 3) è stata identificata, dopo in-stabili attribuzioni al Savonanzi, allo Spadarino e al Crescenzi, con il “quadro di S. Stefa-no che disputa con li Rabì fatto da quel giovane che sta col Crescenzij” segnalato nel 1616nella collezione di Giovanni Battista Mattei39. L’annotazione funge anche da utile testimo-nianza dell’appartenenza del pittore, a quella data, all’entourage di Crescenzi. Il dipinto,con i personaggi a mezzo busto disposti orizzontalmente su un primo piano, è il connubiodi uno schema caravaggesco, di volumetrie ampie e fisionomie solide di matrice roncallia-na e, nuovamente, di una “adesione sperimentale al verbo del Merisi” nella “durezza cri-stallina dei contrasti luministici”40. Due importanti ante quem, dunque, per offrire una cro-nologia all’appropriazione di “quella sua maniera finita con esattezza del naturale, e conbuon stile condotta”41 che dovrebbe non essere lontana dallo scoccare del secondo decennio.Attorno ai due cardini citati Gianni Papi ha aggregato due strepitose prove, il David conla testa di Golia (fig. 4) e una Sibilla42, caratterizzate non tanto da una scrittura di netta ce-sura da una fase all’altra quanto da una felicissima e armoniosa evoluzione, in chiave na-turalistica, benché ancora “aspra e acerba”, della ‘maniera’ già acquisita. Alla Disputa si af-fianca strettamente la Cena in Emmaus del Getty Museum43 (fig. 5), per l’identico tratta-mento dei panni, delle ombre, delle spore di roncallismo nel volto del Cristo che convive,quanto a scelta dell’impianto e a disposizione virtuosistica della straordinaria canestra difrutta, con il modello caravaggesco offerto dalla Cena in Emmaus Mattei (Londra, Natio-nal Gallery). Tanto più che il successivo testo disponibile è da stimare coerente manifestodei risultati ottenuti portando a definitivo compimento il “passaggio dall’esperienza ron-calliana a un naturalismo acerbo, caravaggesco in senso ortodosso”44. Il San Gerolamo,parte delle collezioni medicee ed esposto nella Galleria Palatina (fig. 6), venne realizzatonel 1617, poiché a quel dipinto è certamente riferibile il pagamento che nell’aprile di quel-
3. Bartolomeo Cavarozzi, Disputa disanto Stefano, collezione privata
4. Bartolomeo Cavarozzi, David conla testa di Golia, ubicazione ignota
5. Bartolomeo Cavarozzi, Cena inEmmaus, Los Angeles, The J. PaulGetty Museum
6. Bartolomeo Cavarozzi,San Gerolamo, Firenze,Galleria Palatina
19Bartolomeo Cavarozzi e le ‘Sacre Famiglie’
do la Gregori, che conferisce vitalità agli inserti più propriamente da naturamortista con-tenuti nei dipinti citati, dal teschio del San Gerolamo della Palatina (fig. 6) alle foglie e ar-busti, si aggiunge qui, che compaiono, ad esempio, nella Sacra Famiglia San Paolo (cat. n.1). Anzi, nei rami fogliati che decorano il suolo nella Sacra Famiglia con san Giovannino (cat.n. 4), databile a un momento di già avvenuta evoluzione del suo linguaggio, si nota una sin-tesi descrittiva tradotta con porosità materica riscontrabile parimenti nei dipinti di sola na-tura morta assegnati alla tarda fase evolutiva del Maestro Acquavella66. Nelle opere citate“convergono sia il ‘giovane che sta col Crescenzij’, cioè il Cavarozzi, che il supposto Mae-stro della natura morta Acquavella, suo collaboratore abituale, io penso, fino all’identità”67.E nell’affrontare questo affascinante e complesso tema non si può non imbattersi nel belSan Giovanni Battista della cattedrale di Toledo (fig. 7) per il quale si vedrebbe davvero piùappropriata un’attribuzione a Cavarozzi, come del resto già sosteneva dubitativamente Ro-berto Longhi e più fermamente, ma per la sola figura, Carlo Volpe68. Nel testo, dalla piùrecente critica offerto troppo generosamente al catalogo del Caravaggio69, si evidenzia, siaa livello emozionale sia di più approfondita analisi stilistica, non solo che la scrittura checaratterizza il magnifico fondo condotto a fogliame è davvero vicinissima alle qualità tec-niche esaminate nei brani di natura introdotti nelle tele di Cavarozzi, ma soprattutto che ilvolto del giovane ricoperto di ombre trasparenti e il panneggiare gagliardo reso tridimen-sionale dall’accostamento del porpora puro con il nero profondo dei gorghi paiono del tut-to paragonabili alle qualità che mostrano i panni e gli incarnati delle figure nella Cena inEmmaus del Getty Museum (fig. 5) e del San Gerolamo di Firenze (fig. 6). L’agnello inol-tre è indagato con una tecnica assai gentileschiana – si pensi alla veste che ricopre il Davi-de della Galleria Spada70 – che, si è detto, fu minuziosamente osservata dal giovane Barto-lomeo71. La proposta dovrà essere verificata, eventualmente, attraverso auspicabili notizied’archivio che gettino luce sulle prime vicende di questa tela; al momento si può conget-turare una realizzazione all’indomani dell’approdo spagnolo di Cavarozzi e una considera-zione guadagnata, grazie a Crescenzi, presso la corte di Filippo III e nell’ambiente della com-mittenza altolocata. Del resto, già anteriormente al viaggio in Spagna, Cavarozzi, sempregrazie al suo mecenate, era entrato in contatto a Roma con importanti collezionisti, comeGiovanni Battista Mattei, che nel 1616 era in possesso della Disputa di santo Stefano e diun perduto “Nostro Signore [che] entrò trionfante in Gierusalemme”72, e il cardinale Lu-dovisi, nella cui collezione inventariata nel 1633 compare “una madonna col Puttino in brac-cio […] di Bartolomeo di Crescentio”73.
La permanenza madrilena di Cavarozzi è sempre stata considerata parallela al sog-giorno di Giovanni Battista Crescenzi, che, secondo le fonti, fece ritorno a Roma nel mag-gio del 161974 per poi riguadagnare immediatamente e definitivamente la Spagna per so-vrintendere all’edificazione del Pantheon all’Escorial. Solo Gianni Papi, sulla base dellaregolare presenza a lui nota del pittore a Roma a partire dal 1622, non escluse un ritornoin Spagna col Crescenzi – “magari perché […] poteva avere gettato le basi per nuove com-missioni” – fino a contemplare la possibilità di una tappa per qualche tempo a Genova,secondo l’ipotesi formulata, come si vedrà, sulla base di fondanti considerazioni stilistichee dell’esistenza di alcune sue composizioni nelle quadrerie di quella città75. Tuttavia il rin-venimento di alcuni documenti relativi a commissioni destinate a Viterbo rende possibilecertificare la presenza dell’artista a Roma già dalla metà del 162176, mentre il Ritratto digiovane ecclesiastico77 (collezione privata; fig. 8) che, secondo la probabile ipotesi di Stri-nati, potrebbe raffigurare il figlio oratoriano di Giovanni Battista Crescenzi, Alessandro,nato nel 1607 e stimabile nel dipinto all’incirca tredicenne, consentirebbe un’ulteriore an-ticipazione del rientro fra il 1620 e il 1621. Il dipinto, “fortemente naturalistico e insieme
18 Daniele Sanguineti
tamente tarlato, libri, folianti, clessidra e metalli troppo storicamente determinati […]”49
lasciano intendere che le tentazioni latenti della maniera, ormai parte della concezione ar-tistica del pittore, colpiscono anche il naturalismo caravaggesco, sovraccaricandolo di in-ganni ottici e colte citazioni, come la riproduzione dell’incisione realizzata da Albrecht Dü-rer nel 1514 raffigurante la Madonna davanti alle mura di Norimberga50. La scelta di un pia-no orizzontale a cui dedicare risalto, distribuendovi strumenti della preghiera e parte delcorredo iconografico del santo, guarda da vicino a diretti capolavori caravaggeschi, comeil Suonatore di liuto di San Pietroburgo51, peraltro già considerato per la sistemazione delviolino e degli spartiti nel Lamento di Aminta (fig. 2). Il risultato è di altissima qualità, conuna capacità di personale rielaborazione e di resa estetica davvero sorprendenti, come di-mostra quel manto che si srotola sul tavolo frutto di liquida luce colorata e di sinuosi ara-beschi d’ombra.
Con questo grado di maturazione stilistica, con questo orientamento figurativo la cuievoluzione sarà destinata a proseguire, Bartolomeo si apprestò a recarsi in Spagna insiemea Giovanni Battista Crescenzi in un giorno da reputare successivo al 14 ottobre 1617, al-lorquando il nobile artista e mecenate battezzò a Roma il proprio figlio52, ma ancora entrola conclusione di quell’anno, ricordato con precisione dal Baglione53. Giulio Mancini scris-se dunque la versione breve delle sue Considerazioni sulla pittura dalla fine del 1617 o nelcorso del 1618 se, nelle poche righe dedicate a Cavarozzi, disse, coniugando al presente iverbi, che il pittore “alla corte di Spagna, ivi con util et honore raccoglie i frutti di tante fa-dighe durate” e che “si trova alla corte del Re Cattolico condotto ivi dal suo mecenate Si-gnor Gio Battista Crescentij”54. Quest’ultimo si era posto in viaggio per Madrid al seguitodel cardinale Zapada e, presentato alla corte di Filippo III, aveva certamente “offerto al reuna serie di omaggi tesi ad accreditare la sua immagine di virtuoso e di amatore della artidel disegno”55 tra cui una sua pittura di natura morta, “un lienzo de frutas y flores” secon-do Palomino56, “una bellissima mostra di Cristalli variamente rappresentati, altri con ap-pannamenti di gelo, altri con frutti entro l’acqua” secondo Baglione57.
A questo punto è doveroso un breve ragguaglio su una complessa questione criticache, chiamando in causa il Maestro della natura morta Acquavella, tende ad assegnare i bra-ni di natura morta presenti nelle opere cavarozziane, in particolare quelli inseriti nelle ver-sioni del Lamento di Aminta (fig. 2), a uno specialista e collaboratore di Bartolomeo58. Ciòche ricordavano le fonti a proposito di Giovanni Battista Crescenzi, a momenti identifica-to con questo collaboratore ma anche con il Maestro della natura morta di Hartford59, siprestava facilmente a offrire valide ragioni per smascherare in tal modo l’anonimo autoredi tali splendidi brani e di dipinti autonomi60. Ma la recente proposta avanzata da GianniPapi61 e avallata da Mina Gregori62 sembrerebbe davvero la più ragionevole, oltre che lapiù coerente per fondamentali ragioni di stile, ovvero che l’armonia tangibile nel Lamentodi Aminta (fig. 2) o nella Cena in Emmaus (fig. 5), dalla resa lucida e dorata degli strumentimusicali all’intensa e materica indagine dei grappoli d’uva e delle foglie di vite, implichi ladiretta e costante presenza del pennello dello stesso Cavarozzi. L’alta tenuta del modus ope-randi, dagli esiti davvero superlativi, si presta con coerenza a questi brani, se non a vere eproprie tele di natura morta63, come del resto lasciava – implicitamente ma perentoriamente– intendere Mancini nell’affermare che Bartolomeo fece “grandissimi progressi nella pro-fessione, essendo universale di tutte le cose et con tutti i modi di operare”64. Inoltre la ci-tazione in un inventario genovese del Lamento di Aminta come opera esclusiva di “Barto-lomeo da Viterbo” si presta a comprovare l’assenza di una seconda mano nell’esecuzionedel brano, tutt’altro che secondario, di natura morta65. Il modo veloce, frusciante, di far scor-rere il pennello per delineare le sete dei vestiti nei dipinti di questi anni è lo stesso, secon-
7. Bartolomeo Cavarozzi (?),San Giovanni Battista, Toledo,cattedrale
21Bartolomeo Cavarozzi e le ‘Sacre Famiglie’
mi”, veniva definito “valentuomo” in una lettera indirizzata dall’agente dei Priori di Vi-terbo a Roma ai Priori stessi, preoccupati per il ritardo nella consegna della Visitazione84.La scomparsa prematura dell’artista, che viveva a Roma in via Ripetta insieme alla madrevedova e, nell’ultimo anno di vita, con un “Giovanni garzone”, avvenne, come già riporta-va il Baglione, il 21 settembre 1625 e “veramente la sua fu gran perdita”85.
Le ‘Sacre Famiglie’: variazioni sul temaAll’apertura del secondo decennio del Seicento, la progressiva tensione artistica, stimolataprobabilmente dal Crescenzi e dall’irresistibile fascino emanato dalla nuova prassi consa-crata dal Caravaggio – appena defunto – e dai caravaggeschi della prima ora, si tradussenella mente di Bartolomeo Cavarozzi in un allargarsi dei riferimenti culturali e visivi chedeterminarono un consapevole rinnovamento sia sul versante tecnico che sulle scelte for-mali. Il tema della ‘Sacra Famiglia’, pur non annoverandosi, a quanto è dato sapere, tra leiconografie ad essere affrontate appena “cangiò gusto”86, fu assai reiterato durante quellache Gianni Papi ha individuato come la fase più matura di indagine del linguaggio natura-listico in chiave caravaggesca, dominata da un’attenzione alla riproduzione sofisticata delreale87. Spartiacque di questo momento, dovendo fare i conti con i pochi dati disponibili,può essere assunto il San Gerolamo della Galleria Palatina (fig. 6), a cui è riferibile un pa-gamento dei primi mesi del 161788. Le quattro opere esposte in mostra, ruotanti ad ampioraggio attorno a questa data, sono nel contempo approfondimenti di uno stesso tema e pro-totipi di altrettanti gruppi di repliche; sottendono comunque la confezione di questi capo-lavori sia ragioni di entusiastica risposta di mercato agli esiti ottenuti dal pittore sia le la-tenti “tentazioni seriali”89 che caratterizzano il modus operandi di Cavarozzi come di molticaravaggeschi alla ricerca di una realtà condotta a perfezione.
Vincenzo Giustiniani, nel suo Discorso sopra la Pittura, lasciava intendere la portatadi irradiazione romana del verbo caravaggesco nei confronti di una pittura “la quale al di
20 Daniele Sanguineti
intriso di alto senso etico, di classica impostazione e nel contempo anomalo e originalissi-mo”78, mostra un disegno rigoroso, atmosfere umbratili e una stesura corposa negli incar-nati sfiorati da ombre velate. Gli stessi elementi che si osservano nella Sacra Famiglia del-l’Albertina (cat. n. 3), soprattutto nel volto mariano, e nella splendida Santa Cecilia (Mi-lano, collezione privata; fig. 9)79, opere da porre in stretta vicinanza cronologica, ovverotra il 1618 e il 1619, nel corso dell’estrema permanenza spagnola. Prevale in questa fase,secondo l’efficace analisi di Marco Gallo80, un caravaggismo ormai estenuato, “deprivatod’ogni residuo di tensione morale” e scortato da una proposta naturalistica giunta a scle-rotizzazione, per far emergere, piuttosto, la conversione verso un lessico regolarizzato neitermini del disegno, del colore e delle pieghe tendenti alla geometrizzazione, forgiato os-servando Reni, Domenichino e Lanfranco. È ciò che è possibile osservare dall’immaginedella dispersa pala raffigurante la Madonna con Gesù Bambino e sant’Anna (fig. 10), rea-lizzata per la chiesa di Sant’Anna dei Funari immediatamente dopo il rientro a Roma, co-me già ricordava il Baglione che la giudicava di “buon gusto” e di “tocco gagliardo” rife-rendosi certo al tono magniloquente, all’impianto scenografico e al percorso brioso ed en-fatico intrapreso dai piegami che si accartocciano virtuosisticamente ai piedi delle figure81.La correttezza del linguaggio di questa fase estrema, inaugurata intorno al 1620, quandosi crede abbia visto la luce anche la Sacra Famiglia con san Giovannino (cat. n. 4), sostan-zia la produzione destinata alla città natale del pittore – come la Madonna con Gesù Bam-bino, realizzata durante la seconda metà del 1621 (Viterbo, Museo del Colle del duomo;fig. 11), e la Visitazione, conclusa entro il 31 marzo 1622 (Viterbo, palazzo comunale; fig.12)82 – che rivelano, nell’assumere i caratteri fenomenici della natura all’interno di un con-testo ideale, l’appropriazione di un classicismo naturalistico. La Madonna con Gesù Bam-bino della Galleria Spada a Roma83 (fig. 13), del tutto accostabile al dipinto di identica ico-nografia conservato a Viterbo (fig. 11), dimostra l’appropriazione di una pennellata piùcorposa e campita che regolarizza pieghe geometriche e tornisce nettamente le fisionomie,dalla classica bellezza. Ne sortiscono immagini, come la Santa martire di Murcia (fig. 17),caratterizzate da una devozionalità glassata, a volte piuttosto algida, con una stesura piùsemplificata e sintetica nell’impasto. Nel 1622 il pittore, che “in Roma concorre con i pri-
11. Bartolomeo Cavarozzi, Madonnacon Gesù Bambino, Viterbo, Museodel Colle del duomo
12. Bartolomeo Cavarozzi,Visitazione, Viterbo, palazzocomunale
8. Bartolomeo Cavarozzi, Ritratto digiovane ecclesiastico (AlessandroCrescenzi?), collezione privata
9. Bartolomeo Cavarozzi, SantaCecilia, Milano, collezione privata
10. Bartolomeo Cavarozzi, Madonnacon Gesù Bambino e sant’Anna,ubicazione ignota (già Roma, chiesadi Sant’Anna dei Funari)
23Bartolomeo Cavarozzi e le ‘Sacre Famiglie’
mensione atemporale. Tralasciando per ora la Sacra Famiglia con san Giovannino (cat. n.4), nella quale si assiste a una notevole evoluzione compositiva e linguistica che merita unatrattazione a sé stante, è indubbio che, ponendo a raffronto la tela del Fondo Pensioni delGruppo San Paolo Imi (cat. n. 1), quella attualmente in deposito presso la Galleria Na-zionale della Liguria a Palazzo Spinola (cat. n. 2) e il capolavoro dell’Accademia Alberti-na (cat. n. 3), si sia dinanzi, al di là di ragioni commerciali e di probabile risposta ai desi-deri della committenza, a una maniacale ricerca di approfondimento condotto in uno stret-to giro d’anni su un tema collaudato, consacrato da una tradizione secolare di rappresen-tazione. La grande dimensione conferita alle figure, l’avanzamento su un primissimo pia-no del gruppo Vergine con Bambino, il netto risalto, tramite il dominio della luce, asse-gnato solo ad alcuni brani costituiscono gli elementi di strabiliante rinnovo contenuti inqueste opere, sempre in bilico fra l’imitazione della nuda realtà e una volontà latente diidealizzazione di cui perno è il viso della Vergine, popolana ma anche regina e poi crea-tura sovrannaturale per quel suo sguardo fisso, cristallino, diretto, dalla fisiognomica im-perscrutabile che, trapassando la tela, colpisce direttamente al cuore colui che si trova difronte. Proprio la grande figura mariana, delineata nella sua interezza96 e circondata da ungorgo di vesti adagiate in pieghe serpeggianti sul terreno, svela il diretto riferimento os-servato da Cavarozzi. Che questo riferimento sia rappresentato dallo stesso Caravaggio nonfa che confermare, per un caravaggista blandamente ortodosso, la necessità di studio di-retto dei capolavori più giovanili del maestro eletto a nume tutelare, del resto già abba-stanza esplicita nella Cena in Emmaus del Getty Museum (fig. 5) e nel San Gerolamo del-la Palatina (fig. 6). La splendida Santa Caterina d’Alessandria (Madrid, collezione Thys-sen-Bornemisza; fig. 14)97, impegnativo e grandioso capolavoro giovanile realizzato dalCaravaggio intorno al 1599 per il cardinal Del Monte, funge da indubbio spunto compo-sitivo osservato da Cavarozzi per la posa e per lo sguardo delle sue Madonne, oltre cheper lo sfondo immerso nell’oscurità ma, nel contempo, generatore di spazialità, per il ti-po di illuminazione netta spiovente dall’alto sopra il personaggio e per gli effetti di rea-zione alla luce di stoffe ed epidermidi. Si immagina dunque che Bartolomeo, con la San-ta Caterina del Merisi negli occhi, abbia adottato, per affrontare la prima delle ‘Sacre Fa-
22 Daniele Sanguineti
d’oggi è in colmo di estimazione, non solo per quanto porta l’uso di Roma ordinario maanco per mandare fuori in Spagna, Francia, Fiandra, Inghilterra, a altre parti”90. Dal cantosuo, Cavarozzi, soggiornando in Spagna, dove “vi operò molte cose”91, e, al suo rientro, in-viando a Madrid, secondo le fonti, un buon numero di commissioni, fece la propria partedi divulgazione del verbo caravaggesco, non distogliendosi dalla verifica, condotta con ac-curatissima tenuta analitica, intorno a pochi temi iconografici, del resto già presente dai pri-mi anni dieci come dimostrano le varie versioni del Lamento di Aminta (fig. 2). Non solo,ma i probabili contatti che in Spagna, come si vedrà, il pittore dovette instaurare con la raf-finata committenza genovese, il transito a Genova di sue opere e l’esecuzione – che qui siritiene romana – della prima Sacra Famiglia (cat. n. 1), offrono la misura della notevole traiet-toria di diffusione di questo fortunato tema.
L’esigenza di serialità autografa, prassi condotta dallo stesso Merisi, sembrerebbe unaspetto, per così dire, di seconda mano della ripresa dal vero del modello. È interessantericordare ciò che già si conosce a proposito di Orazio Gentileschi, autore notevolmente os-servato dal nostro Bartolomeo. Si dispone infatti di testimonianze dirette di alcuni model-li che posarono per il pittore, tra le quali è veramente pregnante, per le straordinarie infor-mazioni ricavabili sulla prassi dei caravaggeschi, quella rilasciata da Pietro Molli, un anzia-no pellegrino palermitano secondo il quale Gentileschi si servì di lui, facendolo “spogliaredalla cintura [in su]”, in qualità di san Gerolamo “per certi quadri che lui faceva”, tratte-nendolo in casa sua “tutta la quadragessima”92. Il frutto dell’impegno di Molli con il Gen-tileschi si individua oggi nel dipinto della collezione Koelliker, mentre la presenza di unareplica con varianti, ovvero quella del Museo Civico d’Arte Antica di Torino, e l’impiegodella stessa testa per il Sacrificio di Isacco della Galleria Nazionale della Liguria a PalazzoSpinola di Genova, pongono problemi, difficilmente risolvibili, circa l’uso di cartoni le cuitracce in realtà non si sono trovate in fase di analisi diagnostica93. Nel caso di Cavarozzi –tralasciando in questa sede il rapporto con i dipinti individuabili come possibili replicheautografe delle composizioni qui esposte per l’impossibilità di operare verifiche dirette sudi essi – si osserva per lo più l’evoluzione di uno stesso intreccio compositivo con un uti-lizzo probabilmente parziale di modelli in carne e ossa così come di un repertorio di schiz-zi e disegni per i dettagli. Assunzione dunque delle stesse pose o impiego di strumenti gui-da, come cartoni e incisioni sulla preparazione della tela? Se quest’ultimo elemento potrebberitrovarsi nelle repliche autografe – e si vorrebbe, ad esempio, esaminare il dipinto di col-lezione privata madrilena, replica di quello qui esposto (cat. n. 1) – le analisi praticate sulquadro dell’Accademia Albertina (cat. n. 3) hanno negato la presenza di incisioni ma han-no mostrato l’utilizzo assai interessante del pennello come efficace guida dei contorni, perl’ingombro delle vesti, delle teste, per delineare gli arti, attraverso sottili linee spesso fau-trici di creste di contenimento.
L’impatto unitario di tre delle quattro tele esposte (cat. nn. 1-3) e il rigoroso impiantoluministico che le accomuna confermano l’applicazione di Cavarozzi nel “dipignere conavere gli oggetti naturali d’avanti”94; tuttavia l’evidente volontà di perfezionare la rappre-sentazione con citazioni dai classici o con l’uso della fantasia permette di inserire a pienodiritto Cavarozzi tra coloro che praticavano, secondo la teorizzazione del Giustiniani, ildodicesimo metodo, “il più perfetto di tutti”, cioè “dipignere di maniera e con l’esempioavanti del naturale”95. A cominciare dallo spazio in cui sono calate le prime tre composi-zioni (cat. nn. 1-3), trasformazione quasi metafisica della probabile stanza in cui si trova-va il pittore con i suoi modelli, attraverso raffinate capacità luministiche nel suggerire orauna roccia, per metà inghiottita dall’ombra e per metà svelata da un riflesso di luce, oraun terreno con arbusti, sassi, pianticelle, proiettati da un pennello indagatore in una di-
14. Caravaggio, Santa Caterinad’Alessandria, Madrid, collezioneThyssen-Bornemisza
15. Orazio Gentileschi, Madonnacon Gesù Bambino, Bucarest,Muzeul National de Arta alRomâniei
16. Orazio Borgianni, Madonna conGesù Bambino, collezione privata
13. Bartolomeo Cavarozzi, Madonnacon Gesù Bambino, Roma, GalleriaSpada
25Bartolomeo Cavarozzi e le ‘Sacre Famiglie’
indizi sui lunghi tempi di esecuzione di un’opera: il primo gennaio 1622, infatti, AurelioMarrocchi, l’agente romano dei Priori di Viterbo, giustificava il ritardo accumulato da Bar-tolomeo nella realizzazione della Visitazione (fig. 12) per la cappella del palazzo dei Prio-ri con l’impegno di una precedente commissione – individuabile nella Madonna con GesùBambino per il cardinale Cobeluzzi (Viterbo, Museo del Colle del duomo; fig. 11) – sullaquale si era focalizzato per cinque mesi102. Dunque partendo dal modello, o dai modelli,Bartolomeo, almeno per una certa fase della sua attività, andava a completare abilmente eautonomamente la tela, con una lentezza indispensabile per ottenere l’indagine ottica ri-cercata e per esprimere la propria poetica sempre posta a conferire perfezione estetica al-la realtà. Il risultato è strabiliante e dovette essere tale anche per i contemporanei: par-tendo dall’osservazione di una quotidianità abitata da un vecchio canuto e da una giova-ne madre con il robusto bimbo in grembo egli riuscì a creare, tramite lo studio della luce,le pose lente, i volumi massicci, gli sguardi diretti, una raffigurazione reale della Sacra Fa-miglia, come se un fascio di luce celeste, vincendo ogni barriera di spazio e di tempo, po-tesse restituirci una visione dei tre personaggi, nella loro fisica unicità di figure storiche.Come fotogrammi successivi della stessa scena, lunga alcuni anni, è possibile tentare di con-ferire un ordine cronologico alle prime tre tele, innegabilmente affini per stile e composi-zione in quanto variazioni di uno stesso tema. Ma per prima cosa è opportuno arginare,con i pochi, sfuggenti, dati disponibili, la cronologia della partenza del pittore da Romasul calare del secondo decennio per stabilire un ambito temporale entro cui situare la rea-lizzazione delle Sacre Famiglie, poiché “il fatto che Cavarozzi riprendesse spesso con po-che varianti i propri soggetti di maggior successo ha nuociuto alla corretta definizione delsuo catalogo e della cronologia”103. Bartolomeo, che il 16 aprile 1617 ricevette un paga-mento per ordine del granduca Cosimo II de’ Medici in merito, verosimilmente, al San Ge-rolamo della Galleria Palatina (fig. 6), partì per la Spagna successivamente all’ottobre diquell’anno, poiché Giovanni Battista Crescenzi, al cui seguito si accodò, risulta aver bat-tezzato a Roma un figlio alla metà di quel mese104. Si pensa di collocare dunque ancora nelpieno della prima fase romana successiva alla conversione caravaggesca, segnatamente in-torno al 1615, la Sacra Famiglia del Fondo Pensioni del Gruppo San Paolo Imi (cat. n. 1),non solo per lo schema frontale, poi più decisamente ruotato, o per il carattere accentua-tamente popolaresco della modella, ma soprattutto per notevoli tangenze di scrittura condipinti, come il Lamento di Aminta (collezione privata; fig. 2), la Disputa di santo Stefano(collezione privata; fig. 3) e la Cena in Emmaus (Los Angeles, The J. Paul Getty Museum;fig. 5), databili, sulla base di probanti indizi, nel corso del primo lustro del secondo de-cennio105. Le campiture nette della veste mariana, di derivazione roncalliana, la vicinanzanotevole al Gentileschi nella delineazione di Giuseppe, financo nella resa bruna e com-patta degli incarnati, l’abile pezzo di bravura del lino grezzo meticolosamente indagato nel-la consistenza tessile e nella disposizione delle pieghe, comprova tale ipotesi. Le piante egli arbusti presenti in questo testo la dicono lunga, con quel modo fresco, brioso di lu-meggiare i riflessi e di virgolettare le foglie ripiene di esuberanza cromatica, sulle doti dinaturamortista di Cavarozzi. Decisamente accostabili al San Gerolamo fiorentino (fig. 6)sono invece gli altri due quadri che, anche in virtù – come si vedrà – della probabile pro-venienza, si ritengono eseguiti durante la permanenza spagnola e, dunque, tra la fine del1617 e parte del 1619. L’ordine temporale del rientro dalla Spagna è di gran lunga più pro-blematico: accanto al dato sicuro che registra il pittore a Roma dalla metà del 1621106, siaffianca l’elemento ricavabile dal Ritratto di giovane ecclesiastico (collezione privata; fig.8) che, se fosse giusta l’ipotesi di riconoscerlo in Alessandro Crescenzi, figlio di Giovan-ni Battista, potrebbe anticipare ulteriormente la presenza a Roma, essendo databile, in ba-
24 Daniele Sanguineti
miglie’ note (cat. n. 1), una simile mise en scène disponendone al centro una modella dal-le ricche vesti drappeggiate. In modo similare Orazio Gentileschi, intorno al 1610, avevautilizzato Costanza Ceuli, una vicina di casa, con il suo pasciuto neonato per realizzare unaMadonna con Gesù Bambino (Bucarest, Muzeul Nat‚ional de Arta al României; fig. 15)98,anch’essa sicuramente nota a Cavarozzi per il tipo di effetti, sorprendentemente realistici,del lino grezzo colpito dalla luce. Proprio l’assoluta verità del gesto, che comunica innan-zitutto la fisica e affettuosa gestione di un neonato da parte della propria madre che lo tie-ne in grembo per dispensargli protezione dopo un brusco risveglio nella culla, è rappre-sentata da Cavarozzi secondo quella prassi caravaggesca, registrata dal Van Mander già nel1603, di non eseguire “un solo tratto senza farlo direttamente dal modello vivo, copian-dolo e dipingendolo”99, prassi deplorata da Bellori per il quale i pittori a Roma dipinge-vano “spogliando i modelli ed alzando i lumi”100. Del resto anche Orazio Borgianni avevaottenuto esiti assai simili nella Sacra Famiglia con sant’Anna e, pur in presenza non di mo-delli ma di un “prototipo compositivo […] di ambito raffellesco”, nella tenerissima Ma-donna con Gesù Bambino101 (fig. 16). Il volto mariano presente nei tre dipinti (cat. nn. 1-3) subisce modifiche tali da far ritenere probabile l’impiego in parte di modelle diverse,in parte di successive rielaborazioni fisiognomiche: se la Madonna della tela del Fondo Pen-sioni del Gruppo San Paolo Imi (cat. n. 1) mostra tratti veraci, accentuati da chiome sciol-te, quasi disordinate, quella ritratta nel dipinto ora a Genova (cat. n. 2) presenta una dol-cezza realistica con la capigliatura raccolta in trecce sulla sommità del capo, mentre quel-la che compare nel dipinto dell’Albertina (cat. n. 3) rivela già un’accentuata fisionomia idea-lizzante. Anche i Bimbi delle due prime tele (cat. nn. 1-2) palesano una diversità di trattiche evoca con facilità una loro presenza fisica, mentre il terzo (cat. n. 3), peraltro simile aquello inserito nel Matrimonio mistico di santa Caterina (fig. 20), sembrerebbe più ange-licato, troppo perfetto nel volto. I tre san Giuseppe infine manifestano chiaramente, peri pregnanti caratteri del viso e per un atteggiamento sicuramente frutto di sedute con ilmodello, una ripresa dal vero, con l’impiego, limitatamente alla figura inserita nella telatorinese (cat. n. 3), di una postura genericamente suggerita dal Giuseppe del Riposo cara-vaggesco Doria-Pamphili. Sembra dunque chiaro il ricorso a modelli in carne e ossa suiquali verificare, attraverso un lume posto in alto, gli effetti della luce sui volti e sui tessu-ti: l’assenza di un disegno preparatorio e la presenza di pentimenti piccoli ma significati-vi – come la traiettoria delle dita delle mani e l’occhio sinistro della Vergine – registratinel corso delle analisi condotte sulla tela dell’Albertina (cat. n. 3) offrono, a tal proposi-to, indizi chiari sulle modalità di dipingere dal vero, non precludendo tuttavia una simul-tanea rielaborazione finalizzata a migliorare la realtà, come si ritiene sia accaduto proprioper il dipinto torinese. La ripresa dal vero esigeva la scelta di pose che il modello fosse ingrado di mantenere con una certa continuità e potesse riassumere facilmente da una se-duta all’altra: se ai modelli che si prestarono a rappresentare san Giuseppe toccarono po-se statiche utili per restituire il ruolo meditativo del santo ma anche per offrire un facilepunto d’appoggio durante la seduta, ora con il mento sostenuto dalla mano ora appog-giato al bastone, più elaborate e frammentate furono le sedute con la novella Maria e ilsuo figlioletto, certo a causa della postura non sopportabile a lungo. Proprio per questonon è inverosimile che il pittore fosse ricorso alla presenza dei modelli solo per ciò che eraveramente indispensabile – come i volti lambiti dal chiaroscuro – mentre per le restantiparti avesse ripreso dal vero i singoli oggetti, come drappi, vesti e panneggi, adeguatamentepredisposti. È innegabile, comunque, che la realizzazione di Giuseppe, collocato in secondopiano e come ritagliato sullo sfondo, rappresentasse un inserimento successivo frutto diuna seduta autonoma. Una testimonianza dell’ultima attività dell’artista offre interessanti
27Bartolomeo Cavarozzi e le ‘Sacre Famiglie’
scalare a partire dal 1620, successivamente al rientro in Italia, allorquando, dipinta la pa-la per la chiesa di Sant’Anna dei Funari (fig. 10) – assai vicina, a giudicare dalla fotogra-fia rinvenuta e presentata da Papi110, alla nostra tela (cat. n. 4) – il pittore ebbe ancora mo-do di realizzare opere per la Spagna.
Non è detto che le odierne collezioni private, evoluzioni delle quadrerie a cui eranoindubbiamente rivolte le ‘Sacre Famiglie’ cavarozziane, non possano, prima o poi, rivelarequalche altro prototipo del viterbese: ad esempio la tela a San Pietroburgo111 (fig. 18), ap-parentemente affine alla Sacra Famiglia ora in deposito presso Palazzo Spinola (cat. n. 2)ma caratterizzata da sostanziali varianti rispetto a quest’ultima nell’atteggiamento delle ma-ni mariane e nella disposizione di san Giuseppe, potrebbe testimoniare, in qualità di copia,l’esistenza di un prototipo finora sconosciuto. Oppure la “madonna col Puttino in braccio,co’ un panno roscio sopra la testa […] di Bartolomeo di Crescentio”, menzionata nel 1633nella collezione del cardinale Ludovisi112. Sicuramente esisteva un ulteriore prototipo di Ca-varozzi come bella variante delle sue invenzioni ed è testimoniato dalle due copie, che con-servano l’indubbia matrice cavarozziana ma che sono dovute a pennelli probabilmente nor-dici (Berlino, Gemäldegalerie; Langon, chiesa di Saint Sulpice; fig. 19)113: la composizione,assai simile alla tela dell’Albertina (cat. n. 3), prevede il Bambino che scosta la camicia al-la Madre come per voler essere allattato e san Giuseppe colto nella lettura di un libro. Ta-le ipotesi, che potrà essere confermata dall’auspicabile rinvenimento dell’originale disper-so, permette poi di immaginare un’esecuzione al termine del periodo spagnolo, per la tan-gibile evoluzione sentimentale, resa anche attraverso forme magniloquenti, del tutto con-sona alla pala per Sant’Anna dei Funari (fig. 10).
L’esistenza di innumerevoli copie, tratte soprattutto dalle prime tre ‘Sacre Famiglie’(cat. nn. 1-3), non può che rinviare alla fortuna goduta da quelle opere e all’importanza cheCavarozzi rivestì per l’evoluzione della scuola pittorica spagnola: è ad esempio indicativorilevare il grado di suggestione compositiva e stilistica cavarozziana presente nei quadri delcosiddetto Maestro del Matrimonio mistico di santa Caterina114, oltre a quella particolareaccezione di delicato naturalismo che affascinò il giovane Murillo115. La diffusione capilla-re in Spagna, il cui caposaldo bibliografico resta il lavoro fornito da Pérez Sánchez e di cuisi dà parzialmente conto nelle relative schede, si spiega con la presenza in loco di quellecomposizioni: “cuadros de oratorio o de altar en capillas de fundacíon privada, su mesu-rado realismo, su gracia humana, tierna en sus deliciosos niños y en sus morenas vírgenessoñadoras, hubieron de dejar aquí huella no sólo inmediata, sino fructificadora a la larga”116.Di recente Pierre Curie ha indicato un approccio metodologico alle copie esistenti trattedalle ‘Sacre Famiglie’ di Cavarozzi, ritenendo probabile giustificare la diffusione in Fran-cia e nelle Fiandre non solo con un precoce transito dei prototipi, o di buone copie, in col-lezioni di quelle zone, ma anche con l’esistenza di fogli incisi non ancora rintracciati117. Gliartisti di orbita nordica, non semplicemente copisti, si trovarono, secondo Gianni Papi, difronte agli originali di Bartolomeo direttamente in Spagna o a Genova, “dove i fiamminghierano di casa”118.
Dalla ‘Sacra Famiglia’ al ‘Matrimonio mistico di santa Caterina’:un ampliamento iconograficoIl consenso scaturito dalle ‘Sacre Famiglie’, in particolare da quelle attualmente esposte pres-so la Galleria Nazionale della Liguria a Palazzo Spinola (cat. n. 2) e all’Accademia Alber-tina (cat. n. 3), la cui esecuzione, come si è detto, dovette rientrare nel corso del soggiornospagnolo, permise a Cavarozzi di sfruttare ulteriormente una variante compositiva per l’e-laborazione del grandioso Matrimonio mistico di santa Caterina, conservato al Museo del
26 Daniele Sanguineti
se ai dati anagrafici del personaggio, tra il 1620 e il 1621107. Dunque la tela ora in deposi-to presso il museo genovese (cat. n. 2) e quella di Torino (cat. n. 3) mostrano un’evolu-zione nettissima e serrata del naturalismo caravaggesco, cristallizzato nell’eccessivo vir-tuosismo nel contraffare le stoffe, riprodurre gli effetti ottici della luce, rendere gli scurigagliardi ma con esiti sempre puliti e tersi. Il tutto attraverso una pennellata davvero abi-le nel restituire le soffici consistenze di chiome, la compatta e morbida superficie epider-mica e, soprattutto, i lini, i velluti, le sete grezze delle vesti attraverso mille diavolerie tec-niche racchiuse nell’impasto e nella stesura. I due capolavori mostrano che Bartolomeo,nella ricerca ossessiva della raffigurazione del visibile, si avvicinò, oltre che a Orazio Gen-tileschi per le ombre trasparenti e la strabiliante contraffazione dei panneggi, anche a Cec-co del Caravaggio – che aveva violato il naturalismo professato dal suo maestro trasfor-mandolo in iperrealismo – per l’attenzione maniacale riservata al dettaglio. Ma accanto aquesti modelli il pittore prese in considerazione, soprattutto per san Giuseppe, i grandivegliardi inseriti da Guido Reni nelle sue composizioni e paludati in manti disposti in fal-cature grandiose, mentre la pennellata, soprattutto nella tela torinese, si fa più pastosa inparticolare negli incarnati, dove luce e ombra si fondono a indagare una bellezza marianache sembra tratta da una Sibilla del Domenichino. La progressiva e tangibile evoluzioneche Cavarozzi fece in questi anni, mostrando con intelligenza la curiosa volontà di osser-vare, meditare e metabolizzare, si nota nella Sacra Famiglia con san Giovannino (cat. n. 4),dove, immutati il fascino emanato dalla figura mariana e la lussuosa tecnica che necessitadi brani in cui il virtuosismo può esprimersi in chiave decorativa, come nei rivoli di luceche scivolano lungo la veste e sottolineano i lembi di tessuto raccolto a terra in manieratevolute, si individuano i nuovi impulsi. Non resta che sottoscrivere l’acuta esegesi di Gian-ni Papi ed evidenziare nel dipinto, oltre alla scelta di un’ambientazione paesaggistica, ilrecupero di una “tenera, sentimentale articolazione dei gesti” tipica di uno schema classi-cheggiante più mediato dalla tradizione che ripreso dal vero e la “contaminazione di ti-pologie fiamminghe e rubensiane” per la rappresentazione di Gesù Bambino108. La posturaincrociata degli arti inferiori mariani, oltre al generale allungamento della figura, ricorreidentica nella più tarda Santa Martire di Murcia109 (fig. 17): sussistono dunque le autoci-tazioni, questa volta certamente attraverso ricordi disegnati, per un gruppo di opere da
20. Bartoloemo Cavarozzi,Matrimonio mistico di santaCaterina, Madrid, Museo del Prado
17. Bartolomeo Cavarozzi, Santamartire, Murcia, museo
18. Bartolomeo Cavarozzi(copia da?), Sacra Famiglia,San Pietroburgo, Ermitage
19. Bartolomeo Cavarozzi(copia da?), Sacra Famiglia, Langon,chiesa di Saint Sulpice
29Bartolomeo Cavarozzi e le ‘Sacre Famiglie’
stesso Cavarozzi nel dipinto pubblicato, già sul mercato antiquario, da Volpe e poi da Ni-colson127 (fig. 22). La riproduzione autografa di versioni identiche al prototipo, sia nei par-ticolari che nelle disposizione delle pieghe dei panneggi, doveva avvenire, come per Ora-zio Gentilschi, attraverso l’uso di cartoni, silhouettes o disegni trasparenti128.
Due copie fedeli della tela del Prado e di quella in collezione milanese, rispettiva-mente presso il museo di Stoccarda (fig. 23) e al Duque del Infantado di Madrid (fig. 24),testimoniano non solo la fortuna compositiva del soggetto, reso senz’altro più sordo e glas-sato, ma anche la confezione avvenuta durante la stagione spagnola della variante autogra-fa, quella caratterizzata dallo sguardo rivolto in avanti di Maria e non abbassato129.
Occorre invece constatare l’evidente imbarazzo nell’affrontare il Matrimonio misticodi santa Caterina conservato all’Accademia di San Fernando di Madrid (fig. 25) e repu-tato con costanza di Cavarozzi a partire da Roberto Longhi130. Gianni Papi si domanda-va “come spiegare le notevoli variazioni della seconda versione del soggetto […] all’in-terno della medesima stagione spagnola”, giungendo alla conclusione che Cavarozzi ave-va sicuramente continuato a lavorare per la Spagna anche in seguito al termine del sog-giorno madrileno e che dunque le mutazioni stilistiche, all’insegna di una “pittura più mos-sa e soffice”, generalmente più sontuosa con ampia apertura alla tradizione pittorica spa-gnola e fiamminga, potevano stimarsi assai prossime a quegli stessi cambiamenti che è da-to vedere nell’immagine disponibile della pala per Sant’Anna dei Funari131 (fig. 10) e, inmisura minore, nella Sacra Famiglia con san Giovannino qui esposta (cat. n. 4). Sembre-rebbe più ragionevole rispondere con la restituzione del testo dell’Accademia di San Fer-nando a un pittore spagnolo fortemente suggestionato dall’attività locale di Cavarozzi, lacui ricerca di identità è compito puntuale per uno specialista di tale ambito. Eliminandoinfatti dal catalogo di Cavarozzi questo dipinto e gli altri, sempre condotti dallo stesso au-tore del Matrimonio mistico di San Fernando132, si otterrà un iter stilistico molto più coe-rente in grado di rappresentare, a partire dalla Madonna con Gesù Bambino e sant’Annaper la chiesa di Sant’Anna dei Funari (fig. 10), l’ultima fase linguistica intrapresa dal pit-tore all’insegna, si è detto, di una maggior propensione classicista e di indubbia magnilo-quenza formale.
28 Daniele Sanguineti
Prado119 (fig. 20). Già attribuito a Guido Reni nella collezione di Isabella Farnese a LaGranja120, assegnato da Roberto Longhi a Orazio Gentileschi e in seguito restituito dallostesso studioso a Cavarozzi121, il dipinto, “certainly original”122, mostra un’evoluzione in chia-ve scenografica dell’ormai noto schema e, dal punto di vista tecnico, un’immutata volontàdi “presa di possesso visiva della qualità della materia delle cose”123 che giunge a gareggia-re con il reale, all’insegna dell’inganno ottico, negli arbusti sparsi a terra, nel brano dell’el-sa della spada adagiata sul libro, nell’indagine, a dir poco scioccante, dell’ampio manto didamasco che ricopre la santa accartocciandosi e avviluppandosi in mille riflessi serici. Laprovenienza della tela dalle collezioni reali indicherebbe una commissione rientrante inquello stesso entourage di corte a cui ebbe accesso Giovanni Battista Crescenzi, incaricatoda Filippo III della direzione dei lavori di decoro per il Pantheon della famiglia reale pres-so l’Escorial124. Prendendo avvio dai personaggi delineati nella Sacra Famiglia ora a Geno-va (cat. n. 2), al pittore è bastato raddoppiare lo stesso spazio buio, suggerito da un suolosassoso, e introdurre due angeli reggicorona e la santa genuflessa, per creare, ribaltando asinistra la Vergine assisa con Gesù Bambino divenuto benedicente e spostando a destra ilsan Giuseppe melanconico, un nuovo fortunatissimo prototipo. Ormai la ripresa dal vivoha lasciato spazio a una composizione più manierata, collaudata dalla sua stessa pratica, rie-laborata in studio attraverso gli spunti tratti a piene mani dal metodo di reiterazione, dal-la notevole padronanza della regia luministica e dalla capacità ormai acquisita, e sempre mol-to gentileschiana, di rendere incredibilmente realistici i panneggi. Non si può che concor-dare con Pérez Sánchez nell’osservare che “debe ser obra de su tiempo español (1618-1619) a juzgar por el número de copias aquí realizadas”125. Questa composizione venne nuo-vamente proposta dallo stesso Bartolomeo nella replica autografa segnalata, come ultimaubicazione, in collezione privata milanese (fig. 21), la stessa che Longhi registrò prima inuna collezione genovese (fig. 26) e poi a Bologna126. Nell’opera si osserva una grafia più smal-tata, oltre che una decisa progressione idealizzante nella resa dei tratti mariani, disegnaticon nettezza e variati tramite lo sguardo sognante rivolto all’osservatore. Anche il solo mez-zo busto mariano con il Bimbo stranamente benedicente verso il nulla (a meno che non sia-no presenti decurtazioni) e con i due angeli portatori della corona è stato affrontato dallo
24. Bartolomeo Cavarozzi(copia da), Matrimonio misticodi santa Caterina, Madrid,Duque del Infantado
25. Ignoto pittore spagnolo,Matrimonio misticodi santa Caterina, Madrid,Accademia di San Fernando
21. Bartolomeo Cavarozzi,Matrimonio mistico di santaCaterina, Milano, collezione privata
22. Bartolomeo Cavarozzi, Madonnacon Gesù Bambino, ubicazioneignota
23. Bartolomeo Cavarozzi (copiada), Matrimonio mistico di santaCaterina, Stoccarda, Staatsgalerie
31Bartolomeo Cavarozzi e le ‘Sacre Famiglie’
ab antiquo delle stesse a Genova. Innanzitutto è stato possibile identificare la Sacra Fami-glia con san Giovannino (cat. n. 4) con la tela segnalata per la prima volta da Carlo Giu-seppe Ratti nel 1780 all’interno di palazzo Spinola – ramo di Luccoli – in Strada Nuova eattribuita a Guido Reni. È estremamente probabile poi l’appartenenza della Sacra Famigliaattualmente in deposito presso Palazzo Spinola (cat. n. 2) alla prestigiosa raccolta visiona-ta nel 1875 da Federigo Alizeri nel palazzo dei “marchesi fratelli Spinola di Luigi” (attua-le Palazzo Doria Spinola), dove l’accademico registrò “con affetto speciale” una più chesospetta Sacra Famiglia di Simone Cantarini139. In assenza del tenebrismo più verace, i co-noscitori sette-ottocenteschi, genovesi ma non solo, tendevano a ignorare le numerose de-clinazioni del caravaggismo e, in presenza di una raffigurazione ben sostenuta dal puntodi vista grafico, a propendere per una paternità emiliana. Del resto, nei confronti delle dueopere citate (cat. nn. 2, 4), come pretendere, da parte dell’accademico Alizeri che le asse-gnò l’una a Guido Reni l’altra (probabilmente) a Simone Cantarini, un riferimento al mo-derato caravaggismo di Cavarozzi quando quei panneggi ricadenti sul terreno, quei volti equei manti accesi e falcati paiono avere molto in comune con i maestri emiliani? L’unicodipinto attribuito giustamente a Cavarozzi dalle classiche fonti genovesi (Ratti e la lettera-tura perigetica) fu la Sacra Famiglia Balbi (cat. n. 3), in virtù della corretta e circostanzia-ta comparsa del nome di Bartolomeo da Viterbo in sede inventariale. Tuttavia l’acquisizionedi un dato fondamentale, ovvero che il dipinto fu acquistato nel maggio 1706 insieme a unlotto di trentanove quadri da Costantino Balbi presso gli eredi di Bartolomeo Saluzzo, ren-de molto probabile la provenienza dell’opera dalla Spagna poiché in quella vendita eranoinclusi capolavori di Rubens che, fino a pochi anni prima, si trovavano nella collezione diJuan Gaspar Enríquez de Cabrera, decimo Almirante de Castilla140. È altamente probabi-le che il tramite dell’importazione genovese fosse Francesco de Mari, inviato straordinariodella Repubblica a Madrid nel biennio 1692-1694 e già noto per acquisti madrileni di ope-re d’arte141, anche perché non può essere un caso che nella quadreria del figlio primoge-nito, Ippolito – annoverata in un importante documento, databile intorno al 1735, prope-deutico alla selezione di dipinti di maestri prestigiosi da proporre per una raccolta di in-cisioni142 – fa la sua comparsa una “Nostra Signora con San Giuseppe” di “Fra’ [sic!] Bar-tolomeo da Vitterbo”, diversa da quella posseduta da Costantino Balbi, anch’essa pun-tualmente registrata in quella collezione. Il de Mari potrebbe dunque essersi fatto media-tore dell’approdo a Genova di due opere cavarozziane, delle quali una venne alienata a fa-vore di Bartolomeo Saluzzo e una trattenuta nella propria collezione. Oppure quest’ulti-ma era già presente in famiglia, dato che una nutrita serie di avi e parenti, a partire dal pa-dre Stefano e dallo zio Agostino, ricoprirono, nel corso della prima metà del Seicento143,incarichi ufficiali per conto della Repubblica di Genova a Madrid. La collezione di Fran-cesco de Mari venne dispersa già a metà Settecento a causa dell’assenza di eredi maschi daparte di Ippolito e dei suoi due fratelli144. A questo punto le indicazioni fornite testimo-niano una presenza settecentesca di almeno tre ‘Sacre Famiglie’, le due in mostra (cat. nn.3-4) e quella registrata, intorno al 1735, in collezione de Mari, per la quale non è possibi-le, per ora, comprovare un’identificazione, che sarebbe comunque tentante, con la tela per-venuta al Fondo Pensioni del Gruppo San Paolo Imi (cat. n. 1) o ritenere che si tratti diuna nuova opera finora sconosciuta.
Solo due elementi spingono, invece, fin verso gli anni venti del Seicento, ovvero inun momento molto prossimo al 1619, anno in cui potrebbe datarsi il presunto passaggioin Liguria del pittore. Innanzitutto la ben nota copia d’autore certamente genovese (cfr.cat. n. 1), molto prossima al fare di Giovanni Andrea De Ferrari, custodita presso la Gal-leria Spada di Roma: tratta dal prototipo ora San Paolo (cat. n. 1), costituisce un solido
30 Daniele Sanguineti
Cavarozzi e Genova: le ‘Sacre Famiglie’ e il ‘Lamento di Aminta’Roberto Longhi, nel fondamentale saggio del 1943 dedicato agli aggiornamenti sul Cara-vaggio e sulla sua cerchia, affermò perentorio che Cavarozzi fu “spesso operoso in Geno-va, a Madrid nel 1617 e tramite interessante […] a certi aspetti della civiltà pittorica di Spa-gna, soprattutto allo Zurbarán”133. L’assunto, fondato sulla constatazione della presenza didipinti del pittore in collezioni storiche genovesi e sull’istituzione di vicendevoli tangenzedi stile con Domenico Fiasella, documentato a Roma nel 1615134, venne recepito incondi-zionatamente in ambito critico, come dimostra, ad esempio, quanto sostenuto da Piero Tor-riti nel giustificare la diffusione del caravaggismo a Genova, non certo imputabile al solobrevissimo soggiorno del Merisi in città: il Cavarozzi, oltre a essere annoverato fra i divul-gatori della lezione naturalistica, fu citato per essersi fatto a sua volta suggestionare “dalloStrozzi durante il suo passaggio a Genova verso la Spagna nel 1617”135.
Gianni Papi136, di recente, ha riconsiderato la questione, ponendo in successione idati disponibili, ovvero la presenza in una collezione Spinola della Sacra Famiglia con sanGiovannino (cat. n. 4), dallo studioso conosciuta solo attraverso una foto d’archivio già no-ta a Longhi, “la tela con la Sacra Famiglia nella sacrestia di Sant’Ambrogio e l’aspetto as-solutamente genovese della Sacra Famiglia della Galleria Spada, entrambe copie (la secon-da sicuramente d’autore) della più fortunata invenzione del Cavarozzi” (quella del FondoPensioni del Gruppo San Paolo Imi; cat. n. 1), la provenienza genovese, dichiarata in sededi vendita all’incanto e segnalata nel repertorio del Nicolson, della Sacra Famiglia attual-mente in deposito presso la Galleria Nazionale della Liguria a Palazzo Spinola (cat. n. 2),la presenza a Genova della replica autografa del Matrimonio mistico di santa Caterina (figg.21, 26) attualmente in collezione privata milanese e, infine, la pertinenza settecentesca allacollezione Balbi della Sacra Famiglia conservata ora presso la Pinacoteca dell’Accademia Al-bertina di Torino (cat. n. 3). L’acuto studioso, nel presentare questi indizi, notò che le ipo-tesi possibili erano destinate a moltiplicarsi, soprattutto per il fatto che ciascuna delle ope-re citate per tangenze genovesi poteva vantare copie o repliche spagnole; queste a loro vol-ta potevano prestarsi a far ritenere ugualmente possibile una spedizione di un prototipo daGenova o un’importazione in quella città, visti gli stretti e secolari legami tra la Repubbli-ca e la Spagna. Da tutto ciò Papi trasse la convinzione, stimolata anche dall’innegabile sug-gestione rubensiana visibile nella tela ora in mostra (cat. n. 4) e dall’immagine della palaper Sant’Anna dei Funari (fig. 10), che il rapporto con Genova dovette aver assunto per ilpittore un’importanza più grande del previsto. Pur non escludendo che le relazioni con Ge-nova possano risalire anche anteriormente al soggiorno in Spagna, Papi, aiutato dalle testi-monianze a lui note che documentavano la presenza del pittore a Roma dal 1622, ipotizzòuna permanenza a Genova al rientro da Madrid: “se veramente il pittore avesse seguito ilCrescenzi anche nel viaggio di ritorno dalla Spagna, come si è sempre supposto, cioè nelmaggio del 1619, ci sarebbe un tempo notevole per ipotizzare qualsiasi esperienza, ancheincisiva e profonda, negli anni immediatamente successivi”137.
Nuove considerazioni consentono di precisare i dati già noti relativi al legame delpittore e delle sue opere con il centro ligure. Si è visto come la cronologia della presenzaa Roma possa essere anticipata al 1621 con la possibilità di retrodatarla lievemente, se ègiusta l’ipotesi di individuare nel protagonista del Ritratto di giovane ecclesiastico (colle-zione privata; fig. 8) il figlio tredicenne di Giovanni Battista Crescenzi, Alessandro138. Per-tanto, dovendo basarsi solo sul probabile, ma non certo, rientro in Italia con Crescenzi nel-la primavera del 1619, il tempo da dedicare a una permanenza a Genova risulterebbe qua-si dimezzato rispetto all’ipotesi di Papi. Esaminando a questo punto i dati relativi alla pro-venienza delle opere, emergono interessanti elementi per tentare di chiarire una presenza
26. Bartolomeo Cavarozzi,Matrimonio mistico di santaCaterina, Milano, collezione privata(foto storica dalla scheda 2420conservata presso il Centrodi Documentazione per la Storia,l’Arte, l’Immagine di Genova)
33Bartolomeo Cavarozzi e le ‘Sacre Famiglie’
lezione, ricca di opere di Luciano Borzone, Bernardo Strozzi, Giulio Cesare Procaccini, ol-tre ad artisti lombardi, veneti e fiamminghi, compare, con la valutazione di 60 scudi, unatela raffigurante “due pastori di mano di Bartolomeo da Viterbo”, assente dal precedenteinventario del 1617 circa146. Non si hanno dubbi nel riconoscere, in questa sede, il sogget-to di quell’opera con il Lamento di Aminta (fig. 2), ma non sussistono per ora indizi utiliper proporre un’identificazione con una delle versioni note del tema147. L’approdo entroquel lasso di tempo presso la collezione Doria del dipinto di Cavarozzi consentirebbe diritenere probabile un acquisto di seconda mano, visto che la tela, e le sue numerose ver-sioni, venne ideata dal pittore, come si è detto, entro i primissimi anni del secondo decennio.Certo che il colto entourage di Giovanni Carlo, collezionista e mecenate, si presta a for-mulare più di una suggestiva considerazione. Innanzitutto che quel soggetto, raffiguranteil melanconico pastorello Aminta e il suo compagno Tirsi secondo l’adattamento della ce-lebre favola di Torquato Tasso musicata da Erasmo Marotta148 – di cui giace sul tavolo lospartito – dovette certo entusiasmare Giovanni Battista Marino, che in più occasioni cantòle gesta private del nobile genovese la cui collezione annoverava quasi totalmente dipintidi argomento religioso149. Poi che Doria, che intratteneva dal 1608 contatti con il cardina-le Odoardo Farnese a Roma150, aveva costituito nel suo palazzo genovese di vico del Gel-somino una Accademia del Disegno – “con la raccolta di diversi giovani studiosi […] pernutrire questa bell’arte”151 come testimonia Marino nel 1619 – assai simile a quella roma-na del Crescenzi. Proprio Marino vantava, fin dai primi anni del secolo, una consuetudi-ne in casa Crescenzi a Roma152. Dunque poteva benissimo aver conosciuto Cavarozzi e gliesiti della sua pittura colà, mentre proprio la “scuola di virtù”, fondata da Giovanni Bat-tista Crescenzi e accostabile non poco a quella Doria, potrebbe aver fornito un concretospunto a Giovanni Carlo “per sopperire alla mancanza di un’istituzione pubblica a Geno-va”153. Non è improbabile immaginare che Cavarozzi, pittore principale dell’Accademia delCrescenzi, fosse stato incaricato da quest’ultimo di replicare più volte la fortunata com-posizione del Lamento di Aminta – tipico prodotto di quella “scuola di virtù” – per prov-
32 Daniele Sanguineti
indizio che potrebbe davvero aiutare, oltre a rendere probabile una presenza a Genovadell’autografo cavarozziano, ad azzardare un’identificazione dello stesso con la tela de Ma-ri. E, a proposito di copie, si deve subito sottolineare che non giunge in aiuto, ai fini diquesto discorso, il dipinto conservato nella sacrestia della chiesa di Sant’Ambrogio (Il Ge-sù) a Genova ricavato dalla tela Balbi (cat. n. 3) – e non dalla tela San Paolo (cat. n. 1) co-me è stato sostenuto – nel corso della seconda metà del Settecento. Indizi davvero pro-banti, a proposito di una precocissima conoscenza del dipinto ora in deposito a PalazzoSpinola (cat. n. 2), sono offerti dall’impiego all’interno della pala attribuita a Giovanni Car-lone e raffigurante San Secondo invoca la protezione della Sacra Famiglia sulla città di Ven-timiglia (Ventimiglia, cattedrale; cfr. cat. n. 2) della fedele copia tratta da quell’opera, chedunque era nota in Liguria già nel corso del terzo decennio del Seicento. Gianluca Zanelli,nella bella scheda presentata in questo catalogo (cat. n. 2), ha abilmente considerato cheGiovanni Carlone fu presente nel cantiere per la decorazione della villa Spinola di Sam-pierdarena – appartenente, come il palazzo di città ricordato all’inizio di questo paragrafo,a Giovanni Battista Spinola, ramo San Pietro – e dunque avrebbe potuto in quell’occa-sione visionare la tela di Cavarozzi, fornendo una prova indiretta della pertinenza origi-naria del capolavoro del viterbese alla famiglia, a sua volta non priva di legami politici inSpagna tramite il celebre condottiero Ambrogio.
Quanto al Matrimonio mistico di santa Caterina (Milano, collezione privata; fig. 21),segnalato da Longhi nel 1943 in collezione privata a Bologna ma con la provenienza da Ge-nova, non si ha un riscontro diretto nelle fonti, ma solo una testimonianza rinvenuta pres-so il Centro di Documentazione per la Storia, l’Arte, l’Immagine di Genova, dove sono pre-senti due schede fotografiche dell’opera con la generica segnalazione scritta da Mario Bon-zi circa una proprietà genovese non più rispondente al momento della redazione delle sche-de stesse145 (fig. 26).
Un dato già noto, ma non debitamente indagato, conferma la presenza di un dipin-to del nostro pittore in una prestigiosa quadreria genovese, quella di Giovanni Carlo Do-ria. Nell’inventario, databile anteriormente al 1621 e post 1617, di quella strabiliante col-
29. Bernardo Strozzi, Madonna conGesù Bambino e san Giovannino,Genova, Galleria di Palazzo Rosso
27. Bernardo Strozzi, Santa Cecilia,Kansas City, The Nelson-AtkinsMuseum of Art
28. Bernardo Strozzi, Santa Caterinad’Alessandria, Hartford, WadsworthAtheneum
30. Luciano Borzone, Madonnacon Gesù Bambino e san Giorgio,Genova, Palazzo San Giorgio
31. Domenico Fiasella,Fuga in Egitto, Greenville,Bob Jones Univesity
35Bartolomeo Cavarozzi e le ‘Sacre Famiglie’
vedere alla vendita all’interno di in un circuito di relazioni di cui Giovanni Carlo Doriaavrebbe potuto essere benissimo membro per tramite di Marino. Non è tuttavia neppureda escludere che il Lamento Doria fosse in realtà quello già appartenuto al conte di Villa-mediana, il quale, come si è detto, nel marzo 1615 fu in partenza per Genova e, quindi,per la Spagna. In questa congiuntura è poi straordinariamente indicativo che Bernardo Stroz-zi, propenso alla rilettura in chiave materica e coloratissima dei capolavori di Caravaggio– come dimostra, ad esempio, la Sant’Orsola (Milano, collezione Koelliker) esemplata sultesto caravaggesco veduto in casa di Marcantonio Doria, fratello di Giovanni Carlo154 – paiaaver avuto dinanzi una delle Madonne presenti nelle ‘Sacre Famiglie’ di Cavarozzi per con-fezionare, proprio per Giovanni Carlo, le rutilanti Santa Cecilia (Kansas City, The Nelson-Atkins Museum of Art; fig. 27) e Santa Caterina d’Alessandria (Hartford, Wadsworth Athe-neum; fig. 28)155, databili, anche in virtù di notizie indirette fornite dagli inventari Doria,al 1618-1620. Come non pensare per queste opere e per la coeva Madonna con Gesù Bam-bino e san Giovannino della Galleria di Palazzo Rosso a Genova156 (fig. 29) a una sugge-stione forte, nell’impaginazione, nel fondo scuro, nella fissità garbata dei volti, nei bianchiaccecanti, dalla visione diretta dei testi cavarozziani? Come non rilevare la conoscenza deiprototipi del viterbese che traspare nel viso sognante, nella naturalezza degli affetti, nel bra-no della manica lumeggiata e stropicciata della splendida protagonista della lunetta con laMadonna, Gesù Bambino e san Giorgio (Genova, Palazzo San Giorgio; fig. 30)157, dipintadall’artista prediletto da Giovanni Carlo Doria, Luciano Borzone? Del resto tracce incisi-ve dei tipici e affascinanti stilemi di Cavarozzi appaiono, più o meno stemperati, all’inter-no del personale background di Domenico Fiasella e di Giovanni Andrea De Ferrari. Delprimo sono già stati posti in luce comportamenti artistici, durante il tempo romano, assaiaffini a quelli di Bartolomeo nella messa a punto di una sorta di classicismo naturalistico
34 Daniele Sanguineti
33. Giovanni Andrea De Ferrari,Adorazione dei pastori, Voltaggio,Pinacoteca dei Cappuccini 35. Giovanni Andrea De Ferrari,
Madonna con Gesù Bambino e isanti Giovanni Evangelista e Nicolada Tolentino, collezione privata
34. Giovanni Andrea De Ferrari,Sacra Famiglia con sant’Anna,collezione privata
(coniugando Roncalli e Caravaggio) visibili, ad esempio, nella Fuga in Egitto (Greenville,Bob Jones University; fig. 31) e nei dipinti Giustiniani158. La piccola e inedita Sacra Fami-glia (Sestri Levante, Galleria Rizzi; fig. 32)159, in biblico fra correttezze classicistiche e pro-pensioni al naturalismo, mostra, con quel san Giuseppe posto in secondo piano a sinistra,la conoscenza di Fiasella delle composizioni di Cavarozzi. Più pregnante il caso di GiovanniAndrea De Ferrari, che ebbe modo, anche per tramite del suo maestro Bernardo Strozzi –nella cui bottega fu impegnato tra il 1613 e il 1619 circa – di avvicinarsi alle opere di Bar-tolomeo e di porre in atto su quei testi un’osservazione e uno studio così minuziosi da in-troiettare certi motivi e stilemi nel proprio patrimonio genetico in fase giovanile. Ne sor-tirono opere come l’Adorazione dei pastori (Voltaggio, Pinacoteca dei Cappuccini; fig.33)160, la Sacra Famiglia con sant’Anna di collezione privata161 (fig. 34) e, soprattutto, l’Al-legoria della Pace (Genova, Banco di Chiavari; fig. 36)162, da scalare nel corso degli anniventi, dove, sulla matrice strozzesca utilizzata in forme nettamente pacate per impaginaree colorire, si leggono influssi caravaggeschi e, in particolare, una singolare attenzione al-l’arte di Cavarozzi. Come ha già peraltro rilevato Angela Acordon, la suggestione delle ope-re di Bartolomeo è “quanto meno illuminante ai fini della comprensione delle frequenti at-tenzioni materiche, di serica eleganza, proprie del linguaggio del giovane artista genovesefinora riferite all’influenza di Orazio Gentileschi, ma in realtà talvolta presenti in opere an-teriori all’arrivo del pittore toscano a Genova”163. Esemplare a questo proposito il caso del-l’Allegoria della Pace (fig. 36), dove il pittore, pur nella mediazione delle sante realizzateda Strozzi per Giovanni Carlo Doria, sembra aver visto la Madonna recitante nella SacraFamiglia con san Giovannino di Cavarozzi già Spinola (cat. n. 4), nella disposizione dellafigura, nella ricorrente fissità dello sguardo, nella resa frusciante dei panneggi. Anche nel-la bella e introspettiva Madonna con Gesù Bambino e santi Giovanni Evangelista e Nicolada Tolentino (collezione privata; fig. 35)164 è evidente la conoscenza di quest’ultima opera
32. Domenico Fiasella, SacraFamiglia, Sestri Levante, GalleriaRizzi
37Bartolomeo Cavarozzi e le ‘Sacre Famiglie’
1 Longhi 1943, pp. 31, 54 nota 69; Papi 2001, pp. 430-432.2 Angeli 2000, p. 20.3 Mancini 1617-1620 (ed. 1956, I, pp. 256, 306; 1957, II,pp. 157, 213 nota 1635).4 Papi 1996, p. 86.5 Baglione 1642, pp. 286-287 (ma 186-187).6 Oltre ai testi già indicati cfr. le seguenti voci biografiche:Spezzaferro 1979, pp. 26-28; Schleier in New York-Napoli1985, p. 126; Papi 1989, p. 683; Cavarozzi… 1996, p. 112;Cavarozzi… 1997, pp. 382-383; Papi 2002, p. 466; Idem2003, p. 484.7 Mancini 1617-1620 (ed. 1956-1967, I, p. 256); Baglione1642, pp. 168-169; Angeli 2000, pp. 19-22.8 Mancini 1617-1620 (ed. 1956-1957, I, p. 256). 9 Kirwin 1972; Spezzaferro 1985, pp. 50-51; Pupillo 2002,pp. 140-159.10 Baglione 1642, p. 365 (ma 265).11 Spezzaferro 1985, p. 54.12 Strinati 1995, p. 15.13 Baglione 1642, p. 365 (ma 265).14 Ibidem, p. 286 (ma 186).15 Ibidem. 16 Ibidem, p. 187; Alveri 1664, p. 43.17 Toesca 1957, pp. 42, 44 nota 6; Eadem 1960, pp. 57-59;Schleier in New York-Napoli 1985, pp. 126-128, n. 31;Papi 1996, p. 86; Treffers in Londra-Roma 2001, p. 377,n. 130. La Santa Caterina d’Alessandria, custodita nellachiesa del monastero di San Bernardo a Nepi presso Vi-terbo e assai vicina alla Sant’Orsola, è stata di recente sti-mata un lavoro congiunto del Pomarancio con Cavarozzi(Pupillo in Roma 1995b, pp. 519-520, n. 76).18 “Era imitatore dello stile del Cavalier Pomarancio” (Ba-glione 1642, p. 187).19 Ibidem, p. 286 (ma 186). La pala venne ricordata anchein Mancini 1617-1620 (ed. 1956-1957, I, p. 256).20 Marini 1981, p. 129; Spezzaferro 1985, p. 55; Papi 1996,p. 86. Per il cantiere di Sant’Andrea della Valle: Hibbard1985. Per notizie sulla cappella: Grilli 2003, p. 139 (dovesi ritiene che la pala cavarozziana dovesse essere “a metàtra caravaggismo e fiamminghismo”). 21 Mancini 1617-1620 (ed. 1956-1957, I, p. 306).22 Spezzaferro 1985, p. 55.23 Pagliara 1980, pp. 259-260 nota 8. Cfr. Cronologia.24 Marini 1981, p. 129 (Crescenzi); Cottino 1989, p. 688(Cavarozzi); Papi 1996, p. 91 (non giudicabile); Gregori2002, p. 34; Eadem 2003, p. 38 (Cavarozzi).25 Pagliara 1980, pp. 259-260 nota 8; Spezzaferro 1985, p.55.26 Papi 1996, pp. 85-96; Gallo in Roma-Siena 2000-2001,p. 232.27 Papi 2003, p. 484.28 Baglione 1642, p. 187. 29 Propende invece per un cambiamento repentino Gian-ni Papi, “alla stregua del resto di molti altri seguaci, più omeno temporanei, del Merisi” (Papi 1996, p. 86).30 Schleier in New York-Napoli 1985, p. 126.31 Fumagalli 1994, pp. 101-116; Eadem 1996, pp. 143-150.32 Si tratta della versione già in collezione Perolari a Ber-gamo, per la prima volta assegnata a Cavarozzi da CarloVolpe (1973, pp. 32-33) che inoltre segnalava due versio-ni rispettivamente in collezione Weitzner a Londra e neidepositi del Louvre. La versione londinese, che successi-vamente passò in collezione Piedimonte a Napoli e chevenne ritenuta da Nicolson di “caravaggesque unknown,from Crescenzi circle?” (Nicolson 1979, p. 38; Idem 1990,p. 89), è comparsa, con la corretta attribuzione a Cavarozzi,in numerose esposizioni: Bayer in New York 1990, pp. 68-69; Cottino in Roma-Milano 1995, p. 150, n. 38 (con unelenco completo delle diverse versioni); Laureati in Lon-dra-Roma 2001, p. 84, n. 25; Cottino in Monaco 2002-2003, pp. 160-161; Benedetti in Sydney 2003, pp. 122-123,n. 22; Cottino in Firenze 2003, pp. 166-167. Bayer (in NewYork 1990, p. 68) segnalava una versione presso una col-lezione privata in Pennsylvania, oltre a quelle del Louvree di Bergamo. Sui dipinti cfr. inoltre: Cottino 1989, II, p.712; Bologna 1992, pp. 305-306; Cottino 1995, pp. 59-65;
Fumagalli 1996, pp. 143-150; Papi 1996, pp. 87-88, 90; Gre-gori 2002, pp. 33-35; Cottino 2002, p. 126; Gregori 2003a,pp. 37-39; Cottino 2003, p. 128.33 Idem in Monaco 2002-2003, pp. 160-161; Idem in Firenze2003, pp. 166-167.34 Papi 1996, pp. 87-88; Idem 2002, p. 466; Idem 2003, p.484 (“non più tardi del 1614”).35 Fumagalli 1994, p. 106; Cottino in Monaco 2002-2003,pp. 160-161; Idem in Firenze 2003, pp. 166-167. 36 Per una sintesi: Cottino 2002, pp. 125-127; Gregori 2002,pp. 45-48; Cottino 2003, pp. 127-129; Gregori 2003b, pp.49-52.37 Baglione 1642, p. 365 (ma 265).38 Volpe 1973, p. 32.39 Cappelletti, Testa 1994, pp. 107-108, n. 10, 174 (23),184 (75). La proposta dubitativa di identificazione è statasostenuta con sicurezza da Gianni Papi (1996, p. 87).40 Ibidem, p. 91.41 Baglione 1642, p. 187.42 Papi 1996, p. 92. Le due tele sono in ubicazione scono-sciuta.43 Marini 1981, p. 127 nota 6 (Crescenzi); Papi 1996, pp.91-92; Gregori 2002, pp. 33-34; Eadem 2003a, pp. 37-38.44 Papi 1996, p. 89.45 Corti 1989, p. 140; Papi 1991, p. 209; Idem 1996, p. 87.Cfr. Regesto.46 Longhi 1943, p. 54 nota 69.47 Idem 1916, pp. 271-272.48 Ibidem, p. 272.49 Ibidem.50 Una bella analisi riservata al dipinto, con un interessan-te approfondimento dedicato alla citazione di Dürer, è incorso di pubblicazione da parte di Marieke von Bernstorff,che ha inoltre rinvenuto un nuovo dipinto cavarozziano raf-figurante San Gerolamo, di più verace matrice caravagge-sca (Von Bernstorff c.d.s.). Si ringrazia la studiosa per averconcesso la lettura del suo articolo anteriormente alla pub-blicazione.51 Von Bernstorff c.d.s.52 Noack, Mayer 1913, p. 86. Cfr. Cronologia.53 Baglione 1642, p. 365 (ma 265).54 Mancini 1617-1620 (ed. 1956, I, pp. 256, 306; 1957, II,p. 213 nota 1635).55 Spezzaferro 1985, p. 60. 56 Palomino 1715 (ed. 1947, p. 890).57 Baglione 1642, p. 365 (ma 265).58 Volpe 1973, pp. 25-36. Per una sintesi che da conto deinodi critici: Cottino 1989, pp. 672-676, 710, 712; Idem1995, pp. 59-65; Idem 2002, p. 128 nota 27; Idem 2003, p.130 nota 27.59 Gregori 1973, pp. 41-47.60 Per una recente proposta sull’attività di naturamortistadel Crescenzi: Gregori 2002, p. 36; Cottino 2002, pp. 125-127. Salerno (1984, p. 90) e Spezzaferro (1985, pp. 51-54)continuavano a reputare Crescenzi solo un eclettico im-prenditore.61 “Non vorrei andare oltre, consapevole dell’intricata com-plessità del problema”: Papi 1996, pp. 90-91.62 Gregori 2002, pp. 32-35; Eadem 2003a, pp. 36-40. Se-condo Alberto Cottino (2002, p. 125; 2003, p. 127) non viè identità tra il Maestro Acquavella, “il più importante pit-tore di natura morta a Roma sulla scia di Caravaggio”, eCavarozzi, che è invece presente come figurista in molti suoiquadri.63 Per i dipinti raffiguranti solo brani di natura morta: Cot-tino 1989, p. 712 (Maestro della natura morta Acquavel-la); Gregori 2002, pp. 33-36 (Cavarozzi); Cottino 2002, p.126; Idem 2003, pp. 127-129 (Maestro della natura mortaAcquavella). L’acquisizione di una pastosità più matericain alcune opere rispetto alla smaltata rappresentazione dialtre sembra coerente con l’evolversi del linguaggio di Ca-varozzi. Anche la Cesta di frutta con violinista (collezioneprivata) non sembrerebbe distante, soprattutto nella figu-ra assegnata ad un anonimo caravaggesco (Idem in Mona-co 2002-2003, pp. 164-165), dagli esiti dell’ultimo Cava-rozzi. Cfr. anche Damian 2004, pp. 32-35.
36 Daniele Sanguineti
(cat. n. 4) che era di proprietà, forse non a caso, dello stesso ramo degli Spinola di Lermacui apparteneva la tela del De Ferrari raffigurante la Sacra Famiglia con sant’Anna (fig. 34).Il pittore, come suggerisce Angela Acordon, si ispirò per il viso sognante e per la posturadella Vergine alla figura mariana della tela ora in mostra (cat. n. 4), avendo l’accortezza divariare la posa del Bimbo e di ribaltare l’immagine. Ugualmente riecheggiante stilemi ca-varozziani, nel comporre e nello stendere la materia cromatica (ma anche nella realizza-zione di due versioni autografe con varianti), sono le Giustizie (entrambe a Genova, Gal-leria di Palazzo Bianco), realizzate per il ciclo delle Virtù Cardinali condotto, a gara con al-tri pittori, intorno al 1630 per Palazzo Ducale a Genova165.
Dunque è innegabile che alcuni dipinti di Bartolomeo Cavarozzi fossero presenti as-sai precocemente in collezioni genovesi, come dato aggiuntivo da considerare e approfon-dire nel processo di diffusione a Genova dell’onda caravaggesca che coinvolse i pittori lo-cali sia nel meditare sugli originali del Caravaggio sia nell’interagire con le presenze diret-te in città dei caravaggeschi della prima ora, Caracciolo e Gentileschi166.
ConclusioniSulla base dei dati a disposizione si può dunque accertare la diretta notorietà di testi cava-rozziani a Genova. Le suggestioni prodotte su alcuni pittori genovesi sono infatti indiscu-tibili. Che questi testi fossero almeno le quattro ‘Sacre Famiglie’ esposte in mostra è assaiprobabile, in considerazione della presenza genovese ab antiquo della maggior parte di es-se. Tuttavia i dati desunti e le ipotesi formulate non comprovano un soggiorno a Genovadi Bartolomeo Cavarozzi, ma certificano piuttosto un approdo di quelle opere, anche pre-coce, sulla scia del collezionismo, per i serrati legami della Repubblica di Genova con laSpagna e per la presenza di molti genovesi impegnati in missioni diplomatiche a Madridnel Seicento e nel Settecento.
Il caso della comparsa di una delle versioni del Lamento di Aminta (fig. 2) nel se-condo inventario della quadreria di Giovanni Carlo Doria, steso tra il 1617 e il 1621, di-mostrerebbe invece un ipotetico contatto con il colto ambiente romano di cui forse me-diatore fu il poeta Marino, almeno che non possa giustificarsi con il transito genovese sul-la via di Spagna del conte di Villamediana, il quale possedeva un esemplare autografo diquella composizione.
Si è detto che Gianni Papi, artefice del recupero critico dell’artista a cui si spera vogliapresto dedicare una monografia, ha ipotizzato come possibile il soggiorno a Genova del pit-tore, soprattutto sulla base di innegabili aperture stilistiche, presenti al suo rientro a Roma einterpretabili come visione diretta nella città portuale di testi di Rubens, e forse anche di Gui-do Reni. Si ritiene probabile, allo stato attuale delle informazioni, solo un transito, un velocesoggiorno di studio, insufficiente per interagire con l’ambiente culturale locale e, soprattut-to, per produrre una memoria da tramandare attraverso le fonti. Non è infatti da sottovalu-tare l’assenza di Cavarozzi nella storiografia artistica genovese a partire dalle Vite di RaffaeleSoprani, date alle stampe nel 1674, e, come si è detto, l’assenza di particolari informazione daparte del Ratti, che citò solo il dipinto già in collezione Balbi (cat. n. 3). Nulla vieta comun-que di ipotizzare che, nel corso del presunto sopralluogo genovese, il pittore fosse entrato incontatto con qualche nobile collezionista, forse conosciuto a Madrid dove, probabilmente, fuinvogliato a considerare una tappa ligure.
Tuttavia, nell’attesa di nuovi documenti e nuove testimonianze figurative, resta il fat-to “della grande fortuna del pittore che sembra essere stato un vero e proprio centro di ir-radiazione di iconografie sacre”167, ammaliando artisti e collezionisti romani, genovesi, spa-gnoli e non solo.
36. Giovanni Andrea De Ferrari,Allegoria della Pace, Genova, Bancodi Chiavari e della Riviera Ligure
39Bartolomeo Cavarozzi e le ‘Sacre Famiglie’
149 Farina 2002, p. 50.150 Ibidem, pp. 31-32.151 Marino 1627 (ed. 1966, n. 11).152 Secondo Bellori (1672, p. 218) sarebbe stato lo stessopoeta ad introdurre il Caravaggio presso la casa dei Cre-scenzi.153 Farina 2002, p. 105.154 Roma-Milano-Vicenza 2004.155 Algeri in Genova 1995, pp. 108-109, n. 6; Orlando inGenova 2004, pp. 246-249, nn. 47-48.156 Boccardo in Genova 1995, pp. 134-135, n. 19. I bian-chi di Strozzi, anche secondo Causa, possiedono una den-sità lattiginosa “allusiva al passaggio per Genova, prima del1620, del viterbese Bartolomeo Cavarozzi” (Causa 2000,p. 139 nota 345).157 Manzitti in Genova 2003a, p. 24. L’opera fu attribuitaimpropriamente a Daniele Crespi (Belloni 1975, pp. 172-174).158 Papi 1992, pp. 199-208; Idem 1996, p. 92; Cappelletti1998, pp. 28-30. Per i due dipinti provenienti dalla colle-zione Giustiniani, ovvero Cristo risuscita il figlio della ve-dova di Naim e Cristo risana il cieco nato, entrambi a Sa-rasota (John and Mable Ringling Museum of Art): New-come Schleier in Roma-Berlino 2001, pp. 308-311, nn.D12-D13. Piero Donati (1974, p. 62) negava una sugge-
stione prodotta su Fiasella a Roma da parte del gruppo deicaravaggeschi.159 Olio su tela, 70 76 cm, inv. 4182.160 Acordon in Milano 2003, pp. 90-93, n. 9 (con biblio-grafia precedente).161 Genova 1938, p. 36, n. 39 (come proprietà del marcheseLuigi Spinola di Lerma); Castelnovi 1987, p. 136. Si rin-grazia Angela Acordon per aver messo a disposizione l’im-magine del dipinto.162 Castelnovi 1987, p. 137; Bozzo 2000, pp. 128-130.163 Acordon in Galleria Nazionale… 2002, p. 142. La stu-diosa, che ha in preparazione una monografia dedicata alDe Ferrari, tratta degli influssi del Cavarozzi sul pittore inuna scheda in corso di pubblicazione (Dipinti… c.d.s.).164 Olio su tela, 99 125 cm. Si tratta dello stesso dipintosegnalato da Angela Acordon (in Galleria Nazionale…2002, p. 141) come, involontariamente, Sacra Famiglia ein quell’occasione già posto in relazione dalla studiosa conla Sacra Famiglia con san Giovannino (cat. n. 4), allora no-ta solo per l’immagine pubblicata da Papi (2001, p. 430).Si ringrazia Angela Acordon per aver messo a disposizio-ne l’immagine del dipinto.165 Di Fabio 1997, p. 318 (con bibliografia precedente).166 Pesenti 1992, pp. 74-81.167 Papi 2001, p. 433.
38 Daniele Sanguineti
64 Mancini 1617-1620 (ed. 1956, I, p. 256).65 Cfr. oltre nel testo.66 Cfr. nota 63.67 Gregori 2002, p. 34; Eadem 2003a, p. 38.68 Longhi 1943, p. 54 nota 69 (Caravaggio); Volpe 1973(Caravaggio e Crescenzi), pp. 29-32. 69 Pérez Sánchez 1964b, p. 12 (Caravaggio); Idem in Sivi-glia 1973, n. 3; Gregori 1973, pp. 41-52 (Cavarozzi e “ge-niale generista”); Gregori 1975, p. 33 (Caravaggio); Gre-gori 1989, pp. 99-142 (Caravaggio). Più recentemente:Gregori 2002, pp. 34-35; Eadem 2003a, pp. 39-40 (Cara-vaggio).70 Christiansen in Roma-New York-Saint Louis 2001-2002,pp. 101-103, n. 18.71 “I bianchi del Gentileschi passano nel Cavarozzi” (Lon-ghi 1951b, p. XXVI).72 Cfr. nota 39 e Cronologia. 73 Garas 1967, pp. 339-350. Per un inedito dipinto di Ca-varozzi, raffigurante San Gerolamo e dotato dello stemmaBoncompagni-Ludovisi: Von Bernstorff c.d.s.74 Ceán Bermudez 1800, I, pp. 373-374.75 Papi 1996, p. 94 nota 12; Idem 2001, p. 432. 76 Nicolai 2004, p. 451. Cfr. Cronologia.77 Strinati in Monaco 1997, pp. 16-20, n. 3. Cfr. anche Pu-pillo 1996, p. 165.78 Strinati in Monaco 1997, p. 18.79 Papi 1996, p. 89; Gallo in Roma-Siena 2000-2001, pp.232-233, n. 55; Papi 2001, p. 435.80 Gallo in Roma-Siena 2000-2001, p. 232.81 Papi 2001, pp. 428-429; Baglione 1642, p. 187.82 Scavizzi in Napoli 1963, pp. 29-30, n. 19; Faldi 1970, p.57; Nicolai 2004, pp. 440-462 (con bibliografia prece-dente). In questi stessi anni è databile anche il Sant’Isido-ro Agricola (Viterbo, chiesa di Sant’Angelo in Spatha).83 Zeri 1954, p. 54; Papi 2001, p. 436.84 Carosi 1988, p. 68. Cfr. Cronologia.85 Baglione 1642, p. 187; Papi 1996, p. 86.86 Ibidem, p. 187.87 Papi 1996, pp. 88-89.88 Idem 1991, p. 209. Cfr. Cronologia.89 Idem 1996, p. 89.90 Cfr. nota 94.91 Baglione 1642, p. 187.92 Di Sivo 2005, pp. 15-25.93 Per le opere citate cfr. le schede di Ferdinando Corbe-ri, Clelia Arnaldi di Balme e Gianluca Zanelli in Genova2005b, pp. 27-29, 31-33, 35-42.94 Cfr. Longhi 1951a, p. 50.95 Ibidem.96 Cfr cat. n. 3 per la probabile ipotesi, avanzata da Gian-luca Zanelli, di una decurtazione del dipinto ora presso laGalleria Nazionale della Liguria a Palazzo Spinola. 97 Cfr. Milicua in Madrid-Bilbao 1999-2000, pp. 98-101;Puglisi 2003, pp. 127-129.98 Christiansen in Roma-New York-Saint Louis 2001-2002,pp. 91-93, n. 15.99 Cfr. Longhi 1951a, p. 45.100 Bellori 1672, p. 218.101 Papi 1993, pp. 121-122, nn. 31, 32.102 Nicolai 2004, pp. 450-451. Cfr. Cronologia.103 Cottino in Torino 1990, p. s.n.104 Cfr. note 45, 53 e Cronologia.105 Cfr. il primo paragrafo di questo saggio e Cronologia.106 Nicolai 2004, p. 451. Cfr. Cronologia.107 Cfr. nota 77.108 Papi 2001, p. 431.109 Per le due tele: Pérez Sánchez 1964a, pp. 24, 48 nota23; Idem in Siviglia 1973, n. 20; Papi 1996, p. 89; Gallo inRoma-Siena 2000-2001, pp. 232-233, n. 55; Papi 2001, p.435.110 Idem 2001, pp. 428-429.111 Vsevolozhskaya, Linnik 1975, pp. 63-64. L’opera è con-siderata autografa anche da Cottino (in Torino 1990, p.s.n.), da Papi (2001, p. 433) e da Curie (2003, p. 211).112 Garas 1967, pp. 339-350; Von Bernstorff c.d.s.113 Papi 2001, p. 433; Curie 2003, p. 213.
114 Papi 2001, p. 433.115 Pérez Sánchez 1970, p. 169.116 Idem 1964a, p. 25.117 Curie 2003, pp. 207-208. Del resto la Sacra Famiglia orain Accademia Albertina (cat. n. 3) era stata inserita in unprogetto, steso intorno al 1735, che comprendeva la crea-zione di incisioni dai capolavori presenti a Genova. Cfr.Migliorini 1997-1999, pp. 211-233.118 Papi 2001, p. 433.119 Olio su tela, 256 170 cm, inv. 146.120 Pérez Sánchez 1964a, pp. 22, 47 nota 18; Spear in Cle-veland 1971, pp. 80-81, n. 20 (con bibliografia preceden-te); Idem 1975, pp. 80-81, n. 20.121 Longhi 1916, p. 264; Idem 1943, p. 54 nota 69.122 Nicolson 1979, p. 42; Idem 1990, p. 97. Per una rasse-gna bibliografica sull’opera cfr. da ultimo Curie 2003, p.209 e nota 10.123 Faldi 1970, p. 57.124 Baglione 1642, pp. 365-366 (ma 265-266).125 Pérez Sánchez 1964a, p. 22.126 Olio su tela, 240 171 cm. Longhi 1943, p. 54 nota 69(già Genova, poi Bologna); Gregori 1969, pp. 103-105;Faldi 1970, pp. 280-281 (già Firenze?); Nicolson 1979, p.42 (Milano); Idem 1990, p. 97 (Milano).127 Olio su tela, 157,5 124,5 cm. Volpe 1973, p. 33 (fig.8b); Nicolson 1979, p. 42; Pignatti 1985, pp. 121-123; Ni-colson 1990, p. 97. Nel 1982 si trovava, dopo il passaggioall’incanto (Christie’s, 17 luglio 1964, lotto 108), presso laSarah Campbell Blaffer Foundation in Texas (Kowal 1982,pp. 115-116).128 Christiansen 2001, p. 21.129 Longhi 1943, p. 54 nota 69 (proponeva per la replicadi Stoccarda una mano spagnola sul tipo dell’Orrente); Pé-rez Sánchez 1964a, pp. 22, 47 nota 19a-b.130 Longhi 1943, p. 54 nota 69; Pérez Sánchez 1964a, pp.23, 47 nota 20; Papi 2001, p. 435.131 Ibidem.132 Ci si riferisce al Compianto con la Madonna e due an-geli e alla Madonna Addolorata e due angeli, passati sul mer-cato antiquario (Ibidem, pp. 435-436).133 Longhi 1943, p. 31.134 Il soggiorno romano di Fiasella si svolse fra il 1606-1607e il 1615, poiché il 4 marzo 1616 il pittore, già rientrato aSarzana, ricevette l’allogazione per la pala con San Lazza-ro che implora la Vergine per la città di Sarzana (Papi 1992,pp. 199-208). 135 Torriti 1970 (seconda edizione: 1987, p. 22).136 Papi 2001, pp. 431-432.137 Ibidem, p. 432.138 Cfr. nota 77 e Cronologia.139 Alizeri 1875, p. 241.140 Boccardo 2002, p. 227.141 Ibidem.142 Ristretto… s.d. [1735 circa]; Migliorini 1997-1999, pp.211-233. La redazione definitiva del documento (Proget-to… s.d.) è stata resa nota in Tagliaferro 1995, p. 149 no-ta 1.143 Per una rassegna: Boccardo 2002, p. 238 nota 22.144 Ibidem, p. 239 nota 24. Nella redazione definitiva delRistretto… s.d. [1735 circa] non compare più la Sacra Fa-miglia presso Ippolito de Mari, ma solo quella Balbi (Ta-gliaferro 1995, p. 150).145 Cfr. nota 126. L’apporto di Bonzi al fondo fotograficocomunale dovrebbe collocarsi fra gli anni Cinquanta eSessanta del Novecento. Le schede citate nel testo recanoi seguenti numeri: 2420, 2912.146 Per la figura del collezionista e per la trascrizione de-gli inventari: Boccardo 1997, pp. 30-47; Farina 2002, p.201; Eadem 2004, pp. 189-195.147 Cfr. nota 32. La citazione inventariale sarebbe, per ora,la prima nella quale il dipinto è associato correttamente alnome di Cavarozzi. 148 Camiz Trincheri 1983, pp. 100-103. L’adattamento fuedito a Venezia nel 1600. È interessante segnalare che Era-smo Marotta fu a Roma ospite in palazzo Mattei e che peri Mattei il pittore realizzò alcune opere. Cfr. Cronologia.
43Catalogo42 Catalogo
1.Bartolomeo Cavarozzi(Viterbo 1587 – Roma 1625)
Sacra FamigliaOlio su tela, 173,5 113,4 cm Torino, Fondo Pensionidel Gruppo San Paolo Imi
ProvenienzaI dati disponibili relativi alla pro-venienza sono stati ripercorsi da Al-berto Cottino, che ha potuto rico-struire, anche attraverso le indica-zioni già offerte da Alfonso E. Pé-rez Sánchez, la traiettoria del di-pinto a partire dall’apertura del XXsecolo1. Tuttavia non è sempre age-vole certificare se nei passaggi fi-nora indicati sia stata esclusiva-mente considerata l’opera in esameoppure si siano erroneamente coin-volte copie o repliche del soggetto,quello certamente più reiterato frale ‘Sacre Famiglie’ cavarozziane. Ildipinto, come appartenente alla col-lezione de Zoete e con l’attribuzio-ne a Zurbarán, risulterebbe averfatto la sua prima comparsa a Lon-dra nel 19082. Anna Coliva3, soste-nendo di riconoscere nella telaesposta nel biennio 1913-1914, al-la mostra londinese presso la Graf-ton Galleries4, una “brutta copia”del dipinto in esame – “a meno chenon fosse completamente alteratodalle ridipinture” – non si era inrealtà avveduta che in quell’esposi-zione era presente, accanto a unacopia sempre attribuita allo Zur-barán con il numero 86 – quella acui la studiosa indirizzò i suoi stra-li – anche la nostra tela contraddi-stinta dal numero 1715. Nel 1935venne battuta all’asta londinese Ch-ristie’s6 e approdò a Vienna pressola baronessa Kiess-Scharht, per poipassare, in un periodo imprecisa-to, a Caracas nella collezione diRaphael Raquena7. La comparsa al-l’esposizione del 1952 presso l’Al-len Memorial Art Museum di Ober-lin offrì la testimonianza di un nuo-vo passaggio di proprietà (collezio-ne di Pietro Tozzi a New York) e se-gnò l’acquisizione della corretta at-tribuzione a Cavarozzi8. In seguitol’opera, che comparve all’asta Ch-ristie’s di New York del giugno1984, venne inserita nell’aggiorna-mento del repertorio dedicato daNicolson ai caravaggisti9. Il dipin-to fu acquistato intorno al 1990 dal-l’attuale proprietà e, in seguito, fe-ce la sua comparsa in mostre dedi-cate alla valorizzazione del patri-monio artistico degli istituti banca-ri10. Per ora non sussistono notizie
che permettano di condurre un’in-dagine più arretrata nel tempo; tut-tavia, pur non disponendo di ele-menti utili per istituire un collega-mento in ambito genovese (se nonla copia della Galleria Spada di cuisi tratta oltre), è necessario segna-lare la registrazione “in casa d’Ip-polito de Mari” di una “Sacra Fa-miglia di Bartolomeo da Viterbo”,diversa da quella Saluzzo Balbi (cat.n. 3) che, nello stesso elenco stesointorno al 1735, compare corretta-mente “in casa Balbi”11.
RestauriLa visione del retro ha permesso diconstatare, pur in assenza di docu-mentazione relativa a recenti re-stauri, che il dipinto non è in pri-ma tela e che il telaio è stato sosti-tuito.
BibliografiaLondra 1913-1914, n. 171 (F. deZurbarán); Stechow 1952, p. 39 (B.Cavarozzi); Pérez Sánchez 1964a,pp. 47-48 nota 22; Coliva in Wa-shington-Toronto-Bologna 1990-1991, pp. 28-31; Cottino in Torino1990, s.n.; Nicolson 1990, I, p. 96;Barroero in Torino 1993, p. 56; Bo-na Castellotti in Torino 1997, pp.148-151; Papi 2001, pp. 430, 433;Acordon in Galleria Nazionale…2002, p. 141; Curie 2003, p. 211;Milano-Vienna 2005-2006, in cor-so di stampa.
EsposizioniLondra 1913-1914; Oberlin 1952;Washington-Toronto-Bologna 1990-1991; Torino 1990; Torino 1997; Mi-lano-Vienna 2005-2006, in prepara-zione.
L’iniziale attribuzione dell’opera al-lo Zurbarán, formulata più in sededi mercato antiquario che di dis-sertazione scientifica, non solo dàconto dell’oblio in cui era caduta lafigura del viterbese fino alla risco-perta longhiana ma è anche unaconferma della traccia, a lungo sot-taciuta, lasciata in Spagna da Ca-varozzi in qualità di raffinato di-vulgatore del linguaggio caravag-gesco12. La corretta paternità ven-ne enunciata negli anni cinquantadel Novecento, quando per mezzosecolo la tela era migrata da unacollezione all’altra dell’intero glo-bo come di scuola spagnola. La sottile aureola che circonda ilcapo di Maria, colpita dalla luce,accende di un brillio dorato lo sfon-do che, se non fosse per i sassi e lepiante sparse sul terreno e per l’ac-
cenno, suggerito da un velato trian-golo luminoso, al seggio di rocciasu cui è assisa, non offrirebbe utilispunti d’ambientazione, inghiotti-to com’è dal buio. Una luce fortis-sima, fautrice di ombre taglienti,quasi impietose sul viso mariano –pur bello nonostante l’evidenza de-gli occhi segnati da una stanchez-za che sembrerebbe rinviare al ri-poso durante la fuga – giunge co-me un riflettore di scena a inonda-re da sinistra il gruppo. Alla per-fetta centralità piramidale di Ma-ria, che tiene il Bimbo in grembocon un gesto naturalissimo, tradottocon disarmante, concreta fisicità, sioppone, creando un’importante va-riazione schematica, la figura di sanGiuseppe che, con fare pensoso,dirige dal suo secondo piano unosguardo calmo alla sua sacra fami-glia, così lungo e lento da necessi-tare di un punto d’appoggio per ilvolto sorretto dalla mano. Ma losguardo dello sposo non viene ri-cambiato dalla beata fra le donne,intenta a mostrare il Redentore neo-nato al popolo dei fedeli. Il Bimbodal viso paffuto contornato dabionde chiome ricciute, il volto in-tenso di Giuseppe, quello profon-do di Maria, lambito da una chio-ma sciolta, quasi trascurata con queiciuffi ribelli che scendono sullafronte, offrono la misura del meto-do caravaggesco di ripresa dal ve-ro dei modelli.Le valutazioni dedicate al dipintoda parte degli studiosi che si sonoavvicendati nella redazione delleschede per le esposizioni degli an-ni novanta, sono state orientate aporre in risalto il connubio fra liri-smo ed “evidenza ottica della ma-teria pittorica”, con risultati “piùche reali” attraverso l’uso di “unaluce eccezionalmente analitica edepidermica”13. L’abbagliante resadel manto che avvolge la Vergine edel tessuto che riveste Gesù, di-sposti in pieghe dotate di profon-de anse d’ombra e gonfie d’aria, ca-talizza lo sguardo, offrendo sensa-zioni nel contempo tattili e ottichedella lucida riproduzione del can-dido lino inamidato e croccante.Questo brano, proiettato nella ter-za dimensione grazie a un pennel-lo che indaga con finalità iperreali-stiche le fibre del tessuto e i com-plessi giochi delle ombre, ha tuttoil sapore di un saggio di virtuosismocondotto, alla maniera di Cecco,per potenziare le possibilità del na-turalismo caravaggesco. Una seriedi considerazioni aggiuntive po-trebbero prestarsi a sostenere l’i-
potesi di una datazione precoce e diuna priorità esecutiva rispetto allealtre ‘Sacre Famiglie’. La posturadella Vergine assume una frontalitàche getta in ombra – “caravagge-scamente” – metà del suo viso, ca-ratterizzato da tratti più popolare-schi rispetto ai volti delle altre Ma-donne, pervasi da una bellezza leg-germente più idealizzata e total-mente illuminati perché di tre quar-ti. Il bagno di luce sui tessuti con-ferisce una lucidità qui dovuta allapreponderanza dei bianchi, men-tre l’uso più accentuato delle sete edei velluti blu e azzurri per le altrevesti mariane provoca una maggiordistribuzione luministica, all’inse-gna della raffinata riproduzione diardui cangiantismi. La figura di sanGiuseppe, paludato nel suo mantoocra dalla compatta consistenza,sorge al tocco di un pennello cheanalizza i ciuffi della barba, rendetrasparenti le profonde zone d’om-bra create dalle arcate sopraccigliarie riveste di un morbido e bruno in-carnato le mani con una vicinanzadavvero notevole al fare gentile-schiano. L’immagine, dunque, sem-bra appartenere a quella fase di “na-turalismo acerbo, caravaggesco insenso ortodosso”, che lascia anco-ra intravedere chiare tracce dellaben radicata esperienza roncallia-na14. Anzi, il nostro dipinto sembraarmoniosamente far gruppo, per l’i-dentica impostazione luministica eper la definizione di tutto ciò cheda quell’impostazione deriva (pan-neggi con pieghe a cuneo, pro-grammi cromatici e disposizionedelle ombre), con altre tre tele, ov-vero la Disputa di santo Stefano dicollezione privata (fig. 3), già pre-sente in collezione Mattei nel 1616,e la Cena in Emmaus del Paul GettyMuseum15 (fig. 5), accostabile abuon diritto a questo testo, comedel resto la Madonna con Gesù Bam-bino (Madrid, collezione Conde deMayalde)16, visto che la scrittura èassolutamente conforme e ottem-perante a una “più acuta stilizza-zione naturalistica”17. Non solo, madelle fisionomie predilette dal suomaestro Roncalli la particolare co-struzione del volto mariano, nellatela in esame, conserva ancora unesplicito, evidente ricordo; il nasolungo e importante, gli occhi ton-deggianti sottolineati dall’ombranelle palpebre inferiori, la bocca abocciolo, i ciuffi scomposti sullafronte si ritrovano nelle due figuredelineate nel Lamento di Aminta(fig. 2), di cui una versione facevabella mostra già nel marzo 1615 nel-
45Catalogo
la collezione del conte di Villame-diana18. Se tali caratteri dunque la-sceranno il posto, come confermail San Gerolamo della Galleria Pa-latina (fig. 6), pagato al pittore nel-l’aprile 1617, a un eccesso di son-tuosità cromatica, e se i dipinti fi-nora citati a confronto devono es-sere datati, come suggerisce Papi19,ai primi anni del secondo decen-nio, allora la tela qui esposta dovràritenersi tappa mediana di quelcammino linguistico, che segneràanche il progressivo approccio spe-rimentale non solo verso Gentile-schi ma anche verso Reni, di cui sinota traccia nella figura del nostroGiuseppe. In assenza di ulterioridati d’archivio per una cronologiadelle opere in questi anni, vi è suf-ficiente materiale per argomentare,a livello stilistico, una realizzazionedel dipinto ancora nel tempo ro-mano. Appena giunto in Spagna,Bartolomeo, che doveva aver rica-vato un cartone (o qualcosa di si-mile) da questo primo, strepitosotesto, potrebbe aver confezionatoalmeno una seconda versione che,allo stato attuale delle conoscenze,parrebbe identificabile con quella incollezione privata madrilena20. Oc-corre a questo punto unirsi alla vo-ce di Gianni Papi per mettere in ri-lievo la presenza nel dipinto delFondo Pensioni del Gruppo SanPaolo Imi di un livello qualitativoa tal punto alto da eleggerlo a pro-totipo di una nutrita serie di copie,alcune di ottima fattura. Giusta-mente lo studioso osservava che “lacopia, certamente di autore geno-vese, della Galleria Spada, indur-rebbe a credere che l’originale siatransitato dalla capitale ligure o visia stato eseguito”21. A questo pun-to, visto che le copie esistenti diquella composizione in Spagna con-fermerebbero la presenza colà diun originale cavarozziano e che latela Spada, caratterizzata da un lin-guaggio marcatamente genovese deipieni anni venti del Seicento, di-mostra la notorietà, secondo Gian-ni Papi, di un altro prototipo a Ge-nova, è ragionevole credere che l’ar-tista avesse realizzato almeno dueversioni del soggetto22 e che la se-conda possa coincidere, a quel chesembra dalla mediazione fotografi-ca, con la redazione in collezioneprivata a Madrid23. Quest’ultima“farebbe pensare a un’originariaubicazione (e forse anche esecu-zione) spagnola”24, mentre per quel-la in esame si sarebbe tentati di so-stenere che si tratti del capolavoroveduto – perché transitante per
questioni collezionistiche nel capo-luogo ligure (forse in casa de Ma-ri?) o perché copiato direttamentea Roma – da un artista genovese,l’artefice della copia Spada.
CopieSi è detto che, allo stato attuale del-le conoscenze, il dipinto pubblica-to da Pérez Sánchez in collezioneprivata madrilena e già attribuitoallo Zurbarán mostra, secondoGianni Papi, un livello qualitativotutt’altro che basso e dunque indi-ce di una possibile replica autogra-fa della tela in esame, realizzata daBartolomeo a Madrid25. Un’altra re-plica assegnata dallo studioso al pit-tore viterbese è quella della colle-zione García Hurtado (ma non èverificabile)26. Un’ulteriore tela, dibuon livello qualitativo, è stata pub-blicata dalla Borea come ubicazio-ne ignota e con l’attribuzione a Cec-co del Caravaggio, ma potrebbe es-sere una replica, a quanto dimostrala fotografia, dello stesso Cavaroz-zi27. Non agevole, nell’impossibilitàdi una diretta visione, un giudiziosulla copia, con taglio a mezzo bu-sto (a quel che sembra dall’imma-gine disponibile), registrata in col-lezione Billiter a Vienna28. La co-pia già in collezione Carvalho a Vil-landry presso Tours rivela la mano,non abile con costanza (come di-mostra il pessimo san Giuseppe),di un artista probabilmente iberi-co29. Assai più interessante è il di-pinto collocato nella chiesa di Saint-Valère di Saint-Vallier (Drôme), “ré-plique ancienne fidèle et assuré-ment de bonne qualité”30. Un di-scorso più approfondito esige la co-pia della Galleria Spada, se non al-tro per il fitto e variegato carnet diattribuzioni oscillanti tra un pitto-re genovese (Bernardo Strozzi, Do-menico Fiasella, Giovanni AndreaDe Ferrari), un maestro caravagge-sco (Cecco) e lo stesso Cavarozzi31.Gli studiosi propensi a cogliere, dal-la particolare tecnica pittorica,informazioni utili per una colloca-zione in area genovese hanno con-seguentemente investito il dipintodell’importante ruolo di testimonedella presenza a Genova del pro-totipo cavarozziano. Quest’ipotesi,certamente possibile, entra in con-flitto con quella, ugualmente pro-babile, di una realizzazione a Romada parte di un genovese. Già Alfon-so E. Pérez Sánchez, infatti, soste-neva che “si se admite a Fiasella co-me autor de la copia de Roma, ha-brá que suponer el original comoobra temprana, ya compuesta en
Roma, enviada a España o luegoaquí repetida, pues es, como ve-mos, cuadro de rica fortuna españo-la”32. A una “variante per mano delFiasella nel suo tempo romano”aveva già pensato Longhi, seguitoda Zeri, mentre Papi ha proposto,per la prima volta e in via interro-gativa, il nome di Giovanni AndreaDe Ferrari33. Concordando sul fat-to che non possa trattarsi di Cava-rozzi, poiché la tela “présente unetechnique et un métier savoureuxqui sont absents du modèle”34, sa-rebbe tentante soffermarsi seria-mente sull’ipotesi di Papi se nongravasse su di essa il giudizio pococonfortante di Acordon35. Scartatopacificamente il nome di Fiasellaper assoluta divergenza tecnica,conviene osservare l’uso di una ma-teria pulsante, sugosa, stesa conpennellate dense, frastagliate, la-sciate in evidenza. Tali caratteri so-no particolarmente affini al lin-guaggio di Bernardo Strozzi, so-prattutto nella resa delle dita ma-riane, assai allungate, nelle chiome,vaporose e quasi evanescenti, negliincarnati, rinvigoriti e arrossati, neipanneggi, con una materia stesaquasi a colare. Caratteri che par-rebbero davvero calzanti per ungiovanissimo Giovanni Andrea DeFerrari che fu impegnato nella bot-tega di Strozzi tra il 1613 e il 1619circa36. Pur considerando infattil’insidiosa natura di copia, nella te-la Spada si ritrovano caratteristicheassai simili alle opere realizzate dalDe Ferrari nei primissimi anni ven-ti, come l’Allegoria della Pace (Ge-nova, Banco di Chiavari; fig. 36),dove il pennello pare dosato allostesso modo per la resa degli in-carnati e per la pastosa conduzio-ne dei bianchi tradotti in rivoli dipasta con funzione integrata di sug-gerire le pieghe. E quanto l’osser-vazione di alcuni testi cavarozzianiemani con evidenza da certa pro-duzione del De Ferrari, ma anche,in misura minore, da alcune tele delpiù maturo Strozzi degli anni 1617-1620 circa, si è detto nel saggio inapertura di questo catalogo. La te-la Spada, che varia da quella in esa-me solo per una lieve differenza diinclinazione del volto mariano e perla diversa soluzione conferita a cer-ti sassi e arbusti sul terreno, risul-terebbe già nell’importante qua-dreria romana nel 1663, se è iden-tificabile, come sembra, con “unaMadonna bislonga con S. Giusep-pe e Cristarello”37. Qualora fossegiusta, come si crede, l’ipotesi di ri-tenere genovese l’artefice della Sa-
44 Catalogo
Bartolomeo Cavarozzi (?),Sacra Famiglia, Madrid,collezione privata
Bartolomeo Cavarozzi (copia da),Sacra Famiglia, Villandry,collezione Carvalho
49Catalogo48 Catalogo
cra Famiglia della Galleria Spada –mantenendo un saldo punto inter-rogativo nei confronti di GiovanniAndrea De Ferrari – verrebbe da unlato a consolidarsi l’ipotesi di unapresenza a Genova del prototipodi Cavarozzi (forse in casa de Ma-ri?) ma dall’altro resterebbe irri-solto un approdo così precoce del-la copia in collezione Spada.Daniele Sanguineti
1 Cottino in Torino 1990, s.n.; Pérez Sán-chez 1964a, pp. 47-48 nota 22. 2 Londra, The Burlington Fine Arts Club,n. 5 (Zurbarán).3 Coliva in Washington-Toronto-Bologna1990-1991, p. 31.4 Londra 1913-1914, p. 160, n. 186 (Zur-barán). 5 Nell’impossibilità di consultare diretta-mente il catalogo della mostra londinesedel 1913-1914, l’origine della svista si è de-dotta dalla nota 22 di Pérez Sánchez 1964a,pp. 47-48.6 Londra, Christie’s, 5 aprile 1935, lotto166 (Zurbarán).7 Cottino in Torino 1990, s.n. Fra Viennae Caracas lo studioso indica anche una pro-prietà, non localizzata, a favore di Leopol-do di Segni.8 Stechov 1952, p. 39, n. 2.9 New York, Christie’s, 6 giugno 1984, lot-to 178 (Cavarozzi). Nicolson 1990, I, p.96, II, fig. 397. Nella prima edizione del re-pertorio di Nicolson (1979, p. 42) l’operafu segnalata in collezione privata newyorke-se.10 Coliva in Washington-Toronto-Bologna1990-1991, pp. 28-31; Bona Castellotti inTorino 1997, pp. 148-151.11 Ristretto… s.d. [1735 circa]. Migliorini1997-1999, p. 216.12 Coliva in Washington-Toronto-Bologna1990-1991, p. 28.13 Nell’ordine di citazione: Bona Castellot-ti in Torino 1997, p. 150; Coliva in Wa-shington-Toronto-Bologna 1990, p. 28;Cottino in Torino 1990, p. s.n..14 Papi 1996, p. 89.15 Cappelletti, Testa 1994, pp. 107-108; Pa-pi 1996, pp. 87, 91. Cfr. Cronologia.16 Pérez Sánchez in Siviglia 1973, n. 19; Pa-pi 2001, p. 432. 17 Idem 1996, p. 432.18 Fumagalli 1996, pp. 143-150; Papi 1996,p. 87. Cfr. Cronologia.19 Idem 1996, p. 91.20 Pérez Sánchez 1964a, pp. 23, 47-48.21 Papi 2001, pp. 430, 433.22 Bisogna comunque notare che nessuno,fino ad ora, ha potuto visionare diretta-mente tutti i dipinti considerati ora copieora repliche (cfr. il paragrafo Copie in que-sta scheda). Si deve aggiungere che ancheil dipinto pubblicato da Borea (1972, p.60) sembrerebbe mostrare una qualità sod-disfacente per una possibile attribuzione aCavarozzi replicante di se stesso.23 Pérez Sánchez 1964a, pp. 23, 47-48.24 Papi 2001, p. 435.25 Pérez Sánchez 1964a, pp. 23, 47-48; Pa-pi 2001, p. 435. 26 Pérez Sánchez 1964a, pp. 24, 47. Curie
(2003, p. 211 nota 22) ha identificato, sipensa erroneamente, il dipinto García Hur-tado con quello del Fondo Pensioni delGruppo San Paolo Imi.27 Borea 1972, p. 160.28 Zahn 1928, p. 48; Longhi 1943, p. 53; Pé-rez Sánchez 1964a, p. 47.29 Olio su tela, 160 x 100 cm. Longhi 1943,p. 53; Pérez Sánchez 1964a, p. 47; Curie2003, p. 211. Si tratta della stessa opera(citata nella voce Provenienza di questascheda) che comparve all’esposizione lon-dinese del 1913-1914.30 Olio su tela, 168 x 108 cm. Curie 2003,pp. 211-212, nota 25 (con bibliografia pre-cedente).31 Roma, Galleria Spada, olio su tela, inv.163. Lavagnino 1933, p. 9 (maestro napo-letano o genovese); Longhi 1943, pp. 53-54 nota 69 (Fiasella); Zeri 1954, p. 54, n.153 (Fiasella); Pérez Sánchez 1964a, pp.23-24, 48 (Fiasella?); Pérez Sánchez 1965,p. 57; Faldi 1970, p. 56 (Fiasella); Borea1972, p. 160 (Cecco del Caravaggio); Vol-pe 1972, p. 63 (Cecco del Caravaggio);Brejonde Lavergnée, Cuzin 1974, p. 25 (at-tribuzione a Cecco poco verosimile); DeSalas 1974, p. 38 (attribuzione controver-sa); Marini 1979, p. 74 nota 25 (replica in-certa); Nicolson 1979, p. 42 (Fiasella?); Co-liva in Washington-Toronto-Bologna 1990-1991, p. 28 (Cavarozzi); Nicolson 1990, p.96 (Fiasella?); Cannatà, Vicini 1992, p. 211(scuola di Cavarozzi); Bona Castellotti inTorino 1997, p. 150 (Cavarozzi); Vicini1997, p. 43 (Cavarozzi?); Papi 2001, p. 430(De Ferrari?); Acordon in Galleria Nazio-nale… 2002, pp. 141-142 (maestro geno-vese?); Curie 2003, p. 211 (maestro geno-vese?).32 Pérez Sánchez 1964a, p. 24.33 Longhi 1943, pp. 53-54 nota 69; Zeri1954, p. 54, n. 153; Papi 2001, p. 430.34 Curie 2003, p. 21135 Papi 2001, pp. 430-431; Acordon in Gal-leria Nazionale… 2002, p. 142.36 Acordon 1992, pp. 156-157.37 Cannatà, Vicini 1992, p. 63. Nell’inven-tario del 1759 l’opera è identificabile nel“quadro di palmi 7 e 5 in piedi, cornice in-tagliata antica dorata rappresentante la Ma-donna col Bambino, e San Giuseppe ope-ra del Caravaggio in varii luoghi scrostato”(Cannatà, Vicini 1992, p. 173).
Bartolomeo Cavarozzi (copia da),Sacra Famiglia, Saint-Vallier(Drôme), chiesa di Saint-Valère
Ignoto pittore genovese (GiovanniAndrea De Ferrari?) da BartolomeoCavarozzi, Sacra Famiglia, Roma,Galleria Spada
51Catalogo50 Catalogo
2.Bartolomeo Cavarozzi(Viterbo 1587 – Roma 1625)
Sacra FamigliaOlio su tela, 156 118 cm Genova, in deposito pressola Galleria Nazionale dellaLiguria a Palazzo Spinola
ProvenienzaQuesta elegante versione del sog-getto neotestamentario, così tantevolte affrontato dal giovane mae-stro viterbese, comparve a un’astaorganizzata a Roma nel dicembre19731. Sei anni dopo la tela, perve-nuta in una collezione privata ro-mana, venne menzionata da Mau-rizio Marini e Benedict Nicolson, iquali ne ribadirono l’appartenenzaall’esiguo catalogo di BartolomeoCavarozzi2. Riproposta all’incantonel dicembre 19983, dall’inizio del2001 l’opera è stata concessa in de-posito alla Galleria Nazionale del-la Liguria a Palazzo Spinola4 e si-gnificativamente esposta nelle saledel museo che documentano l’atti-vità per i ricchi committenti dellaRepubblica ligure di importanti ar-tisti forestieri, da Giovanni Pisanoa Jean de Boulogne, da Joos vanCleve a Pieter Paul Rubens e Ora-zio Gentileschi5. Grazie alla brevetestimonianza riportata nel 1990 inoccasione della revisione e amplia-mento da parte di Luisa Vertovadel monumentale contributo di Ni-colson, dove viene precisato a pro-posito di questa composizione che“its vendors claimed a provenancefrom a Spinola collection, Genoa”6,la critica ha collocato la tela all’in-terno della complessa problemati-ca riguardante l’ipotetico soggior-no del maestro di Viterbo nella cittàportuale7.Ritenendo più che attendibile unapresenza ab antiquo del dipinto al-l’interno di una raccolta genovesein considerazione dell’esistenza nelterritorio ligure di una fedele copiaseicentesca, ovvero la pala attribui-ta a Giovanni Carlone raffiguranteSan Secondo invoca la protezionedella Sacra Famiglia sulla città diVentimiglia conservata nella catte-drale del centro ponentino, di cuisi tratterà ampiamente in seguito, ebasandosi sull’annotazione fornitanel 1990, si vuole proporre in que-sta occasione, quale cauta ipotesidi lavoro, una suggestiva identifi-cazione di questa Sacra Famiglia neldipinto di analogo soggetto ricor-dato con “affetto speciale” da Fe-derigo Alizeri nel 1875 in uno de-
gli ambienti del palazzo allora diproprietà dei “marchesi fratelli Spi-nola di Luigi”8 (oggi meglio notocome Palazzo Doria Spinola), sitonelle vicinanze della porta dell’Ac-quasola ed edificato nel quinto de-cennio del XVI secolo su commis-sione del capitano Antonio Doria9.Lo storico genovese, analizzando lagrandiosa collezione allora dispo-sta sulle pareti della residenza ari-stocratica, sottolineò con partico-lare enfasi la qualità di una SacraFamiglia e di un San Gerolamo,“eletti e stupendi”, per i quali pro-pose rispettivamente l’attribuzionea Simone Cantarini e ad AnnibaleCarracci10. L’accostamento del qua-dro al nome del maestro di originipesaresi non deve apparire inveroun elemento indiscutibile, anche inconsiderazione del fatto che gli eru-diti locali ottocenteschi ebbero dicerto ben poca dimestichezza conil linguaggio di Cavarozzi, dimo-strandosi soliti a oscurare il suo no-me con paternità più tradizionali –forse non a caso sempre a favore dimaestri il cui linguaggio è caratte-rizzato da una matrice culturaleemiliana – come accadde anche perla Sacra Famiglia con san Giovan-nino del viterbese assegnata dallefonti periegetiche a Guido Reni(cat. n. 4). È dunque quantomenoammissibile che la Sacra Famigliaattualmente depositata presso laGalleria Nazionale della Liguria aPalazzo Spinola possa realmenteprovenire dal Palazzo Doria Spi-nola, confermando in tal senso l’e-lusiva notizia riportata nel reperto-rio del 1990 e riproposta, pur informa dubitativa, nella scheda cheaccompagnava il dipinto nel cata-logo dell’asta londinese del dicem-bre 199811. Tale ipotetica ricostru-zione, che sarà eventualmentesmentita o avvalorata in seguito al-l’auspicabile rinvenimento di pun-tuali carte d’archivio relative allastoria di questa consistente ed ete-rogenea quadreria, potrebbe forsepermettere dunque di collegare laSacra Famiglia in esame alla famigliaSpinola di San Pietro, la quale ac-quistò l’immobile dai Doria all’ini-zio degli anni venti del Seicento,avviando poco tempo dopo, tra l’al-tro, la costruzione sul lato a levan-te di una galleria progettata da Bar-tolomeo Bianco e destinata a rac-cogliere parte della loro quadre-ria12. È plausibile supporre di con-seguenza che l’opera possa esserestata allontanata da questa dimoratra il 1875, anno in cui FederigoAlizeri redasse l’accurata descri-
zione delle sale sopra ricordata, e il1876, quando la proprietà dell’edi-ficio passò dagli Spinola di Lerma,divenuti nel frattempo possessoriper via ereditaria, al Comune di Ge-nova13. Appare utile sottolineare ariguardo che nel corso degli ultimianni risultano essere varie le operedi questa collezione Spinola un tem-po esposte nel palazzo costruito daAntonio Doria immesse sul merca-to antiquario, come accadde, se sirivelerà esatta tale congettura, allatela di Bartolomeo Cavarozzi neiprimi anni settanta del Novecento.Visitando i numerosi spazi della di-mora, l’attento e curioso sguardodi Alizeri venne infatti catturato,oltreché dalla Sacra Famiglia acco-stata dall’erudito a Simone Canta-rini, da altre testimonianze pittori-che, tra cui in particolare due teledi notevole qualità, delle quali eglifornì un’appassionata descrizione:“l’una (è) il ritratto del card. G. B.Spinola, operato in Roma dal Ba-ciccio14; né qui soltanto io riguardoalla rarità, ma son preso alla bontàdel dipinto, si schietto e verace chepoco più chiedereste da Guido –l’altra poi, fra cotanta dovizia cheabbiam del Fiasella, trascende performa ciascun suo quadro, che aprima giunta vi sarà forte il tener-lo per suo. Rappresenta Sansonetradito da Dalila, che si divincolada’ Filistei; e so quel gagliardo delnudo, e quel feroce del volto, e quelfaticar dei satelliti, e l’ansia pauro-sa della rea donna, disgraderebbe-ro non ch’altro i Caracci, io non soda qual’altra scuola, se non forseda tutte insieme, derivare le vividetinte, e la dotta composizione, equel pronto linguaggio d’affetti chepiace e sommuove ad un tempo”15.Proprio la minuziosa esposizionestesa dallo storico ligure permettedi riconoscere facilmente l’episo-dio tratto dall’Antico Testamentoche vede protagonista il giudice d’I-sraele e la donna filistea nella straor-dinaria composizione di Domeni-co Fiasella presentata nel giugno2005 dalla casa d’arte Sotheby’s diRoma e da considerare tra le mag-giori espressioni del fare maturodell’artista ligure16. Tale importan-te rinvenimento, insieme alla pre-sunta identificazione della Sacra Fa-miglia di Bartolomeo Cavarozzi quisupposta, permettono di ridare for-ma in nuce a una delle rinomatequadrerie genovesi andate dispersenel corso del XIX secolo, raccoltache, grazie alle passioni del mar-chese Massimiliano Spinola, “au-teur de différens ouvrages sur la
zoologie”17, si era oltretutto impre-ziosita proprio nell’Ottocento “(de)la plus riche et la plus belle collec-tion des insectes de la Ligurie, aiun-si que des pays étrangers”18, espo-sta nel primo piano del palazzo as-sieme a “una scelta collezione diquadri”19.Ma nell’ambito dell’ipotetica rico-struzione delle vicende che po-trebbero aver caratterizzato la SacraFamiglia di Bartolomeo Cavarozzi,è opportuno segnalare anche chein un documento risalente al 1735circa venne annotata l’esistenza aGenova di due opere riferite a “Fra’[sic!] Bartolomeo da Vitterbo” raf-figuranti entrambe “Nostra Signo-ra [con] san Giuseppe”, una in ca-sa Balbi (e si tratta sicuramente diquella poi passata nella collezioneMossi di Morano e infine nelle rac-colte dell’Accademia Albertina diTorino; cat. n. 3), l’altra “in casad’Ippolito de Mari”20. Non avendoelementi a disposizione per poterriconoscere eventualmente que-st’ultimo quadro nella versione oraesposta nella Galleria Nazionaledella Liguria (non essendo riporta-te nell’elenco neppure le misure),fatto che negherebbe di conse-guenza un iniziale legame tra la te-la e la famiglia Spinola di San Pie-tro – ma non l’identificazione conla tela ricordata nella quadreria diMassimiliano Spinola, dove po-trebbe essere giunta nel secondoSettecento in seguito a passaggi ere-ditari o transazioni – appare inte-ressante sottolineare che la casatadei de Mari mantenne stretti rap-porti con la Spagna per lungo tem-po. Se la facoltà di pensare a unapresenza della Sacra Famiglia Spi-nola nel centro ligure entro i primianni venti del XVII secolo escludeda una parte l’occasione di colle-gare il dipinto all’attività collezio-nistica di Francesco de Mari, rico-struita di recente da Piero Boccar-do con l’individuazione di impor-tanti acquisti effettuati dal nobile aMadrid alla fine del Seicento21, dal-l’altra si può pensare che la com-posizione di Cavarozzi menzionatanel documento degli anni trenta delSettecento, sia o non sia quella poiappartenuta alla famiglia Spinola,possa essere stata comprata in Spa-gna da un avo di Francesco, comead esempio l’omonimo nonno Fran-cesco de Mari, che nel 1601 risultatitolare di una società in Spagna22.Pertanto le possibilità sembrano es-sere due, ovvero che il dipinto deMari corrisponda a questa Sacra Fa-miglia, poi passata per via eredita-
53Catalogo
ria o mediante una vendita agli Spi-nola, oppure che il quadro ricor-dato tra i beni di Ippolito de Maricostituisca un’ulteriore versione delfortunato soggetto. Potrebbe aspi-rare a questo ruolo l’opera del Fon-do Pensioni del Gruppo San Pao-lo Imi (cat. n. 1), della quale non siconosce però la storia antica, ma lecui influenze in opere di GiovanniAndrea De Ferrari fungono da pro-va di un attendibile passaggio a Ge-nova, oppure un’ulteriore replicaautografa non rintracciata.Quello che sembra comunque con-traddistinguere le opere di Barto-lomeo attestate a Genova è la loroprovenienza spagnola, certa in al-cuni casi, verosimile per altri, realtàche deve costituire un punto di par-tenza imprescindibile per la deter-minazione dei rapporti generatisifra il pittore viterbese e i collezio-nisti della Superba. Tale itinerariopotrebbe essere stato lo stesso per-corso da questa Sacra Famiglia nel-l’eventualità di un’appartenenza ori-ginaria alla famiglia Spinola di SanPietro, ciò in considerazione delruolo ricoperto da alcuni membri diquesta casata nelle vicende storichelegate alla corona spagnola, come ri-levato da Carlo Bitossi ricordandoche “gli eminenti Doria e Spinoladel primo Seicento erano dei tramiti(interessanti e accorti quanto si vo-glia) tra Genova e la Spagna; i lorodiscendenti erano dei grandi di Spa-gna che posavano occasionalmentea protettori della Repubblica e deisuoi interessi alla corte madrile-na”23. Basterebbe citare a riguardocome esempio il comandante Am-brogio Spinola24, cognato del Gio-vanni Battista Spinola che com-missionò gli affreschi della villa Spi-nola di San Pietro a Sampierdare-na, strumento di celebrazione deifasti della propria dinastia attra-verso il suo più importante espo-nente, ovvero proprio il grande con-dottiero, protagonista di alcune del-le scene affrescate da Giovanni An-drea Ansaldo all’inizio del terzo de-cennio del Seicento nella villa diponente25, e, poco tempo dopo, nelpalazzo di città (già Doria) dove,come si è supposto, potrebbe esse-re stata conservata la tela di Barto-lomeo Cavarozzi26. La presenza nelcantiere di Sampierdarena di Gio-vanni Carlone27, probabile autore,come si vedrà meglio in seguito,della fedele copia della Sacra Fami-glia inserita nella pala della catte-drale di Ventimiglia e di certo de-rivata da uno studio attento sul pro-totipo, ha la capacità di costituire al-
lora una non infondata prova indi-retta dell’appartenenza della com-posizione cavarozziana alla famigliaSpinola, con la quale Carlone ebbetangibili contatti nel periodo im-mediatamente successivo all’arrivoa Genova del dipinto, per il quale,nel caso, verrebbe così confermataun’esecuzione durante il soggiornodi Cavarozzi presso la corte di Fi-lippo III. Ad attestare ulteriormentel’esistenza di un nesso tra un di-pinto del maestro caravaggesco raf-figurante la Sacra Famiglia e gli Spi-nola è infine la rapida segnalazionenel 1947 da parte di Gian VittorioCastelnovi di una “replica” o “va-riante” individuata presso la colle-zione dei marchesi Spinola di Ac-qui Terme28. È alquanto probabileche quest’ultimo manufatto coinci-da con la tela qui esposta.
BibliografiaMarini 1979, pp. 72, 74 nota 25;Nicolson 1979, p. 42; Nicolson1990, I, p. 96; Papi 2001, pp. 430;Acordon in Galleria Nazionale...2002, pp. 141-142, n. 51; Curie2003, p. 212; Sanguineti in Mae-stri… 2005, p. 10.
Come già anticipato, dopo la com-parsa alla vendita romana del 1973,la Sacra Famiglia venne segnalata nel1979 da Marini e Nicolson. Se que-st’ultimo studioso inserì stringata-mente la tela nel catalogo delle ope-re ascrivibili a Bartolomeo Cava-rozzi, segnalandone solo il passaggioall’incanto e riportando le misuresenza l’aggiunta di ulteriori com-menti, il primo la considerò inveceuna “variante più matura di unacomposizione assai fortunata, notatramite varie repliche (oltre a quel-la incerta della Spada – tra cui Spa-gna, Madrid, collezione privata, To-rino, Pinacoteca Albertina) e co-pie”29. Nella ristampa di Caravaggi-sm in Europe, del 1990, la segnala-zione fornita in precedenza da Ni-colson si arricchì della preziosa po-stilla attraverso la quale veniva datanotizia di una possibile provenien-za del dipinto da una non meglioprecisata collezione Spinola di Ge-nova30. Questa informazione è statarecepita successivamente da GianniPapi, al quale si deve la più recentee accurata analisi dell’esperienza ar-tistica del maestro viterbese, con unparticolare riguardo alla sua produ-zione matura31. Lo studioso ha vo-luto considerare la tela nell’ambitodei rapporti creatisi tra Cavarozzi el’ambiente culturale genovese, dan-do dunque credito all’informazione
52 Catalogo
Domenico Fiasella, La catturadi Sansone, collezione privata(per gentile concessione di Christie’s Roma)
57Catalogo56 Catalogo
riportata da Nicolson. La vicendaartistica della Sacra Famiglia, abba-stanza scarna rispetto alla straordi-naria qualità esecutiva e all’indubbiagrazia veicolata da ogni elementocompositivo delineato dal maestro –è sufficiente citare il materno ab-braccio della Vergine – è stata infi-ne ripercorsa da Angela Acordon,la quale, sulla scia delle riflessioniesposte da Papi, ha analizzato il sog-getto cavarozziano interpretandolocome probabile testimonianza di“una lunga sosta di Cavarozzi in Li-guria tra la primavera del 1619 e laPasqua del 1622, ignorata dalle fon-ti e poco considerata negli studi sul-l’arte locale come in quelli relativi aBartolomeo”32. Alla studiosa si de-ve inoltre anche l’accurata disaminadell’ascendenza avuta dal modus delviterbese nei confronti di artisti lo-cali quali Domenico Fiasella e Gio-vanni Andrea De Ferrari, nonchédella fortuna raggiunta dagli esiti diBartolomeo presso la committenzaligure attestata dalla presenza in si-tu di varie copie. Lasciando a Da-niele Sanguineti il non facile compitodi esaminare globalmente nel sag-gio che introduce le schede delleopere esposte in mostra l’ambiguo eincerto problema relativo alla pos-sibilità dell’effettiva esistenza di unsoggiorno genovese di Cavarozzi,appare rilevante focalizzare invecel’attenzione sulla raffinata scena idea-ta dal pittore viterbese secondo unfare che caratterizza la sua produ-zione pienamente matura, corri-spondente alla fase “caravaggesca”,come la definisce Gianni Papi, delsuo breve ma elevato percorso stili-stico. Tale momento trova uno deisuoi vertici nel San Gerolamo (Fi-renze, Galleria Palatina; fig. 6), “ca-polavoro assoluto della sua manieracaravaggesca ortodossa giunta a pie-na maturazione”33, eseguito nel1617, che si ritiene debba essere con-siderato il punto di partenza per ana-lizzare la Sacra Famiglia in questio-ne. Sono infatti palesi i rimandi frala testa reclinata del padre dellaChiesa e quella del canuto san Giu-seppe, nella quale riconosciamoun’analoga definizione dell’epider-mide e della lunga barba, nel dipin-to genovese sottolineata da un se-gno che conferisce un aspetto mag-giormente plastico. Anche la regia lu-ministica accomuna i due dipinti,come pure quella magistrale curanella resa attraverso pennellate insi-stite ed energicamente sovrappostedegli effetti materici dei tessuti, mo-vimentati da profonde pieghe chene esaltano, mediante attenti pas-
saggi chiaroscurali, la consistenza eaccentuano nel contempo la mas-siccia volumetria dei corpi sotto-stanti. Le stesse peculiarità si ritro-vano pure nell’emozionante SantaCecilia (collezione privata; fig. 9),collocata da Papi alla fine del se-condo decennio del Seicento34 e daritenere un ulteriore termine di con-fronto per il quadro genovese, so-prattutto se si accosta la morbidadescrizione delle mani femminili edegli incarnati, nonché la ricchezzacromatica delle superfici delle vestio, nel caso della tela con la santamartire, degli oggetti disposti in pri-mo piano, elementi linguistici cheimpreziosiscono composizioni con-traddistinte da un’ambientazionesorprendentemente intima, quasi di-sarmante. L’“esattezza” dello studio“del naturale”35, nonostante l’artifi-ciosità della postura fatta assumeredai modelli, trova nella tenera espres-sione del paffuto Bambino assisosulle ginocchia della madre, nel si-lenzioso dialogo che si instaura fraquesti due personaggi, veicolato me-diante una gestualità di immediatasemplicità, e nell’incredibile voltodel san Giuseppe, definito a ragio-ne da Pierre Curie “mélancolique”36,il raggiungimento da parte di Bar-tolomeo Cavarozzi di una totale pa-dronanza dei propri mezzi espressi-vi, qui arrivata al suo apice e sotto-lineata anche dall’inserimento di al-cune piante minuziosamente de-scritte in ogni loro componente, in-serti che dovrebbero far riflettereanche sulla sua eventuale produzio-ne di nature morte e sull’identifica-zione dell’artista nel Maestro dellanatura morta Acquavella propostada Mina Gregori37. Considerato“frutto di una meditazione su capo-lavori raffaelleschi quali la Madonnadella seggiola della Galleria Palatinadi Firenze”38, il dipinto si può per-tanto collocare nel pieno del sog-giorno spagnolo, verosimilmente inprossimità del Matrimonio misticodi santa Caterina del Prado (an-ch’esso notevolmente replicato; fig.20), per il quale Gianni Papi ha pro-posto una convincente esecuzione“subito dopo l’arrivo in Spagna”39 diCavarozzi al seguito di Giovanni Bat-tista Crescenzi, ossia dopo la finedel 1617. Sembrano palesare talecronologia anche i rimandi con lealtre versioni dello stesso soggetto,tra le quali si ricorda soprattutto laSacra Famiglia pervenuta nelle col-lezioni del Fondo Pensioni delGruppo San Paolo Imi (cat. n. 1), lacui realizzazione potrebbe essere fis-sata anche prima del trasferimento
in terra iberica, dove l’artista, ante-riormente al ritorno del Crescenziin Italia avvenuto secondo la criticanella primavera del 1619, dipinse in-vece la Sacra Famiglia già Balbi del-l’Accademia Albertina di Torino(cat. n. 3).Ritenendo ancora alquanto incertal’ipotesi di un’attività genovese diBartolomeo Cavarozzi anche inconsiderazione dell’assoluto silenzioin tal senso degli storiografi sei-set-tecenteschi liguri – il minuzioso Raf-faele Soprani in primis – allo statoattuale delle ricerche la tela in esa-me potrebbe essere stata quindi ese-guita durante il soggiorno presso lacorte di Filippo III, che “dovetteconquistare al pittore un notevolemercato”40, o su commissione di unmecenate ligure – di cui si ignoraper ora l’identità – legato a questoambito politico-culturale e poi in-viata a Genova, oppure acquistatain seconda battuta sul vivace mer-cato spagnolo, sempre ricco di im-portanti occasioni per gli attenticollezionisti della Superba. Pur nonescludendo che Cavarozzi possaaver sostato a Genova durante ilviaggio di ritorno, giustificando inquesto modo “le tracce forti del-l’influenza rubensiana” segnalateda Papi nelle testimonianze matu-re dell’artista41, tenuto conto da unaparte sia delle recenti ipotesi di unapresenza di Bartolomeo a Roma al-meno intorno alla metà del 162142,sia, dall’altra, del fatto che alcunedelle opere documentate nelle col-lezioni genovesi giunsero in realtàdalla Spagna molti anni dopo l’at-tività dell’artista, sembrano assot-tigliasi sempre più le possibilità diun soggiorno prolungato nel centroligure e, pertanto, anche l’eventua-lità di un’esecuzione in loco di que-sta Sacra Famiglia, che costituisce,comunque, un palese esempio delfavore ottenuto presso i nobili ge-novesi, nonché un’accettabile tap-pa intermedia fra la tela del FondoPensioni del Gruppo San Paolo Imi(cat. n. 1) e quella giunta presso laPinacoteca dell’Accademia Alber-tina (cat. n. 3). Si può comunque as-serire con certezza che il dipinto inesame si trovava a Genova già neiprimi anni venti del XVII secolo, es-sendo stato il fondamentale mo-dello d’ispirazione per il pittoreGiovanni Carlone nel momento incui realizzò la pala con San Secon-do invoca la protezione della SacraFamiglia sulla città di Ventimiglia.
CopieL’ancona conservata nella chiesa
Bartolomeo Cavarozzi (copia da),Sacra Famiglia, Bayeux, MuseoBaron-Gérard
59Catalogo
del centro ponentino risulta men-zionata alla fine dell’Ottocento suuna parete della cappella dedicataal Santissimo Sacramento con unriferimento al pennello di Bernar-do Strozzi43. È successivamente Ca-stelnovi a considerare il dipinto“una composizione con elementidella Sacra Famiglia derivati dalpittore viterbese Bartolomeo Ca-varozzi”44, peculiarità che portò lostudioso ad attribuirlo alla manodi un suo imitatore. Ribadendo ilparere espresso dallo studioso, nel1981 Erino Viola propose inoltreuna datazione della tela intorno al-la metà del terzo decennio del Sei-cento45. Considerata ancora negliultimi anni “una replica dal Cava-rozzi” di un anonimo del XVII se-colo46, la composizione è stata piùrecentemente messa in relazioneda Franco Boggero con il lessico diGiovanni Carlone47. Tale propostarisulta alquanto convincente, so-prattutto se si confronta il dipintodi Ventimiglia, e in particolare la fi-gura di san Secondo, l’unica a nonrisentire totalmente della contami-nazio cavarozziana, con quanto rea-lizzato dal pittore ancora all’inter-no degli anni venti assieme al fra-tello Giovanni Battista nella chie-sa dell’Annunziata di Genova48 op-pure, soprattutto, con esiti di po-co anteriori come l’ancona raffi-gurante l’Assunzione della Verginecommissionata all’artista GiovanniBattista De Giudici per la cappel-la edificata all’interno della catte-drale negli anni 1619-1621, dopoaverne ricevuto nel 1617 il giuspa-tronato dal vescovo Nicolò Spino-la49. Ed è in questo stesso momen-to che deve essere collocata con at-tendibilità la realizzazione della pa-la d’altare, voluta da un esponen-te della stessa famiglia De Giudi-ci: come indicato da Castelnovi50,in basso a sinistra compare infattilo stemma, “d’azzurro alla banda dirosso caricata di tre gigli d’oro nelverso della pezza”51, di questa im-portante casata, legata profonda-mente alle vicende politiche delcentro rivierasco e alla nobiltà ge-novese. È dunque verosimile pen-sare che negli stessi anni o imme-diatamente dopo l’esecuzione deldipinto per Giovanni Battista DeGiudici, inserito all’interno di unraffinato altare di Alessandro Fer-randino52, Giovanni Carlone abbiarealizzato anche la pala con San Se-condo invoca la protezione della Sa-cra Famiglia sulla città di Ventimi-glia, della quale non sono attual-mente disponibili notizie d’archi-
vio o testimonianze antiche circal’ubicazione originaria. In consi-derazione però dell’importanzaconferita nell’impaginazione dellasacra conversazione alla figura disan Secondo, patrono della città diVentimiglia (accuratamente de-scritta lungo il bordo inferiore),appare lecito pensare che questodipinto fosse stato richiesto per or-nare l’altare in cui si venerava ilsanto presente in cattedrale, forsein sostituzione della dispersa an-cona cinquecentesca raffigurantela Decollazione di san Secondo coni santi Pietro e Paolo uscita dallabottega dei fratelli Bartolomeo eGiacomo de Rogerys e voluta, co-me si evince dal contratto redattol’8 marzo del 1507, dal “cantor etcanonicus ecclesie maioris Vinti-milii”53 Secondino De Giudici, alquale si deve la costruzione dellacappella di San Secondo, avviatanel gennaio del 150554. Pertanto èplausibile pensare che un suo di-scendente sia intervenuto poco piùdi un secolo dopo per aggiornarel’apparato decorativo del sacello.Candidato a cui riferire tale inter-vento appare lo stesso GiovanniBattista De Giudici, “dotto cano-nico” eletto del 1602 vicario gene-rale dal vescovo Stefano Spinola55,o un suo stretto famigliare. La te-la di Carlone potrebbe essere dun-que rimasta nella sua sede sino al1689, quando la cappella venne do-nata da Francesco Maria De Giu-dici al parroco Antonio FrancescoOlignani56. Non si può escludere,ma si tratta di una semplice sup-posizione non fondata sull’analisidi dati precisi, che dopo questa da-ta l’opera possa essere stata trasfe-rita, in considerazione dei perso-naggi raffigurati, nella cappella chenel 1780 risulta dedicata a “s. Se-condo e Giuseppe”57; sicuramenteall’inizio del Settecento la tela nondecorava più l’altare intitolato alsanto protettore, dato che una vi-sita del vescovo Ambrogio Spino-la compiuta nel 1704 ricorda una“icone ornatu ligno deaurato deiure patronatus laicorum D. D. Ju-dicibus”58.Ritornando all’analisi stilistica deldipinto, appare subito lampanteche l’artefice ebbe modo di stu-diare accuratamente il prototipocavarozziano, sia nella generale im-postazione della Vergine che ab-braccia il Bambino e di san Giu-seppe, sia nella stesura di ogni par-ticolare secondario, dall’andamen-to delle pieghe alla resa dei can-giantismi che impreziosiscono le
58 Catalogo
Bartolomeo Cavarozzi (copia da),Sacra Famiglia, Genova, Galleriadi Palazzo Bianco, depositi
Giovanni Carlone, San Secondoinvoca la protezione della SacraFamiglia sulla città di Ventimiglia,Ventimiglia, cattedrale
61Catalogo
16 Roma, Christie’s, 15 giugno 2005, lotto702. Il dipinto misura 183 173 cm.17 Nouveau Guide… 1842, p. 313.18 Ibidem. La “scelta collezione d’insettidella Liguria, e di eccellenti quadri” ven-ne segnalata anche in Guida… 1837, p. 71.19 Alizeri 1847, II, parte 1, p. 776.20 Migliorini 1997-1999, p. 216.21 Boccardo 2002, p. 225.22 Ibidem, pp. 238-239 nota 22. 23 Bitossi 1990b, p. 74. Per la situazione po-litica e i rapporti con la corona spagnola:Costantini 1986, pp. 217-244, 335-354.24 Su questo intrigante personaggio e la dif-fusione dei soggetti collegati alle sue im-prese militari: Colomer 2002, pp. 177-205.25 Per questo fondamentale ciclo: Gavazza1974, pp. 53-72; Gavazza 1976, pp. 5-15;Boggero 1985, p. 20 nota 38; Colomer2002, p. 179.26 Sui perduti affreschi di Palazzo DoriaSpinola José Luis Colomer ha annunciatoun prossimo studio di Piero Boccardo: Co-lomer 2002, pp. 204-205 nota 13. Alcuneinformazioni per le scene di Ansaldo si rin-tracciano in Alizeri 1847, II, parte 1, p.782, dove viene riportato che Gio PaoloSpinola “chiamò Andrea Ansaldo ad isto-riare la […] Galleria già adorna riccamen-te di stucchi”. Nella stessa occasione l’e-rudito ebbe modo di far percepire il fasci-no dell’ambiente, decorato con immagini“che alludono alla grandezza del perso-naggio che ivi si loda, tuttochè siano cosedi stupendo effetto, disegnato con istudio,e colorite con un sapore che incanta”. Lostesso entusiasmo caratterizza la descrizio-ne fornita da Alizeri l’anno precedente ilpassaggio dell’edificio al Comune di Ge-nova: “Bellezza simile o non vedeste fino-ra, o assai poco che rivaleggi; sia pel gen-tile accordarsi che fan le plastiche colle pit-ture, o per brillar di queste ultime, che fat-te a grandissimo studio dal più vivace de’nostri pennelli, vi ferman di primo trattocon un tal riso che v’innamora” (Alizeri1875, p. 243). Con accesa preoccupazioneAlizeri che “prima che la gentil Galleriacada tutta in frantume […] i novelli Spi-noli strappino almeno alle picche distrug-gitrici le rare medaglie, e le serbino ai po-steri in alcun luogo del loro palazzo; essiche tanto a difenderlo s’affaticarono, conplauso de’ buoni, e con sincera coscienza”(Alizeri 1875, p. 244). Cfr. inoltre Biavati1974, pp. 33-39.27 Gavazza 1974, pp. 53-72; Gavazza 1976,pp. 5-15; Boggero 1985, p. 20 nota 38; Pe-senti 1986, pp. 123-124.28 Castelnovi 1947, p. 10 nota 5.29 Marini 1979, p. 74 nota 25.30 Londra, Sotheby’s, 17 dicembre 1998,lotto 80.31 Papi 2001, pp. 427-438.32 Acordon in Galleria Nazionale… 2002,p. 141.33 Papi 2001, p. 432.34 Idem 1996, pp. 89-90; Gallo in Roma-Sie-na 2000-2001, p. 232, n. 55; Papi 2001, p.435.35 Con queste parole il Baglione (1642, p.287) descrisse una delle peculiarità pro-prie del linguaggio cavarozziano.36 Curie 2003, p. 212.37 Gregori 2003a, pp. 36-40. Il modo di de-scrivere la superficie della pianta disposta
in basso a destra risulta particolarmenteprossimo, ad esempio, alla resa delle foglieche impreziosiscono la tela raffigurante ilLamento di Aminta (collezione privata): siriscontra una stessa sensibilità nella de-scrizione degli effetti della luce che scivo-la sulle discontinue superfici e nell’accuratostudio scientifico di ogni minimo partico-lare. Per il dipinto appena ricordato, notoattraverso due versioni autografe: Cottinoin Roma-Milano 1995, p. 150, n. 38; Cot-tino in Firenze 2003, pp. 166-167.38 Acordon in Galleria Nazionale… 2002,p. 142.39 Papi 2001, p. 435.40 Spezzaferro 1979, p. 27.41 Papi 2001, p. 432.42 Nicolai 2004, pp. 440-462. La lettera ste-sa da Aurelio Marrocchi il primo gennaiodel 1622 permette infatti di documentarela presenza di Cavarozzi a Roma quanto-meno nel corso della seconda metà del-l’anno precedente. Cfr. Cronologia.43 Rossi 1886, p. 331. Il dipinto misura218 145 cm. Si ringrazia l’Ufficio ArteSacra della Curia Vescovile di San Remo-Ventimiglia per aver autorizzato la pub-blicazione dell’immagine della tela.44 Castelnovi 1947, p. 10. 45 Viola 1981, p. 67.46 Ciliento, Pazzini Paglieri 1991, pp. 171-172.47 Acordon in Galleria Nazionale… 2002,p. 142. Come osservato da Massimo Bar-toletti (comunicazione orale), l’esecuzionenei primi anni Venti della pala per la Cat-tedrale si collocherebbe nel momento dimaggiore attività di Carlone per la com-mittenza dell’estremo ponente ligure.48 Pesenti 1986, pp. 126-127. 49 Rossi 1886, p. 374, con alcuni interessantipassi tratti dal testamento di Giovanni Bat-tista De Giudici del 23 aprile 1630. Per levicende legate alla cappella: Bartoletti 1990,pp. 94-95.50 Castelnovi 1947, p. 10 nota 7.51 Bono 1924, p. 22.52 Bartoletti 1990, pp. 94-96.53 Bres 1914, p. 82.54 Per l’atto di commissione del dipinto,saldato il 25 gennaio 1508: Bres 1914, pp.81-82. 55 Rossi 1886, p. 233.56 Allaria Oliveri 1996, p. 25.57 Rossi 1886, p. 331 nota 1. Questo alta-re, caratterizzato da una doppia intitola-zione, nel 1603 non risulta menzionato dalvescovo Stefano Spinola.58 Questa notizia è stata rintracciata da Va-lentina Zunino (Ufficio Arte Sacra dellaCuria Vescovile di San Remo-Ventimiglia)che ringrazio per la preziosa disponibilità.Per la trascrizione di alcune lapidi collegatealla cappella di San Secondo: Rossi 1886,pp. 473, 493.59 Per il documento: Bartoletti 1990, p. 95nota 11.60 Rossi 1886, pp. 232-233.61 Pesenti 1986, pp. 124-125.62 Curie 2003, p. 212.63 Parigi, Hotel Drouot, 5 aprile 1991, lot-to 70. Curie 2003, p. 212 nota 28.64 Vsevolozkaya, Linmik 1975, p. 64.65 Olio su tela, 154 114 cm, inv. PB 1959.Presenta un formato pressoché identico alprototipo di Cavarozzi. Si ringrazia Clario
Di Fabio per aver segnalato a Daniele San-guineti l’esistenza del dipinto nei depositidel museo che dirige.66 VI Mostra Nazionale Antiquariato. Vi-terbo, Palazzo dei Papi (19 ottobre – 10 no-vembre 1985). Ringrazio sentitamente laGalleria Petrella di Orvieto per aver in-viato il materiale fotografico relativo al di-pinto. Secondo la comunicazione di Erne-sto Petrella, Italo Faldi presentò come au-tografa questa tela in un articolo compar-so in occasione dell’esposizione antiquariasul giornale “Il Tempo”. Desidero ringra-ziare Farida Simonetti, alla quale dedicoquesto breve contributo, per avermi affi-dato l’incarico di studiare il dipinto di Bar-tolomeo Cavarozzi depositato presso laGalleria Nazionale della Liguria da lei di-retta. Un grazie particolare a Massimo Bar-toletti, Marzia Cataldi Gallo, Matteo Mo-retti, Maria Luce Repetto, Paola Traverso-ne e Valeria Zunino.
60 Catalogo
superfici tessili, alla particolare ac-conciatura femminile, sino all’usodi un’identica tavolozza cromaticaper le vesti. Se i morbidi contornidelineati da Bartolomeo risultanoirrigiditi nella pala di Ventimigliada un tratto maggiormente incisi-vo, la coscienziosa osservazione delductus del maestro laziale, certa-mente dovuta a puntuali richiesteformulate dalla committenza, sipercepisce anche nella ricerca chia-roscurale, con la ripresa delle zo-ne di luce che colpiscono, esaltan-doli, i lisci incarnati delle gambedi Gesù, le mani e il roseo volto diMaria. La presenza nel quadro li-gure di un insistito sovrapporsi dipanneggi in corrispondenza delbordo dell’abito della Vergine po-trebbe documentare l’esistenza nel-l’originale di Cavarozzi di un ta-glio lungo il lato inferiore, sicura-mente presente a sinistra, dovemanca una parte considerevole delbraccio di san Giuseppe avvoltonel manto. Si è a conoscenza deirapporti che la famiglia De Giudi-ci mantenne nei primi decenni delSeicento con la nobiltà genovese: inparticolare, nel suo testamento del1630 Giovanni Battista De Giudi-ci rivela l’esistenza di una strettaamicizia con Stefano Rivarola, non-ché di una relazione con la comu-nità religiosa barnabita di San Pao-lo il Vecchio59. Fu dunque verosi-milmente in occasione di un sog-giorno nella città portuale che Gio-vanni Battista o un suo parente eb-be modo di osservare la Sacra Fa-miglia di Cavarozzi poi indicata aCarlone come irrinunciabile mo-dello. E forse i risultati di prossi-me ricerche permetteranno di con-siderare non solo una coincidenzala nomina nel gennaio del 1617 diNicolò Spinola quale vescovo diVentimiglia, personaggio con cuiDe Giudici ebbe sicuramente stret-ti e favorevoli legami60. Pure ana-lizzando il fare di Carlone potreb-bero essere rintracciati minimi in-dizi dell’avvenuto confronto conl’eloquio di Bartolomeo: osservan-do ad esempio una delle figure al-legoriche affrescate dall’artista nel-la Villa Spinola di San Pietro diSampierdarena sembrerebbe infat-ti percepirsi nella delicata espres-sione, nel morbido contorno delvolto e nell’acconciatura un’ecodello Madonna cavarozziana61.Anche la copia “d’après Cavarozzi”conservata nel museo Baron-Gé-rard di Bayeux, recentemente resanota da Pierre Curie62, dimostra co-me questa composizione sia stata
oggetto di continua ammirazione.Sulla base delle notizie relative al-la provenienza dell’opera fornitedallo studioso, non appare possi-bile formulare una proposta sicuracirca il luogo e il momento d’ese-cuzione della tela, anche se l’ormaievidente esistenza di più versionidello stesso soggetto di mano diBartolomeo non può far escluderea priori la presenza di un originaleanche in questo ambito territoria-le, come dimostrerebbe pure unapiccola copia passata nel 1991 al-l’incanto e attribuita alla scuolafrancese del XIX secolo63. Meno fe-dele rispetto ai risultati di Giovan-ni Carlone e alla tela di Bayeau ri-sulta al contrario la copia dell’Er-mitage64 (fig. 18), nella quale si no-tano numerose indicative varianti,forse interpretabili come indizio diun ulteriore prototipo cavarozzianodisperso.Importante invece, in quanto lega-ta alla Sacra Famiglia esposta pres-so la Galleria Nazionale della Li-guria, è la copia di pertinenza del-le collezioni della Galleria di Pa-lazzo Bianco di Genova, dove giun-se attraverso il legato Peirano65. Èuno studio “meccanico” dell’aulicoesemplare “Spinola”, forse esegui-to verso la fine del XVIII secolo daun modesto pittore ligure. Si trattadi un’opera priva di elevate ricer-catezze pittoriche ma che contri-buisce a documentare l’esistenzanell’originale di un taglio in corri-spondenza del bordo sinistro, non-ché a ribadirne la presenza in unaquadreria genovese.Il consenso ottenuto da questo sog-getto, ben testimoniato dai manu-fatti appena ricordati, è palesatoanche da un dipinto ovale di ubi-cazione sconosciuta raffigurante lasola Madonna con Gesù Bambinoproposto, con la diretta paternità aCavarozzi, nel 1985 a Viterbo nel-l’ambito di una mostra antiquaria66.L’opera, purtroppo nota solo attra-verso una fotografia, appare carat-terizzata da una notevole delica-tezza pittorica, percepibile soprat-tutto nella descrizione delle capi-gliature, nei diafani incarnati e nel-l’accurata stesura delle stoffe can-gianti. Volendo lasciare in sospesol’attribuzione della tela per l’im-possibilità di leggerne corretta-mente ogni singola componente, èindubbio che comunque questonuovo tassello debba essere perce-pito come un ulteriore sensibile“approccio” alla fortunata ideazio-ne cavarozziana.Gianluca Zanelli
1 Roma, Finarte, 12-13 dicembre 1973, lot-to 65.2 Marini 1979, p. 74 nota 25; Nicolson1979, p. 42.3 Londra, Sotheby’s, 17 dicembre 1998, lot-to 80.4 Per le recenti vicende del dipinto: Acor-don in Galleria Nazionale… 2002, pp. 141-143, n. 51.5 Per i criteri che contraddistinguono lapresentazione delle opere nel percorso del-la Galleria Nazionale della Liguria a Pa-lazzo Spinola: Simonetti 2002, pp. 5-13.Per l’analisi approfondita di alcuni dei ma-nufatti conservati nel museo genovese sirimanda ai vari contributi pubblicati neicataloghi delle seguenti esposizioni: Ge-nova 2003; Genova 2005a; Genova 2005b.6 Nicolson 1990, I, p. 96. Secondo quantoindicato questa informazione risalirebbe al1988.7 Papi 2001, pp. 427-438. Cfr. inoltre il sag-gio di Daniele Sanguineti in questa stessasede.8 Alizeri 1875, pp. 232-245.9 Per l’origine del palazzo: Boccardo 1989,pp. 121-123; Giusso in Una reggia… 1998,p. 196, n. 118; Marica 2000, pp. 1-7; Piz-zorno 2004a, pp. 9-15.10 Alizeri 1875, p. 241.11 Riguardo alla provenienza del dipintovennero infatti fornite le seguenti indica-zioni: “possibly Spinola collection, Geno-va” e “Anonymous sale, Roma, Finarte, 12-13 december 1973, lot. 65”.12 Giusso in Una reggia… 1998, p. 196, n.118; Marica 2000, pp. 7-8 (con bibliogra-fia precedente).13 Parma 1999, p. 195. 14 Non è ancora possibile individuare il Ri-tratto di Giovanni Battista Spinola di Gaul-li ricordato da Alizeri, anche perché lo sto-rico non specifica se si tratti di una effigiedel cardinale di Santa Cecilia in Trasteve-re e, poi, governatore di Roma, oppure delpiù giovane cardinale Giovanni BattistaSpinola iuniore. Ma verosimilmente il ri-tratto venne citato da Carlo Giuseppe Rat-ti: egli segnalò nel 1769 infatti “nella log-gia de’ Signori Spinola […] un maestoso ri-tratto d’un Cardinale di questa Famiglia”(Ratti 1769, p. 87). A riguardo bisogna sot-tolineare che Engass pubblicò un Ritrattodi Giovanni Battista Spinola seniore già incollezione Spinola di Lerma (Engass 1964,p. 127; 80 68 cm). Per un’attenta indagi-ne sulla diffusione dell’immagine di Gio-vanni Battista Spinola seniore ideata daGaulli: Grilli in Roma 1999, p. 121, n. 16.Si segnala che in quest’ultimo contributoil dipinto di collezione privata contraddi-stinto dal numero di riferimento 16a(73,5 61 cm), viene più volte ricordatonel testo come di pertinenza di una “col-lezione Spinola”. È stato recentemente rin-tracciato presso una collezione privata unRitratto del cardinale Giovanni Battista Spi-nola iuniore, caratterizzato da uno “scattoimprovviso verso lo spettatore, […] l’i-perrealismo del raso della mozzetta, del-l’incarnato e lo sguardo penetrante” (Pe-trucci 1999, p. 98), caratteri che fanno ve-nire in mente la schiettezza e la veracità as-segnate da Alizeri al quadro della colle-zione di Massimiliano Spinola.15 Alizeri 1875, p. 242.
Bartolomeo Cavarozzi (attribuito),Madonna con Gesù Bambino,ubicazione ignota
63Catalogo62 Catalogo
3.Bartolomeo Cavarozzi(Viterbo 1587 – Roma 1625)
Sacra FamigliaOlio su tela, 176,5 132,9 cmTorino, Pinacotecadell’Accademia Albertina di BelleArti, inv. 107
ProvenienzaCon atto del 6 maggio 1706, il ge-novese Alessandro Saluzzo, in con-to proprio e dei numerosi fratelli,alienò un consistente lotto di qua-dri a Costantino Balbi (1676-1740),come da inventario allegato in cui sipuò rintracciare agevolmente, fra itrentanove strepitosi capolavori, ildipinto ora presso la Pinacoteca del-l’Accademia Albertina: “N[ost]raSig[no]ra con Bambino e S. Giu-seppe di Bart[olome]o da Viterbo”1.Dell’opera, fino a oggi, era nota so-lo la provenienza dalla collezioneBalbi2. Parte dell’importante qua-dreria ereditata dai figli di Bartolo-meo Saluzzo (1651-1705) vienedunque restituita da questo docu-mento, per la maggior parte inedi-to, concepito come un elenco diopere precedute dal topografico ri-feribile a un inventario generale eseguite dal prezzo3. La Sacra Fami-glia, che occupava il numero 1 delsecondo salotto di palazzo Saluz-zo, venne stimata 2000 lire, en-trando nel novero degli undici di-pinti, dovuti ai pennelli di Seba-stiano del Piombo, Tiziano, Rubense Van Dyck, valutati somme di granlunga superiori alle 1000 lire4. L’in-ventario è giunto dunque a circo-stanziare il corposo acquisto Balbi,di cui peraltro già da tempo si eraa conoscenza per la registrazionearchivistica della considerevole spe-sa totale di 32.920 lire segnata, indata 17 maggio, dal facoltoso ac-quirente nel proprio libro di contia favore di “Alessandro e fratelliSaluzzi per prezzo de quadri ven-dutimi e consegnatimi”5. Ora è dun-que possibile definire con preci-sione un ambito d’origine più ar-retrato, dal momento che l’assenzadella tela in esame dagli inventaridella collezione di Francesco MariaBalbi6, da cui il nipote Costantinoereditò 17 opere7, già lasciava du-bitare di una presenza originariadella tela nel circuito di quella fa-miglia. Ciò che a questo punto ac-quista estremo interesse è la con-statazione, avanzata di recente daPiero Boccardo, della permanenzain collezione Saluzzo di alcuni di-pinti di Rubens, giunti dalla qua-
dreria madrilena di Juan GasparEnríquez de Cabrera (1625-1691),decimo Almirante de Castilla8, an-teriormente al 1706 poiché an-ch’essi inclusi nell’acquisto Balbi9.Lo studioso ha giustamente ipotiz-zato, in considerazione dell’assen-za di notizie utili per certificare con-tatti diretti del Saluzzo con la Spa-gna, che quei quadri, come forseanche altri, fossero approdati a Ge-nova per tramite di Francesco deMari (1656-1710), che, a Madridcome inviato straordinario della Re-pubblica nel biennio 1692-1694,aveva acquistato opere anche pres-so la collezione di Gaspar de Haroy Guzmán10 e che potrebbe aver ri-venduto in loco parte delle sue di-versificate acquisizioni madrilene11.Del resto è significativo sottolinea-re che proprio nella collezione diIppolito de Mari, figlio primogeni-to di Francesco, era presente – co-me attesta l’interessante Ristretto didifferenti quadri e pitture a frescoesistenti in Genova databile intor-no al 173512 – una “Nostra Signo-ra san Giuseppe” di BartolomeoCavarozzi, diversa da quella in esa-me che, nello stesso documento,compare correttamente “in casaBalbi”. Proprio in quegli anni d’i-nizio secolo Costantino Balbi, chesi accingeva a percorrere l’iter del-le più importanti cariche pubbli-che13, stava sontuosamente ristrut-turando il palazzo “in contro lachiesa di San Geronimo” nella viaomonima (attuale civico 6), di cuidivenne proprietario nel 1704 almomento della morte del nonnoFrancesco Maria14. Il progressivotrasporto dei quadri acquistati daiSaluzzo va di pari passo, negli an-ni immediatamente successivi, conpagamenti a maestranze specializ-zate per una sontuosa sistemazionedella quadreria, dalla “fattura dicornici e parapetti” alla realizza-zione di “diverse cornici fatte per liquadri” fino alla loro indoratura15.Il posto riservato al dipinto di Ca-varozzi fu nel secondo salotto, do-ve compare, per la prima volta, nel-l’inventario dei “quadri diversi po-sti nel presente Palazzo che abito”commissionato il primo gennaio1724 a Rolando Marchelli e PaoloGerolamo Piola, “moderni pittori inGenova”: “n. 28: lire 2000 N[ost]raSig[no]ra col Bambino e S. Giu-seppe di Bart[olome]o da Viterbo,palmi 9 e 7”16. Quel documento fualla base dell’eredità lasciata, contestamento del 18 maggio 1739, alfiglio Giacomo, il quale andava ainaugurare nel giugno 1740, de-
funto Costantino, il proprio Libromastro riportando in apertura lostesso elenco di “quadri diversi”17.La ricca quadreria di Giacomo fuillustrata in entrambe le guide arti-stiche su Genova di Carlo Giusep-pe Ratti. In quei testi, pubblicatinel 1766 e nel 1780, il “quadro del-la Madonna col Bambino e s. Giu-seppe, di Bartolomeo Cavarozzi daViterbo” venne sempre ammiratonel secondo salotto di quel palaz-zo18. Un’utile indicazione per vi-sualizzare la “Sainte Famille de F.Barthelemi de Witerbe” nel conte-sto della quadreria giunge dall’a-nonima Description des beautés deGénes del 1768 (e successive edi-zioni) che l’annovera nel registrosuperiore di una parete del salotto(“au dessus”)19. Anche Luigi Lan-zi, nel suo Viaggio pel Genovesatodel 1793, segnalò in collezione Bal-bi il “quadro grande” di Bartolo-meo da Viterbo “dipinto con colo-rito sugoso”20. Ancora nel 1818 l’a-nonimo compilatore della guida pe-riegetica sulle bellezze artistiche ge-novesi annotava colà la tela, dive-nuta nel frattempo di proprietà, co-me l’immobile e l’intera quadreria,del figlio di Giacomo, Costantinojunior21. Nel 1823, in seguito allamorte di costui, le due figlie, Vio-lante e Tommasina, portarono alculmine l’opera di cessione del pa-trimonio artistico già intrapresa dalpadre22; a tale scopo contattaronoil pittore Santino Tagliafichi (1765-1829), che stimò le opere, redassetra il 26 marzo e il 3 aprile un in-ventario – nel quale la “Sacra Fa-miglia di Bartolomeo da Viterbo”venne valutata mille lire23 – e, neglianni immediatamente successivi, sioccupò dell’alienazione unitamen-te a Giacomo Filippo Raggi in qua-lità di amministratore dell’ereditàBalbi. Il “ricavo di diversi quadrivenduti” nel 1824 ammontava a2300 lire, mentre le vendite – chedal 1825 avvennero nello studio delTagliafichi dove erano stati tra-sportati i dipinti in seguito all’alie-nazione del palazzo a Marcello Du-razzo – continuarono copiose ben-ché frammentarie fino al 183224.L’elenco delle vendite aveva unoscopo esclusivamente contabile epertanto, tranne pochissimi casi,non vennero segnati né i nomi de-gli acquirenti né il soggetto delleopere alienate: la tela in esame do-vette comunque giungere a Torinofra il 1824 e il 1827, poiché nel lu-glio di quest’ultimo anno è docu-mentata la cessione della coppia didipinti di Marcantonio Franceschini
raffiguranti Rinaldo e Armida edErminia fra i pastori, attualmentein Pinacoteca dell’Accademia Al-bertina in virtù del legato Mossi diMorano25. Un inedito elenco26 re-stituisce, pur privo di data, i detta-gliati appunti sulla quadreria do-vuti molto probabilmente alla pen-na dello stesso Tagliafichi nel cor-so di una prima ricognizione. Il no-stro dipinto compare al numero 23con la seguente descrizione: “Bar-tolomeo da Viterbo. Sacra Famigliagrande al naturale, di gran forza, eben conservato (sarà piuttosto unbel lavoro del Cavedoni Bologne-se?); Maria Vergine ha il Bambinoin grembo, che guarda lo spettato-re, e S. Giuseppe sta in atto di com-piacenza. Figure intiere. Altezzapalmi 7 Larghezza palmi 5”. Ac-canto ad alcune opere, come i Fan-ciulli De Franchi di Van Dyck (Lon-dra, National Gallery) e il Cardina-le Bendinello Sauli di Sebastianodel Piombo (Washington, NationalGallery), tra le prime a essere alie-nate nel 1823, è segnata, con di-versa grafia, la scritta “venduto”:questo appunto non compare in re-lazione a nessuna delle opere ap-prodate nella quadreria Mossi. Lecircostanze rendono plausibile l’i-potesi che Vincenzo Maria Mossidi Morano (1752-1829), vescovo diVercelli e poi arcivescovo di Sida,avesse acquistato attraverso un me-diatore il lotto di opere Balbi per in-crementare con nuovi dipinti di al-tissima levatura il già nutrito lasci-to a “pubblico vantaggio” dell’Ac-cademia Abertina, ideato fin dal1825 e portato a compimento nel1828, un anno prima della morte27.Oltre alle due tele del Franceschi-ni28, sopra citate, e al dipinto di Ca-varozzi, vennero acquistate dalMossi presso la vendita Balbi la Sa-cra Famiglia di Giovanni BattistaPaggi29, la Maddalena di DomenicoPuligo30 e la Carità di FrancescoSalviati31.Residente negli ultimi anni di vitaa Torino in palazzo Peiretti di Con-dove32, dove aveva radunato lagrandiosa e antica collezione di fa-miglia traslata in parte dalla dimo-ra avita a Casale Monferrato33, l’ar-civescovo fece realizzare nel 1828,da un anonimo estensore, un det-tagliato inventario propedeutico al-la volontà munifica a favore della“istruzione dei giovani inclinati al-la bell’arte del disegno e della pit-tura”34. Nell’Indice e descrizione de’quadri costituenti la Pinacoteca dimonsignor Mossi di Morano, dona-ta alla R. Accademia di belle arti di
67Catalogo66 Catalogo
Torino, il dipinto in esame si ritro-va al numero 8 con la seguente de-scrizione e con una nuova attribu-zione: “Sacra Famiglia, composi-zione di tre figure intiere, di gran-dezza naturale, cioè la SS. Verginecol bambino tra le braccia, semi-coperto di un panno di lino, cosìben piegato che fa illusione, e S.Giuseppe che lo sta contemplandocon molto affetto. Bartolomeo Schi-done, scuolaro di Annibale Carraccie grande imitatore di Antonio Al-legri detto il Correggio”35. Con ilperfezionamento della donazione(1830), il dipinto, insieme a tutti glialtri che costituivano il legato, ven-ne ricoverato provvisoriamente aPalazzo Madama, mentre giunsenella sede attuale nel 183736.
Restauri e interventi antichiDurante il restauro, terminato nel1983 (Nicola Restauri)37, il dipintoè stato foderato e l’antico telaio, sulquale dovevano trovarsi certamen-te numerazioni inventariali, il mar-chio a fuoco con corona e il timbroin ceralacca della Reale AccademiaAlbertina, è stato sostituito. La pel-licola pittorica, che era opacizzata esollevata a scaglie lungo la fascia disinistra, è stata consolidata, pulita eintegrata nelle micro-lacune sparse.Nel corso dell’ultimo intervento(Barbara Rinetti)38 si è fondamen-talmente revisionata la vernice, at-tenuando l’effetto riflettente con unvelo di mat applicato a nebulizza-zione. Inoltre sono state reintegra-te le piccole lacune che si trovava-no lungo i bordi nella porzione ditela coperta dalla battuta della cor-nice moderna.L’osservazione particolareggiata del-l’opera, anche attraverso la rifletto-grafia e la radiografia (PanArt), hapermesso di individuare elementiche, comparati ad alcune note d’ar-chivio, gettano luce sugli interven-ti antichi. La radiografia ha rivela-to con nettezza, sul lato lungo di si-nistra, una giunta di larghezza irre-golare39, peraltro visibile a occhionudo sia per il differente andamen-to della craquelure, sia per la sceltadi una tela del tutto diversa da quel-la dell’originale, a tessitura moltoevidente, sia per l’impiego di un duc-tus pittorico abile ma differente daquello del viterbese. L’applicazionedi tale giunta può farsi risalire a unmomento ben preciso, individuabi-le nel pagamento da parte di Co-stantino Balbi, avvenuto nel 1710, diuna consistente cifra (2632 lire) al“Pittore Piola per lavoro fatto à tut-ti li quadri di casa”40. Evidentemente
per la distribuzione di tutti i dipin-ti che costituivano a quel momentola sua ambiziosa collezione, che con-stava dunque anche delle 39 tele Sa-luzzo, Costantino, dopo aver pro-gettato precise collocazioni nelle sa-le del piano nobile del suo palazzo,dove, come si è visto, erano al lavorointagliatori e indoratori, fece realiz-zare modifiche in funzione dell’o-mogeneo assetto a quadreria ri-spondente al nuovo gusto. PaoloGerolamo Piola (1666-1724), tito-lare della celebre bottega genoveseereditata dal padre Domenico, pra-ticava, secondo una specialità ap-presa dal celebre e poliedrico geni-tore, operazioni di ingrandimentodi opere41. L’intervento su tele inchiave di “restauro” e di riadatta-mento, che si prestava a libere in-terpretazioni per assecondare la vo-lontà della committenza, era un’ul-teriore attività svolta in “casa” Pio-la a riprova dell’espletamento di va-ri aspetti relativi alla confezione delprodotto artistico42. È possibile in-dividuare traccia del lavoro esegui-to per Costantino Balbi non solonella tela in esame ma anche, attra-verso gradevoli giunte su tavola, nel-la Carità di Francesco Salviati e nel-la Maddalena del Puligo, che, comesi è detto, approdarono anch’essein Albertina dalla collezione Balbi43.L’operazione era finalizzata all’in-grandimento della composizioneoriginaria, abilmente realizzato at-traverso la continuazione di fonda-li e panneggi: nel caso della tela diCavarozzi l’abile pennello piolesco,con un fare ampio, abbondante, dal-la stesura porcellanosa, si agganciaall’estremità della spalla di san Giu-seppe, offrendo alla massa corpo-rea del personaggio, che in origineterminava, come mostra la radio-grafia, con spalla e braccio destro in-terrotti circa a metà, una visionemolto più estesa. La parte superio-re della giunta continua lo sfondoscuro, mentre la zona inferiore ri-prende la vegetazione attraverso ildisomogeneo inserimento di unapianta dal fogliame carnoso. Il faredella prolunga pittorica possiedeinoltre una sigla nient’affatto voltaa simulare la tecnica pittorica del-l’originale ma rispondente a un co-dice linguistico proprio dei pittoripioleschi, indifferentemente appli-cato da Paolo Gerolamo o da qual-che suo diretto collaboratore, qua-li i fratelli Anton Maria e GiovanniBattista44.Il lato lungo destro e i due lati bre-vi rivelano invece un’interruzionedella tela originaria qualche milli-
metro prima della fine del perime-tro offerto dal telaio e l’innesto diuna modesta giunta che, trattata afondo scuro, gira immediatamenteattorno al telaio stesso. Entrambe lezone di tela destinate a rivestire lacosta del telaio lungo i due lati mag-giori presentano tracce di policro-mia scura antica. Tali indizi porta-no a considerare che la giunta pio-lesca doveva essere più estesa e chevenne in gran parte eliminata in unafase successiva, forse coincidentecon la rimozione del dipinto dal po-sto a cui venne destinato da Co-stantino Balbi nel secondo salottodel suo palazzo. Non è inverosimi-le che lo stesso Santino Tagliafichi,nel cui studio parte delle opere Bal-bi trovarono momentaneo ricovero,fosse l’artefice della nuova inqua-dratura riservata al dipinto ripor-tandolo, attraverso la dotazione diun telaio rettangolare (quello ri-mosso nel corso del restauro del1983), a dimensioni simili a quelleoriginarie e mantenendo nel con-tempo l’equilibrio compositivo ga-rantito da una porzione aggiuntivaal corpo di Giuseppe45. Tale ipote-si spiegherebbe, d’altronde, l’an-damento lievemente diagonale del-l’attuale giunta, sortita da una di-sposizione della tela al nuovo telaioappena inclinata. Ma l’indizio piùimportante a favore dell’ipotesi diuna radicale riduzione ottocente-sca dell’ingrandimento realizzatodalla bottega piolesca nel 1710, èl’esame di una copia del dipinto at-tualmente conservata nei depositidella Galleria di Palazzo Bianco aGenova e proveniente proprio da“casa” Piola46: la tela mostra, purnelle ridotte dimensioni, un peri-metro rettangolare movimentato dalievi curve che fanno assumere unassetto mistilineo assai in voga nel-la Genova d’inizio Settecento. Aquesto punto è ragionevole ritene-re che tale copia debba essere sta-ta realizzata nel corso del 1710, pro-prio al termine delle modifiche con-dotte sull’originale che si trovavanell’atelier piolesco. La tela orapresso la Galleria di Palazzo Bian-co è dunque una copia realizzata,per motivi di documentazione, distudio o di esercitazione, sul dipintocavarozziano per essere custoditain bottega con le stesse finalità concui erano stati, anni addietro, co-piati capolavori presenti nelle col-lezioni nobiliari genovesi a cui i Pio-la avevano il privilegio di accederee prestare servigio47. Tali finalità so-no dichiarate dalla permanenza del-l’opera in “casa” Piola, dove le ope-
Domenico Puligo, MariaMaddalena, Torino, Pinacotecadell’Accademia Albertina(proveniente dalla collezionedi Costantino Balbi e ingranditoai quattro lati da un pittoredi Casa Piola)
razioni di replica venivano condot-te anche per esigenze commercialio su richiesta diretta dei proprieta-ri48. Del resto che l’ingrandimentodovesse essere più esteso e interes-sare tutti i lati della tela originale ètestimoniato dalle misure in palmi(9 7)49 segnate nell’inventario del172450, equivalenti a circa 225 cmdi altezza e 175 cm di larghezza,mentre nell’elenco ottocentesco chesi ritiene realizzato da Tagliafichi51
i palmi indicati sono 7 e 5, ovveroall’incirca le misure attuali.
BibliografiaRatti 1766, p. 172 (B. Cavarozzi);Description… 1768, p. 56 [1769, p.56; 1773, p. 67; 1781, p. 66; 1788,p. 141; 1792, p. 141; 1796, p. 141];Ratti 1780, p. 196; Lanzi 1793 (ed.1984, p. 24); Descrizione… 1818(ed. 1969, p. 79); Nouvelle descrip-tion… 1819, p. 110; Longhi 1916,pp. 275, 311 (O. Gentileschi); Voss1920, p. 411; Porcella 1927, p. 1644(B. Cavarozzi); Bollea 1932, p. 306(B. Schedoni); Gabrielli 1933a, p.28 (O. Gentileschi); Gabrielli1933b, pp. 7, 10; Bollea 1936, p. 93;Longhi 1943, p. 31 (B. Cavarozzi);Milano 1951, p. 52, n. 83; Griseri1958, p. 87, nota 12; Pérez Sánchez1964, p. 48; Moir 1967, I, pp. 97,nota 98, 113, 118, 122, 124-126,199; II, p. 97; Faldi 1970, pp. 57,279; Marini 1979, p. 74, nota 25;Nicolson 1979, pp. 41-42; Spezza-ferro 1979, p. 27; Boccardo, Ma-gnani 1987, p. 86; Papi 1989, p.683; Coliva in Washington-Toron-to-Bologna 1990-1991, p. 28; Cot-tino in Torino 1990, s.n.; Nicolson1990, I, p. 96; Pesenti 1992, pp. 77-78; Barroero in Torino 1993, pp.56-57, s.n.; Tagliaferro 1995, p. 150nota 1; Papi 1996, p. 89; Bona Ca-stellotti in Torino 1997, p. 150; Ca-varozzi… 1997, p. 383; Migliorini1997-1999, p. 216; Papi 2001, pp.430, 438 nota 19; Papi 2002, p. 466;Acordon in Galleria Nazionale…2002, p. 141; Curie 2003, pp. 210,212; Papi 2003, p. 484; Sanguinetiin Maestri… 2005, pp. 8-13, n. 2.
ManoscrittiRistretto… s.d. [1735 circa] (ed.Migliorini 1997-1999, p. 216) (B.Cavarozzi); Progetto… s.d. (ed. Ta-gliaferro 1995, p. 150 nota 1); Car-tolare… 1724-1734, c. 9, n. 28; Li-bro mastro… 1740, c. 13, n. 28; Car-tolare… 1823-1831, c. 53; Indice edescrizione… 1828, n. 8 (B. Sche-doni); Indice e descrizione… post1830, ante 1831, n. 164/8; Indice edescrizione… ante 1833, p. 20, n.
164/8; Rapporto… 1833, n. 8 (L.Cambiaso); Nome degli Autori…1833, n. 8; Indice de quadri… ante1837, n. 8; Indice dei quadri… po-st 1837, n. 164; Descrizione… 1847,n. 164/8; Inventario… 1856, p. 387,n. 164; Elenchi e appunti… 1869, n.164; Galleria Mossi… 1869, n.164/107; Catalogo… 1869, n. 107;Elenchi e appunti… 1925, p. 28, n.123 (maniera del Caravaggio); Ope-re… 1925, p. 10, n. 123.
EsposizioniMilano 1951; Torino 1993.
Non è dato irrilevante la correttaassegnazione del dipinto a Cava-rozzi nell’inventario della venditaSaluzzo a favore di Costantino Bal-bi (1706). Quell’attribuzione per-mette di avvicinarsi il più possibilea fonti di prima mano, dato che,come si è detto, è assai probabileche il dipinto fosse giunto dalla Spa-gna intorno all’ultimo decennio delSeicento, forse per tramite di Fran-cesco de Mari52. È inoltre sintoma-tico che il vigore di tale paternità ri-manesse inalterato pochi decennidopo, visto che Marchelli e Piola,certamente a conoscenza dei lega-mi, diretti o indiretti, che Bartolo-meo ebbe con Genova, indicarononell’inventario Balbi del 1724 il no-me del viterbese, e lo stesso fecel’anonimo estensore del Ristretto didifferenti quadri e pitture a frescoesistenti in Genova, databile intor-no al 173553. Quest’ultimo, anzi –segnalando il dipinto in esame co-me degno di venire inciso unita-mente a una lista di altre opere deigrandi maestri del Cinque e Sei-cento presenti a Genova e appar-tenenti, nella maggior parte dei ca-si, a collezioni private – dava pro-va di considerare il pittore alla stre-gua di Guido Reni, Caravaggio,Guercino, Mattia Preti e altri an-cora. Invece il profilo artistico diCavarozzi sembrerebbe sfuggire aCarlo Giuseppe Ratti, il cui ap-proccio all’opera dell’artista nonpermise di dar sfoggio alla sua so-lita cultura, visto che, se da un la-to non pose in discussione l’attri-buzione suggerita dagli inventariBalbi, dall’altro non offrì nessunanotizia supplementare e non fu ingrado di riconoscere il linguaggiodel pittore in nessun’altra tela pre-sente a Genova54. È chiaro, giun-gendo all’Ottocento, che l’attribu-zione suggerita dai citati inventarivenga avvalorata con difficoltà sem-pre crescente: se Tagliafichi, che siritiene aver steso l’inventario rin-
venuto da Gianluca Zanelli55, misein dubbio momentaneamente la tra-dizionale attribuzione della SacraFamiglia Balbi a favore della scuo-la emiliana – “sarà piuttosto un bellavoro del Cavedoni Bolognese?”– l’estensore torinese dell’inventa-rio Mossi di Morano sancì, nel1828, il passaggio definitivo a taleambito con una paternità a favoredi Bartolomeo Schedoni. Del restola “nuova” attribuzione ottempe-rava a ragioni di estetica classi-cheggiante prevalenti nelle sceltecollezionistiche dell’arcivescovoMossi di Morano. L’ignoto compi-latore torinese non poteva comun-que possedere – poiché il recupe-ro critico della pittura seicentescatenebrista avrà inizio quasi un se-colo dopo – gli strumenti necessa-ri per collocare il brano realisticoche violentemente lo colpì – il drap-po di lino “così ben piegato che faillusione” – in area caravaggesca;pertanto, ingannato dal nitore del-le forme e dalla tematica, assai in-dagata anche da Schedoni, formulòil nome di un maestro allora piùnoto e apprezzato per l’inserimen-to nella corrente classicheggiantecarraccesca. I numerosi inventarisuccessivi mostrano una curiosaevoluzione attribuzionistica che,chiamando in causa addirittura Lu-ca Cambiaso, riflettono la tarda ri-valutazione critica della pittura ca-ravaggesca: solo la commissione del1925 giunse a collocare la tela nel-la maniera del Caravaggio, mentrefu per primo Porcella, nel 1927, ariproporre quasi in sordina il no-me del viterbese56. L’approccio conl’opera manifestato da RobertoLonghi fu progressivo, non imme-diato: ignorando le vicende relati-ve alla provenienza, il grande stu-dioso aveva in un primo tempo af-fidato “la grande e bella Sacra Fa-miglia” a Orazio Gentileschi57 – at-tribuzione condivisa da Voss nel1920 e da Noemi Gabrielli nel193358 – per giungere a formularein seguito la corretta attribuzione:“Del Cavarozzi, spesso operoso inGenova, a Madrid nel 1617 e tra-mite interessante a certi aspetti del-la civiltà pittorica di Spagna, so-prattutto allo Zurbaran, basterà quiripresentare la Sacra Famiglia del-l’Accademia Albertina a Torino che,in gioventù, ritenni, per qualchemese, opera del Gentileschi”59. Nel-la puntuale indagine longhiana erapotenzialmente contenuta la piùcorretta esegesi del dipinto, che di-verrà cardine del catalogo dellostraordinario pittore60. Nel 1951 l’o-
pera fu prescelta per rappresenta-re l’attività di Cavarozzi nel conte-sto espositivo dedicato al Caravag-gio e ai caravaggeschi, nella cuischeda di catalogo venne ricordatala travagliata vicenda critica nove-centesca e fornito un dato in realtàinesatto circa una presunta e pre-cedente esposizione alla grande mo-stra fiorentina del 1922 sulla pittu-ra italiana del Sei e Settecento61.Da uno spazio scuro, senza tempo,impercettibilmente inondato in al-to a destra da una flebile luce do-rata fautrice di spazialità, emergein primo piano, colpito dalla luci-da e potente fonte luminosa deri-vante da sinistra, il gruppo Vergine-Bambino. Con un effetto di coin-volgimento emozionale scaturitodall’osservazione diretta, penetran-te, depurata da ogni sbavatura fi-siognomica convenzionale, Maria,imitata da Gesù, guarda dinanzi asé l’osservatore, allo stesso modoin cui una modella in posa osservaimperscrutabile il suo pittore. L’ab-braccio feriale degli affetti materni,impreziosito dalla danza arabesca-ta del drappo bianco fra le dita ma-riane, si salda nella granitica sacra-lità meditativa di san Giuseppe, conil quale il fruitore condivide l’at-teggiamento contemplativo nei con-fronti del mistero. Sul terreno, sulquale si posano i lembi ripiegati del-le vesti abbondanti, spicca, fra ar-busti e piccoli sassi, il piede di Ma-ria, colpito dalla stessa luce che tra-sforma gli incarnati in volumi do-tati di una tridimensionalità quasitangibile al di fuori della tela.Proprio l’ispirazione tratta da unmodello classico – la raffaellescaMadonna della seggiola della Gal-leria Palatina di Firenze – combi-nata con un’attenzione al dato iper-realistico nell’indagine forbita deitessili colpiti dalla luce, giustifica-va un parallelismo con l’età matu-ra di Gentileschi62. In effetti l’inte-resse di Cavarozzi verso un cara-vaggismo caratterizzato da partico-lare raffinatezza cromatica e stra-biliante perfezione illusionistica simanifestò negli ultimi anni del se-condo decennio, sulla scia delle ela-borazioni cromaticamente elegantidi Gentileschi e Simon Vouet. Alperiodo più maturo, limitabile aglianni 1617-1620 e caratterizzato dauna maniacale, quasi fiamminga, re-stituzione tattile della forma, la cri-tica più recente ha assegnato l’o-pera dell’Albertina, “a metà stradafra il caravaggismo ancora esplici-to” del San Gerolamo (Firenze, Gal-leria Palatina; fig. 6), pagato nel
73Catalogo72 Catalogo
Casa Piola (Rollando Marchelli oAnton Maria Piola) da BartolomeoCavarozzi, Sacra Famiglia, Genova,Galleria di Palazzo Bianco, depositi
Particolare dell’angolo in bassoa sinistra in radiografia con l’innestodella giunta settecentesca
1617, e “le contaminazioni classi-ciste che assestano i panneggi e legestualità della Visitazione del1622” del Palazzo Comunale a Vi-terbo63 (fig. 12).Fra i vertici della poetica del pitto-re, la tela offre un’immagine sortaal tocco di un esasperato virtuosi-smo tecnico nella disposizione ac-corta dei panneggi, nella loro rea-listica e raffinatissima resa e nellaconduzione delle ombre che acca-rezzano visi e carni. La visione at-traverso la riflettografia e la radio-grafia (PanArt) ha offerto nuovi in-dizi sulla genesi dell’opera. Una se-rie di pentimenti mostra un’atten-ta attività strettamente connessa conla ricercata descrizione del natura-le e con l’adesione a un’idea di per-fezione compositiva ottenuta pro-gressivamente: il più significativoriguarda la disposizione originariadell’occhio sinistro della Vergine,lievemente più piccolo e realizzatocon una diversa inclinazione. Por-tato idealmente a compimento,avrebbe conferito una postura mag-giormente frontale all’intero voltomariano. Il fianco del Bambino,triangolo di incarnato fra la fine deldrappo e la mano della madre, erastato in un primo tempo coperto. Inriflettografia la postura del dito me-dio della mano sinistra della Ma-donna appare più arcuata, mentrein radiografia entrambe le manisembrano generalmente e imper-cettibilmente spostate. Anche laspalla di Maria mostra una lieve ri-duzione così come il piede, che pre-senta un leggero ridimensiona-mento delle dita. I panneggi, in par-ticolare quello che lambisce il pic-colo Gesù, sono caratterizzati dalievi variazioni di andamento risol-te direttamente in sede pittorica.Invece il manto di Maria che giacein basso a destra sul terreno è co-struito, come denuncia la radio-grafia, con un andamento di pie-ghe differenti dalla resa finale: lamiglior costruzione di ciò che si esa-mina al di sotto della pellicola pit-torica lascia ipotizzare una limitatae antica ridipintura di questa parte(forse piolesca?), del resto caratte-rizzata, come rivela la riflettografiaa falso colore, da un diffuso impo-verimento del pigmento utilizzato,probabilmente Oltremare naturale(lapislazzulo)64. La riflettografia ren-de maggiormente visibili dettaglidestinati a essere ricoperti da unatavolozza “tenebrosa”: in partico-lare la minuziosa presenza di arbu-sti che risaltano nettamente sul ter-reno e il magnifico viluppo di pie-
ghe, torte e ritorte in svariate anse,della manica mariana e del pan-neggio del manto. Queste parti per-dono visibilità a occhio nudo, siaper l’impoverimento del pigmento,già evidenziato, sia per una finalitàcostruttiva destinata a essere in-ghiottita dall’ombra caravaggesca. Icontorni, soprattutto le teste, maanche i panneggi, sono delimitatida una pennellata stesa per stabili-re i volumi, con la funzione sup-plementare di creare un’area di pro-tezione delle figure nel corso dellastesura scura dello sfondo. Il corri-spettivo a luce radente è una sortadi sottile cresta, visibile sui pan-neggi e, ad esempio, sulla linea checrea l’ingombro superiore del brac-cio del Bimbo in un primo mo-mento ritenuta una sottile incisio-ne65. Tale prassi sottende, come perOrazio Gentileschi, un’importanzariservata all’utilizzo del disegno. Lastesura del pigmento sul manto diGiuseppe mostra, oltre alla picco-la cresta nei contorni principali, unimpasto steso a pennello minutocon alcune zone dove si è predilet-ta un’applicazione più generosa del-la materia. Tale metodo, ottenutoper conferire raffinate vibrazioniottiche, è oltremodo utilizzato suldrappo bianco e sul manto blu: inquest’ultimo, soprattutto sulle an-se più ardite in prossimità dellespalle di Maria, si osserva un mi-nuto gioco di riflessi ottenuti im-pastando al lapislazzulo il pigmen-to bianco, lasciandolo in evidenzacon tutti gli esiti delle sfumaturenaturali. Stesso procedimento, macon l’addizione al bianco di un pig-mento scurente, per il lenzuolo cherifascia il Bimbo. Esiti di altissimatecnica pittorica mostrano gli in-carnati, ottenuti attraverso raffina-te velature di rosati e bianchi stesee tirate a tal punto da creare su-perfici di luce tersa e volumetrica.Vi sono dunque indizi, contenutinella storia dell’opera, che portanoa ritenere altamente probabile laprovenienza spagnola66. Nell’eco-nomia dei dati biografici disponibilisul pittore, ciò significa che la telapuò essere venuta alla luce proprioin Spagna, durante il soggiorno con-dotto da Cavarozzi al seguito diGiovanni Battista Crescenzi suc-cessivamente all’aprile 161767. Lalettura stilistica interviene, d’altraparte, a escludere che l’opera pos-sa essere stata realizzata al rientroromano, verificabile con certezza apartire dal 162168, quando, secon-do Mancini, il pittore fece “coseprivate, delle quali molte sono an-
date in Spagna”69. Si è infatti in pre-senza, rispetto agli esiti monumen-tali e alle stesure assai più campitepienamente riscontrabili nella Visi-tazione di Viterbo (fig. 12) e, aquanto sembra, nella pala per lachiesa romana di Sant’Anna dei Fu-nari (nota attraverso una fotogra-fia; fig. 10)70, di un ductus pittoricominuto, illusionistico, impastato diluce, ricco di tersi virtuosismi la-sciati in evidenza nella grafia delcolore, tutto teso alla restituzionedegli aggiornamenti caravaggeschiattraverso l’approccio diretto agliartifici illuminotecnici del Merisi e,soprattutto, del Gentileschi. Glistessi esiti, in sintesi, che si osser-vano nel San Gerolamo della Pala-tina (fig. 6), pagato al pittore daCosimo de’ Medici nel 161771, do-ve il protagonista, colpito da unaluce identica a quella che sbalza ivolumi e i panneggi dei protagoni-sti della Sacra Famiglia in esame,mostra oltretutto una straordinariaaffinità, sia nel tipo che nella suarealizzazione, con il nostro pensie-roso san Giuseppe. Con il San Ge-rolamo ancora negli occhi, Cava-rozzi, incline a riproporre ap-profondimenti di iconografie ecomposizioni già affrontate e dopoaver già eseguito almeno due ‘SacreFamiglie’ (cat. nn. 1-2), deve averposto mano dunque al dipinto nelcorso del soggiorno in Spagna, do-ve, secondo Baglione, “vi operòmolte cose”72. Risulta a questo pun-to probabile, agganciando crono-logicamente l’ipotesi al 1619 – an-no ricordato dalle fonti per il rien-tro temporaneo del Crescenzi – cheil capolavoro dell’Albertina si deb-ba situare in prossimità della con-clusione di quel soggiorno, quandoil pittore era tutto propenso a sco-prire gli esponenti di un classici-smo dichiarato, in primis Domeni-chino73. Tanto più che la lettura delmodus operandi, resa possibile dal-la campagna diagnostica sopra de-scritta, sembrerebbe offrire consi-derazioni aggiuntive in tal senso: glisvariati piccoli pentimenti ricon-ducibili al perfezionamento di unacomposizione nota, il volto idealiz-zato della Vergine, l’inserimento diun san Giuseppe indagato con unapennellata più aspra nella rugositàdi epidermidi e nella vaporosità dibarba e chiome, si offrono all’ipo-tesi di una maturità esecutiva del-l’opera rispetto alle altre ‘Sacre Fa-miglie’, pur ritenendo che la crea-zione della tela ora presso la Gal-leria Nazionale di Palazzo Spinola(cat. n. 2) dovette avvenire in uno
77Catalogo
“casa” Piola, non si può giungere ad indi-viduare l’autore della giunta, che operavasotto la diretta egida di Paolo Gerolamo.45 Tuttavia tale operazione non è docu-mentata nella registrazione dei compensi ri-servati al pittore, di cui è registrata notiziadelle seguenti attività: inventariazione del-le opere, trasporto parziale nel suo studioe pigione sulla vendita in qualità di me-diatore (Cartolare… 1823-1831, c. 54).46 Genova, Galleria di Palazzo Bianco (de-positi), inv. PB 1637, 130 114 cm (San-guineti 2004, I, pp. 103, 232). Il dipinto faparte del cospicuo lascito indirizzato nel1913 da Carlotta Ageno De Simoni, ultimaerede della famiglia Piola, alla municipalitàgenovese: Ibidem, I, pp. 219-236. 47 Sulle copie realizzate dai membri di ca-sa Piola da capolavori di Tiziano, Carrac-ci, Lanfranco e Van Dyck: Dugoni 1996,pp. 79-90; Sanguineti 2004, I, pp. 102-105(con bibliografia precedente).48 Cartolare… 1703-1714, c. 107. Proprionel caso della quadreria Balbi, è interes-sante la registrazione di ben 4098 lire elar-gite da Costantino al “Pittore Marchelliper rifatta di 4 quadri cioè uno di Vandi-ch istoriato, altro di Rubens, altro del Guer-cino simile, et una S.a M.a Mad.na del Gui-doreni”. Oltre alla cifra stabilita il nobi-luomo offrì a Rolando Marchelli, “tre qua-dri del Cambiaggio e due del Paggi in per-muta”.49 Il palmo genovese era unità di misura dicirca 25 cm.50 Cfr. nota 16.51 Cfr. nota 26.52 Cfr. Provenienza.53 Cartolare… 1724-1734, c. 9; Boccardo1987, p. 77; Migliorini 1997-1999, pp. 211-233.54 Ratti 1766, p. 172; Idem 1780, p. 196.Questo accadde, almeno, nei confronti del-la Sacra Famiglia di collezione privata espo-sta in mostra (scheda 4).55 Cfr. nota 26.56 Porcella 1927, p. 1644.57 Longhi 1916, p. 275.58 Voss 1920, p. 411; Gabrielli 1933a, p. 28.59 Longhi 1943, p. 31.60 Ibidem, pp. 53-54 nota 69.61 Milano 1951, p. 52, n. 83. Nella schedasi afferma che “l’opera è stata esposta co-me scuola del Caravaggio alla mostra del1922”: tuttavia nel catalogo (Firenze 1922)non vi è riscontro di tale presenza e, conl’attribuzione a scuola caravaggesca, è rin-tracciabile solo la Santa Caterina allora incollezione Barberini e attualmente a Madridin collezione Thyssen-Bornemisza con lapacifica attribuzione a Caravaggio in per-sona.62 Faldi 1970, p. 57; Barroero in Torino1993, p. 56.63 Papi 1996, p. 89.64 La mappatura dei ritocchi-ridipinture,realizzati probabilmente con Oltremarinoartificiale, non è realizzabile poiché in ri-flettografia a falso colore questo pigmentopossiede una risposta identica al Lapislaz-zulo (Oltremarino naturale).65 In radiografia non compare alcuna trac-cia riconducibile all’incisione che, qualorapresente, si deve presentare come una sot-tile riga bianca a causa della materia pitto-rica che colma il solco dello stilo.
66 Cfr. Provenienza.67 Cfr. Cronologia.68 Cfr. Cronologia. Il nostro dipinto è sta-to accostato cronologicamente alla Visita-zione di Viterbo da Bona Castellotti (in To-rino… 1997, p. 150).69 Mancini 1617-1620 (ed. 1956, I, p. 256).70 Papi 2001, pp. 428-429.71 Cfr. Cronologia.72 Baglione 1642, p. 187.73 Papi 2001, p. 435. Lo studioso però in-dicava una realizzazione già in Italia, forsein Liguria.74 Cfr. nota 46.75 Cfr. Restauri e interventi antichi.76 Cfr. nota 49.77 Ratti 1769, p. 50.78 Dugoni 1996, pp. 79-90; Sanguineti 2004,I, pp. 102-105.79 Genova, chiesa di Sant’Ambrogio (Il Ge-sù), sacrestia, olio su tela, 190 115 cm.Longhi 1943, p. 53 nota 69; Pérez Sánchez1964a, p. 48; Papi 2001, pp. 430; Curie2003, p. 211. Solo Pesenti (1992, p. 78) eAcordon (in Galleria Nazionale… 2002, p.141) avevano notato che il dipinto del Ge-sù discende dalla versione della Sacra Fa-miglia dell’Albertina.80 PARTHEN. SODALITATIS S.STAN. /COMMENTATIONIB. S.P. IGNAT. / DE.FUNDATO. CENSU. EXCOLENDAE /MODESTIAE. PIETATISQ. FUNDA-TORIS / MEM. PERP. / MDCCLXIX. L’i-scrizione può lasciar intendere la prove-nienza dell’opera dal complesso di Sant’I-gnazio, sede genovese del noviziato dei pa-dri Gesuiti. Si deve ricordare che il palaz-zo di Costantino Balbi si trovava di frontealla chiesa dei Santi Gerolamo e FrancescoSaverio e al collegio dei Gesuiti. 81 Pérez Sánchez 1964a, pp. 24, 48. Si trat-ta di un ovale su tavola (103 75 cm) diambito fiammingo, di una copia firmata daFrancisco Cortés de Bega custodita al Pi-lar di Zaragoza (Longhi 1943, p. 53) e dialtre tele ubicate in conventi a Cuzco.82 Pérez Sánchez 1964a, p. 48 (dimensioni64 57 cm).
76 Catalogo
stretto giro cronologico all’insegnadi identiche variazioni sul tema. L’e-vidente ricerca di perfezionamentodella composizione, espressa da al-cune correzioni in sede pittorica,concorre a questa ipotesi, unita-mente all’accentuata presenza neldipinto dell’Albertina di una pras-si pittorica di eccezionale e varie-gato tenore.
CopieDel dipinto Saluzzo Balbi Mossi diMorano esistono, allo stato attualedegli studi, due copie che dannoconto della presenza del dipinto aGenova a partire dall’inizio delXVIII secolo. Quella già citata, pro-veniente dalla quadreria di “casa”Piola e conservata presso la Galle-ria di Palazzo Bianco (inv. PB1637)74, fu realizzata verosimilmen-te intorno al 1710, quando PaoloGerolamo Piola ricevette l’incaricoda parte di Costantino Balbi di met-tere in opera un ingrandimento del-la tela originale75. Condotta da Rol-lando Marchelli, il cui ruolo di co-pista è documentato76, o da AntonMaria Piola, che secondo le fontiebbe “gran facilità nel copiare i qua-dri de’ più insigni Maestri”77, la co-pia, fedele pur nella riconoscibilitàdello stile piolesco, ottemperava al-lo stesso significato, all’insegna del-l’esercizio e della documentazione,espresso nella celebre e operosa bot-tega dall’esistenza di molte altre co-pie ricavate da dipinti celebri78.Una seconda copia, proveniente dauno dei conventi genovesi dell’or-dine dei padri Gesuiti ed erronea-mente ritenuta dalla critica deri-vante dal dipinto di proprietà delFondo Pensioni del Gruppo SanPaolo Imi (cat. n. 1), si trova nellasacrestia della chiesa del Gesù aGenova79. La tavolozza squillante,l’andamento sostenuto dei panni ela resa flessuosa delle mani denun-ciano una confezione settecentesca,come del resto dichiara la data con-tenuta nell’iscrizione posta in bas-so a sinistra (1769), dal caratterededicatorio80, e l’inclusione dell’in-grandimento piolesco. Alfonso E.Pérez Sánchez raccoglieva una se-rie di tele attorno al prototipo del-l’Albertina, definite “indudable-mente copias”81 e dovute a pennel-li fiamminghi e spagnoli. Non è sta-to possibile verificare l’originalitàdi una versione identica, annovera-ta da Alfonso E. Pérez Sánchez co-me replica autografa in collezioneScholz Forni di Amburgo82.Daniele Sanguineti
1 ASG, Notai di Genova. I sezione: notaioGio Stefano Frugone, 154, 6 maggio 1706.2 Boccardo, Magnani 1987, p. 86.3 Il documento è stato segnalato in Mi-gliorini, Assini 2000, p. 154 nota 101. Suc-cessivamente Piero Boccardo l’ha utilizza-to limitatamente ad alcune opere (Boccar-do 2002, pp. 227, 239 nota 32; Idem in Ge-nova 2003, p. 114). Recentemente Alfon-so Assini ha nuovamente preso in consi-derazione il documento estrapolando al-cune citazioni ma tralasciando quella rela-tiva al nostro dipinto (Assini 2004, p. 156).Un ulteriore inventario (ASG, Notai di Ge-nova. I sezione: notaio Gio Stefano Frugo-ne, 155, 26 dicembre 1715), offre inveceuna consistenza non aggiornata della qua-dreria Saluzzo, poiché fra gli oltre centodipinti si trovano opere già vendute a Bal-bi nove anni prima, fra le quali una “No-stra Signora il Bambino e san Giuseppe”,priva di attribuzione (segnalato in Miglio-rini, Assini 2000, p. 154 nota 101, con er-rata trascrizione dell’anno come 1714; siringrazia Roberto Santamaria per la verifi-ca). Sulle quadrerie dei Saluzzo sono incorso ulteriori ricerche da parte di M. Aus-serhofer.4 È di grande interesse visionare, attraver-so questo acquisto mirato di dipinti dallaquadreria Saluzzo, il gusto del Balbi, scar-samente orientato (almeno nel contesto diquesta operazione commerciale) verso i pit-tori genovesi (è presente solo un’opera diStrozzi), e quasi completamente rivolto al-la ritrattistica vandyckiana, ai capolavoridi Rubens e ai maestri veneti.5 Cartolare… 1703-1714, c. 107; Boccardo1987, p. 77. Si ringraziano Farida Simo-netti e Gianluca Zanelli per aver permes-so la verifica di questo e degli altri mano-scritti Balbi, custoditi nell’Archivio Spino-la presso la Galleria Nazionale di PalazzoSpinola di Pellicceria. Un ringraziamentoanche a Matteo Moretti per l’aiuto direttonella ricerca.6 Inspiegabilmente invece Maurizia Mi-gliorini sostiene che nell’inventario di Fran-cesco Maria Balbi del 1701 l’opera in realtàcompaia (Migliorini 1997-1999, p. 224 no-ta 49).7 Boccardo, Magnani 1987, pp. 54-64.8 Vergara 1995, pp. 34-39.9 Boccardo 2002, p. 227; Idem in c.d.s. L’in-ventario spagnolo del 1691 “trascura qua-si del tutto i nomi degli autori, rendendocosì molto difficile l’identificazione delleopere” (Idem 2002, p. 227).10 Burke, Cherry 1997, I, pp. 832, 842, 851.11 Boccardo 2002, pp. 225, 227. Per Fran-cesco de Mari: Bitossi 1990a, pp. 488-492.12 Ristretto… s.d. [1735 circa]; Progetto…s.d.. Cfr. rispettivamente Migliorini 1997-1999, p. 216; Tagliaferro 1995, p. 150 no-ta 1.13 Costantino Balbi, ambasciatore a Vien-na dal 1706 al 1710, diventerà doge dellaRepubblica di Genova nel biennio 1738-1739 (Gencarelli 1963, pp. 360-361).14 Boccardo, Magnani 1987, p. 64.15 Cartolare… 1703-1714, c. 107.16 Idem 1724-1734, c. 9; Boccardo 1987, p.77.17 Libro mastro… 1740, c. 13; Boccardo,Magnani 1987, p. 86.18 Ratti 1766, p. 172; Idem 1780, p. 196.
19 Description… 1768, p. 56.20 Lanzi 1793 (ed. 1984, p. 24).21 Descrizione… 1818 (ed. 1969, pp. 79,81).22 Boccardo, Magnani 1987, pp. 65, 88 no-ta 137.23 Cartolare… 1823-1831, c. 52; Boccardo1987, pp. 79, 84 nota 41.24 Cartolare… 1823-1831, c. 54; Boccardo1987, p. 79.25 Cfr. nota 29.26 ASpG, foglio sparso rinvenuto da Gian-luca Zanelli e in corso di pubblicazione daparte dello studioso.27 Gaglia 1982, pp. 125-136 (con biblio-grafia precedente); Sanguineti 2005, pp. 4-5.28 Torino, Pinacoteca dell’Accademia Al-bertina, inv. 193 e 194 (Boccardo, Magna-ni 1987, p. 87). 29 Torino, Pinacoteca dell’Accademia Al-bertina, inv. 109 (Ibidem, p. 87). La telacompare per la prima volta nell’inventariodi Francesco Maria Balbi del 1701.30 Torino, Pinacoteca dell’Accademia Al-bertina, inv. 148 (Ibidem, p. 86). Nell’in-ventario del 1723, realizzato da Marchellie Piola (cfr. nota 15), l’opera venne asse-gnata ad Andrea del Sarto.31 Torino, Pinacoteca dell’Accademia Al-bertina, inv. 192 (Ibidem, p. 86). Nell’in-ventario del 1723, realizzato da Marchellie Piola (cfr. nota 15), l’opera venne asse-gnata a Perin del Vaga. L’opera era stata ac-quistata da Costantino Balbi nel 1706 daiSaluzzo (“64. Carità di Perino, con tre Put-ti lire 1000”). Cfr. nota 1.32 Mossetti 1993, p. 327 nota 1; Eadem1995, pp. 111-121.33 Perin 1999, pp. 118-121.34 Bollea 1932, p. 324.35 Ibidem, p. 306.36 Gaglia 1982, pp. 125-136.37 1983, Nicola Restauri, Aramengo (dire-zione di G. Galante Garrone con l’utiliz-zo di fondi ministeriali e perizia tecnica diA. Bottino del 6 settembre 1979).38 2005, Barbara Rinetti, Torino, con inda-gini diagnostiche di Teobaldo Pasquali del-la PanArt s.a.s, Firenze (direzione di D.Sanguineti con l’utilizzo di fondi ministe-riali e perizia tecnica di A. Bottino del 29dicembre 2003).39 La larghezza della giunta è di 14,5 cm inbasso e sale a scalare divenendo di 12,5 cmin alto.40 Cartolare… 1703-1714, c. 107. Oltre al-la cifra indicata vennero registrate lire 3“per porto e riporto di due quadri dal Pit-tore Piola”. Si trattava evidentemente dinuovi acquisti, visto che nel biennio 1709-1710, approdarono in collezione quattrotele di Luca Giordano, due di Marcanto-nio Franceschini e due del Grechetto, al-cune delle quali potevano aver bisogno diqualche modifica o ritocco che la perizia diPiola poteva assicurare.41 Per i due pittori: Toncini Cabella 2002;Sanguineti 2004.42 Ibidem, I, pp. 105-106 (con una antolo-gia di lavori di questo tipo realizzati da Do-menico e Paolo Gerolamo Piola).43 Cfr. note 30 e 31.44 In questa limitata porzione, in assenza dibrani più estesi dove è solitamente possibilediscernere le diverse mani dei membri di
Bartolomeo Cavarozzi (copia da),Sacra Famiglia, Genova, chiesa diSant’Ambrogio (Il Gesù), sacrestia
Particolare del manto della Verginein radiografia
79Catalogo78 Catalogo
4.Bartolomeo Cavarozzi(Viterbo 1587 – Roma 1625)
Sacra Famiglia consan GiovanninoOlio su tela, 195 140 cmCollezione privata
ProvenienzaNel 1780 Carlo Giuseppe Ratti ri-servò una dettagliata elencazionealla notevole quadreria custodita inPalazzo Spinola in Strada Nuova aGenova (attuale via Garibaldi, ci-vico 5): in quell’occasione andò acircostanziare la generica segnala-zione di “quadri preziosi”, conte-nuta nella prima versione della gui-da dedicata alle bellezze artistichedella città nel 17661. Il palazzo ap-parteneva a un ramo degli Spinoladi Luccoli, conti di Tassarolo: neidue testi rattiani venivano indicatiin qualità di proprietari del palaz-zo, in ordine cronologico, ora Ma-ria Margharita de Carion de NisasSpinola ora Ferdinando. Margha-rita e Ferdinando erano fratelli, fi-gli di Agostino Spinola (1738-1816)ed Enrichetta de Carion de Nisas2:evidentemente il matrimonio diMargharita con Antonio Pallavici-no (1774?) segnò la cessione del pa-lazzo a favore del fratello minoreFerdinando. Dal 1780 si apprendedunque che nel primo salotto cam-peggiava “un quadro grande rap-presentante N.S. col Bambino, S.Giuseppe, e S. Giovambattista, diGuido Reni”3. L’opera compare al-l’interno della letteratura periege-tica ottocentesca nella stessa collo-cazione e con immutata attribuzio-ne4. In particolare Federigo Alize-ri, che ebbe accesso al palazzo di-venuto nel frattempo proprietà deimarchesi Vincenzo, Anton Maria eFrancesco Spinola, figli di Ferdi-nando († 1826), riservò al dipintoun giudizio entusiastico: “una telabellissima, ove son figurati in san-ta conversazione N.D. col putto eil Battista e S. Giuseppe, spetta al-la prima epoca di Guido Reni,quando dalla forza de’ Carracci ten-tava un passaggio a quella genti-lezza che distingue lo stile della se-conda età”5. Alla “premiere ma-nière” del Reni lo assegnava inve-ce l’anonimo compilatore della se-rie di guide sulla città redatte infrancese6. Tre schede fotograficheconservate presso il Centro di Do-cumentazione per la Storia, l’Arte,l’Immagine di Genova si sono ri-velate fondamentali per l’identifi-cazione del dipinto in esame. La
scheda 2913, sulla quale è applica-ta una foto Brogi che documentaun dipinto raffigurante una SacraFamiglia calata in un contesto pae-saggistico e affiancata da san Gio-vannino, recita nell’intestazione:“Cavarozzi Bartolomeo, La SacraFamiglia con S. Giovannino, Ge-nova, proprietà privata (Spinola)”.Tale indicazione non sarebbe stataprobante se, sul retro del supportocartaceo, Mario Bonzi, che avevaarricchito con attribuzioni e com-menti il materiale artistico dell’Ar-chivio Fotografico comunale7, nonavesse scritto la seguente, preziosa,nota autografa: “Genova, proprietàprivata (Spinola). Cavarozzi Barto-lomeo, La Sacra Famiglia con S.Giovannino. Dipinto ad olio su te-la. Già attribuito a Guido Reni! egià esposto a Palazzo Bianco. FotoBrogi (n. 11503). M.B.”. Questascheda dunque supportava la ri-stampa da un negativo Brogi del di-pinto, di cui è visibile una limita-tissima porzione di cornice, mentreun’altra scheda, precedente per cro-nologia (n. 2410), offriva gli stessicontenuti dattiloscritti sempre dalBonzi, con la sola eccezione del-l’aggiunta di un segno di interro-gazione accanto al nome di Cava-rozzi e di un nuovo dato relativoall’ubicazione: “Genova, Piazza Pel-licceria, Galleria Spinola”. Una ter-za scheda (n. 2914), priva di com-menti sul retro (se non un rimando,scritto con grafia diversa da quellariconoscibile di Bonzi, al n. 2410),ospita un diverso scatto fotografi-co – di cui non è segnata la pater-nità – che ritrae, apparentemente,lo stesso dipinto racchiuso in unaricca cornice in legno intagliato edorato. Quest’ultima pare diversada quella, visibile limitatamente alprofilo interno, di cui era dotato ildipinto fotografato nelle schede2410 e 2913; inoltre questa tela mo-stra una considerevole riduzione asinistra, in prossimità dell’apertu-ra paesaggistica e dei panneggi del-la veste di san Giovannino. Non èfacile stabilire se si tratti dello stes-so dipinto o di due tele distinte acausa del medium fotografico or-mai invecchiato e dei diversi tempidi posa utilizzati per le due ripreseche non permettono di valutare, neidifferenti effetti del contrasto lu-ministico, possibili variazioni di det-taglio. Sembrerebbe far propende-re per la prima ipotesi l’evidentepresenza nella foto Brogi (nn. 2410e 2913) di una giunta, caratterizza-ta da un’accentuata craquelure resaben visibile dai riflessi e del tutto
corrispondente alla porzione cheparrebbe essere stata eliminata inseguito (con la necessità di dotareil quadro di una nuova diversa cor-nice), come testimonierebbe la se-conda foto disponibile. Non è da-to sapere se la tela, unitamente al-la quadreria, rimase nel palazzo fi-no al 1919, allorquando gli erediSpinola, Bendinelli Spinola di Fer-dinando e Francesco Spinola diBendinelli, signori di Arquata, alie-narono l’edificio al Credit Com-mercial de France8. Tuttavia, il tran-sito dell’opera, sotto forma di de-posito temporaneo, a Palazzo Bian-co deve situarsi entro il 1909, al-lorquando venne ritirata dalla gal-leria civica ove risultava segnalatanel Catalogo delle opere d’Arte espo-ste per sale databile al 18939. Nel1916 Roberto Longhi, con un’at-tribuzione a Orazio Gentileschi,pubblicò la tela di “casa Spinola”,che “era esposta fino a qualche an-no fa a Palazzo Bianco col nomedel Reni”10. Non sappiamo se il di-pinto, a pochi anni dalla venditadel palazzo di via Garibaldi (1919),fosse ritornato laddove lo videroRatti e Alizeri o fosse stato già mo-vimentato. Fu nuovamente Longhi,quando nel 1943 offrì il primo fon-damentale repertorio dei caravag-geschi, a ricordare, nella lungimi-rante nota monografica dedicata aBartolomeo Cavarozzi, la “SacraFamiglia e San Giovannino in unpaesaggio, già attribuita al Genti-leschi in casa Pallavicini a Geno-va”11. Si crede di poter tranquilla-mente giustificare l’indicazione diuna diversa collocazione privata conun errore dello studioso, come di-mostrano gli appunti di Bonzi a fa-vore della proprietà Spinola, stesisulle schede fotografiche esamina-te in un periodo successivo al194312. Anzi, quegli appunti infor-mano di una permanenza presso ilpalazzo Spinola di Pellicceria: ciòdovette avvenire entro il maggio del1958, poiché la tela cavarozziana, dicui si persero le tracce13, non figu-ra nell’atto di donazione realizzatodai marchesi Franco e Paolo Spi-nola, eredi senza discendenti degliSpinola di Luccoli, allo Stato Ita-liano del palazzo in piazza Pellic-ceria e delle opere ivi contenute14.Si ritiene, con un buon margine diprobabilità, di riconoscere la telaSpinola in quella di collezione pri-vata qui esposta in mostra: infatti,considerando l’eliminazione dellagiunta, la conformità con il dipin-to documentato dalla foto Brogi incollezione Spinola è tale da coinci-
dere con l’identità. Inoltre la splen-dida cornice, a fogliame aggettan-te, che racchiude il dipinto in mo-stra è la stessa visibile nella foto del-la citata scheda 2914. La ripropo-sta da parte di Gianni Papi dellafoto storica, già utilizzata da Lon-ghi, per documentare il dipinto, ri-tenuto in ubicazione sconosciuta,nel contesto dei “rapporti di Bar-tolomeo con la Superba”15, andavaa sovrapporsi con l’inattesa com-parsa dell’opera, dopo più di ses-sant’anni, in uno spazio pubblici-tario sul numero di gennaio 2000del “Burlington Magazine”. PierreCurie con prontezza segnalava ilfatto in un contributo dedicato al-la diffusione in Francia e in Spagnadi composizioni cavarozziane16.
BibliografiaRatti 1780, p. 274 (G. Reni); De-scrizione… 1818 (ed. 1969, p. 155);Nouvelle description… 1819, p. 160;Nouvelle description… 1826, p. 148;Nouveau guide… 1830, p. 157; Gui-da… 1837, p. 67; Nouveau guide…1842, pp. 300-301; Piccola guida…1846, p. 93; Alizeri 1847, II, parte1, p. 455; Alizeri 1875, p. 198; Lon-ghi 1916, p. 274 (O. Gentileschi);Longhi 1943, p. 54 nota 69 (B. Ca-varozzi); Pérez Sánchez 1964, p. 23;Pérez Sánchez 1965, pp. 57, 253;Papi 2001, pp. 430-431, 433, 435;Acordon in Galleria Nazionale…2002, p. 141; Curie 2003, p. 210.
Si inserisce nel consueto contestoemiliano, contenitore davvero ca-piente per i conoscitori e gli erudi-ti settecenteschi (e non solo geno-vesi), l’attribuzione della tela a Gui-do Reni formulata da Carlo Giu-seppe Ratti17. Costui, che poteva di-sporre quantomeno di un testo cer-to del Cavarozzi – ovvero la SacraFamiglia della collezione Balbi (cat.n. 3) correttamente attribuita nellesue due guide – non fu in grado didecodificare nell’opera veduta pres-so la quadreria Spinola l’evoluzio-ne dello stesso linguaggio cavaroz-ziano in chiave classicista (ma pursempre barocca!). Eppure la resadei panneggi, con quei tecnicismi eimpasti peculiari per ottenere ma-gici riflessi, e l’impostazione dei vol-ti, soprattutto quello bellissimo emagnetico della Vergine, conserva-no le impronte salienti del dipintogià in collezione Saluzzo (cat. n. 3),realizzato da Bartolomeo qualcheanno prima rispetto a quello quiesaminato. Anche Alizeri18, ingan-nato dall’inedita ambientazionepaesaggistica, dalla tavolozza cal-
83Catalogo
da, dominata dagli incarnati plasti-ci e dal biondo soffuso di GesùBambino, dall’intreccio pacato estudiatissimo dei gesti e degli sguar-di, giustificava una decisa assegna-zione a un Reni ancora suggestio-nato dal classico nitore di volume-trie sulla scia dei Carracci. Dovevaessere lo spiccato raffaellismo chealeggia innegabilmente nella sceltad’ambientazione e che governa lamise en pose dei protagonisti a farescludere, alla mente accademica-mente impostata di un conoscitoreottocentesco, che potesse trattarsidel più abile mediatore allora in cir-colazione di un impeccabile equili-brio fra classicismo e naturalismo distampo caravaggesco. Nella tela silegge chiaramente che il cambio digusto operato dal pittore rispettoalla tarda maniera professata nelcorso del primo decennio del Sei-cento non fu tale da fargli negare ildisegno e da vietargli l’osservazio-ne dei classici del Rinascimento fil-trata attraverso i contemporaneiDomenichino e Reni. Del resto lostesso Longhi, cui va il merito del-la riscoperta novecentesca dell’o-pera19, l’aveva assegnata, nella tap-pa intermedia verso la corretta in-dividuazione della mano cavaroz-ziana, a Gentileschi, che, per quan-to ben radicato al naturalismo –“sceglie con gran cura Orazio la na-tura”20 – non abbandonò, come fe-ce Caravaggio, la tornitura offertain prima battuta dal mezzo grafi-co, compiacendosi poi nel riempi-re le anse dei panneggi di colorisontuosi e sofisticati intrisi di luce.“Ai ricchi genovesi dovevano pia-cere assai queste contaminazioni diCaravaggio e di Bologna”, portatea buon esito proprio nella Sacra Fa-miglia in esame, dove Longhi, sot-to il travestimento reniano, ebbemotivo di ravvisare inizialmenteOrazio21 e solo in seguito, giusta-mente, Cavarozzi22, attratto dagliesiti artistici gentileschiani. Di re-cente Gianni Papi, nel tracciare ilprofilo dell’artista maturo, non so-lo confermava la paternità cava-rozziana dell’opera, nota attraversola fotografia Brogi pubblicata daLonghi, ma annoverava la tela fra gliindizi più probanti per una map-patura dei “rapporti di Bartolomeocon la Superba”23. Dal centro si irradia lo sguardo fis-so, dal fascino penetrante, di Maria,che sorregge in grembo uno scal-pitante Bambino; l’asimmetria com-positiva è ottenuta dalla diagonaletracciata dalla disposizione delle fi-gure e dall’interruzione della cate-
na dei gesti fra Madonna, Gesù esan Giovannino, in prossimità del-le rispondenze degli sguardi, poichéresta disatteso il rivolgersi di Giu-seppe, introdotto a destra di profi-lo, alla sua sposa, attratta da unapresenza posta dinanzi a sé. Il pae-saggio, in parte frondoso, in parteaperto su un brano di cielo su cuisi stagliano con nettezza il profilo diun edificio turrito e un albero spo-glio, è pervaso da una atmosferacromatica soffusa, che accentua ilcarattere di immobilità “senza tem-po” provocato dalla lenta gestua-lità dei personaggi. Un tema me-diato dunque da uno schema neo-cinquecentesco, praticato attraver-so tutta la maestria di un linguag-gio ormai personale pur nella ser-rata attenzione al panorama artisti-co contemporaneo: basterà solo os-servare la vicinanza della figura se-riosa di Giuseppe, con dita ossutee profilo allungato, ai vegliardi re-niani protagonisti della spettacola-re Madonna con Gesù Bambino e isanti Antonio abate e Paolo eremi-ta, già nella collezione di VincenzoGiustiniani24, oppure, come ha acu-tamente osservato Papi, la “conta-minazione di tipologie fiamminghee rubensiane” evidenti nella fattu-ra di Gesù, dalla “platinata bion-dezza”25. Lo studioso inoltre pone-va in risalto la “tenera, sentimenta-le articolazione dei gesti” rispetto al-la “ipnotica fissità” delle altre SacreFamiglie (cat. nn. 1-3), di cui restaqui solo l’immobilismo riflessivodel volto mariano. Rispetto alle al-tre opere esposte in mostra, è dun-que possibile per la tela in esameproporre, in virtù di complicanzestilistiche che vanno ad addizionarsia quelle già preesistenti, una data-zione posticipata. Certificano un’i-potesi cronologica più avanzata daun lato le suggestioni provocate daRubens e da Reni, le cui opere fu-rono visionate in Spagna oppurenel corso dell’ipotetico transito ge-novese, dall’altro le serrate tangen-ze, nella scrittura resa più magni-loquente e volumetrica, con la pa-la che il pittore realizzerà al pro-prio rientro romano per la chiesa diSant’Anna dei Funari, nota solo at-traverso una fotografia rinvenutada Papi26. A proposito di sugge-stioni respirate a Genova, parreb-bero sfiorare la citazione, per il Bim-bo e il san Giuseppe della tela inesame, il putto collocato in primopiano a sinistra nella Circoncisionedi Rubens e l’apostolo barbuto diprofilo posto a destra nell’Assun-zione del Reni, entrambi ancora fre-
82 Catalogo
Foto storica dalla scheda 2913conservata presso il Centro diDocumentazione per la Storia,l’Arte, l’Immagine di Genova
84 Catalogo
schi di vernice nella chiesa del Ge-sù. Poiché nella nostra è già pre-sente il “tocco gagliardo”27 – neitermini anche di una pastosa e po-rosa stesura cromatica – con cui ap-prontò la Madonna con Gesù Bam-bino e sant’Anna (fig. 12), attual-mente in ubicazione sconosciuta,sarà possibile ancorarsi all’indiret-to termine cronologico ricordatoper quest’ultima dalle fonti – ovve-ro successivamente al rientro dallaSpagna28 – per formulare una da-tazione che, in virtù dell’impalca-tura di dati disponibili, può fissar-si intorno al 1620. Se per il dipin-to già di proprietà Spinola potreb-be ipotizzarsi un acquisto spagno-lo sulle rotte del collezionismo (eciò spiegherebbe l’esistenza dellacopia in collezione Gil a Barcello-na), nulla vieta, all’interno di quel-lo che è stato definito un vero eproprio “rompicapo per gli studiosiche dell’attività del viterbese in-tendano occuparsi”29, di immagi-nare Cavarozzi transitare per Ge-nova, visionare i capolavori di Ru-bens e Guido Reni colà presenti,rientrare a Roma e realizzare il su-perbo dipinto. Che poi l’innegabi-le sentore di questa composizionesi trovi in svariate opere realizzatea Genova dal giovane Giovanni An-drea De Ferrari30 significa certa-mente un approdo precocissimo nelcentro ligure, sia per ragioni di di-retta commissione al pittore, sia perun acquisto indiretto. In ogni caso,escludendo una serrata vicinanzacronologica fra la Sacra Famigliadell’Albertina (cat. n. 3) e la nostratela, è possibile anche ipotizzareuna confezione romana finalizzataall’esportazione in Spagna – dal mo-mento che il pittore può aver tran-quillamente dipinto in patria lavo-ri destinati a Madrid – e un suc-cessivo, ma quasi immediato, ap-prodo genovese per quella via.
CopieCon l’attribuzione a Cavarozzi,Alfonso E. Pérez Sánchez presen-tava nel 1964 e nel 1965 una SacraFamiglia con san Giovannino, pro-veniente dalla collezione Gil di Bar-cellona31, ponendola in rapportocon il dipinto segnalato da Longhia Genova. Proprio gli elementi chemetteva in risalto lo studioso, ov-vero l’illuminazione piuttosto tersae diffusa – “que no es tan cerrada-mente tenebrsita” – e “los recuer-dos clasicistas, rafaelescos”, sonotalmente accentuati da non con-sentire di scorgere nell’opera la di-retta mano di Cavarozzi, ma quel-
la di un valido copista, forse un al-lievo o un seguace spagnolo32. Nel-l’opera sono notevoli i dettagli va-riati, oltre a essere nettamente me-no vigorosi i brani anatomici e pe-dissequamente calligrafici i pan-neggi. Si concorda dunque conquanto già evidenziato, a proposi-to dell’opera in collezione spagno-la, da Gianni Papi, per il quale la te-la “paragonata al quadro genovesemostra piuttosto i caratteri di unabuona copia”33.Daniele Sanguineti
1 Ratti 1766, pp. 242-243; Idem 1780, p.274.2 Battilana 1826, II, tav. 115 (Spinola diLuccoli).3 Ratti 1780, p. 274.4 Cfr. Bibliografia.5 Alizeri 1847, II, parte 1, p. 455. Stesso giu-dizio, ma in forma più succinta, l’eruditoespresse nel 1875: “del Reni la Santa Con-versazione che tanto ritiene del vigore ca-raccesco” (Alizeri 1875, p. 198).6 Nouveau guide… 1842, pp. 300-301.7 Papone 2004, p. 132. L’apporto di Bon-zi, che ordinò tutto il materiale di argo-mento artistico fino ad allora presente, do-vrebbe collocarsi fra gli anni cinquanta esessanta del Novecento.8 La notizia è fornita da Poleggi, unita-mente alla segnalazione dell’atto di vendi-ta rogato dal notaio Federico Arata il 15aprile 1919 (Poleggi 1972, p. 189). Dal1926 l’edificio divenne proprietà della Ban-ca d’America e d’Italia.9 La sensazione iniziale che l’esposizione aPalazzo Bianco altro non fosse che la com-parsa dell’opera all’eclettica e grandiosamostra del 1892 è stata smentita dall’as-senza di un dipinto con quel soggetto econ l’attribuzione al Reni dal relativo ca-talogo (Genova 1892). L’opera, come “Sa-cra Famiglia di Guido Reni” e con la pro-prietà agli eredi del marchese FrancescoSpinola, compare in Galleria (civica)…[1893], p. 4. Nell’esemplare del volumeconservato presso la Biblioteca di Storiadell’Arte del Comune di Genova è segna-to a matita il giorno del ritiro da parte del-la proprietà (9 marzo 1909). Peraltro tra il1909 e il 1910 gli eredi Spinola ritiraronodalla galleria civica circa trenta dipinti de-positati, tutti rintracciabili nella descrizio-ne della quadreria di Ratti e Alizeri.10 Longhi 1916, p. 274, fig. 20.11 Idem 1943, p. 54 nota 69.12 Labò, profondo conoscitore soprattuttodell’arte genovese, dovette certamente di-sporre del testo longhiano per giungere al-la corretta attribuzione del dipinto a Ca-varozzi.13 Nell’Archivio Spinola custodito presso laGalleria Nazionale di Palazzo Spinola diPellicceria non vi è traccia del transito deldipinto. Si ringraziano Farida Simonetti eGianluca Zanelli per aver permesso la con-sultazione e Matteo Moretti per l’aiuto nel-la ricerca.14 Rotondi 1960.15 Papi 2001, p. 430, fig. 3.16 Curie 2003, p. 210 e nota 19.
17 Ratti 1780, p. 274.18 Alizeri 1847, II, parte 1, p. 455.19 Longhi 1916, p. 274.20 Ibidem, p. 252.21 Ibidem, p. 274.22 Idem 1943, p. 54 nota 69.23 Papi 2001, p. 430.24 Danesi Squarzina 2001, p. 34.25 Papi 2001, p. 431.26 Ibidem, pp. 428-429.27 Baglione 1642, p. 18728 Ibidem, p. 187.29 Papi 2001, p. 432.30 Cfr. il saggio in apertura di questo cata-logo.31 Barcellona, collezione Gil, olio su tela,195 140 cm (depositata per molti annipresso il Museo di Barcellona). Pérez Sán-chez 1964a, pp. 23, 47 nota 21; Idem 1965,pp. 57, 253 (con bibliografia precedente). 32 Cfr. il saggio in apertura di questo cata-logo.33 Papi 2001, p. 431.
Foto storica dalla scheda 2914conservata presso il Centro diDocumentazione per la Storia,l’Arte, l’Immagine di Genova
Bartolomeo Cavarozzi (copia da),Sacra Famiglia con san Giovannino,Barcellona, collezione Gil
87
Cronologiaa cura di Daniele Sanguineti
1587Nasce a Viterbo il 15 febbraio (An-geli 2000, p. 20). Solitamente la na-scita veniva fissata tra il 1588 e il1590, poiché nel 1617-1620 GiulioMancini (ed. 1956, I, p. 256) lo de-finiva “d’età di 30 anni incirca”.
1600-1605In mancanza di documenti, sonoverosimilmente collocabili in talelustro il trasferimento del pittore,“fanciulletto”, a Roma – che “persua buona sorte fu raccolto da Tar-quinio Ligustri, pittor viterbese”(Mancini 1617-1620; ed. 1956, I, p.256) – e l’inizio della frequentazio-ne di casa Crescenzi (Baglione 1642,p. 286 [ma 186]).
1608Realizza la Sant’Orsola e le sue com-pagne (Roma, chiesa di San Mar-co), datata nell’iscrizione relativaalla committenza, per l’altare mag-giore della distrutta chiesa diSant’Orsola in piazza del Popolo(Toesca 1960, pp. 57-59).
1609Il 14 aprile vengono consegnati 10scudi “a m. Bartholomeo da ViterboPittore in casa delli S.ri Crescentii abuon conto delli desegni che fa perla vita del Beato padre in figure”(Parma Armani 1978-1979, pp. 141-142). Si è ipotizzato che il pagamen-to si riferisca al corpus di cinquantadisegni circa della Vita di san Filip-po Neri (Roma, Biblioteca Vallicel-liana, cod. O 23), ma l’attribuzioneè dibattuta (Melasecchi 1995, p. 46).
1610, postIn un momento successivo al primonovembre, data della canonizza-zione di san Carlo, può datarsi l’e-secuzione della perduta pala d’al-tare “entrovi san Carlo orante” (Ba-glione 1642, p. 286) per la cappel-la Crescenzi, edificata nel corso delsecondo lustro del primo decennio(Hibbard 1971, p. 148; Grilli 2003,pp. 139, 184 nota 243) in Sant’An-drea della Valle.
1615In una lettera datata 11 marzo, Juan
de Tassis y Peralta, conte di Villa-mediana, richiedeva a Cosimo IIde’ Medici il permesso di esporta-re alcuni dipinti da Siena in Spagna,fra i quali è elencata una tela raffi-gurante “due putti, che uno suonaun flauto, et l’altro ha posato unviolino”. Si tratta di una delle ver-sioni del Lamento di Aminta (Fu-magalli 1996, pp. 143-150).
1616“Un quadro di S. Stefano, che di-sputa con li Rabì” compare nell’in-ventario della Guardaroba di Gio-vanni Battista Mattei. L’autore è in-dicato in “quel giovane, che sta colCrescenzij” (Cappelletti, Testa1994, p. 174, n. 23). Il dipinto èstato identificato con la Disputa disanto Stefano di collezione privata(Cappelletti, Testa 1994, pp. 107-108, n. 10; Papi 1996, p. 87). Nel-lo stesso inventario compare, privodi paternità, un quadro raffiguran-te “Nostro Signore [che] entròtrionfante in Gierusalemme” (Cap-pelletti, Testa 1994, p. 174, n. 34)al di sopra della porta della secon-da camera. Nell’inventario del 1624la Disputa e il “Cristo in trionfo inJerusalem” vengono definiti “di ma-no del Meuccio” (Cappelletti, Te-sta 1994, pp. 182, 184, nn. 38, 75),diminutivo dunque di Bartolomeo.Inoltre nella stima dei quadri diAlessandro Mattei, databile ante-riormente al 1729, il “Trionfo del-le palme” è ricordato come di “…da Viterbo” (Cappelletti, Testa1994, p. 211, n. 3).
1617Il 16 aprile l’ambasciatore del gran-duca Cosimo II de’ Medici, PieroGuicciardini, emette il pagamentodi “scudi cento di moneta di lire 7”a “messer Bartolomeo Pacarozzi daViterbo” per “servizio di Sua Altez-za Serenissima”, ottemperando a unordine ricevuto dal segretario delgranduca il 14 febbraio (Corti 1989,p. 140). Gianni Papi (1991, p. 209;1996, p. 87) ha riconosciuto nellaquietanza il pagamento per il SanGerolamo (Firenze, Galleria Palati-na), verosimilmente consegnato algranduca il 14 febbraio 1617.
Bartolomeo è al seguito di Giovan-ni Battista Crescenzi nel viaggio inSpagna con il cardinale Zapata (Ba-glione 1642, pp. 187, 365 [ma265]). La partenza può fissarsi suc-cessivamente al 14 ottobre, giornoin cui avvenne il battesimo a Romadi un figlio del Crescenzi (Noack,Mayer 1913, p. 86). Nella versionebreve del Discorso di pittura, che sipuò dunque datare fra la fine del1617 e il 1618, Giulio Mancini (ed.1957, II, p. 306) afferma che il pit-tore “si trova […] in Spagna allacorte del Re Cattolico condotto ividal suo mecenate signor Gio. Bat-tista Crescentij”.
1617, post – 1621, anteNella quadreria di Giovanni CarloDoria, collocata nel palazzo in vicodel Gelsomino a Genova, è regi-strata, come da inventario databiletra il 1617 e il 1621, una tela raffi-gurante “due pastori di mano diBartolomeo da Viterbo”, con la va-lutazione di 60 scudi (Farina 2002,p. 201; Farina 2004, pp. 193). Sitratta di una delle versioni del La-mento di Aminta (cfr. saggio), for-se quella appartenente al conte diVillamediana.
1619Le fonti fissano a maggio il mo-mentaneo rientro a Roma di Gio-vanni Battista Crescenzi (Céan Ber-mudez 1800, I, pp. 373-374). Si èsempre ritenuto, a eccezione del con-divisibile approccio critico di Gian-ni Papi (2001, pp. 427-438), che Bar-tolomeo seguisse Crescenzi anchenel viaggio di ritorno. Papi, inoltre,non ha escluso, in quello stesso an-no, un soggiorno a Genova, in con-siderazione della notevole presenzadi suoi dipinti in collezioni nobilia-ri di quella città (cfr. saggio).
1620-1621 circaÈ databile a questo biennio il Ri-tratto di un giovane ecclesiastico(collezione privata), identificabilesecondo Strinati (in Monaco 1997,pp. 16-20, n. 3) con AlessandroCrescenzi, figlio di Giovanni Batti-sta, nato nel 1607 e rappresentatoall’età di tredici o quattordici anni.
Di conseguenza il pittore sarebbegià rientrato a Roma.
1621Sono in corso di lavorazione, nelprimo semestre dell’anno, il dipin-to (ora disperso) raffigurante SanFilippo per la cappella di FilippoMancini in San Pietro del Castagnoa Viterbo e, nel secondo semestredell’anno, la Madonna con GesùBambino per il cardinale ScipioneCobelluzzi (Viterbo, Museo delColle del duomo). Ciò si ricava dauna lettera datata primo gennaio1622 (Nicolai 2004, pp. 450-451).In una lettera, priva di data, ma da-tabile entro il 1621, i Priori di Vi-terbo sollecitano il pittore “per ha-ver l’esecutione del quadro dellanostra cappella” (Carosi 1988, p.68). Da tali elementi si deduce inol-tre che il pittore risiede stabilmen-te a Roma.
1622In una lettera del primo gennaioche l’agente dei Priori a Roma, Au-relio Marrocchi, spedisce a Viterbo– in risposta a quella inviata daiPriori a Cavarozzi entro la fine del1621 – si giustifica il ritardo nellarealizzazione della Visitazione per lacappella del palazzo dei Priori diViterbo con le sovrapposizioni diimpegni del pittore: “doppo chefinì il quadro del signor FilippoMancini, è stato cinque mesi intor-no ad un altro per il signor Cardi-nal nostro di S. Susanna” (ovverola Madonna con Gesù Bambino peril Cobelluzzi). Dunque si apprendeche il pittore ha eseguito per il car-dinale Scipione Cobelluzzi un di-pinto “riuscito tanto bello, ch’è giu-dizio comune di tanti Signori et al-tri intendenti di questo mestieroche l’han visto, che in Roma hogginon ci sia che possa farlo migliore”(Carosi 1988, p. 69). Il dipinto èstato identificato con la Madonnacon Gesù Bambino (Viterbo, Mu-seo del Colle del duomo), prove-niente dalla cappella del seminario(successivamente condotto nellachiesa di Sant’Ignazio sull’altaredella famiglia Calabresi) e donatodal religioso ai Gesuiti secondo le
88 Cronologia
disposizioni testamentarie del 1626(Carosi 1988, p. 31; Nicolai 2004,pp. 444-447).Il 31 marzo è registrata, nei Ricor-di dei Priori di Viterbo, la conclu-sione della Visitazione: “si è intesoche il quadro della cappella è fini-to: procurino di farlo venire” (Ca-rosi 1988, p. 69; Nicolai 2004, p.451).Negli Stati d’anime della parroc-chia di Santa Maria del Popolo aRoma si attesta, in occasione dellaPasqua, la presenza del pittore inuna casa in “strada di Ripetta” in-sieme alla madre vedova (Papi1996, p. 94 nota 12).In prossimità di questo anno si de-ve datare l’esecuzione della pala conSant’Isidoro agricola nella chiesa diSant’Angelo in Spatha a Viterbo,poiché il santo venne canonizzatonel mese di marzo. Tuttavia nellavisita pastorale di settembre il di-pinto non compare, mentre risultanella successiva descrizione (1630)delle opere conservate in chiesa (Ni-colai 2004, p. 448, per una interes-sante ipotesi di commissione del-l’opera da parte del cardinale Co-beluzzi).
1623Il pittore, nel censimento pasqualedelle anime, risulta risiedere anco-ra in “strada di Ripetta” con la ma-dre (Papi 1996, p. 94 nota 12).
1624Il pittore, nel censimento pasqualedelle anime, risulta sempre resi-dente in “strada di Ripetta” con lamadre (Papi 1996, p. 94 nota 12).In questo anno è citato come lavo-ro del “Crescentio” la pala con ilMartirio di santo Stefano nel duomodi Monterotondo, datato dalla cri-tica al primo lustro del secondo de-cennio del Seicento (Pagliara 1980,pp. 259-260, nota 8).
1625Il pittore, nel censimento pasqualedelle anime, risulta sempre resi-dente in “strada di Ripetta” con lamadre e con un Giovanni garzone(Papi 1996, p. 94 nota 12).Il 21 settembre è registrata nel Li-
bro dei Morti della parrocchia diSanta Maria del Popolo a Roma lanotizia della sepoltura in chiesa delpittore, in età di anni 39 (Papi 1996,pp. 85-86, 93 nota 5). Anterior-mente alla scoperta archivistica re-lativa all’estremo anagrafico inizia-le, tale dato aveva giustamente in-dotto a fissare l’anno di nascita al1586 (Papi 1996, p. 86).
89
Bibliografia
Elenco delle abbreviazioniAGNPSG: Archivio Galleria
Nazionale di Palazzo Spinola,Genova
ASCG: Archivio Storico delComune, Genova
ASpG: Archivio Spinola, Genova(custodito presso PalazzoSpinola di Pellicceria)
ASG: Archivio di Stato, GenovaAST: Archivio di Stato, TorinoASAAT: Archivio Storico
dell’Accademia Albertina,Torino
Manoscritti
“Cartolare…” 1703-1714Cartolare di Costantino Balbi, 1703-
1714, ASpG, vol. 39“Cartolare…” 1724-1734Cartolare di Costantino Balbi, 1724-
1734, ASpG, vol. 196“Cartolare…” 1823-1831Cartolare dell’eredità di Costantino
Balbi, 1823-1831, ASpG, vol. 119“Catalogo…” 1869Catalogo inventario della Galleria
Mossi posseduta dalla R. Accade-mia Albertina di belle arti redattoda una Commissione accademicanel 1869 con le aggiunte posterio-ri alla donazione Mossi, in R. Ac-cademia Albertina. Galleria Mossie Cartoni 1825-1870, ASAAT, 3.b,fascicoli 30 e 30bis [stampato concopertina manoscritta; noti dueesemplari conservati in ASAAT]
“Descrizione…” 1847Descrizione dei quadri esistenti nel-
la Galleria Mossi, in R. Accade-mia Albertina. Galleria Mossi eCartoni 1825-1870, ASAAT, 3.b,fascicolo 18
“Elenchi e appunti…” 1869[Elenchi e appunti della Commis-
sione del 1869], in R. AccademiaAlbertina. Galleria Mossi e Car-toni 1825-1870, ASAAT, 3.b, fa-scicolo 29
“Elenchi e appunti…” 1925[Elenchi e appunti della Commis-
sione del 1925], in R. AccademiaAlbertina. Galleria Mossi e Car-toni 1825-1870, ASAAT, 3.b, fa-scicolo 32
“Galleria Mossi…” 1869Galleria Mossi. Catalogo ricevuto
dalla Commissione Accademia ingiugno 1869, in R. Accademia Al-bertina. Galleria Mossi e Cartoni1825-1870, ASAAT, 3.b, fascico-lo 29bis
“Indice e descrizione…” 1828Indice e descrizione de’ quadri co-
stituenti la Pinacoteca di monsi-gnor Mossi di Morano, donata al-la R. Accademia di belle arti di To-rino, AST, Sezione I, IstruzionePubblica, Accademia di Belle Artie Istituti relativi, mazzo 1 (copiain ASAAT, R. Accademia Alberti-na. Galleria Mossi e Cartoni 1825-1870, 3.b, fascicolo 15)
“Indice e descrizione…”post 1830, ante 1831Indice e descrizione dei quadri esi-
stenti nella Pinacoteca di S.E. mon-signor arcivescovo Mossi-Moranocancelliere dell’Ordine Supremodella SS.ma Annunziata - li 16 feb-braio 1828, in R. Accademia Al-bertina. Galleria Mossi e Cartoni1825-1870, ASAAT, 3.b, fascico-lo 16
“Indice e descrizione…” ante 1833Indice e descrizione dei quadri già esi-
stenti nella Pinacoteca della fu S.E.monsignor Mossi di Morano arici-vescovo di Sida cancelliere dell’Or-dine Supremo della SS.ma Annun-ziata ora esistenti nel Real Castellodetto di Madama col titolo di Gal-leria Mossi, in R. Accademia Alber-tina. Galleria Mossi e Cartoni 1825-1870, ASAAT, 3.b, fascicolo 17
“Indice de quadri…” ante 1837Indice de quadri esistenti nel Reale
Castello di S.M. nelle camere delDebito Pubblico, in R. AccademiaAlbertina. Galleria Mossi e Car-toni 1825-1870, ASAAT, 3.b, fa-scicolo 20
“Indice de quadri…” post 1837Indice dei quadri, in R. Accademia
Albertina. Galleria Mossi e Car-toni 1825-1870, ASAAT, 3.b, fa-scicolo 21
“Inventario…” 1856Inventario di tutti i mobili, quadri,
gessi, statue, libri, arredi, ed altrioggetti d’arte esistenti nei localidella Reale Accademia Albertinadi Belle Arti e di spettanza della do-tazione della Corona (22 gennaio1856), ASAAT, 4.i
“Libro mastro…” 1740Libro mastro di Giacomo (fu Co-
stantino) Balbi, 1740, ASpG, vol.69
“Nome degli Autori…” 1833Nome degli Autori de’ quadri della
Galleria Mossi rimasti sin ora in-certi o men noti, in R. AccademiaAlbertina. Galleria Mossi e Car-toni 1825-1870, ASAAT, 3.b, fa-scicolo 26bis
“Opere…” 1925Opere da trattenersi in Galleria, in
R. Accademia Albertina. GalleriaMossi e Cartoni 1825-1870,ASAAT, 3.b, fascicolo 33
“Progetto…” s.d. [1735 circa]Progetto d’incisione de’ migliori di-
pinti in Genova, e nota di essi,ASCG, fondo Brignole Sale
“Ristretto…” s.d. [1735 circa]Ristretto di differenti quadri e pitture
a fresco esistenti in Genova, meri-tevoli d’essere intagliate a gloriade’ Signori che le possedono in be-neficio di Giovani Studiosi e digrande utile a chi ne farà l’intra-presa poiché sarebbe un’operaaplaudita e ricercata in tutta l’Eu-ropa, 1735 circa, ASCG, ms.107B4
“Rapporto…” 1833Rapporto della Commissione del dì
11 maggio 1833 per la verificazio-ne de’ nomi di autori de quadridella Galleria di monsignor Mos-si arcivescovo di Sida, ASAAT, 3.b,fascicolo 26
Opere a stampa
Acordon 1992A. Acordon, Giovanni Andrea De
Ferrari, in Genova nell’Età Baroc-ca, catalogo della mostra a curadi E. Gavazza, G. Rotondi Ter-miniello (Bologna), Genova 1992,pp. 157-158
Allaria Olivieri 1996N. Allaria Olivieri, La reliquia di S.
Secondo sua cronistoria dal secoloXI al secolo XIX, Ventimiglia 1996
Alizeri 1846-1847F. Alizeri, Guida artistica per la città
di Genova, 2 voll. (I, 1846; II, par-te 1 e 2, 1847), Genova 1846-1847
Alizeri 1875F. Alizeri, Guida illustrativa del cit-
tadino e del forastiero per la cittàdi Genova e sue adiacenze, Geno-va 1875
Angeli 2000N. Angeli, I Ligustri di Viterbo e di
Bagnaia nei documenti degli Ar-chivi viterbesi, in “Biblioteca e so-cietà”, 2000, 19, pp. 19-22
Assini 2004A. Assini, Le fonti d’archivio per la
storia del collezionismo, in L’Età diRubens. Dimore, committenti ecollezionisti genovesi, catalogo del-la mostra a cura di P. Boccardocon la collaborazione di C. Di Fa-bio, A. Orlando, F. Simonetti (Ge-nova), Milano 2004, pp. 147-157
Baglione 1642G. Baglione, Le vite de’ pittori scul-
tori et architetti. Dal Pontificatodi Gregorio XIII fino a tutto quel-lo d’Urbano VIII, Roma 1642
Bartoletti 1990M. Bartoletti, Documenti inediti sul-
l’attività di alcuni “scultori di mar-mi” lombardi e ticinesi nei territo-ri di Ventimiglia, Sanremo e Tag-gia nel Sei e Settecento, in “Qua-derni Franzoniani”, 1990, 2, pp.91-122
Battilana 1826N. Battilana, Genealogie delle fa-
miglie nobili di Genova, 3 voll.,Genova 1826
Belloni 1975V. Belloni, Caröggi, crêuze, möntae.
Documenti di storia, cultura, pit-tura, scultura, mecenatismo, vitagenovese dal Cinque all’Ottocento,Genova 1975
Bellori 1672G.P. Bellori, Le vite de’ pittori, scul-
tori et architetti moderni, Roma1672 (ed. a cura di E. Borea, To-rino 1976)
Biavati 1974G. Biavati, Ipotesi per una vicenda
artistica nel palazzo di Antonio Do-ria, in “Genova”, 1974, 54, pp.33-39
Bitossi 1990a
C. Bitossi, De Mari Francesco, inDizionario Biografico degli Italia-ni, Roma 1990, 38, pp. 488-492
Bitossi 1990b
C. Bitossi, Il governo dei Magnifici.Patriziato e politica a Genova fraCinque e Seicento, Genova 1990
91Bibliografia
“Description…” 1781Description des beautés de Génes,
Genova 1781“Description…” 1788Description des beautés de Génes,
Genova 1788“Description…” 1792Description des beautés de Génes,
Genova 1792“Description…” 1796Description des beautés de Génes,
Genova 1796“Description…” 1818Descrizione della città di Genova da
un anonimo del 1818, a cura di E.Poleggi, F. Poleggi, Genova 1969
Di Fabio 1997C. Di Fabio, Il ciclo delle Virtù car-
dinali per la Sala dell’udienza pri-vata, in El Siglo de los Genovesese una lunga storia di arte e splen-dori nel palazzo dei dogi, catalogodella mostra a cura di P. Boccar-do, C. Di Fabio (Genova), Mila-no 1997, p. 318-323
“Dipinti…” c.d.s.Dipinti genovesi del Seicento e Sette-
cento. Collezione Koelliker, a curadi A. Orlando, in corso di stampa
Di Sivo 2005M. Di Sivo, “Il signor Horatio mi ri-
traheva e faceva un quadro di SanGeronimo…”: l’uomo dei dipintinel processo per stupro, in OrazioGentileschi e Pietro Molli, catalo-go della mostra a cura di F. Si-monetti, Genova 2005, pp. 15-25
Donati 1974P. Donati, Domenico Fiasella. Il
“Sarzana”, Genova 1974Dugoni 1996R. Dugoni, “La dolce fratellanza di
que’ pittori che confondeva gli unicogli altri gli studi e le bozze cheuscivano da loro pennelli”. Propo-sta su alcuni dipinti di “casa Pio-la” e una nuova traccia per il sog-giorno di Domenico Piola a Pia-cenza, in “Bollettino dei Musei Ci-vici Genovesi”, 1996, 52-53-54,pp. 79-90
Enggass 1864R. Enggass, The Painting of Bacic-
cio. Giovanni Battista Gaulli,Pennsylvania 1964
Faldi 1970I. Faldi, Pittori viterbesi di cinque se-
coli, Roma 1970
Farina 2002V. Farina, Giovan Carlo Doria, pro-
motore delle arti a Genova nel pri-mo Seicento, Firenze 2002
Farina 2004V. Farina, Gio. Carlo Doria (1576-
1625), in L’Età di Rubens. Dimo-re, committenti e collezionisti ge-novesi, catalogo della mostra a cu-ra di P. Boccardo con la collabo-razione di C. Di Fabio, A. Orlan-do, F. Simonetti (Genova), Mila-no 2004, pp. 189-195
Firenze 1922Mostra della pittura italiana del Sei-
cento e del Settecento, catalogodella mostra (Firenze), Roma-Mi-lano-Firenze 1922
Firenze 2003La natura morta italiana da Cara-
vaggio al Settecento, catalogo del-la mostra a cura di M. Gregori(Firenze), Milano 2003
Fumagalli 1994E. Fumagalli, Precoci citazioni di
opere del Caravaggio in alcuni do-cumenti inediti, in “Paragone”,1994, 535-537, pp. 101-116
Fumagalli 1996E. Fumagalli, Precoci citazioni di
opere del Caravaggio in alcuni do-cumenti inediti, in Come dipinge-va il Caravaggio, atti del conve-gno (1992) a cura di M. Gregori,Milano 1996, pp. 143-150
Gabrielli 1933a
N. Gabrielli, Inventario degli oggettid’arte esistenti nella R. AccademiaAlbertina di Belle Arti in Torino, To-rino 1933 (estratto con numerazio-ne autonoma delle pagine dal “Bol-lettino Storico Bibliografico Subal-pino”, 1933, I-II, pp. 137-200)
Gabrielli 1933b
N. Gabrielli, La Regia Galleria del-l’Accademia Albertina di Torino,Roma 1933
Gaglia 1982P. Gaglia, La formazione della Pina-
coteca, in F. Dalmasso, P. Gaglia, F.Poli, L’Accademia Albertina di To-rino, Torino 1982, pp. 125-136
“Galleria (civica)…” [1893]Galleria (civica) di Palazzo Bianco.
Catalogo delle opere d’Arte espo-ste per sale, Genova [1893]
“Galleria Nazionale…” 2002Galleria Nazionale di Palazzo Spi-
nola. Galleria Nazionale della Li-guria, a cura di F. Simonetti, G.Zanelli, Genova 2002
Gavazza 1974E. Gavazza, La grande decorazione
a Genova, Genova 1974Gavazza 1976E. Gavazza, Villa Spinola di San Pie-
tro, Genova 1976Gencarelli 1963E. Gencarelli, Costantino Balbi, in
Dizionario Biografico degli Italia-ni, Roma 1963, 5, pp. 360-361
Genova 1892Catalogo degli oggetti componenti
la Mostra d’arte antica aperta nel-le sale di Palazzo Bianco, catalogodella mostra a cura di V. Poggi,L.A. Cervetto, G.B. Villa, Geno-va 1892
Genova 1938Mostra di pittori genovesi del Sei-
cento e del Settecento, catalogodella mostra a cura di O. Grosso,M. Bonzi, C. Marcenaro (Geno-va), Milano 1938
Genova 1995Bernardo Strozzi. Genova 1581/82
- Venezia 1644, catalogo della mo-stra a cura di E. Gavazza, G. Ne-pi Sciré, G. Rotondi Termminiel-lo (Genova), Milano 1995
Genova 1997Van Dyck a Genova. Grande pittu-
ra e collezionismo, catalogo dellamostra a cura di S.J. Barnes, P.Boccardo, C. Di Fabio, L. Ta-gliaferro (Genova), Milano 1997
Genova 2003a
Dipinti dal collezionismo privato,catalogo della mostra a cura di F.Simonetti, G. Zanelli (Genova),Roma 2003
Genova 2003b
Joos van Cleve e Genova. Intornoal Ritratto di Stefano Raggio, ca-talogo della mostra a cura di F.Simonetti, G. Zanelli (Genova),Firenze 2003
Genova 2004L’Età di Rubens. Dimore, commit-
tenti e collezionisti genovesi, cata-logo della mostra a cura di P. Boc-cardo con la collaborazione di C.Di Fabio, A. Orlando, F. Simo-netti (Genova), Milano 2004
Genova 2005a
La Santa Caterina di Barnaba da Mo-
dena, catalogo della mostra a cu-ra di F. Simonetti, G. Zanelli, Ge-nova-Roma 2005.
Genova 2005b
Orazio Gentileschi e Pietro Molli,catalogo della mostra a cura di F.Simonetti, Genova 2005.
Gregori 1969M. Gregori, Seicento. Arte moder-
na, arte di domani, in “Arte Illu-strata”, 1969, ottobre-novembre,pp. 103-105
Gregori 1973M. Gregori, Notizie su Agostino
Verrocchi e un’ipotesi per Giovan-ni Battista Crescenzi, in “Parago-ne”, 1973, 275, pp. 36-56
Gregori 1975M. Gregori, Significato delle mostre
caravaggesche dal 1951 ad oggi, inNovità sul Caravaggio. Saggi e con-tributi, a cura di M. Cinotti, Mi-lano 1975, pp. 26-60
Gregori 1989M. Gregori, Il Sacrificio di Isacco: un
inedito e considerazioni su una fa-se savoldesca del Caravaggio, in“Artibus et historiae”, 1989, 10,pp. 99-142
Gregori 2002M. Gregori, Due partenze in Lom-
bardia per la natura morta, in Na-tura morta italiana tra Cinquecen-to e Settecento, catalogo della mo-stra a cura di M. Gregori (Mona-co), Milano 2002, pp. 17-40
Gregori 2003a
M. Gregori, Le botteghe romane el’accademia di Giovanni BattistaCrescenzi, in La natura morta ita-liana da Caravaggio al Settecento,catalogo della mostra a cura di M.Gregori (Firenze), Milano 2003,pp. 49-52
Gregori 2003b
M. Gregori, Verso una storia dellanatura morta italiana, in La natu-ra morta italiana da Caravaggio alSettecento, catalogo della mostra(Firenze), a cura di M. Gregori,Milano 2003, pp. 21-56
Grilli 2003C. Grilli, Le cappelle gentilizie del-
la chiesa di Sant’Andrea della Val-le: i committenti, i documenti, leopere, in A. Costamagna, D. Fer-rara, C. Grilli, Sant’Andrea dellaValle, Milano 2003, pp. 69-193
90 Bibliografia
Boccardo 1987P. Boccardo, Per la storia della qua-
dreria di Palazzo Spinola, in Pa-lazzo Spinola a Pellicceria. Due mu-sei in una dimora storica, “Qua-derni della Galleria Nazionale diPalazzo Spinola”, n. 10, Genova1987, pp. 62-86
Boccardo 1988-1989P. Boccardo, Materiali per una sto-
ria del collezionismo artistico a Ge-nova nel XVII secolo, Tesi dotto-rale, Università degli Studi di Mi-lano, Milano a.a. 1988-1989
Boccardo 1989P. Boccardo, Andrea Doria e le Arti.
Committenza e mecenatismo a Ge-nova nel Rinascimento, Roma 1989
Boccardo 1997P. Boccardo, Ritratti di collezionisti
e committenti, in Van Dyck a Ge-nova. Grande pittura e collezioni-smo, catalogo della mostra a curadi S.J. Barnes, P. Boccardo, C. DiFabio, L. Tagliaferro (Genova),Milano 1997, pp. 29-58
Boccardo 2002P. Boccardo, Viceré e finanzieri:
mercato artistico e collezioni traMadrid e Genova (secoli XVII-XVIII), in Genova e la Spagna.Opere, artisti, committenti, colle-zionisti, a cura di P. Boccardo, J.L.Colomer, C. Di Fabio, CiniselloBalsamo 2002, pp. 221-239
Boccardo c.d.s.P. Boccardo, Finanza, collezionismo
e diplomazia tra la Spagna e Ge-nova, in Arte y diplomacia de lamonarquía hispánica en el sigloXVII, atti del convegno (maggio2001) a cura di J.L. Colomer, incorso di stampa
Boccardo, Magnani 1987P. Boccardo, L. Magnani, La com-
mittenza, in Il Palazzo dell’Uni-versità di Genova. Il Collegio deiGesuiti nella Strada dei Balbi, Ge-nova 1987, pp. 47-88
Boggero 1985F. Boggero, Introduzione, in Un pittore
genovese del Seicento. Andrea An-saldo 1584-1638 restauri e confron-ti, catalogo della mostra a cura di F.Boggero, Genova 1985, pp. 7-22
Bono 1924F.A. Bono, La nobiltà ventimiglie-
se, Genova 1924
Bollea 1932L.C. Bollea, La donazione Mossi di
Morano alla R. Accademia Alber-tina, in “Bollettino Storico Bi-bliografico Subalpino”, 1932, I,pp. 87-96, II, pp. 205-218, III, pp.293-325
Bollea 1936L.C. Bollea, La Galleria dell’Acca-
demia, TorinoBologna 1992F. Bologna, L’incredulità del Cara-
vaggio, Torino 1992Borea 1972E. Borea, Considerazioni sulla mo-
stra “Caravaggio e i suoi seguaci”a Cleveland, in “Bollettino d’Ar-te”, 1972, 3-4, pp. 154-164
Bozzo 2000G. Bozzo, Genova. Palazzo Spinola
Gambaro. Banco di Chiavari e del-la Riviera Ligure, Genova 2000
Brejonde Lavergnée, Cuzin 1974A. Brejonde Lavergnée, J.P. Cuzin,
Cecco del Caravaggio, in I caravag-gisti francesi, catalogo della mostraa cura di A. Brejonde Lavergnée,J.P. Cuzin, Roma 1974, p. 25
Bres 1914G. Bres, L’arte nell’estrema Liguria
occidentale. Notizie inedite, Nizza1914
Burke, Cherry 1997M.A. Burke, P. Cherry, Collections
of Paintings in Madrid (1601-1755), 2 voll., Los Angeles 1997
Camiz Trincheri 1983F. Camiz Trincheri, Music and pain-
ting in Cardinal del Monte’s hou-sehold, in “Metropolitan MuseumJournal”, 1991, 26, pp. 213-226
Cannatà, Vicini 1992R. Cannatà, M.L. Vicini, La Galle-
ria di Palazzo Spada. Genesi e sto-ria di una collezione, Roma 1992
Cappelletti 1998F. Cappelletti, Two Roman pain-
tings by Domenico Fiasella, in“The Burlington Magazine”,1998, 1138, pp. 28-30
Carosi 1988A. Carosi, Note al Palazzo Comu-
nale di Viterbo, Viterbo 1988Castelnovi 1947G.V. Castelnovi, Dipinti antichi del-
la Liguria Intemelia, in “RivistaIngauna e Intemelia”, 1947, 1, pp.1-10
Castelnovi 1987G.V. Castelnovi, La prima metà del
Seicento: dall’Ansaldo a Orazio DeFerrari, in La pittura a Genova ein Liguria dal Seicento al primoNovecento, Genova 1987, pp. 59-150
Causa 2000S. Causa, Battistello Caracciolo. L’o-
pera completa, Napoli 2000“Cavarozzi…” 1996Cavarozzi, Bartolomeo, in The Dic-
tionnary of Art, New York 1996,VI, p. 112
“Cavarozzi…” 1997Cavarozzi (Cavarozza) Bartolomeo,
in Allgemeines Künstlerlexikon,München Leipzig 1997, 17, pp.382-383
Ceán Bermudez 1800J.A. Ceán Bermudez, Diccionario
histórico de los mas illustres pro-fesores de las bellas Artes enEspaña, Madrid 1800
Christiansen 2001K. Christiansen, L’arte di Orazio
Gentileschi, in Orazio e ArtemisiaGentileschi, catalogo della mostraa cura di K. Christiansen, J. W.Mann (Roma-New York-SaintLouis), Milano 2001, pp. 3-37
Ciliento, Pazzini Paglieri 1991B. Ciliento, N. Pazzini Paglieri, Ven-
timiglia, Genova 1991Cleveland 1971Caravaggio and his followers, cata-
logo della mostra a cura di R.E.Spear, Cleveland 1971
Colomer 2002J. Luis Colomer, Ambrogio Spinola:
la fortuna iconografica di un ge-novese del Seicento, in Genova ela Spagna. Opere, artisti, commit-tenti, collezionisti, a cura di P. Boc-cardo, J. L. Colomer, C. Di Fa-bio, Cinisello Balsamo 2002, pp.177-205
Costantini 1986C. Costantini, La Repubblica di Ge-
nova, Torino 1986Cottino 1989A. Cottino, La natura morta cara-
vaggesca a Roma, in La naturamorta in Italia, Milano 1989, II,pp. 650-689
Cottino 1995A. Cottino, “Dipinger fiori e frutti
sì bene contraffatti…”: la natura
morta caravaggesca a Roma, in Lanatura morta al tempo di Cara-vaggio, catalogo della mostra a cu-ra di M. Gregori (Roma), Napo-li 1995, pp. 59-65
Cottino 2002A. Cottino, La natura morta a Roma:
il naturalismo caravaggesco, in Na-tura morta italiana tra Cinquecen-to e Settecento, catalogo della mo-stra a cura di M. Gregori (Mona-co), Milano 2002, pp. 120-129
Cottino 2003A. Cottino, La natura morta a Ro-
ma: il naturalismo caravaggesco,in La natura morta italiana da Ca-ravaggio al Settecento, catalogodella mostra a cura di M. Grego-ri (Firenze), Milano 2003, pp.122-131
Curie 2003P. Curie, Bartolomeo Cavarozzi. Un
exemple problématique de diffu-sion du caravagisme en France eten Espagne, in Nicolas Tournier etla peinture caravagesque en Italie,en France et en Espagne, atti delconvegno a cura di P.F. Bertand (7- 9 giugno 2001), Toulouse 2003,pp. 206-216
Damian 2004V. Damian, Pittura italiana tra Sei e
Settecento. Galerie Canesso, Pari-gi 2004
Danesi Squarzina 2001S. Danesi Squarzina, La collezione
Giustiniani. Benedetto, Vincenzo,Andrea nostri contemporanei, inCaravaggio e i Giustiniani. Toccarcon mano una collezione del Sei-cento, catalogo della mostra a cu-ra di S. Danesi Squarzina (Roma-Berlino), Milano 2001, pp. 17-45
De Salas 1974X. De Salas, Caravaggio y los cara-
vaggistas en la pintura española,in Caravaggio e i Caravaggeschi,atti del convegno (12 - 14 febba-rio 1973), Roma 1974, pp. 29-43
“Description…” 1768Description des beautés de Génes,
Genova 1768“Description…” 1769Description des beautés de Génes,
Genova 1769“Description…” 1773Description des beautés de Génes,
Genova 1773
93Bibliografia
Natura morta italiana tra Cinque-cento e Settecento, catalogo dellamostra a cura di M. Gregori (Mo-naco), Milano 2002, p. 466
Papi 2003G. Papi, Bartolomeo Cavarozzi, in
La natura morta italiana da Cara-vaggio al Settecento, catalogo del-la mostra a cura di M. Gregori(Firenze), Milano 2003, p. 484
Papone 2004E. Papone, Il Centro di Documenta-
zione per la Storia, l’Arte, l’Imma-gine di Genova, in I Musei di Stra-da Nuova a Genova. Palazzo Ros-so, Palazzo Bianco e Palazzo Tursi,a cura di P. Boccardo, C. Di Fabio,Torino 2004, pp. 125-136
Parma Armani 1978-1979E. Parma Armani, I “quadretti” di
San Filippo Neri e un’ipotesi perBartolomeo Cavarozzi disegnato-re, in “Studi di Storia delle Arti”,1978-1979, pp. 131-148
Parma 1999E. Parma, Palazzo di Antonio Doria
(Spinola), in La pittura in Liguria.Il Cinquecento, Genova 1999, pp.195-202
Pérez Sánchez 1964a
A.E. Pérez Sánchez, Borgianni, Ca-varozzi y Naldi en España, Madrid1964
Pérez Sánchez 1964b
A.E. Pérez Sánchez, Dos importan-tes pinturas del barocco, in “Ar-chivio Español de Arte”, 1964,145-148, pp. 7-15.
Pérez Sánchez 1965A.E. Pérez Sánchez, Pintura Italia-
na del s. XVII en España, Madrid1965
Pérez Sánchez 1970A.E. Pérez Sánchez, Pintura italia-
na del siglo XVII, Madrid 1970Perin 1999A. Perin, Palazzo Mossi Pallavicini,
in Da Musso a Guala, catalogo del-la mostra a cura di G. Romano, C.Spantigati (Casale Monferrato),Savignano 1999, pp. 118-121
Pesenti 1986F. R. Pesenti, La pittura in Liguria.
Artisti del primo Seicento, Geno-va 1986
Pesenti 1992F.R. Pesenti, Il primo momento del
caravaggismo a Genova, in Geno-
va nell’Età Barocca, catalogo del-la mostra a cura di E. Gavazza,G. Rotondi Terminiello (Geno-va), Bologna 1992
Petrucci 1999F. Petrucci, La ritrattistica, in Gio-
van Battista Gaulli il Baciccio1639-1709, catalogo della mostraa cura di M. Fagiolo dell’Arco, D.Graf, F. Petrucci (Roma), Milano1999, pp. 89-102
“Piccola guida…” 1846Piccola guida di Genova, Genova
1846Pignatti 1985T. Pignatti, The Sarah Campbell
Blaffer Foundation. Five Centu-ries of Italian Paintings 1300-1800,New York 1985
Pizzorno 2004S.E. Pizzorno, Passaggi di proprietà,
in Palazzo Doria Spinola sede dellaPrefettura di Genova, a cura di G.Bozzo, Genova 2004, pp. 37-40
Poleggi 1972E. Poleggi, Strada Nuova. Una lot-
tizzazione del Cinquecento a Ge-nova, Genova 1972
Porcella 1927A. Porcella, Un ispiratore del Mu-
rillo, in “Il Carroccio”, 1927, 52,pp. 1641-1645
Puglisi 2003C. Puglisi, Caravaggio, Londra 2003Pupillo 1996M. Pupillo, I Crescenzi, Francesco
Contarelli e Michelangelo da Ca-ravaggio: contesti e documenti perla commissione in San Luigi deiFrancesi, in Michelangelo Merisida Caravaggio. La vita e le opereattraverso i documenti, atti delconvegno (5-6 ottobre 1995) a cu-ra di S. Macioce, Roma 1996, pp.148-166
Pupillo 2002M. Pupillo, “Alleati dal diletto del-
le virtù”. Giovanni Baglione, i Cre-scenzi e l’Accademia di San Luca,in Giovanni Baglione (1566-1644).Pittore e biografo di artisti, a curadi S. Macioce, Roma 2002, pp.140-159
Ratti 1766C.G. Ratti, Istruzione di quanto può
vedersi di più bello in Genova inPittura, Scultura ed Architettura,Genova 1766
Ratti 1769C.G. Ratti, Delle vite de’ pittori,
scultori ed architetti genovesi. To-mo secondo scritto da Carlo Giu-seppe Ratti Pittore, e Socio delleAccademie Ligustica e Parmensein continuazione dell’opera di Raf-faello Soprani, Genova 1769
Ratti 1780C.G. Ratti, Instruzione di quanto
può vedersi di più bello in Geno-va in pittura, scultura ed architet-tura, Genova 1780
Roma 1995a
La natura morta al tempo di Cara-vaggio, catalogo della mostra, Ro-ma 1995
Roma 1995b
La Regola e la Fama. San FilippoNeri e l’arte, catalogo della mo-stra a cura di A. Costamagna (Ro-ma), Milano 1995
Roma 1999Giovan Battista Gaulli il Baciccio 1639-
1709, catalogo della mostra a curadi M. Fagiolo dell’Arco, D. Graf, F.Petrucci (Roma), Milano 1999
Roma-Berlino 2001Caravaggio e i Giustiniani. Toccar
con mano una collezione del Sei-cento, catalogo della mostra a cu-ra di S. Danesi Squarzina (Roma-Berlino), Milano 2001
Roma-Milano 1995La natura morta al tempo di Cara-
vaggio, catalogo della mostra (Ro-ma, Milano), Napoli 1995
Roma-Milano-Vicenza 2004L’ultimo Caravaggio. Il Martirio di
Sant’Orsola restaurato. CollezioneBanca Intesa, catalogo della mostra(Roma-Milano-Vicenza), Milano2004
Roma-New York-Saint Louis2001-2002
Orazio e Artemisia Gentileschi, cata-logo della mostra a cura diK.Christiansen, J.W. Mann (Roma-New York-Saint Louis), Milano2001
Roma-Siena 2000-2001Colori della musica. Dipinti, stru-
menti e concerti tra Cinquecento eSeicento, catalogo della mostra acura di A. Bini, C. Strinati, R. Vo-dret (Roma-Siena), Milano 2000
Rossi 1886G. Rossi, Storia della città di Venti-
miglia, Oneglia 1886Rotondi 1960P. Rotondi, La Galleria Nazionale di
Palazzo Spinola a Genova, Geno-va 1960
Salerno 1984L. Salerno, La natura morta italia-
na 1560-1805, Roma 1984Sanguineti 2004D. Sanguineti, Domenico Piola e i
pittori della sua “casa”, 2 voll., Son-cino 2004
Sanguineti 2005D. Sanguineti, Note sulla collezione
Mossi di Morano, in Maestri cara-vaggeschi, a cura di D. Sanguineti,“Le collezioni dell’Accademia Al-bertina”, Genova 2005, pp. 4-5
Simonetti 2002F. Simonetti, Acquisizioni per la Gal-
leria Nazionale della Liguria evo-luzione della logica di incrementodal 1959 ad oggi, in Galleria Na-zionale di Palazzo Spinola. Galle-ria Nazionale della Liguria, a cu-ra di F. Simonetti, G. Zanelli, Ge-nova 2002, pp. 5-13
Siviglia 1973Caravaggio y el naturalismo español,
catalogo della mostra a cura diA.E. Pérez Sánchez, Siviglia 1973
Spear 1975R.E. Spear, Caravaggio and his fol-
lowers, New York 1975Spezzaferro 1979L. Spezzaferro, Cavarozzi Bartolo-
meo, in Dizionario Biografico degliItaliani, Roma 1979, 23, pp. 26-28
Spezzaferro 1985L. Spezzaferro, Un imprenditore del
primo Seicento: Giovanni BattistaCrescenzi, in “Ricerche di Storiadell’Arte”, 1985, 26, pp. 50-73
Stechow 1952W. Stechow, Italian Paintings of the
17th Century, in “Allen MemorialArt Museum Bulletin”, 1952, 2, p.39
Strinati 1995C. Strinati, La mano di ferro, in Cara-
vaggio e la collezione Mattei, catalo-go della mostra a cura di R. Vodret(Roma), Milano 1995, pp. 11-16
Sydney 2003Darkness & Light. Caravaggio & his
world, catalogo della mostra, Syd-ney 2003
Tagliaferro 1995
92 Bibliografia
Griseri 1958A. Griseri, Una revisione nella Gal-
leria dell’Accademia Albertina inTorino, in “Bollettino d’Arte”,1958, 1, pp. 69-88
“Guida…” 1837Guida per la città di Genova. Lu-
nario, Genova 1837Hibbard 1985H. Hibbard, Carlo Maderno and
Roman Architecture 1580-1630,Londra 1971
Kirwin 1972C. Kirwin, Cristoforo Roncalli,
Standford University, Ph. D. 1972Kowal 1982D.M. Kowal, Italian Art from the
Sarah Campbell Blaffer Founda-tion, in “Apollo”, 1982, 266, pp.115-116.
Lanzi 1793L. Lanzi, Viaggio del 1793 pel Ge-
novesato e il Piemontese. Pittori spe-cialmente di questi due stati e qual-cosa de’ suoi musei, 1793 (ed. a cu-ra di G.C. Sciolla, Treviso 1984)
Lavagnino 1933E. Lavagnino, La Galleria Spada in
Roma, Roma 1933Londra 1913-1914Spanish Old Master Paintings, ca-
talogo della mostra (Grafton Gal-leries), Londra 1913-1914
Londra-Roma 2001The genius of Rome 1592-1623, ca-
talogo della mostra a cura di B.L.Brown (Londra-Roma), Londra2001
Longhi 1916R. Longhi, Gentileschi padre e fi-
glia, in “L’Arte”, 1916, pp. 245-314
Longhi 1943R. Longhi, Ultimi studi sul Cara-
vaggio e la sua cerchia, in “Pro-porzioni”, 1943, I, pp. 5-63
Longhi 1951a
R. Longhi, Alcuni pezzi rari nell’an-tologia della critica caravaggesca, in“Paragone”, 1951, 17, pp. 44-62
Longhi 1951b
R. Longhi, Introduzione, in Mostradel Caravaggio e dei caravaggeschi,catalogo della mostra (Milano),Firenze 1951, pp. XVII-XXXI
Madrid-Bilbao 1999-2000Caravaggio, catalogo della mostra
(Madrid-Bilbao), Milano 1999
“Maestri…” 2005Maestri caravaggeschi, a cura di D.
Sanguineti, “Le collezioni dell’Ac-cademia Albertina”, Genova 2005
Mancini 1617-1620G. Mancini, Considerazioni sulla
pittura, 1617-1620 (ed. a cura diA. Marucchi, L. Salerno, 2 voll.,Roma 1956-1957)
Marini 1979M. Marini, “San Pietro Nolasco tra-
sportato dagli angeli”: BartolomeoCavarozzi e Cecco del Caravaggio,in “Antologia di Belle Arti”, 1979,9-12, pp. 68-76
Marini 1981M. Marini, Del Signor Giovanni Bat-
tista Crescentij Pittore, in “The J.Paul Getty Museum Journal”,1981, IX, pp. 127-132
Marino 1627G.B. Marino, Lettere, 1627 (ed. a
cura di M. Guglielminetti, Torino1966)
Marica 2000P. Marica, Palazzo Doria Spinola,
Genova 2000Melasecchi 1995O. Melasecchi, Nascita e sviluppo
dell’iconografia di San Filippo Ne-ri dal Cinquecento al Settecento,in La Regola e la Fama. San Filip-po Neri e l’arte, catalogo della mo-stra a cura di A. Costamagna (Ro-ma), Milano 1995, pp. 34-49
Migliorini 1997-1999M. Migliorini, Note sul collezioni-
smo genovese da un manoscrittosettecentesco e aggiornamenti sudipinti di Van Dyck a Genova, in“Studi di Storia delle Arti”, 1997-1999, 9, pp. 211-233
Migliorini, Assini 2000M. Migliorini, A. Assini, Pittori in
tribunale. Un processo per copie efalsi alla fine del Seicento, Nuoro2000 (con Cd-rom, Documenti)
Milano 1951Mostra del Caravaggio e dei Cara-
vaggeschi, catalogo della mostracon introduzione di R. Longhi,Milano 1951
Milano 2003Le chiavi del Paradiso. I Tesori dei
Cappuccini della Provincia di Ge-nova, catalogo della mostra a cu-ra di L. Temolo Dall’Igna (Ge-nova), Milano 2003
Milano-Vienna 2005-2006Da Caravaggio a Mattia Preti. The
International Caravaggesque Mo-vement, catalogo della mostra, incorso di stampa
Moir 1967A. Moir, The Italian Followers of
Caravaggio, 2 voll., Cambridge1967
Monaco (Montecarlo) 1997Genua Tempu Fa. Tableaux de Maî-
tres actifs à Gênes du XVIIe auXVIIIe siècle et relations d’art etd’historie entre la République deGênes et la Principauté de Mona-co, catalogo della mostra a curadi T. Zennaro, Monaco 1997
Monaco 2002-2003Natura morta italiana tra Cinque-
cento e Settecento, catalogo dellamostra a cura di M. Gregori (Mo-naco), Milano 2002
Mossetti 1993Un committente della nobiltà di
corte: Ottavio Provana di Druent,in Torino 1675-1699. Strategie econflitti del Barocco, a cura di G.Romano, Torino 1993, pp. 253-353
Mossetti 1995C. Mossetti, La “copiosa gallerija di
buoni quadri” di casa Mossi a Casale:primi accertamenti documentari, inLe collezioni del Museo Civico diCasale. Catalogo delle opere esposte,a cura di G. Mazza, C. Spantigati,Tortona 1995, pp. 111-121
Napoli 1963Caravaggio e caravaggeschi, catalo-
go della mostra, Napoli 1963New York 1990A Caravaggio Rediscovered. The Lu-
te Player, catalogo della mostra acura di K. Christiansen, NewYork 1990
New York-Napoli 1985Caravaggio e il suo tempo, catalogo
della mostra (New York-Napoli),Napoli 1985
Nicolai 2004F. Nicolai, La collezione di quadri del
Cardinale Scipione Cobelluzzi, in“Studi Romani”, 2004, 3-4, pp.440-462
Nicolson 1979B. Nicolson, The International Ca-
ravaggesque Movement. Lists ofPictures by Caravaggio and his Fol-
loers throughout Europe from 1590to 1650, Oxford 1979
Nicolson 1989B. Nicolson, Caravaggism in Euro-
pe (second edition revised and en-larged by L. Vertova), Torino1989, 3 voll.
Noack, Mayer 1913F. Noack, A. Mayer, Crescenzi, Gio-
vanni Battista, in AllgemeinesLexikon der bildenden Künstler,a cura di U. Thieme, F. Becker,Lipsia 1913, VIII, pp. 86-87
“Nouveau guide…” 1830Nouveau guide de Gènes et de ses
environs, Genova 1830“Nouveau guide…” 1842Nouveau guide de Gènes et de ses
environs, Genova 1842“Nouvelle description…” 1819Nouvelle description des beautés de
Gênes et de ses environs, Genova1819
“Nouvelle description…” 1826Nouvelle description des beautés de
Gênes et de ses environs, Genova1826
Oberlin 1952Italian Paintings of the17th century,
Oberlin 1952Pagliara 1980P.M. Pagliara, Monterotondo, in Sto-
ria dell’arte italiana. Inchieste suicentri minori, Torino 1980, pp.235-278
Palomino 1715A. Palomino, El Museo Pictorico,
1715 (ed. Madrid 1947)Papi 1989G. Papi, Cavarozzi Bartolomeo, in
La Pittura in Italia. Il Seicento,Milano, II, p. 683
Papi 1992G. Papi, Tre dipinti della fase gio-
vanile di Domenico Fiasella, in“Arte Cristiana”, 1992, 750, pp.199-208
Papi 1996G. Papi, Riflessioni sul percorso ca-
ravaggesco di Bartolomeo Cava-rozzi, in “Paragone”, 1996, 5-6-7,pp. 85-96
Papi 2001G. Papi, Indagini sulla fase matura di
Bartolomeo Cavarozzi, in “Arte Cri-stiana”, 2001, 807, pp. 427-438
Papi 2002G. Papi, Bartolomeo Cavarozzi, in
94 Bibliografia
L. Tagliaferro, La magnificenza pri-vata. “Argenti, gioie, quadri e al-tri mobili” della famiglia BrignoleSale secoli XVI-XIX, Genova 1995
Toesca 1957I. Toesca, Pomarancio a Palazzo Cre-
scenzi, in “Paragone”, 1957, 91,pp. 41-45
Toesca 1960I. Toesca, Un’opera giovanile del
Cavarozzi e i suoi rapporti col Po-marancio, in “Paragone”, 1960,123, pp. 57-59
Toncini Cabella 2002A. Toncini Cabella, Paolo Gerolamo
Piola e la sua grande casa genove-se, Genova 2002
Torino 1990Dipinti Italiani 1460 - 1760, cata-
logo della mostra a cura di A. Cot-tino, M. Voena, Torino 1990
Torino 1993Accademia Albertina. Opere scelte del-
la Pinacoteca, catalogo della mostraa cura di F. Dalmasso, G. GalanteGarrone, G. Romano, Torino 1993
Torino 1997Dipinti italiani del Seicento di pro-
prietà di Istituti Bancari, catalogodella mostra a cura di M. BonaCastellotti, Torino 1997.
Torriti 1970P. Torriti, Apporti toscani e lom-
bardi, in La pittura a Genova e inLiguria dal Seicento al primo No-vecento, Genova 1970, pp. 13-58(seconda edizione con aggiorna-mento a cura di M. C. Galassi,Genova 1987, pp. 13-58)
“Una reggia…” 1998Una regia repubblicana. Atlante dei
palazzi di Genova 1576-1664, acura di E. Poleggi, Torino 1998
Vergara 1995A. Vergara, The ‘Room of Rubens’
in the collection of the 10th Admi-ral of Castile, in “Apollo”, 1995,396, pp. 34-39
Vicini 1997M.L. Vicini, Galleria Spada. Visita
guidata, Roma 1997Viola 1981E. Viola, Ventimiglia nel ’600. Vita
di un baluardo di confine, in Unabiblioteca pubblica del Seicento:l’Aprosiana di Ventimiglia, Pine-rolo 1981, pp. 61-75
Volpe 1972
C. Volpe, Annotazioni sulla mostracaravaggesca di Cleveland, in “Pa-ragone”, 1972, 263, pp. 50-76
Volpe 1973C. Volpe, Una proposta per Gio-
vanni Battista Crescenzi, in “Pa-ragone”, 1973, 275, pp. 29-33
Von Bernstorff c.d.s.M. von Bernstorff, La traduzione
della Bibbia in pittura. Il San Ge-rolamo di Bartolomeo Cavarozzi, inc.d.s.
Voss 1920H. Voss, Gentileschi Orazio, in Al-
l gemeines Lexikon der bildendenKünstler, a cura di U. Thieme, F.Becker, Lipsia 1920, XIII, p. 411.
Vsevolozhskaya, Linmik 1975S. Vsevolozhskaya, I. Linmik, Ca-
ravaggio and his followers. Pain-tings in Soviet Museums, Lenin-grado 1975
Washington-Toronto-Bologna 1990-1991
Dipinti barocchi delle banche italia-ne, catalogo della mostra (Wa-shington-Toronto-Bologna), Ve-nezia 1990
Zahn 1928L. Zahn, Caravaggio, Berlino 1928Zeri 1954F. Zeri, Catalogo della Galleria Spa-
da, Roma 1954