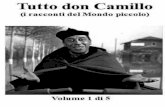Ospedali e ospizi: carità pubblica e cristiana, in Il Rinascimento italiano e l’Europa
Gli ospedali la nuova pietas e la committenza musicale cittadinesca a Venezia (1590-1620): i casi di...
-
Upload
conservatorioadria -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Gli ospedali la nuova pietas e la committenza musicale cittadinesca a Venezia (1590-1620): i casi di...
1
Rodolfo BaRoncini
Gli Ospedali, la nuova pietas e la committenza musicalecittadinesca a Venezia (1590-1620): i casi di Bartolomeo
Bontempelli dal Calice e di Camillo Rubini
L’attività musicale dei quattro Ospedali maggiori veneziani e la fama delle virtuose di canto e di suono ivi allevate raggiunsero – come noto – il loro apice nel corso del Settecento. è su questo secolo, del resto, e sull’attrazione suscitata da figure del calibro di Vivaldi, Porpora, Hasse, Traetta e altri che si fonda prevalentemente la ricezione odierna di questo straordinario fenomeno sociale e musicale lagunare. Se è vero che il xviii fu il secolo aureo degli «Ospitali», è pur vero che nel momento in cui i precitati compositori vi misero piede come maestri di canto e di suono, i cori femminili di questi istituti vantavano già, a seconda dei casi, tra il secolo e il secolo e mezzo di onorata storia musicale. Una storia, tuttavia, più opaca di quella settecentesca su cui hanno pesato, finora, sia la perdita di gran parte della documentazione ufficiale,1 sia la dispersione e la non facile individuazione del repertorio vocale e strumentale scritto appositamente per le figlie di coro in questi due secoli.2 Una storia, va
1 è ben noto che di tre Ospedali su quattro non ci sono pervenuti i notatori e i registri contabili relativi ai secoli XVI e XVII, lacuna che rende difficile ricostruirne la prassi mu-sicale e perfino l’avvicendarsi dei rispettivi maestri di musica. L’unico Ospedale a conser-vare un discreto patrimonio documentario è quello dei Mendicanti, mentre notoriamente desolante è la situazione degli Incurabili (di cui manca qualsiasi atto amministrativo fino al 1767) e oltremodo lacunosa appare sia quella della Pietà (le cui più antiche termina-zioni pervenuteci risalgono agli anni 1629-1655), sia quella dei Derelitti del cui fondo amministrativo cinque-seicentesco è rimasto il solo notatorio primo (1547-1605). Cfr. Arte e musica all’Ospedaletto. Schede d’archivio sull’attività musicale degli ospedali dei De-relitti e dei Mendicanti di Venezia (sec. XVI-XVIII), Venezia, Stamperia di Venezia, 1978. Ricerche d’archivio a cura di G. Ellero, J. Scarpa e M. C. Paolucci; e P. G. Gillio, L’attività musicale negli ospedali di Venezia nel Settecento, Firenze, Olschki, 2006.2 La dispersione dei fondi musicali è un fenomeno che ha pesato anche sulla storia set-tecentesca degli ospedali, ma che grava in modo assai più drammatico sui due secoli precedenti. Per un breve ma eloquente ragguaglio del fenomeno vedi G. Ellero, La ri-scoperta della musica dei quattro ospedali - conservatori veneziani nel ventesimo secolo, in
RODOLFO BaROnCInI
2
aggiunto, così appannata e lacunosa dal far desistere molti studiosi dal tentativo di ricostruirne il percorso o dal convincerli che soltanto dal tardo Seicento o, al più, dalla seconda metà di questo secolo, gli organici delle figlie di coro acquisirono un’effettiva consistenza e abilità musicali.3
Che gli ospedali della Pietà, dei Derelitti e degli Incurabili, fossero, già nella seconda metà del Cinquecento, dei luoghi ben noti e apprezzati, non solo per il loro fondamentale ruolo sociale e assistenziale, ma per le virtù musicali delle rispettive figlie di coro lo si percepisce da una lettura attenta delle poche fonti note e disponibili sull’argomento. Già il Sansovino nella sua celeberrima guida del 1581, riferendosi a «lo Spedale di san Giovanni, & Paolo» della congregazione dei Derelitti, altresì noto come «Ospedaletto» lo definisce «luogo famoso, & celebre fra gli altri della città».4 Questa nota elogiativa non contiene espressi riferimenti alle esecuzioni delle «fie», ma da alcune delibere votate dalla congregazione tra il 1570 e il 1604 emerge chiaramente come il coro femminile di questo ospedale costituisse all’epoca una realtà musicale ben avviata e riconosciuta, caratterizzata, oltretutto, da molti dei meccanismi che poi diverranno tipici della futura attività musicale dei quattro Ospedali
La musica negli Ospedali. Conservatori veneziani tra Seicento e Ottocento / Musik an den venezianischen Ospedali. Konservatorien vom 17. Bis zum Frühen 19. Jahrhunder, (atti del Convegno, Venezia, 4-7 aprile 2001), a cura di H. Geyer – W. Osthoff, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2004, pp. 1-21.3 non esistono al momento studi di impianto moderno sull’attività musicale degli Ospe-dali maggiori veneziani tra Cinque e Seicento. Gli unici contributi specifici sull’argomen-to sono una coppia di articoli risalenti agli anni Settanta di G. Ellero (Origini e sviluppo storico della musica nei quattro grandi ospedali di Venezia, «nuova Rivista Musicale Ita-liana», XIII/1, 1979, pp. 160-167; e Le scuole musicali degli ospedali veneziani, frutto del metodo educativo di San Girolamo, in San Girolamo Miani e Venezia nel 5° centenario della nascita, Venezia, IRE, 1986, pp. 39-54) le cui notizie sono riprese, senza troppe novità, in studi più recenti di ampio respiro (anche cronologico) come quello di J. L. Baldauf-Berdes (Women musicians of Venice, Musical Foundations, 1525-1855, Oxford, Clarendon Press, 1996, 1a ed. 1993) o quello recentissimo, già citato, di Gillio (L’attività musicale negli ospedali di Venezia nel Settecento). In ogni caso, la percezione che si ricava da tutto quanto è leggibile sull’argomento è che la musica eseguita dalle figlie di coro in questa fase fosse semplice e generalmente priva dell’attrazione virtuosistica tipica dell’aureo pe-riodo settecentesco.4 F. Sansovino – G. Martinioni, Venetia citta nobilissima et singolare descritta in XIIII libri da M. Francesco Sansovino […] con aggiunta di tutte le cose notabili della stessa città, fatte, & occorse dall’anno 1580 fino al presente 1663 da D. Giustiniano Martinioni […], in Venetia, appresso Steffano Curti, 1663, p. 91.
I CaSI DI BaRTOLOMEO BOnTEMPELLI DaL CaLICE E DI CaMILLO RUBInI
3
maggiori. Da una delibera del 1568 apprendiamo, per esempio, che durante l’ufficio dei vespri il «cantar» delle figlie attira «una moltitudine di persone […] che se ne vede de quelle che non vengono per la devotion ad aldir vespro».5 La consuetudine del «cantar in publico» è confermata da un successiva risoluzione del 1571;6 mentre, da una terza delibera del 4 aprile 1575 risulta che le esibizioni canore delle figlie, in virtù delle generose offerte lasciate dagli uditori (devoti e non), sono divenute fonte di un certo guadagno da «applicarsi la mità al maritar, e monacar delle fie e l’altra mità andar in cassa corrente, a beneficio del luogo».7 Una notizia quest’ultima che, se pare eloquente del buon livello professionale raggiunto già in questa fase dal coro dell’Ospedaletto, mostra come da parte dei governatori vi sia piena consapevolezza delle potenzialità insite in una adeguata formazione musicale delle figlie, da coltivarsi non più e non solo come necessità della vita claustrale e ornamento delle celebrazioni liturgiche ma anche come forma di auto-mantenimento e preparazione alla vita delle orfane e, soprattutto, come forma di autofinanziamento, promozione e onorevolezza del luogo e dei suoi governanti. è per tali ragioni che le figlie impegnate nel servizio musicale, già in questa fase, divengono oggetto di particolare attenzione e di piccoli privilegi che vanno dall’esenzione della «tasca» alla concessione di un vitto migliore.
Un evento significativo e inedito del prestigio di cui godeva all’epoca l’Ospedaletto, indicativo dell’eccellenza della formazione (anche musicale) impartita ai suoi figlioli e figliole ci è segnalato da una delibera votata il 15 febbraio del 1579, da cui risulta che per la fondazione del Seminario patriarcale, operativo come quello marciano a partire dal 1580, l’allora patriarca di Venezia Zuanne Trivisan chiese espressamente l’aiuto e la collaborazione della congregazione dei Derelitti:
Havendo presentito questa congregatione che monsignor reverendissimo Patriarca di Venetia desidera sommamente di eriger un seminario di chierici in questa cittade per il beneficio delle anime, et specialmente valersi dell’aiuto di essa congregatione per il governo et buona riuscita di esso et conoscendosi chiaramente questa esser una opera necessarissima utilissima
5 Cfr. Arte e musica all’Ospedaletto, p. 50, documento del 1 novembre 1568.6 Ibidem, documento del 3 maggio 1571.7 Ibidem, documenti del 4 aprile 1575, 11 dicembre 1575 e del 5 febbraio 1576.
RODOLFO BaROnCInI
4
et di grandissima gloria di nostro Signore, fu deliberato che per ms Lunardo Emo e Zuan Battista Contarini nostri fratelli sia trattato con sua signoria reverendissima di questo negocio con quelli modi che saranno prima discorsi et conclusi in questa camera.Ms Hieronimo andrusian presidenti ms Bertucci CiuranMs Lunardo Emo ms Hieronimo Moresini Ms Zuan da Mosto ms Santo RizzoMs Dona’ de Rubin cassier ms antonio de JacomoMs Zuan Balbiani ms Costantin CastagnaMs Polo Priuli ms Bernardin dalla StaieraMs Bortolamio Contarini ms antonio MazzoccoMs Francesco Gradenigo ms Gioan Battista Contarini8
non stupisce, a questo punto, che a prendersi cura della formazione musicale delle figlie di coro i governatori chiamino, verso la fine del Cinquecento, una figura dell’autorevolezza e dell’esperienza didattica di Baldassarre Donato. Subentrato allo Zarlino nel 1590 nella conduzione della cappella marciana,9 Donato insegnava, fin dal 1574, agli «zaghi» della basilica e, dal 1580, agli allievi del neonato Seminario gregoriano.10
altrettanto significative e forse più clamorose di queste fin qui presentate sono alcune testimonianze concernenti il coro dell’Ospedale della Pietà. Che la chiesa di S. Maria della Pietà, che il Sansovino, non a caso, ci dice «benissimo officiata»,11 fosse teatro, verso la fine del Cinquecento, di esecuzioni polifoniche di un certo livello lo si evince già chiaramente dalla ristampa di una raccolta di mottetti a 5 e 8 voci di Ruggero Giovannelli, edita da Giacomo Vincenti, nel 1598, con una espressa dedica «alle virtuose giovani del pio loco della Pietà di
8 Venezia, archivio IRE, Der B.1, notatorio (1546-1604), c. 84, 15 febbraio 1579 (more veneto 1578).9 Donato assunse ufficialmente la guida della cappella il 9 marzo del 1590, dopo un pe-riodo di circa due anni di supplenza dello Zarlino il quale nell’autunno del 1588 si era ritirato per motivi di salute (I-Vas, Procuratoria de supra, Terminazioni, reg. 137, c. 148v, 30 ottobre 1588; ibid., reg. 138, c. 11v, 9 marzo 1590).10 L’incarico a maestro di canto degli zaghi di san Marco risale precisamente al giugno del 1574, mentre la nomina a maestro del Seminario gregoriano, la scuola di chierici della Basilica di S. Marco, istituita ufficialmente nel 1578, ma operativa solo due anni dopo, risale all’agosto del 1580 (I-Vas, Procuratoria de supra, Terminazioni, reg. 133, c. 20v, 3 giugno 1574; ibid., reg. 135, c. 10v, 7 agosto 1580).11 Sansovino – Martinioni, Venetia citta nobilissima, p. 91.
I CaSI DI BaRTOLOMEO BOnTEMPELLI DaL CaLICE E DI CaMILLO RUBInI
5
Venetia».12 Menzionata da svariati studiosi, ma curiosamente mai discussa né riportata parzialmente o integralmente, la dedicatoria del Vincenti costituisce un’inequivocabile attestazione del prestigio e della notorietà di cui godevano all’epoca le «virtuose giovani» della Pietà:
aLLE VIRTUOSE GIOVanI DEL DEVOTO ET PIO LOCO DELLa PIETa DI VEnETIa Come sorelle in Christo honorande. S’Ella è vera. Virtuo e Giouani, la opinione di quei Filo ofi, che affermarono, coloro à cui non piaciono, i Concerti, & le co e Mu icali oggetto dell’udita Corporale, e -ere di concertati d’animo & de co tumi, di maniera che, in un certo modoi puo dire che non siano huomini. Sarà il verò ancora, che quelli, che molto
si dilettano delle belle Harmonie; siano & di pirito, & di ciuiltà molto pregiati. Potrò adonque io liberamente dire, che voi Modestissime Giouani nodrite, & cu todite in loco cosi santo & soto la protetione della Clarissima S. arcanzola da Ponte vostra suprema Gouernatrice, & Gentildonna per nobiltà di sangue, & per santità di vita illustrissima Siate di costumi, di bontà, & di deuotione ornate; poi che come ape andate raccogliendo, nel giardino pieno di tanti fiori, che sono le diuerse Compositioni di valenti Mu ici, le migliori, & quelle riponete in voi stesse, per porgerle, fatte mele suauissimo, al gusto di quelli che bene Concertati l’ascoltano volontieri; Io per ciò vi inuio questi piaceuoli fiori Spirituali, & vè nè faccio dono, acciò come cosa pietosa, & parto nato dal Signor Ruggiero / Giouannelli huomo in questa professione singolare, ripoponiate [sic] fra gli altri odoriferi, / già da voi raccolti, & che à questa nobilissima Città porgete, con tanto vostro honore, / & tanta sodisfattione, & tanto applauso di tutto il popolo. piaccia al Signore di farmi / degno delle vostre Orationi, & preghiere, che con questi Concerti Musicali le porgete / si come io humilmente mi vi raccomando, & prego dal Signore ogni bene. / Dalla mia stampa il primo di Maggio 1598. / Vostro come frattello / Giacomo Vincenti.
Che le parole elogiative del Vincenti non fossero dettate esclusivamente dalla convenienza di omaggiare la governatrice arcangela da Ponte e gli altri patrizi che con alessandro Zorzi di Paulo, nel 1598, governavano
12 Roggerii Ioannelli in basilica vaticana principis apostolorum Mu icæ præfe ti. Sacrarum modulationum quas vulgo Mote ta appellant, quæ Quinis, & O tonis vocibus concinuntur. Liber Primus. Secunda editio. Venetiis. apud Iacobum Vincentium. 1598. L’opera è una ristampa della prima edizione apparsa a Roma nel 1593 per i tipi di Francesco Coattino.
RODOLFO BaROnCInI
6
l’ospedale13 e che effettivamente le giovani cantatrici della Pietà, come «api» dai fiori, cogliessero le composizioni dei migliori musici dell’epoca per trasformarle con «l’applauso di tutto popolo» in «mele suavissimo» è ben attestato da un inedito resoconto, risalente allo stesso anno, che conferisce, una volta tanto, alla storia musicale cinquecentesca degli ospedali quella vivacità e nitidezza di particolari così tipici della sua celebrata stagione settecentesca. Il resoconto in parola fa parte di una serie di reportages concernenti il pellegrinaggio a Loreto effettuato nel 1598 dall’arciduca Ferdinando di Graz e la visita che in quell’occasione compì in incognito a Venezia tra il 29 aprile e il 3 maggio.14 Giunto in Laguna il giorno della Vigilia della Sensa, la massima solennità civico-religiosa veneziana, Ferdinando – come apprendiamo dal dettagliato rapporto delle sue cinque giornate veneziane stilato dal conte Hermes di Porcia per l’arciduchessa Maria von Bayern – nel pomeriggio assistette ai vespri solenni in san Marco e alla musica «bellissima» che vi fu eseguita:
Ricordai poscia che nella chiesa di san Marco si sarebbe cantato un bellissimo Vespero per esser la Vigilia de l’ascensione di nostro Signore, et così se ne venimmo al Vespero dove Sua Serenissima altezza hebbe un luoco comodissimo per poter veder il Doge con la Signoria senza essere veduto da lui, et sentire la musica che fu bellissima.15
La sera stessa il corteo arciducale si recò alle Zitelle ove Ferdinando udì una compieta «molto ben cantata».16 La sera seguente, 30 aprile, fu la volta delle monache di S. Zaccaria che eseguirono una compieta cantata
13 Zorzi, come risulta da un inedito atto notarile concernente l’assegnazione di un co-spicuo lascito alla Pietà da parte del patrizio Pietro Pasqualigo di Vincenzo, ricopriva all’epoca la carica di «rettor e governator del locho della Pietà» (I-Vas, notarile atti, Francesco de Medicis, b. 8370 (1598), cc. 99v-100v, 29 maggio 1598).14 Si tratta di un ampio corpus di lettere di mano dello stesso Ferdinando, di alcuni gen-tiluomini del suo seguito e della arciduchessa madre Maria von Bayern, conservate in Haus-Hof- und Staatsarchiv Wien, Habsburgisch-lothringisches Familien-archiv (Hau-sarchiv), Familienkorrespondenz a, Karton 10, 42, 45.15 Ibidem, Karton 42, n. 144, lettera di Hermes von Porcia a Maria von Bayern del 5 maggio 1598, c. 1r. Stralci della lettera del Porcia assieme a brani di altre lettere sono leggibili in T. antonicek, Italienische Musikerlebnisse Ferdinands II, 1598, «anzeiger der philosophisch-historischen Klasse der Oesterreichischen akademie der Wisseschaften», vol. 104, 1967, pp. 91-111.16 Ibidem, c. 1v.
I CaSI DI BaRTOLOMEO BOnTEMPELLI DaL CaLICE E DI CaMILLO RUBInI
7
«tanto leggiadramente, e gratiosamente, che Sua Serenissima Altezza vi tornò poi un altra volta a sentirne un’altra».17 Finalmente, la sera del primo maggio, scrive il conte di Porcia,
andammo ad una Compieta a la Pietà cantata da quelle Vergini, che ci fecero stupire, poiché cantano ogni cosa sicura per difficile che ella si sia, et fra le altre cose cantate ci fecero sentire, il Percussit Saul mille, del Chiozotto.18
Il «Chiozotto» è naturalmente Giovanni Croce, all’epoca vice-maestro della cappella di San Marco e, con Giovanni Gabrieli, uno dei massimi esponenti della scena musicale veneziana. Mentre, il Percussit Saul mille, mottetto in stile concitato, pubblicato da Croce nel suo Primo libro di mottetti a 8 voci (e due cori) del 1594, è indubbiamente un brano d’effetto, richiedente a causa delle ricorrenti batterie di crome una certa rapidità e sicurezza d’esecuzione.19 Testimonianza nitida e inequivocabile della bravura delle vergini della Pietà e di una fama che si appresta a valicare i confini lagunari, il resoconto del Porcia fornisce anche materia per avanzare qualche ipotesi sia sulla conduzione musicale del coro della Pietà in un’epoca di cui nulla c’è dato di sapere, sia sugli eventuali retroscena di quella esecuzione. V’è più di una ragione per credere che l’esecuzione in quell’occasione di un’opera di Croce di facile presa e sicuro effetto come il Percussit, non fosse casuale. Benché non vi siano evidenze dirette in grado di confermarlo, è del tutto verosimile che il maestro incaricato della cura musicale delle virtuose della Pietà fosse proprio il Chiozzotto. Che la guida del coro di un istituto da sempre sotto la protezione e la diretta influenza del Doge e del patriziato che contava fosse affidata a un membro illustre e in ascesa della cappella di San Marco appare più che comprensibile, considerato anche che, all’epoca, l’anziano Baldassarre Donato aveva già il suo da fare con i chierici del seminario gregoriano e con il coro dell’Ospedaletto. a Croce, infine, non mancava l’esperienza didattica poiché, dal 1592, anch’egli aveva iniziato a coadiuvare il maestro di cappella nella cura dei giovani del Seminario.20 17 Ibidem, c. 4r.18 Ibidem, c. 4v.19 Mottetti ad otto voci comodi per le voci, e per cantar con ogni stromento, Venetia, Giaco-mo Vincenti, 1594.20 I-Vas, Procuratoria de supra, Terminazioni, (1589-1600), reg. 138, c. 79v, 31 gennaio
RODOLFO BaROnCInI
8
Se questa ipotesi è esatta l’impeccabile esecuzione del Percussit da parte delle virtuose giovani della Pietà non fu probabilmente una semplice esibizione di bravura, ma una sorta di preordinata auto-promozione del loro intraprendente maestro il quale, da tempo, come mostrano le dediche accluse al suo Primo e Secondo libro di mottetti a otto voci (indirizzate, la prima, all’ambasciatore cesareo Raimondo Della Torre e, la seconda, allo stesso arciduca Ferdinando), era alla ricerca di un legame mecenatesco con gli asburgo e che, non a caso, come apprendiamo dal Porcia, in quegli stessi giorni, la sera, si esibiva nella residenza dell’ambasciatore imperiale con la propria compagnia di canto al cospetto dell’arciduca.21 L’eventualità che Croce fosse il maestro del coro della Pietà e che dietro le brillanti esecuzioni udite dall’arciduca di Graz vi fosse la sua regia, aiuta anche spiegare l’interesse di Giacomo Vincenti per questo ospedale. è forse per mera coincidenza che Vincenti firmi la sua dedicatoria alle giovani della Pietà il primo maggio del 1598, proprio lo stesso giorno in cui queste si esibiscono al cospetto dell’arciduca. Un fatto tuttavia è certo. autore di punta del catalogo della «Pigna», Croce, come mostrano recenti ritrovamenti documentari, era in strettissimi rapporti con l’editore veneziano.22 è possibile, dunque, che sia proprio su suggerimento dell’amico compositore, che Vincenti abbia risolto di indirizzare una propria stampa alle coriste della Pietà: un omaggio che costituiva un riconoscimento della loro virtù, ma indirettamente anche del prestigio del loro maestro.
Che i cori femminili della Pietà, dei Derelitti e – come vedremo ora – degli Incurabili fossero già verso la fine del Cinquecento delle realtà musicali consolidate, protagoniste riconosciute e apprezzate della vita musicale cittadina, non deve stupire. L’operatività sociale di questi ospedali è infatti attiva già da svariati anni. Se la Pietà, sorta, com’è noto,
1593 (more veneto 1592).21 Si veda in merito la succitata lettera di Hermes von Porcia a Maria von Bayern del 5 maggio 1598, c. 4r. Va rilevato, tuttavia, come il desiderio del Chiozzotto di allacciare un rapporto privilegiato con la corte di Graz (privilegio che gli sarà precluso dalla per-sonalità dominante di Gabrieli) era un’ansia comune, fin dagli anni Settanta, a tutte le maestranze musicali lagunari (cfr. R. Baroncini, Giovanni Gabrieli, Palermo, Fondazione Cini-L’Epos, in corso di stampa, Parte prima, paragrafo II.8).22 Cfr. R. Baroncini – L. Collarile, Vincenti Giacomo e Alessandro, in Dizionario degli editori musicali italiani 1500-1750, a cura di B.M. antolini, Pisa, ETS, in corso di stampa.
I CaSI DI BaRTOLOMEO BOnTEMPELLI DaL CaLICE E DI CaMILLO RUBInI
9
esclusivamente per la cura dei fanciulli esposti, è un’istituzione antica risalente addirittura al secolo xiv, i Derelitti e gli Incurabili sorgono entrambi negli anni Venti del Cinquecento, sull’onda della nuova pietas controriformista. è questa un’idea di carità attiva che superando l’approccio individualistico di quella medievale (in cui la salvezza dell’anima del benefattore costituisce il movente principale), volge ora la sua attenzione al ricovero e al recupero sociale e spirituale delle fascie più deboli e diseredate della popolazione (anziani inabili, malati curabili e incurabili, mendicanti, orfani e esposti); un’attenzione che, nel caso dei minori di entrambi i sessi, si traduce in un rigoroso programma di istruzione e preparazione al lavoro e alla vita.23 Finalità lodevoli, ma che in quell’inestricabile intreccio di convenienze politico-sociali e religiose tipico dell’epoca, si realizzavano – è bene ricordarlo – a prezzo della segregazione e della evangelizzazione forzata degli assistiti.24
Prescindendo da virtù e vizi della ‘nuova filantropia’, quello che urge ribadire ai nostri scopi è che, verso la metà del Cinquecento, gli Ospedali maggiori veneziani erano delle istituzioni pienamente operative. E ciò in virtù dell’impegno pratico e morale di una serie di patrizi devoti, come Girolamo Miani, Girolamo Cavalli, Giovan Battista Contarini e altri,25 ma anche per l’apporto sempre crescente di esponenti del ricco ceto cittadinesco, mercanti e impreditori che trovando nella appartenenza a queste istituzioni un modo per accrescere la propria onorabilità e il proprio prestigio sociale, vi portano, oltre alla loro ricca esperienza economica e organizzativa anche i loro interessi culturali. Trattasi, in buona parte, di cittadini già membri delle Scuole Grandi e, particolarmente, della Scuola Grande di S. Rocco che, al di là di una più o meno sincera devozione, colgono comunque nel vento della nuova filantropia l’opportunità di
23 Sulla nuova filantropia controriformista e le sue applicazioni veneziane si veda l’eccel-lente e ormai classica monografia di B. Pullan, Rich and Poor in Renaissance Venice. The Social Institution of a Catholic State, to 1620, Oxford, Basil Blackwell, 1971, trad. it.: La politica sociale della repubblica di Venezia 1500-1620, 2 voll., Roma, Il Veltro, 1982, vol. I, Parte seconda, La nuova filantropia.24 Si veda in merito quanto osserva B. Pullan, La nuova filantropia nella Venezia Cinque-centesca, in B. aikema – D. Meijers, Nel regno dei poveri. Arte e storia dei grandi ospedali veneziani in età moderna 1474-1797, con contributi di D. arnold, G. Ellero, G. Marcolini, R. Palmer e B. Pullan, Venezia, IRE, arsenale Editrice, 1989, pp. 19-34.25 Sulla figura, in particolare, di Girolamo Miani e i suoi rapporti con gli ospedali dei Derelitti e degli Incurabili vedi Pullan, La politica sociale, pp. 278-281.
RODOLFO BaROnCInI
10
nobilitare ulteriormente la propria immagine e di garantirsi durata e memoria. Un percorso, questo, che è assai ben illustrato dai casi di Bartolomeo Bontempelli dal Calice e di Camillo Rubini, approdati, dopo anni di militanza nella Scuola di S. Rocco, l’uno all’ospedale degli Incurabili (e poi ai Mendicanti) e l’altro a quello dei Derelitti.
Gestore di una merceria sita, all’insegna del Calice, in S. Salvador, il Bontempelli che era giunto in laguna con pochi mezzi assieme al fratello Grazioso verso il 1550, dovette la sua straordinaria fortuna e la sua rapida ascesa sociale alla produzione e al commercio di stoffe pregiate che gli valsero in poco tempo l’attenzione di una clientela altamente selezionata comprendente tra gli altri l’arciduca di Graz, il duca di Mantova e il sultano. Ottenuta nel 1579 la cittadinanza de intus e de extra, si diede con successo anche al commercio di cinabro e mercurio (una sola operazione con l’arciduca Ferdinando gli fruttò ben 70.000 fiorini) accumulando un patrimonio tale da consentirgli da avviare un’intensa attività finanziaria, includente frequenti e grossi prestiti a Ferdinando di Graz e a Vincenzo Gonzaga.26 La popolarità e il prestigio sociale del Bontempelli, tuttavia, furono determinati soprattutto dal suo forte impegno caritativo, orientato, come mostra il suo interesse nei confronti degli Ospedali prevalentemente, anche se non solo, al sostegno degli strati più diseredati della popolazione.27 La lista delle istituzioni caritative e degli ordini religiosi veneziani che beneficiarono del suo sostegno è lunga e comprende, oltre all’Ospedale degli Incurabili di cui parleremo fra breve, l’Ospedale dei Mendicanti, la Scuola Grande di S. Rocco (di
26 Sul Bontempelli, oltre al profilo generale tracciato da U. Tucci, Bontempelli (Bontem-pello) dal Calice (Calese) Bartolomeo, in DBI, vol. 12, 1970, pp. 426-427, si veda anche quello, assai dettagliato sulle vicende iniziali della sua fortuna, fornito da G. Corazzol, Varietà notarile: scorci di vita economica e sociale, in Storia di Venezia, vol. VI, Dal Rina-scimento al Barocco, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1994, pp. 775-791. Sulla sua acquisizione della cittadinanza de intus e de extra si veda invece a. Bellavitis, “Ars mechanica” e gerarchie sociali a Venezia tra XVI e XVII secolo, in M. arnoux – P. Monnet, Le technicien dans la cité en Europe occidentale, 1250-1650, Rome, École Française de Rome, 2004, pp. 161-179: 173; mentre sul credito che egli fornì agli asburgo di Graz si veda a. De Maddalena – H. Kellenbenz, La Repubblica internazionale del denaro tra XV e XVII secolo, Istituto storico Italo-Germanico, 1986, pp. […].27 Estremamente eloquente, in merito, è quanto riporta il medico-cronista coevo Gian Carlo Sivos: «uomo [il Bontempelli] molto elemosinario, et che ogni anno fa elemosina per molti migliaia de ducati, et si vede che il signor Dio dà cento per uno ai suoi devoti elemosinieri» (I-Vnm, mss italiani, Cl VII, 1818 [9436], c. 129).
I CaSI DI BaRTOLOMEO BOnTEMPELLI DaL CaLICE E DI CaMILLO RUBInI
11
cui il Bontempelli era divenuto confratello nel 1580 e Guardian Grande nel 1599),28 la chiesa delle Convertite alla Giudecca (di cui finanziò la ricostruzione), i cappuccini (sovvenzionati tra il 1585 e il 1591 con diverse somme di danari) e i frati girolamini delle Grazie.29
Va da sé come per un uomo delle facoltà e del prestigio del Bontempelli esercitare una qualche forma di patrocinio artistico fosse un fatto quasi fisiologico. Il menu delle sue relazioni artistico-musicali è infatti ricco e vario: compositori del calibro di Giovanni Gabrieli30 o meno noti ma di tutto rispetto come il fiorentino Pietro Lappi,31 musici marciani come il tenore Paulo Veraldo (che fu anche prolifico autore di commedie), il tenore Francesco Cassani e il violinista Battista Zanetti,32 letterati e 28 Cfr. Venezia, archivio della Scuola Grande di S. Rocco, Registi delle Parti, reg. 3, cc. 230v-231; ibidem, «Banche e zonte della veneranda Scuola di san Rocco», reg. 33, cc. nn.29 Bontempelli finanziò la fabbrica dei Mendicanti prima con una tranche di 30.000 ducati e quindi, dopo la sua morte, con un lascito di 100.000 ducati (cfr. Tucci, Bontempelli, p. 427). Fece inoltre restaurare a proprie spese la chiesa delle convertite alla Giudecca di cui nel 1606 era divenuto «cassier sopra la fabrica» (B. aikema – D. Meijers, Le convertite. Chiesa e ospedale di Santa Maria Maddalena, in Nel regno dei poveri, pp. 191-195: 191) e fece erigere alcuni altari nella chiesa di S. Salvador e nella Scuola di S. Rocco; opere per le quali egli è ricordato dal Martinioni nel suo aggiornamento alla guida del Sansovino (Sansovino – Martinioni, Venetia città nobilissima, pp. 88 e 123). Sui finanziamenti ai cappuccini vedi D.M. Da Portogruaro, Storia dei cappuccini veneti, 1979, Volume 2, […]; mentre per i danari versati ai girolamini, all’epoca allocati nella convento di santa Maria delle Grazie in isola, si veda la lettera dedicatoria indirizzata al Bontempelli da Pietro Lappi riportata e discussa più avanti.30 Sui rapporti del Bontempelli con G. Gabrieli vedi Baroncini, Giovanni Gabrieli, Parte prima, paragrafo II.8.31 Frate girolamino e per molti anni maestro di cappella della Basilica delle Grazie di Bre-scia, Lappi dedicherà al Bontempelli, come vedremo in dettaglio più avanti, la raccolta La Terza con il Te Deum: et Litanie della B. Vergine, et Santi. A Otto voci di Pietro Lappi fiorentino Maestro della Musica di santa Maria delle Gratie in Brescia […] In Venetia, appresso alessandro Raverij, 1607.32 Sulle relazioni del Bontempelli con il cantante-drammaturgo Paulo Veraldo vedi R. Miller, The Composers of San Marco and Santo Stefano and the Development of Venetian Monody (to 1630), Ph.D. dissertation, University of Michigan, 1993, p. 61; per quel che riguarda il Cassani che nel 1607 ottene un prestito dal mercante bresciano, vedi I-Vas, Procuratia de supra, Chiesa actorum (1607-1614), reg. 140, cc. 15v, 8 novembre 1607; mentre su Zan Battista di Piero Zanetti alias Zane o Zanotti, «dicto dal violin», attivo dal 1607 in S. Marco, il quale, oltre che al Bontempelli, era legato da un vincolo di pa-drinaggio anche con il patrizio Pietro Foscarini, vedi I-Vacp, Parrocchia di S. Cassian, Battesimi, reg. 1, cc. nn., lettera C, 31 agosto 1595; ibidem, lettera P, 24 luglio 1584; ibi-dem, Parrocchia di S. aponal, Battesimi, reg. 1, cc. nn., lettera E, 18 marzo 1589; e I-Vas, notarile atti, Girolamo Brinis, b. 770, cc. 312v-313v, 10 agosto 1610.
RODOLFO BaROnCInI
12
commediografi, ‘dilettanti’, come il medico-filosofo di origine bresciana Fabio Glissenti (autore di alcune «favole morali» di successo)33 e, professionali, come il celebre comico Giovan Battista andreini34 e, infine, pittori in ascesa come Sante Peranda.35 Che il Bontempelli coltivasse ab antiquo interessi e ambienti musicali lo si evince già dai suoi stretti rapporti con alessandro de Bonis un facoltoso merciaio di S. Salvador legato a doppio filo con andrea Gabrieli e angelo Gardano.36 Mentre, che egli non fosse del tutto sprovveduto in materia lo dimostra una sua lettera del 1592 a un imprecisato funzionario della corte mantovana con la quale commissiona a Giaches de Wert la composizione di un mottetto, su un testo, da lui allegato alla missiva, purtroppo perduto:
33 Sono due le favole morali del Glissenti recanti una dedica al Bontempelli: Il diligente overo il sollecito favola morale dell’E. Sig. Fabio Glissenti. Al M. Magnif. & Illustre Sig. Bartolomeo Buontempelli dal Calice. In Venetia, Appresso Gio. Alberti, 1608, un’opera il cui protagonista è chiaramente ispirato alla esemplare vicenda personale del Bontempelli e L’Andrio cioè l’huomo virile Favola Morale dell’Eccellentiss. Sig. Fabio Glissenti […]. In Venetia, appresso Ciovanni alberti, 1607. Originale esponente dell’ambiente riformatore veneziano con forti simpatie per i gesuiti, Glissenti, oltre a un corposo dialogo sulla mor-te (Discorsi […] contra il dispiacer del morir, Venezia, Domenico Farri, 1596), fu autore di numerose altre «favole morali», commedie allegoriche di argomento moraleggiante, strutturalmente modellate sulla pastorale (cinque atti in endecasillabi, ciascuno conchiu-so da un coro strofico) che godettero di una certa fortuna editoriale e rappresentativa.34 Relazioni particolari, in virtù anche delle sue aderenze mantovane, doveva avere il Bontempelli con l’andreini il quale gli dedicò un volumetto contenente ben due compo-nimenti: La Maddalena di Gio. Battista Andreini fiorentino e la Divina visione in soggetto del B. Carlo Borromeo dello stesso, Venezia, Somasco, 1610 (cfr. F. Fiaschini, L’«incessabil agitazione». Giovan Battista Andreini tra professione teatrale, cultura letteraria e religione, Pisa, Giardini, 2007, pp. 93-100). 35 Sante Peranda i cui stretti rapporti con i fratelli Bontempelli sono ben attestati dai re-gistri canonici delle parrocchie di S. Martin e S. Marco (I-Vacp, parrocchia di S. Martin, Matrimoni, reg. 1, 1587-1615, cc. nn., 27 dicembre 1589; ibid., parrocchia di S. Marco, Registri canonici diversi, reg. 1, 1571-1649, c. 19, 5 settembre 1594), eseguirà per l’altare, fatto erigere in S. Salvador da Bartolomeo, una tela raffigurante la pietà, s. Carlo Borro-meo e i ritratti dello stesso Bartolomeo e del fratello Grazioso, tutt’oggi conservata in loco.36 Il dato si evince dal confronto tra tre inedite fonti documentarie concernenti andrea Gabrieli, angelo Gardano e il Bontempelli dalle quali risulta come tutti avessero allaccia-to una relazione di parentela spirituale con il succitato de Bonis. Un intreccio di relazioni che potrebbe essere indizio della frequentazione di uno stesso ambiente o di un ridotto musicale di cui forse il de Bonis era fra gli animatori (cfr. I-Vacp, Parrocchia di S. Salva-dor, Battesimi, reg. 1, 1564-1584, c. 100, 15 giugno 1583; ibid., c. 149, 9 gennaio 1575 (more veneto 1574); ibid., c. 151, 2 dicembre 1578).
I CaSI DI BaRTOLOMEO BOnTEMPELLI DaL CaLICE E DI CaMILLO RUBInI
13
assicurato dalla solita cortesia di vostra Signoria illustre vengo a pregarla si degni fare ufficio col signor Giachet Vuert che facci stampare il motetto qui occluso come vien detto in essa polizza et quanto prima lo farà tanto più mi sarà grato, di che si degnerà vostra signoria illustre favorirmi di risposta [ ] cioè componerlo, come saprà meglio esso signor Giachet et vostra signoria mi perdoni il disturbo [ ].37
Per quale speciale evento o per conto di chi il Bontempelli scomodasse il maestro della cappella mantovana non ci è dato di sapere. Certo è che i suoi interessi musicali furono strettamente integrati con quelli caritativi e con il ruolo non solo di finanziatore che egli svolse nell’ambito degli Ospedali. a rivelarcelo con dovizia di particolari è la lettera dedicatoria acclusa a una raccolta di musica liturgica di Pietro Lappi del 1607 (La terza con il Te Deum a otto voci)38 a lui indirizzata da cui risulta che il Bontempelli era governatore dell’Ospedale degli Incurabili e che, in tale veste, teneva in particolar cura le annesse figlie di coro del cui canto si dilettava e alle quali evidentemente l’opera del Lappi era destinata. Considerato il silenzio documentario che fino a questo momento ha gravato sugli Incurabili, questa fonte, ignorata sia dalla letteratura musicologica sugli Ospedali che dai biografi del Bontempelli, assume un’importanza tale dal meritare una trascrizione integrale:
all’illustre signor mio osservandissimo il signor Bartolomeo Bontempelli dal Calice. Le gloriose imprese, che in serviggio d’Iddio, con spese di generosità da Prencipe, V. S. ha sempre con un perpetuo, e felicissimo corso fatte, & va tutta via facendo; come movono gl’istessi Prencipi ad amarla, e preggiarla al pari de meriti suoi; così allettano quelli etiandio, che di vista non la conoscono, ma per fama di lontano la riveriscano, a procacciare la gratia, & servitù sua, con tutti quei meglior modi che loro possibil sia. Fra
37 I-Maa, archivio Gonzaga, busta 1524, f. III, c. 299, Lettera di Bartolomeo Bontempelli dal Calice da Venezia del 21 gennaio 1592 alla corte di Mantova. La missiva è parzialmen-te riprodotta in a. Bertolotti, Musici alla corte dei Gonzaga in Mantova dal secolo XV al XVIII […], Milano, G. Ricordi & C., 1890, p. 46; e in M. Sermidi, Le collezioni Gonzaga. Il carteggio tra Venezia e Mantova (1588-1612), Milano, Silvana Editoriale, 2003, p. 140, documento 143.38 La raccolta consiste in un’intonazione a 8 voci e due cori dei canti di Terza: l’inno Nunc sancte nobis spiritus, la terza, quarta e quinta parte del lungo salmo 118, il Te Deum, le Litaniae B. Virginis Mariae, le Litaniae de Sanctis, il Laudate Dominum e un mottetto (Tota pulchra es) di antonio Bertani.
quali io ancora debole soggetto, ma a lei cordialissimamente affettionato, & per me stesso, & molto più per la liberalità uguale all’altre sue, usata sovente alla Religion mia in cotesta eccelsa Città di Veneggia, ho voluto con questo picciol dono, & aggratiarmi V. S. & sodisfar in parte ai molti oblighi, che le tiene la mia cara Madre. Sappiamo che fra i molti santi, & devoti trattenimenti, che V. Sig. si piglia di cotesta sua honoratissima età, uno, & molto principale è la melodia, & canto delle divine lodi, le quali da coteste fanciulle de gl’Incurabili, quasi angeli di Paradiso, da lei, con particolar cura governate, & poco men che affatto mantenute, sono mandate al Cielo. Serviranno credo al medesimo suo devotissimo gusto ancora queste operette di Musica, che io mando in luce come dono fatto a V. S. la quale mi confido, che sia per riceverlo, con quella cortesia, & amore che sono tanto proprij della gentilissima natura sua; si come le vengono recate da huomo, che desiderarebbe con molto più nobile, & chiaro argomento, palesar al mondo, & i molti meriti di lei, & l’obligo grande, che tutti noi altri le teniamo: & quivi facendo fine, prego Iddio n. S. che longamente la conservi a honor suo, & beneficio di tutte l’opre pie di cotesta Città. & le bascio la mano. Di Venetia il Primo settembre 1607. Di V. S. Illustre affetionatiss. Servit. Fra’ Pietro Lappi.
Dunque anche agli Incurabili, come alla Pietà e ai Derelitti, sulla spinta e la protezione di devoti e competenti patroni, le figlie di coro costituiscono già all’inizio del Seicento, una compagine ben avviata e qualificata in grado di eseguire non solo il consueto repertorio polifonico a doppio coro, bensì anche come prevede il Lappi nelle avvertenze accluse al «Basso principale per l’organo», episodi in uno stile simil-concertante (vedi esempio 1) in cui segmenti a voce sola, migranti da una voce all’altra e, talvolta, duetti sono giustapposti antifonalmente a episodi a quattro voci e a tutti:
anchorcha [sic] in queste mie fatture si possino cantare tutte le parti sempre a piacere de Maestri o de cantori, pur in alcune come si vede nella Partitura dell’organo, ho voluto anco che si possino cantare, talvolta parte per parte, & tal volta due insieme, con simil modo stimando di più dilettare gli ascoltanti, & moverli a divotione per la recitatione delle parole che si ode più chiaramente, & anco perché il cantore andandosi più adaggio in simil caso, possa più gratiosamente dimostrare le sue perfettioni. Sarà carico dell’organista o del maestro di avisare a chi toccherà, nel modo descritto da
me dovendosi sempre nell’organo praticar questa sorte di concerti, sia tutto a laude del Signore, che io desiderandovi felici vi bacio le mani.39
In questa procedura, concernente esclusivamente tre brani della raccolta (le Litaniae B. Virginis Mariae, le Litaniae de Sanctis e il Te Deum laudamus), e facilmente applicabile, in virtù della loro stretta omoritmia, si possono cogliere almeno due aspetti di un certo interesse. Essa, in generale, ci rivela come una scrittura polifonica tradizionale come quella a coro spezzato, potesse all’atto performativo con pochi accorgimenti essere aggiornata agli stilemi del nuovo fervore concertante. Mentre, ai nostri stretti fini, le indicazioni concertanti del Lappi, ammesso che la sua raccolta – come pare plausibile – sia stata effettivamente eseguita agli Incurabili, costituiscono un chiaro indizio di come, già all’epoca, l’uso e l’apprezzamento della voce sola non fossero estranei alla pratica degli Ospedali (si veda l’Es. 1: Pietro Lappi, Te Deum, 1607). Un altro prezioso contributo alla ricostruzione della prima storia musicale degli Ospedali ci è fornito dal caso di Camillo Rubini (1557-1630) e dal suo stretto rapporto con i Derelitti. Priva dei contorni di singolarità ed eccezionalità che improntano l’immagine del Bontempelli, la figura del Rubini (pur venendo da una famiglia agiata egli non raggiunse né la ricchezza né la celebrità del merciao bresciano) è per tal motivo più rappresentativa del percorso seguito da altri mercanti di ceto cittadinesco. Figlio di Donato Rubini di Tomaso e di Cecilia Milani di Polo e residente in S. Marcuola nel campiello de l’anconeta,40 Camillo era proprietario di una «bottega de ogli et savoni» in Rialto e di una ben avviata «savoneria» attigua alla sua abitazione.41 Oltre che nella produzione e nel commercio di saponi pregiati era impegnato in società con Giovan Battista Benzi nel commercio di panni
39 Basso principale per l’organo della Terza, et litanie si della B. Vergine come de Santi et hinno Te Deum a otto voci. Di Pietro Lappi fiorentino maestro della musica in S. Maria delle Gratie in Brescia, In Venetia appresso alessandro Raverii 1607, p. 19, [avvertimenti].40 Sullo stato di Famiglia e il luogo di residenza del Rubini vedi I-Vacp, Curia, Sezione antica, Status animarum, Contrada di S. Marcuola [1592], cc. 27r-28v. nel documento da cui risulta che all’epoca Camillo risiedeva con il padre e la madre, non figurano però i fratelli Tomaso, deceduto alcuni anni prima, e Rubino che dopo le sue nozze con Camilla Colonna si era trasferito nella contrada di S. Fosca.41 Le notizie si evincono, oltre che da svariati atti notarili, dal testamento autografo di Camillo (I-Vas, notarile testamenti, Giulio Ziliol, b. 1242, cedola 194, 12 agosto 1630).
di lana42 e aveva un negotio di carte di cambi con uno studio in cui operavano diversi «zoveni», sito in san Silvestro.43 Diversamente dal Bontempelli, Rubini fu animatore, fin dagli anni Ottanta, assieme ai fratelli Tomaso e Rubino di un attivo ridotto letterario-musicale frequentato da personaggi del calibro di Orazio Vecchi (che a Camillo e Tomaso dedicherà il suo Terzo libro di canzonette a quattro voci del 1585)44 e di Giovan Battista Zuccarini, letterato di origine feltrina, autore nel 1579 di una silloge di sonetti dedicati a Bianca Capello che godranno, alcuni anni dopo, di una fortunata intonazione musicale cui contribuiranno Marenzio, i due Gabrieli e lo stesso Vecchi.45 Più tardi Camillo che, in quanto membro e dirigente della Scuola di S. Rocco doveva conoscere assai bene anche Gabrieli,46 entrerà in relazione con due giovani compositori di stretta fede gabrieliana come Giovan Battista Grillo e, soprattutto, Giovan Battista Riccio. Quest’ultimo infatti allaccerà con i Rubini una duplice relazione di parentela spirituale47 e a Camillo dedicherà il suo Primo libro delle divine lodi [...] a 2 voci e basso continuo, apparso in seconda edizione con aggiunte nel 1612, e presumibilmente in prima (oggi dispersa) verso il 1610.48 Una relazione stretta e durevole quella di Riccio con i Rubini se ancora nel Terzo libro delle divine lodi musicali, edito nel 42 I-Vas, notarile atti, Giovanni andrea Catti, busta 3384 (1607), cc. 103v-104v, 13 marzo 1607.43 Oltre succitato testamento, vedi anche I-Vacp, parrocchia di S. Marcuola, Battesimi, reg. 5, Lettera P, 22 febbraio 1614 (m. v. 1613), da cui risulta che lo studio era allocato nella contrada di S. Silvestro.44 Canzonette di Horatio Vecchi da Modona libro terzo a quattro voci. Nouamente posto in luce. Con Privilegio. In Venetia appresso angelo Gardano 1585.45 Corona di dodici sonetti di Gio. Battista Zuccarini alla gran Duchessa, di Toscana posta in musica da dodici eccellentiss. auttori a cinque voci. In Venetia, appresso angelo Gardano 1586. Per un quadro esaustivo del ridotto Rubini vedi Baroncini, Giovanni Gabrieli, Parte prima, paragrafo I.3.2.1, I «mercadanti» di Cannaregio.46 Presente con una certa frequenza negli organi di governo della Scuola (Banca e giunta), Camillo nel 1593 è eletto Vicario e nel 1614 Guardian Grande (Venezia, archivio della Scuola Grande di San Rocco, Libro delle Banche e li XII agonti (sic), reg. 38, cc. n.n., anni 1593 e 1614).47 nel 1610 Zan Battista Rubini, il primogenito di Camillo, tiene a battesimo Marietta Riccio la quintogenita del compositore, mentre nel 1612 Rubin Rubini, fratello minore di Camillo, tiene a battesimo Paula, la sestogenita (I-Vacp, Parrocchia di S. Margherita, Battesimi, reg. 3, 1608-1618, c. 21v, 3 giugno 1610; e ibid., c. 40, 28 maggio 1612).48 G. B. Riccio, Il primo libro delle divine lodi accomodate per cantar nell’organo. A due voci con il suo basso continuo [...] Novamente reviste, e ristampate. Con l’aggiunta in questa ultima impressione d’alcuni concenti armonici spirituali a una doi, & tre voci. Dell’istesso Auttore. In Venetia appresso Ricciardo amadino, 1612.
1620, il compositore intitolerà una delle dodici canzoni da sonar incluse nella raccolta «La Rubina»: una composizione per «doi violini overo cornetti & trombon», il cui incipit, significativamene, altri non è che una citazione letterale della celebre Canzon noni Toni (C173) a 8 voci di Gabrieli.49 Tra i personaggi frequentanti ca’ Rubini nel corso del primo decennio del Seicento v’era un medico di S. Marcuola, tal Giacomo Castellano,50 che animato – come molti suoi colleghi – da forti ambizioni letterarie, tra il 1608 e il 1610, aveva dato allo stampe per i tipi di Evangelista Deuchino e Giovan Battista Pulciani svariate raccolte di rime di argomento profano e spirituale: I giovanili scherzi, rime varie, dedicati ai principi di Savoia,51 la Sacra triade, Canzoni di argomento spirituale dedicate al duca di Urbino;52 il Testamento amoroso, idillio, dedicato a Vincenzo Gonzaga53 e, infine, una raccolta di Rime spirituali e morali. Edite nella primavera del 1608, quest’ultime, anziché essere indirizzate a qualche principe, sono dedicate «al molto illustre sig. Camillo Rubini».54 L’acclusa lettera dedicatoria è paragonabile per quantità e qualità di informazioni a quella precitata del Lappi:
al molto illustre sig. Camillo Rubini.Due cause principalmente mi movono a dedicare a V. S. queste mie poche Rime Spirituali; l’una; perché desiderando di mostrare in qualche modo l’affetto dell’animo mio verso lei, non ho saputo trovare più opportuno mezo di questo. L’altra; perché essendo buona parte di queste compositioni
49 Su questo specifico caso di citazione e, in generale, sui rapporti tra Gabrieli e Riccio vedi Baroncini, Giovanni Gabrieli, Parte prima, paragrafi I.3.2.1 e ii.9, e Parte seconda, paragrafo VI.2.1.50 La professione e la residenza del Castellano (da non confondersi con l’omonimo e coevo Jacobus Castellanus, teologo trevigiano, autore di un’opera in latino edita da Ro-berto Meietto nel 1602) si evincono da una registrazione battesimale della contrada di S. Marcuola (I-Vacp, Parrocchia di S. Marcuola, Battesimi, reg. 2, c. 43v, 3 marzo 1588).51 I giovanili scherzi, Rime varie di Jacomo Castellano. Dedicate a i serenissimi prencipi Vittorio Amadeo et filiberto di Savoia […] in Venetia appresso Evangelista Deuchino, e Giambatista Pulciano, 1608.52 Sacra triade natività, morte e resurretione di Cristo. Canzoni di Iacomo Castellano, de-dicate al serenissimo duca d’Urbino. In Venetia appresso Evangelista Deuchino, & Gio: Battista Pulciani, 1608. 53 Testamento amoroso, Idillio di Giacomo Castellano, dedicato al serenissimo Don Vincen-zo Gonzaga, In Venetia, appresso Gio. Battista Pulciani, 1610.54 Rime spirituali, et morali. Di Iacomo Castellano. Al molto illustre signore, il signor Ca-millo Rubini dedicate, in Venetia, appresso Evangelista Deuchino, & Gio: Battista Pul-ciani, mdcviii.
fatte da me per le figliuole dell’Ospitale de SS. Gio. e Paulo, al governo del quale V. S. con somma Carità s’impiega; & in particolare per quella, nella musica tanto eccellente, che dalla pietà di lei è tenuta particolarmente per figliuola Spirituale, ben di ragion si conveniva, ch’alla prottetion di lei anco queste mie fatiche fossero raccomandate. aggiungerei per terza ragione, che l’obligo mio a questo m’astringe; se l’impostomi silentio della sua modestia non m’obligasse a tacerlo: ma se tacerlo convengo, siami lecito almeno mostrar di non obliarlo. E non sdegni V. S. ricever da me per hora questo picciol segno di riconoscimento, sin tanto ch’io possa meglio sodisfar al mio debito. Con che pregandola a favorirmi de’ suoi commandi, le bacio le mani. Di Venetia il dì 14 Maggio 1608.Di V. S. molto illustre Servitore affetionatissimo Iacomo Castellano.
Dunque, il Rubini era governatore dell’Ospedale dei Derelitti. Inoltre, è proprio «per le figliuole di questo ospedale» e, particolarmente, «per quella tanto eccellente nella musica» che il Castellano ha scritto «buona parte di queste composizioni». Sappiamo da un superstite notatorio dell’Ospedale, nonché dai Capitoli et Ordini del 1667, che effettivamente il 28 marzo del 1604 Rubini era stato eletto governatore55 e che, già nel febbraio del 1605, aveva ottenuto assieme a Zan Francesco Lippomano e Marcantonio Zorzi l’ufficio di deputato «sopra le fie et fioli».56 Dal che si educe che similmente a quanto aveva fatto il Bontempelli agli Incurabili, Rubini aveva preso sotto la sua protezione le figlie di coro e, particolarmente, «quella tanto eccellente nella musica» che egli aveva eletto a sua figliola spirituale. Di che natura fossero, più precisamente, le virtù musicali di questa giovane lo si può comprendere se si prova ad aprire la lente sulle Rime a lei destinate. Un’attenta lettura di questi versi rivela, intanto, che il Castellano era persona assai vicina ai Derelitti, mostrandosi ben informato dell’insieme delle pratiche ricreative – letterarie, musicali e teatrali – che le figlie, a dispetto degli impossibili ritmi claustrali prescritti dal Capitolare del 1667, erano solite coltivare
55 Venezia, archivio IRE, Der B.1, notatorio (1546-1604), c. 132, 28 marzo 1604 («Fu elletto per Governator di questo magnifico Ospital il magnifico signor Camillo Rubini […]); e ibid., «Capitoli, et Ordini Per il buon Governo del Pio Hospitale de Poveri Dere-litti appresso Santi Giovanni, e Paolo di Venetia […]», 1567 e 1568, c. 48 («Governatori […] 1604 28 marzo Camillo Rubini de Donà […]»).56 Venezia, archivio IRE, Der B.1, notatorio (1546-1604), c. 133, 2 febbraio 1605 (more veneto 1604).
ed esternare di fronte a pietosi e munifici uditori.57 Se, in generale, i sedici madrigali e gli undici sonetti spirituali formanti il grosso della sua raccolta rientrano senza difficoltà nell’ampio filone della poesia per musica (e come tali presumibilmente, al di là delle loro immediate finalità ricreativo-spirituali furono intesi dall’autore), i riferimenti al canto e ai «canori accenti» sono in essi così frequenti e, nel caso dei due esempi riportati di seguito,58 così espliciti dall’indurre a credere che la giovane virtuosa protetta dal Rubini fosse una dotata cantatrice:
[argomento:] «Desidera che il suo canto accenda di celeste amore» Sacro spirto del cielo,Tu ch’addolcisti i miei canori accentiOnd’altri hebbe in udir gioia, e dilettoQuanto già vaghe, hor altrettanto ardentiFa le mie voci col tuo santo zelo,Ch’infiamma i cori di celeste affettoOnd’a tua gloria il vanto Dar mi giovi al mio canto,E dir: O fortunato il cantar mioCh’accende l’alme dell’amor di Dio
[argomento:] «L’umiltà el core innalza il canto al cielo» Basso è il mio canto, e vileSiccome basso e vile è il mio pensiero, Che tanto è basso più quanto più altero.Così con vario stilePiù grande è il più arrogantenel cieco mondo errante;Ma nel Cielo è maggiore quel ch’è più humilealma Vergine Dea,Che per vera humiltadeMadre fosti a colui, che il tutto bea;
57 Lo dimostrano i quattro madrigali (Caggiano homai le tenebrose tende; O miseri mor-tali; S’affretti homai, s’affretti, e’l chiaro albergo; e Col patir co’l soffrire) che il Castellano dedica al ricordo di una serie di rappresentazioni teatrali recitate dalle figlie nel 1606 e nel 1607.58 Rime spirituali et morali. Di Iacomo Castellano, pp. 10 e 16.
Tu fa’ l mio cor humil, ch’a l’alto coroS’udrà’l mio canto alhor dolce, e sonoro
Di virtuose cantore allevate nell’ambito del coro dei Derelitti nei primi due-tre decenni del Seicento abbiamo notizia, del resto, dal testamento steso nel 1630 dal libraio Pietro Coletti, un assiduo frequentatore delle prodezze musicali di queste figlie di coro cui egli lascia la cospicua somma di 200 ducati, da essere equamente divisi tra loro, lasciando però anche altri cento ducati a una tal «Lauretta cantora […] per affetione a lei pigliata per il suo cantar, che tra tutte quelle più mi piaceva».59
L’eventualità che presso l’Ospedaletto nel primissimo Seicento vi fossero dotate cantore capaci magari di prodursi anche nell’ambito del nascente mottetto a una e due voci, induce ad avanzare una seconda ipotesi mirata a far riemergere dalle nebbie la qualità dei repertori che si eseguivano agli ospedali in questa prima fase.
Si è visto come il Rubini, pochi anni dopo il suo ingresso ai Derelitti, avesse preso sotto la sua particolare protezione l’organista Giovan Battista Riccio, autore, va ricordato, tra il 1610 e il 1620, di ben tre raccolte di Divine lodi, contenenti prevalentemente mottetti a una e due voci e continuo. Riccio, nel 1610, probabile data della sua prima edizione del Primo libro delle divine lodi, era entrato in relazione, oltre che con i Rubini, con un altro mercante di ceto cittadinesco: Matteo noris, un ricco merciao della contrada di S. Giovanni Grisostomo, il quale nel 1608 era stato eletto anch’egli governatore dei Derelitti.60 Il fatto che due dei suoi principali patroni svolgessero un incarico di rilievo ai Derelitti e, soprattutto, il peso che una figura musicalmente coltivata come il Rubini, può aver svolto nelle scelte musicali dell’ospedale, rende plausibile che anche Riccio fosse implicato in qualche modo con i Derelitti. Se l’idea di un suo possibile impiego come maestro di musica è smentita da una memoria, compilata nella seconda metà del Settecento, da cui risulta che a svolgere questo incarico nel 1612 v’era
59 Arte e musica all’Ospedaletto, pp. 108-109.60 Per le relazioni tra Riccio e il noris vedi I-Vacp, Parrocchia di S. Margherita, Battesimi, reg. 3, 1608-1618, c. 21v, 3 giugno 1610. Mentre per l’elezione di noris a governatore vedi Venezia, archivio IRE, Der a.3, «Capitoli, et Ordini Per il buon Governo del Pio Hospitale de Poveri Derelitti […]», 1567 e 1568, c. 48 («Governatori […]1608 29 luglio Mattio noris quondam Zuan Giacomo»).
Giovanni Bassano61 (informazione attendibile, visto l’ineccepibile curriculum didattico del Bassano e visto che era stato proprio lui, nel 1596, a rimpiazzare il Donato al Seminario marciano),62 non è invece da scartarsi l’eventualità che alcuni dei suoi mottetti a una e due voci e continuo (in particolar modo quelli per due soprani e per due contralti) fossero tra il materiale utilizzato dalle figlie di coro nel corso delle principali solennità dell’anno che, ai Derelitti, erano l’assunta (festa del titolo), la natività della Vergine, le feste quaresimali e della Settimana Santa, la Pasqua, la Pentecoste e il natale. è lecito credere, del resto, che quello mottettistico costituisse probabilmente, già all’epoca, il tipo di repertorio più eseguito nell’ambito degli ospedali. In un documento indirizzato alla congregazione dei Derelitti databile al 1675 Legrenzi sostiene di aver scritto nell’arco di cinque anni oltre 70 mottetti63 e antonio Pollarolo in una nota allegata a un documento consimile asserisce di averne composto, tra il 1716 e il 1730, 185.64 Si tratta di numeri considerevoli sovrastanti di diverse lunghezze quelli concernenti i salmi e gli altri repertori liturgici65 che non possono certo ascriversi esclusivamente agli ovvi cambiamenti verificatisi nel corso del tempo, ma che sono, verosimilmente anche il riflesso di una precedente e ben stabilita consuetudine. Consuetudine che forse spiega anche perché un compositore autorevole ma non particolarmente innovativo come natale Monferrato, nel 1655, mandi alle stampe una raccolta di mottetti a voce sola composta «per esercitio delle allieve» dell’Ospedale dei Mendicanti.66
61 Venezia, archivio IRE, Der. G. 2, fascicolo Musica, «Informatione per Musica all’Ospe-dal de Derelitti», foglio a.62 Bassano, fin dal 1582, era stato il coadiutore del Donato nell’educazione musicale degli «zaghi» della basilica e dei chierici del seminario. Ciò spiega perché i procuratori nel 1596 lo individueranno come naturale sostituto del Donato nel magistero del Seminario. è ovvio a questo punto ritenere, come attesta la succitata memoria, che a rimpiazzare il Donato all’Ospedaletto dopo la sua morte sia stato, probabilmente fin dal 1604, proprio il Bassano (cfr. I-Vas, Procuratoria de supra, Terminazioni, 1580-1582, reg. 135, c. 61v, 1 gennaio 1582, more veneto 1581; ibid., Terminazioni, 1589-1600, reg. 138, c. 153r-v, 16 marzo 1596).63 Arte e musica all’Ospedaletto, Lettera di dimissioni del maestro don Giovanni Legren-zi, pp. 123-124.64 Venezia, archivio IRE, Der. G. 2, n. 48, c. 23.65 Il numero dei mottetti sovrasta, per esempio, quello dei Salmi più nettamente in Pol-larolo (che dice di aver composto 185 mottetti e 95 salmi) e in misura più moderata in Legrenzi (che dichiara di aver composto oltre 70 mottetti e oltre 60 salmi).66 Motetti a voce sola di D. Natale Monferrato Vice Maestro di Cappella della Serenissima Republica Dedicati Al Clarissimo Signor Gio. Domenico Biava. Libro Primo. Opera Quarta.
Riesumare la storia musicale degli ospedali tra Cinque e Seicento è dunque importante anche per una piena comprensione degli indirizzi che queste istituzioni svilupperanno negli anni successivi. Gli ‘squarci’ modesti ma significativi aperti in questo contributo dimostrano come, a dispetto della perdita della documentazione ufficiale e dei repertori musicali, sia possibile, rintracciando e coniugando fonti ‘alternative’ di diversa congerie, ricomporre un quadro apparentemente irricostruibile. Lo confermano ricerche ancora in corso su un aspetto fin qui inedito della pratica ricreativo-spettacolare degli ospedali: le rappresentazioni teatrali con inserti e intermezzi musicali che le figlie di coro nei primi anni del Seicento erano solite allestire e recitare in tempo di carnevale. Un argomento ulteriormente dimostrativo della precoce vivacità e vitalità di queste istituzioni che, pur essendo strettamente integrato con quanto svolto nel presente articolo, richiede per la sua specificità di essere affrontato in un contributo a parte.67
In Venetia appresso alessandro Vincenti 1655.67 R. Baroncini, Musica e teatro negli Ospedali maggiori veneziani tra Cinque e Seicento, in preparazione.