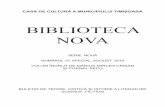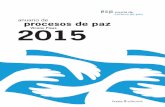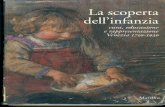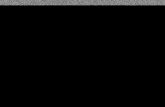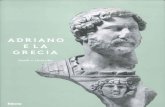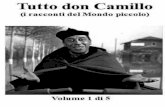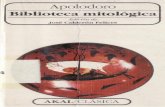Lo spazio della biblioteca accademica. Seminario di studi, Pavia, 3 marzo 2015.
Camillo Baldassarre Zamboni ordinatore della Biblioteca Martinengo
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Camillo Baldassarre Zamboni ordinatore della Biblioteca Martinengo
Alessia Cotti
Camillo Baldassarre Zamboniordinatore della Biblioteca Martinengo
Pubblicato in
Viaggi di testi e di libriLibri e lettori a Brescia tra Medioevo e età modernaa cura di V. Grohovaz
Udine, Forum, 2011
ALESSIA COTTI
CAMILLO BALDASSARRE ZAMBONI ORDINATOREDELLA BIBLIOTECA MARTINENGO
La biblioteca dei Martinengo da Barco
Le vicende della collezione Martinengo sono strettamente legate alla storia della Biblioteca Queriniana. Per la precisione alla volontà lungimirante dell’ultimo erede dei da Barco, Francesco Leopardo V che, qualche anno prima della mor-te avvenuta il 6 agosto 1884, decideva di donare la raccolta libraria di famiglia alla prestigiosa biblioteca bresciana1. Sebbene non sia stato possibile consultare direttamente il testamento redatto nel febbraio del 1879, il ritrovamento di una serie interessante di documenti nell’archivio della Queriniana ci ha consentito di ricostruire materialmente le fasi che portarono al deposito. Fu il notaio Giusep-pe Sartori, pochi giorni dopo la scomparsa del conte, a scrivere all’allora diret-tore della Queriniana Filippo Garbelli, per informarlo della donazione riceven-done in cambio il presente biglietto:
Brescia, 14 settembre 1884Biblioteca Civica QuerinianaN° 752Illustre signore,In nome della commissione mi onora avvertire la signoria vostra illustrissima di aver ricevuto comunicazione del legato fatto a favore di questa biblioteca dal benemerito e compianto conte Leopardo Martinengo.Con perfetta stima,
DevotissimoFilippo Garbelli2
1 Per la donazione e la figura del Martinengo si veda P. GUERRINI, Una celebre famiglia lombarda. I conti di Martinengo. Studi e ricerche genealogiche, Brescia, F.lli Geroldi, 1930, p. 231.2 Brescia, Biblioteca Queriniana, Archivio, B 11, 1884, fasc. 3 Doni.
ALESSIA COTTI148
Alla prima comunicazione faceva seguito la richiesta, al comune e sempre da parte dello stesso Garbelli, di un nuovo scaffale:
Biblioteca Civica Querinianan. 86
Brescia 6 Febbraio 1885
Onorevole Giunta Municipale in Brescia
La commissione, in sua seduta 1° Febbraio, deliberava di far costruire apposite teche per meglio conservare alcuni preziosi codici miniati di questa biblioteca e principalmente il codice di Sant’Eusebio. Deliberava inoltre la costruzione di un nuovo scaffale per accogliere i libri del legato Martinengo. Tanto mi pregio parteciparle, affinché si compiaccia provvedere in proposito3.
Ma evidentemente il numero cospicuo di volumi richiedeva ben altro, se presto si arrivava allo sgombero di una scuola elementare:
I libri legati del benemerito conte Leopardo Martinengo vogliono essere tra-sportati presso questa biblioteca. Sono essi numerosi e ordinati in propri scaffa-li donati dalla generosa cortesia de’ nobili eredi, vorrebono servarsi distinti, in propria sala, col nome a onore dell’illustre benefattore, di sala Martinengo4. A quest’uso non può la scrivente Commissione se non destinare la stanza ora oc-cupata da una scuola elementare: ed è quindi costretta a far preghiera che sia la detta scuola mutata altrove, per effettuare sollecitamente il detto trasferimento.
La Commissione5
Biblioteca Civica Querinianan. 309
Brescia 30 Marzo 1885
Onorevole Giunta Municipale in Brescia
La sottoscritta Commissione fa sue istanze all’Onorevole Giunta affinché voglia procedere allo sgombero della sala terrena di questa biblioteca, ora occupata da
3 Brescia, Biblioteca Queriniana, Archivio, B 11, 1885, fasc. 1 Municipio.4 In realtà il progetto di dedicare una sala al Martinengo non venne mai realizzato, il suo nome trovò spazio, con altri generosi benefattori, su una lapide che ancor oggi è ben visibi-le in uno dei saloni della biblioteca. Quanto ai volumi, sgomberata la rumorosa scuola ele-mentare, vennero collocati nella sala al piano terreno dell’edificio queriniano.5 Brescia, Biblioteca Queriniana, Archivio, B 11, 1885, fasc. 1 Municipio.
149CAMILLO BALDASSARRE ZAMBONI ORDINATORE DELLA BIBLIOTECA MARTINENGO
una scuola elementare. Tra pochi giorni perverrà alla Queriniana la copiosa collezione dei libri legatile dal benemerito conte Leopardo Martinengo e, come risulta da apposita visita, le altre sale non sono assolutamente in grado di conte-nerla. La Commissione spera che questa Onorevole Giunta apprezzando la ra-gionevolezza della domanda e l’urgenza del caso, si compiacerà provvedere onde cessi al più presto l’occupazione di questo locale da parte della scuola, occupazione che non è scompagnata da gravi inconvenienti i quali riescono spesso di non poco disturbo ai frequentatori di questo istituto: per tutti basta accennare ai canti quotidiani in cui si esercitano gli allievi6.
Infine la raccolta veniva materialmente spostata da palazzo Martinengo7 nel novembre del 1885, provocando la chiusura della Queriniana per tre giorni:
Biblioteca Civica Querinianan. 1031
Brescia 26 Novembre 1885
Illustrissimo Signore,Prego far noto nel di Lei pregiato giornale che la biblioteca Queriniana rimarrà chiusa al pubblico nei giorni 27, 28 e 29 corrente Novembre dovendosi proce-dere al trasporto della libreria legata dal testamento del quondam conte Leopar-do Martinengo.
Con perfetta stimaIl direttoreF. Garbelli8
Si trattava di un’acquisizione di ampio respiro economico per la Querinia-na, della quale subito il “regio delegato” chiedeva conto a nome del Comune di Brescia:
Municipio di BresciaBrescia 23 Giugno 1885
Urgentissimon. 8517
Onorevole Signor Bibliotecario della Queriniana Brescia
6 Brescia, Biblioteca Queriniana, Archivio, B 11, 1885, fasc. 1 Municipio.7 Ricordiamo che prima di essere collocata tra le pareti della Querinina, la biblioteca Mar-tinengo si trovava nell’antico palazzo di famiglia che attualmente ospita la Pinacoteca Tosio-Martinengo.8 Brescia, Biblioteca Queriniana, Archivio, B 11, 1885, fasc. 9 Miscellanea.
ALESSIA COTTI150
Dovendosi provvedere al pagamento della tassa dell’1 per 1000 [ …] in data 3 Maggio che autorizzava il Comune di Brescia ad accettare i lasciti disposti a fa-vore di esso dal fu conte Leopardo Martinengo, prego la compiacenza della Si-gnoria Vostra Illustrissima di volermi far conoscere, possibilmente per domani, il valore approssimativo degli enti legati alla biblioteca dal benemerito defunto9.
Il Garbelli così immediatamente rispondeva:
Biblioteca Civica Querinianan. 565
Brescia 24 Giugno 1885
Onorevole Regio Delegato del Comune di Brescia
Per quanto riesca difficile determinare il valore complessivo di una biblioteca i cui libri stampati e manoscritti non siano stati ancora sottoposti ad un minuto esame, lo scrivente tuttavia da una prima visita fatta oggi stesso alla libreria Martinengo crede di poterla approssimativamente valutare in una cifra variabile dalle lire quattromila alle cinquemila10.
Giunta alla sua nuova destinazione, nel corso dei mesi successivi la biblio-teca veniva sottoposta ad un più articolato esame così da compilare un Inven-tario dei libri legati dal benemerito signor conte Leopardo Martinengo alla biblio-teca Queriniana11. Il documento si proponeva di quantificare la reale consisten-za della raccolta depositata in relazione ai cataloghi compilati nel XVIII secolo da Camillo Baldassarre Zamboni12. Nell’inventario, i bibliotecari segnalavano l’acquisizione di 30 incunaboli, la presenza di 29 opere incomplete, ed anche tutta una serie di annotazioni che dimostravano l’evoluzione della raccolta do-po l’operazione di riordino condotta dall’erudito bresciano. In particolare si evidenziava la presenza di 6 manoscritti registrati nel Catalogo di Zamboni ma mancanti all’atto della consegna, di 302 libri a stampa registrati nel Catalogo ma mancanti dalla libreria13, di 383 libri a stampa non registrati nel Catalogo ma esistenti nella libreria e indicati come “non duplicati”, di 123 libri a stampa
9 Brescia, Biblioteca Queriniana, Archivio, B 11, 1885, fasc. 1 Municipio.10 Brescia, Biblioteca Queriniana, Archivio, B 11, 1885, fasc. 1 Municipio.11 Brescia, Biblioteca Queriniana, Archivio, F 5, Protocollo n. 1155.12 C.B. Zamboni (Montichiari 1723 - Calvisano 1797), storico ed erudito bresciano di rara cultura, fu l’ordinatore teorico e materiale della biblioteca Martinengo. Su di lui avremo modo di soffermarci a lungo nelle prossime pagine.13 In questo modo indichiamo la biblioteca Martinengo per distinguerla dalla biblioteca Queriniana.
151CAMILLO BALDASSARRE ZAMBONI ORDINATORE DELLA BIBLIOTECA MARTINENGO
non registrati nel Catalogo ma esistenti nella libreria e indicati come “duplica-ti” e infine di 93 stampe e disegni a mano che, non essendo materiale librario, non avevano trovato posto nell’opera di catalogazione dello Zamboni.
Successivamente i manoscritti, gli incunaboli e le cinquecentine prendevano la strada delle sezioni loro dedicate e gli altri stampati venivano ridistribuiti nelle diverse sale della civica biblioteca14. L’immagine che di questo fondo ci restituisce oggi la Queriniana, quindi, è falsata dai successivi smembramenti, nondimeno la fortunata sopravvivenza di una serie di inventari e cataloghi ad essa riferiti ci consentono di avventurarci, seppure virtualmente, in una delle collezioni più interessanti che la città di Brescia potesse vantare15.
Non è possibile conoscere con assoluta certezza l’anno di nascita della Martinengo. Come spesso accade per le raccolte librarie private. Dovendo tuttavia indicare un nome, almeno come punto di partenza, cominceremo con il suggerire quello del conte Francesco Leopardo II, vissuto nella seconda metà del XVII secolo, citato dallo Zamboni come uno dei personaggi che più alacremente si adoperarono per la creazione di una biblioteca di famiglia16. Non che prima di lui fossero mancati personaggi degni di nota per il loro impegno culturale: i Martinengo da Barco infatti, non diversamente da molte altre famiglie aristocratiche, unirono sempre in un unico, forte e imprescindi-bile connubio l’impegno civile con quello della promozione del sapere, ma possiamo affermare che la coscienza, o forse sarebbe meglio dire l’esigenza, di
14 Si veda R. ZILIOLI FADEN, Libreria Martinengo Da Barco, in I fondi speciali delle bibliote-che lombarde, II, Milano, Editrice bibliografica, 1998, p. 218.15 Significative in tale direzione le considerazioni di Giulio Antonio Averoldi: «Non credia-te scarsa la nostra patria di curiosi dilettanti, no, v’avrei introdotto nelle stanze del nobil uomo conte Leopardo Martinengo, ove in più armari vagamente lavorati avreste voi ben veduto qual bell’innesto sia quello della nobiltà e della virtù. Sono essi pieni di quantità di volumi in ogni scienza, e con maggiore ansietà ricercati, li più esotici e rari né tra questi li-miti si trattiene il virtuoso diletto» in G. A. AVEROLDI, Le scelte pitture di Brescia additate al forestiere, Brescia, Rizzardi, 1700, p. 252. Sebbene si trattasse di una collezione privata, la sua consistenza e la sua ricchezza dovevano dunque essere ben noti, se consentivano di annoverarla tra le tappe più significative del panorama culturale cittadino.16 C. B. ZAMBONI La libreria di sua eccellenza il nobil uomo signor Leopardo Martinengo pa-trizio veneziano conte di Barco, condomino di Villanuova, feudatario di Pavone, e signore di Clanesso, cogli uomini illustri della chiarissima famiglia Martinengo umiliata al medesimo cavaliere dalla spettabile comunità di Calvisano, Brescia, Vescovi, 1778, pp. 79-84. Il testo, oltre ad essere un saggio di catalografia di notevole interesse, rappresenta una fonte prezio-sa di informazioni per un numero considerevole di personaggi della famiglia Martinengo, si vedano in proposito le pp. 58-138. Notizie su Francesco Leopardo II anche in L. COZZAN-DO, Libreria bresciana. Prima e seconda parte. Nuovamente aperta dal M.R.P. Maestro Leonar-do Cozzando servita bresciano, Brescia, Rizzardi, 1694, pp. 124-125 e P. GUERRINI, Una cele-bre famiglia lombarda, pp. 222-225.
ALESSIA COTTI152
una raccolta ordinata e fruibile si fece sentire con forza proprio nel XVII se-colo, quando la fisionomia della “libraria” doveva aver raggiunto dimensioni tali da richiedere, per la sua stessa gestione, uno sforzo non indifferente. Di tale esigenza rimangono oggi tre inventari manoscritti, che entrarono a far parte del patrimonio queriniano con il resto della raccolta all’atto del suo de-posito, essi consentono di delinearne il carattere prima degli interventi con-dotti nel XVIII secolo.
I manoscritti queriniani I III 14, I I 3 e I II 25
Nel tentativo di comprendere in quale condizione versasse la raccolta prima degli interventi di riordino del XVIII secolo, potrà forse essere utile seguire le sorti di un testo, attraverso le sue diverse collocazioni17. Avremo così la possi-bilità di constatare con quale fatica e con quanta difficoltà si potesse cercare e ritrovare lo stesso libro a distanza di tempo, sebbene nella medesima collezio-ne. Lo facciamo presentando innanzi tutto il manoscritto queriniano I III 14 indicato con il titolo di Indici tre de libri. Si tratta di un codice cartaceo compi-lato presumibilmente nel XVII secolo, non sappiamo se da un solo autore, delle dimensioni di 300 x 210 mm nel quale appare la numerazione solo per le ultime 169 pagine. Sono qui riuniti quattro diversi indici variamente organizza-ti attestanti le opere a stampa e manoscritte presenti nella raccolta:
[ff. 53] I sezione[Catalogo topografico-alfabetico]I libri sono organizzati per formato: in folio, in quarto, in ottavo e gli autori ci-tati in ordine alfabetico per nome. Risultano distribuiti in “vestiari” o “vestari” cioè in armadi talora accompagnati da un numero d’ordine, vestario primo, ve-stiario secondo… o anche con indicazioni quali “Vestarietto alto in capo alla sala verso sera”)18
17 Abbiamo scelto in proposito LEONARDO DA VINCI, Trattato della pittura di Lionardo da Vinci. Nuovamente dato in luce, con la vita dell’istesso autore scritta da Rafaelle du Fresne. Si sono giunti i tre libri della pittura e il trattato della statua di Leon Battista Alberti, con la vita del medesimo, Parigi, appresso Giacomo Langlois, stampatore ordinario del rè Christianissi-mo, al monte Santa Genovefa, dirimpetto alla fontana, all’insegna della Regina di pace, 1651.18 Per vestiario/vestario è da intendersi l’armadio dove fisicamente trovavano posto i volu-mi. La forma vestario è attestata, proprio in questa accezione, alla voce Vestiario1, in Gran-de dizionario della lingua italiana, XXI, Torino, UTET, 2002, p. 816: «Region. Guardaroba, armadio. Beccaria, II-489: L’archivio, che consiste in un piccolo vestaro, è posto in pochis-simo ordine, né vi ho trovato rubrica o repertorio».
153CAMILLO BALDASSARRE ZAMBONI ORDINATORE DELLA BIBLIOTECA MARTINENGO
Ecco un esempio:Vestario 13 in folio
Leonardo da Vinci. Trattato della pittura. Parigi 1651 T 1 Lire 40
Nella sezione dei libri in ottavo i vestari 18 e 19 presentano una catalogazione incompleta nella quale manca l’indicazione del tipografo e l’anno di stampa ad esempio:
Vestario 18Francesco Pona. Galleria delle donne celebri T 1 Lire 1.10
Le indicazioni riprendono complete dal vestiario 20. Abbiamo 24 vestari nume-rati e altri 6 denominati con la loro posizione ad es. “Vestarietto verso la Garza a mattina”. In totale si trattava di 30 vestari.Ciò che interessa notare in questa sede è sicuramente l’indicazione del valore per ogni opera. Saremmo di fronte, dunque, ad un tentativo non solo di defini-re la consistenza numerica della raccolta ma anche a quello di quantificarne lo spessore economico. Sarà qui solo il caso di ricordare che i libri, a qualsiasi li-vello della gerarchia sociale, se da un lato squisitamente culturale rappresenta-vano uno strumento di affermazione e di autodefinizione, dall’altro alludevano ad un bene economico, ed era quindi fondamentale conoscerne l’esatto valore. La biblioteca, là dove se ne possedeva una, rientrava a pieno titolo tra le voci che componevano l’eredità, che si trattasse di famiglie nobili o meno. Appare, dunque, normale e legittimo che i Martinengo, di fronte al continuo ampliarsi della loro raccolta libraria e nella prospettiva di eventuali divisioni patrimoniali, sentissero l’esigenza di conoscere con sufficiente precisione a quanto ammontas-se il valore della libreria19.
19 Si pensi a quello che accade alla morte del mercante di pelli Felice Montanari: «La figlia Giulia, moglie di un farmacista locale, alla morte del padre si rifiutò di separarsi completa-mente da questo affascinante patrimonio [allude alla biblioteca paterna descritta preceden-temente] e raggiunse un accordo con il fratello Antonio e la sorella Chiara. In base a questo accordo, le opere più interessanti vennero spartite tra Giulia e Antonio, mentre il resto andò alla sorella Chiara. Evidentemente nel tardo Settecento i libri erano ancora un segno di prestigio o un “mezzo di promozione sociale”, ma, e forse questo è l’elemento più impor-tante, erano, per chi li possedeva, soprattutto degli strumenti di autodefinizione». In B. DOOLEY, Lettori e letture nel Settecento italiano, in L’editoria del ’700 e i Remondini, Atti del convegno (Bassano, 28-29 settembre 1990), a cura di M. INFELISE - P. MARINI, Bassano del Grappa, Ghedina et Tassotti Editori, 1992, p. 20. Per quanto concerne la questione relativa alla divisione della biblioteca di famiglia, apprendiamo dal testamento rogato da Francesco Leopardo III il 5 maggio 1707 che la collezione era stata precedentemente smembrata, ve-rosimilmente dopo la morte di Francesco Leopardo II avvenuta nel 1689, ma concordemen-te con i fratelli Lodovico e Giovanni Battista, Leopardo III stabilì che fosse nuovamente ricomposta e trasmessa in perpetuo ai primogeniti maschi e che non venisse mai più divisa
ALESSIA COTTI154
[3 ff.][Celebrazione della famiglia Avogadro]
[7 ff. non numerati]bianchi
[59 ff. non numerati]II sezione [Catalogo alfabetico]L’organizzazione risulta assai complessa: gli autori sono registrati in ordine alfa-betico per nome e poi ulteriormente divisi per formato con rimando al vestario. Sono elencati tutti gli autori dalla A alla Z in folio, quelli in quarto e infine quel-li in ottavo. Prendendo l’esempio già proposto vedremo che l’opera è ora indi-cata secondo quanto segue:
L in folio11 Leonardo da Vinci. Trattato della pittura. T 1 V 13
Tutti i volumi sono ora preceduti da un numero. È verosimile ipotizzare che si tratti del numero d’ordine occupato dal libro sul palchetto. Notiamo che non compare più il valore dell’opera.
[4 ff. non numerati]bianchi
[53 ff. non numerati] III sezione [Catalogo topografico-alfabetico]Indicazione con tutti i libri in folio, in quarto, in ottavo presenti nel vestario I, II, III…Considerando sempre la stessa opera ritroviamo la medesima indicazione biblio-grafica già registrata nella prima sezione dell’inventario:
Vestario 13°In folio
Leonardo da Vinci. Trattato della pittura. Parigi 1651 T 1 L 40
Ricompaiono il numero dei tomi e il valore, ma spesso mancano l’indicazione dell’editore e la data di stampa.È questa la parte dell’inventario nella quale sono attestate azioni di riorganizza-zione del materiale come nel caso dei titoli in ottavo registrati al vestario 21 dove leggiamo: “Libri tolti dal vestario 8 e posti al 21. Libri da porsi nel vestario
tra gli eredi. Si veda il testamento in M. POLI, Francesco Leopardo Martinengo da Barco: tradizioni nobiliari e cultura nella Brescia del Seicento, tesi di laurea, relatore C. Donati, Milano, Università degli Studi, a.a. 2004-2005, pp. 93-94. Per i tre Martinengo rimandiamo a P. GUERRINI, Una celebre famiglia lombarda, pp. 225-226.
155CAMILLO BALDASSARRE ZAMBONI ORDINATORE DELLA BIBLIOTECA MARTINENGO
21 in 8°” In questa pagina troviamo appunto la serie di testi che risultano can-cellati nel vestario 8.
[2 ff. non numerati]bianchi
169 pp. numerate e [3 ff. non numerati] IV sezione [Catalogo per materie e indice]Ancora una volta gli autori sono elencati secondo il formato in folio, in quarto e in ottavo e in ordine alfabetico per nome ma ora sono organizzati, potremmo dire, per materia. Ricompare l’indicazione con il numero dei volumi e la collo-cazione nell’armadio. Il nostro testo è ora confluito a pagina 163 tra i libri in folio:
Di Agricoltura, Giardini e simili, Economia,Scalceria, Pittura, Scultura, Caccia e Giochi
In folioLeonardo da Vinci. Trattato della pittura. T 1 Vestario 13°
Alla fine dell’inventario compare anche un vero e proprio indice, con riman-do al numero preciso della “carta” alla quale cercare i volumi relativi ad una certa materia:
– Cosmografici, Cronologici, Geografici, Istorici di monarchie o repubbliche; Viaggi, Discrittioni di provincie, isole, paesi; Relazioni et altre materie istori-che universali; Sacri e profani
In foglio, carta 1 In quarto, [carta] 4 In ottavo e piccolo, [carta] 15
– Istorici di città et altri luoghi particolari, sacri e profani In foglio, [carta] 26 In quarto, [carta ]28 In ottavo e piccolo, [carta] 33
– Vite, elogi e attioni di personaggi illustri sacri e profani, cataloghi e bibliote-che
In foglio, [carta] 36 In quarto, [carta] 38 In ottavo e piccolo, [carta] 44
– Genealogie di famiglie illustri. Origine e casi di cavaglieri e religiosi secolari e regolari
ALESSIA COTTI156
In foglio, [carta] 48 In quarto, [carta] 49 In ottavo e piccolo, [carta] 50
– Medaglie, Marmi, Religioni, Usi, Riti e Magistrati antichi, Note antiche, Cose sepolcrali et altre antichità istoriche
In foglio, [carta] 51 In quarto, [carta] 53 In ottavo e piccolo, [carta] 56
– …, Emblemi, Simboli, Geroglifici, Sentenze, Motti e Proverbi In foglio, [carta] 58 In quarto, [carta] 58 In ottavo e piccolo, [carta] 60
– Teologici, di Sacra Scrittura, Religione cattolica, Riti et Ordini sacri, Casi di conscienzia, Prediche, Sermoni, Essempi e miraculi
In foglio, [carta] 82 In quarto, [carta] 83 In ottavo e piccolo, [carta] 86
– Spirituali, Morali, Politici, Civili e di varia erudizione In foglio, [carta] 90 In quarto, [carta] 91 In ottavo e piccolo, [carta] 98
– Legali, Militari, di Diritto, Paci, Nobiltà, Honore, Blasonerai et altre materie cavalleresche
In foglio, [carta] 110 In quarto, [carta] 112 In ottavo e piccolo, [carta] 116
– Rettorici, Gramatici, Poetici, Lettere, Orazioni, Rime, Romanzi sacri e pro-fani, Novelle
In foglio, [carta] 120 In quarto, [carta] 122 In ottavo e piccolo, [carta] 128
– Matematici, Aritmetici, Geometrici, di Fortificazione, Architettura, Gnomo-nica, Macchine o simili
In foglio, [carta] 147 In quarto, [carta] 148 In ottavo e piccolo, [carta] 150
– Filosofici naturali, Medici, Chimici, Cirugici, Historie di animali, … Piante, Herbe, Metalli e simili
157CAMILLO BALDASSARRE ZAMBONI ORDINATORE DELLA BIBLIOTECA MARTINENGO
In foglio, [carta] 151 In quarto, [carta] 152 In ottavo e piccolo, [carta] 154
– Astrologici, Fisionomici, Chiromantici e simili, di Divinazione, …, Sibille, Vaticini, Oracoli, Auguri e Sogni
In foglio, [carta] 159 In quarto, [carta] 159 In ottavo e piccolo, [carta] 161
– Di Agricoltura, Giardini e simili, Economia, Scalceria, Pittura, Scultura, Caccia e Giochi
In foglio, [carta] 163 In quarto, [carta] 163 In ottavo e piccolo, [carta]165
– Di figura diverse… e non In foglio, [carta] 167 In quarto, [carta] 167 In ottavo e piccolo, [carta] 168
Al codice si accompagna anche un fascicolo di 20 fogli non numerati delle dimensioni di 300 x 105 mm, non rilegato con il manoscritto, nel quale sono elencati i libri contenuti nei cassetti dei vestari.
L’indicazione bibliografica è assoluta mente scarna: nome e cognome dell’au-tore e titolo dell’opera spesso abbreviata. Le indicazioni sembrano dire che nei cassetti erano conservate le copie doppie.
Prendiamo ad esempio il caso di un’opera di Teofilo Folengo nel suddetto fascicolo indicata come duplicato e conservata nel cassetto del “Vestario 12 sotto il cornicione”:
Vestiario 12° sotto il cornicioneLimerno Orlandino Pitocco duplicato
Una seconda copia, sempre in ottavo, si conservava invece al vestiario 9 come registra appunto il ms I III 14:
L in ottavoVestiario 9°
21 Limerno Orlandino Pitocco T 1 V 9 duplicato
Entrambe le copie sono ora conservate in Queriniana. Si tratta di due diver-se edizioni dell’opera del Folengo. Per la precisione sembra di poter intuire che
ALESSIA COTTI158
nel vestario nono ci fosse la prima edizione stampata a Venezia da Gregorio Gregori nel 152620, mentre nel vestario dodicesimo era custodita l’edizione del 1550 stampata sempre a Venezia ma da Agostino Bindoni con l’aggiunta di numerose ottave21. Tale ipotesi sembrerebbe confermata dal confronto tra i diversi inventari, nei quali sempre compare, sebbene con segnature diverse, solo l’edizione del 1526 a chiara testimonianza dei diversi tentativi di riorganiz-zazione del materiale librario che si trovava, per così dire, a scaffale aperto.
Altrettanto interessante il manoscritto I I 3, cartaceo, privo della numerazio-ne delle pagine, delle dimensioni di 260 x 390 mm, compilato presumibilmen-te dal conte Lodovico Martinengo22 nel XVII secolo. Anche in questo caso sono registrate opere a stampa e manoscritte. Si tratta ancora una volta di un inventario di tipo topografico-alfabetico nel quale i libri sono registrati per formato e gli autori citati in ordine alfabetico per nome. Al termine dell’indica-zione bibliografica talvolta sono segnalati il numero dei tomi del quale si com-pone l’opera, un numero d’ordine e il vestario:
L in foglioLeonardo da Vinci. Della pittura. Parigi presso Giacomo Langlouis. 1651 T 1
n. 122 V 323
Talvolta, invece, manca completamente anche la minima segnatura di collo-cazione. Se prendiamo in considerazione ancora una volta l’opera del Folengo abbiamo:
L in ottavoLimerno Pitocco Orlandino Venetia per Gregorio Gregorii 1526 T 1
Troviamo infine il manoscritto I II 25, cartaceo, compilato presumibilmente nel XVII secolo, di 300 x 185 mm24. Il codice presenta una numerazione per fogli con l’aggiunta di una numerosa serie di fascicoli, privi di numerazione,
20 Segnatura queriniana Cinq. I. 3.21 Segnatura queriniana 10° M VI 14.22 Nell’Indice dei codici mss. della libreria Martinengo, manoscritto queriniano H III 6, Zamboni fa esplicito riferimento ad I I 3 e scrive: «[…] è l’indice della libreria di casa Mar-tinengo innanzi che fosse divisa. Sembra scritto di mano del conte Lodovico Martinengo» (p. 9). Da qui in avanti tutti i manoscritti citati si intendono conservati presso la Biblioteca Queriniana, salvo diversa indicazione.23 Completamente diversa la segnatura di collocazione rispetto a I III 14. Ancora una volta è confermata la ridistribuzione del patrimonio librario.24 Sempre in H III 6 leggiamo: «Altro indice della libreria medesima, innanzi che fosse di-visa, scritto per diverse mani e in foglio minore», p. 9.
159CAMILLO BALDASSARRE ZAMBONI ORDINATORE DELLA BIBLIOTECA MARTINENGO
testimoni di continui interventi di riordino, nel tentativo di razionalizzare l’or-ganizzazione della biblioteca.
Anche in questo caso si tratta di un inventario di tipo topografico-alfabetico nel quale sono registrate opere a stampa e manoscritte. I libri sono organizzati per formato e gli autori citati in ordine alfabetico per nome. Ogni autore è preceduto da una lettera. Al termine dell’indicazione bibliografica è segnato il numero dei tomi del quale si compone l’opera e talvolta compare un numero d’ordine:
L in foglioP Leonardo da Vinci: della Pittura. Parigi presso Giacomo Langlouis. 1651 T 1
n. 45925
I tre inventari rappresentano, dunque, l’immagine della raccolta prima che su di essa intervenisse lo Zamboni, trasformandola in una vera e propria biblio-teca razionalmente ordinata. Essi testimoniano, inequivocabilmente, quanto fosse divenuto complicato orientarsi all’interno della collezione che, accresciu-tasi nel tempo, nel XVIII secolo doveva aver raggiunto dimensioni tali da ri-chiedere una completa riorganizzazione.
Camillo Baldassarre Zamboni ordinatore della biblioteca Martinengo
La prima fonte d’informazione circa la figura dello Zamboni è data dalla bio-grafia di Germano Jacopo Gussago26. In essa leggiamo che Zamboni nacque a Montichiari nel 1723. Nel 1742 sarebbe diventato sacerdote27 e nel 1746 a Mi-
25 L’opera è registrata al f. 88r.26 G. J. GUSSAGO, Memorie intorno alla vita e agli scritti di Baldassarre Zamboni, arciprete di Calvisano distese da Jacopo Gussago minor osservante, Brescia, Vescovi, 1798. Per la figura e la produzione del Gussago (1747-1827) rimandiamo a C. COCCHETTI, Del movimento in-tellettuale nella provincia di Brescia dai tempi antichi ai nostri, memorie di Carlo Cocchetti, Brescia, Libreria antica e moderna, 18803, p. 74; A. VALENTINI, Nuova bio-bibliografia degli scrittori bresciani, principiata l’anno 1880 riveduta ed aumentata quattro volte nell’anno 1896; di nuovo copiata ed aumentata l’anno 1903 da Andrea Valentini, tomo 28, manoscritto presso la Biblioteca Queriniana, senza segnatura; F. FORMENTI, La biblioteca clarense dell’abate Germano Jacopo Gussago, in Nel cantiere della memoria, Chiari, Nordpress Edi-zioni, 2000, pp. 9-23; E. FERRAGLIO, Jacopo Gussago, in Dalla pergamena al monitor, p. 160.27 Il 1742 quale anno dell’ordinazione sacerdotale appare quanto mai insolito, avendo lo Zamboni a quell’epoca circa 19 anni. È verosimile pensare ad un errore del Gussago, che talvolta risulta poco preciso nelle indicazioni di carattere cronologico. Si pensi, ad esempio, che nella biografia egli afferma che il nostro avesse 21 anni quando il Querini lo chiama a
ALESSIA COTTI160
lano, presso il collegio gesuitico di Brera, ottenne la laurea in teologia. Fu in quegli anni che ebbe modo di conoscere e frequentare alcune significative figu-re dell’ambiente culturale milanese, tra le quali Carlo Antonio Tanzi28, che di-mostrò da subito grande simpatia per il giovane studioso. Stima che manifeste-rà ripetutamente anche negli anni successivi quando, trasferitosi lo Zamboni a Brescia, lo solleciterà più volte a collaborare alla stesura della Raccolta milane-se29. Nel 1749, per volere del cardinale Angelo Maria Querini fu nominato professore di teologia presso il seminario di Brescia. In qualità di insegnante elaborò numerosi testi a carattere teologico, conservatisi pressoché tutti mano-scritti30, e partecipò al dibattito attorno al giansenismo, allora molto vivo in città31. Divenne presto un personaggio particolarmente apprezzato per la sua
Brescia perché ricopra la cattedra di Teologia, dato questo impossibile visto che nel 1749 Zamboni doveva avere almeno 26 anni: C. J. GUSSAGO, Memorie intorno alla vita, p. 12.28 Carlo Antonio Tanzi (1710-1762), erudito letterato milanese, membro dell’Accademia dei Trasformati, promotore del foglio la Raccolta milanese, partecipò attivamente alla vita culturale del capoluogo lombardo, sia in qualità di poeta dialettale sia legando il suo nome alle polemiche sorte intorno alla questione della lingua. Notizie in F. GIANNESSI, La poesia dialettale, in Storia di Milano, XII, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1959, pp. 652-653; C. A. TANZI, Le poesie milanesi, a cura di R. MARTINONI, Pistoia, Edizioni Can Bianco Niccolai, 1990, pp. 15-26. Molto significativa la corrispondenza con il Mazzuchelli per la quale rimandiamo a G. PANIZZA, Erudizione lombarda: Carl’Antonio Tanzi e Giamma-ria Mazzuchelli in Studi di letteratura italiana offerti a Dante Isella, Napoli, Bibliopolis, 1983, pp. 199-210. Tra le sue opere ricordiamo C. A.TANZI, Alcune poesie milanesi e toscane, Mi-lano, Agnelli, 1766. La raccolta fu pubblicata postuma a cura del Parini, che distende un ritratto del poeta nella prefazione.29 R. MARTINONI, Un foglio erudito lombardo del Settecento. La «Raccolta Milanese» (1756-1757), «Archivio Storico Lombardo», s. XI, VIII, 1991, pp. 203-257: 204. Si veda inoltre il carteggio manoscritto Tanzi-Zamboni E.V.10-1/2. Per una prima conoscenza dell’ambiente culturale milanese rimandiamo a G. SEREGNI, La cultura milanese nel Settecento, in Storia di Milano, XII, pp. 567-641; A. TURCHINI, Intellettuali a Milano nel Settecento, in La Lombardia delle riforme, Milano, Electa, 1987, pp. 103-118; F. LOI, Verso il Romanticismo: Milano ca-pitale della letteratura italiana, in La Lombardia delle riforme, pp. 119-140.30 Theologicae exercitationes (De fide, de Deo, de legibus, de conscientia, de actibus huma-nis eorumque regulis) H III 2 m3; Theologicae exercitationes (Sui concili, il pontefice, la Trinità e i sacramenti) G IV 18 m1; Exercitationes theologicae de Verbi incarnatione (Copia del 1760 di Stefano Veneziani, alunno di Zamboni presso il seminario vescovile di Brescia) G IV 17 m2; De Cristo hominum redemptore eiusque virgine matre Maria theologicae insti-tutiones G IV 18 m3.31 Sulla diffusione del giansenismo a Brescia e sui principali protagonisti si vedano R. MAZ-ZETTI, Il cardinale Angelo Maria Querini. Uomini e idee del Settecento e la nascita del gianse-nismo bresciano, con lettere inedite, Brescia, Tannini Editore, 1933, pp. 105-119; G. GUADA-GNINI, Lettere a Giambattista Rodella, a cura di O. FRANZONI - G. MORELLI - L. SANTINI, Brescia, Vannini, 1989; M. COMINI, Pietro Tamburini (1737-1827). Un giansenista lombardo
161CAMILLO BALDASSARRE ZAMBONI ORDINATORE DELLA BIBLIOTECA MARTINENGO
attività di erudito e assiduo frequentatore di archivi32. Tale impegno si tradusse nella pubblicazione di opere a stampa e nell’allestimento di numerosi mano-scritti, frutto dell’attento lavoro condotto sulle “carte” conservate nelle raccol-te documentarie monastiche e cittadine33. Di questa attività troviamo eco sia negli accurati apparati di note che accompagnano i suoi lavori, sia nella fitta corrispondenza con gli amici, come appare da questa significativa lettera, che proponiamo a solo titolo di esempio, scritta a Lodovico Ricci34 il 9 aprile del 1765:
la mia vita in città, questa festa e tutta la mattina le ho consumate in cancelleria a rivolgere una infinità di libri, ora con noia ed ora con piacere. Il fatto è che vi sono molte belle cose per la storia bresciana degli ultimi secoli e tante che sto per dire che poche sieno le città d’Italia le quali abbiano un simil tesoro35.
Egli rappresentò per i contemporanei un valido aiuto nel reperimento delle fonti necessarie alle loro opere36; e non doveva essere insolito che lavori nati
tra riforma e rivoluzione, Brescia, Grafo, 1992; G.V. SIGNOROTTO, Le inquietudini del clero bresciano tra XVII e XVIII secolo, in Pietro Tamburini e il giansenismo lombardo, a cura di P. CORSINI - D. MONTANARI, Brescia, Morcelliana, 1993, pp. 43-61; M. COMINI, Giovanni Battista Guadagnini. Un sacerdote giansenista in Val Camonica, Brescia, Grafo, 1995.32 La sua fama travalicherà nel tempo i confini locali: nel 1769 il vescovo principe di Lubia-na gli offrirà un incarico in ambito teologico e pastorale al quale lo Zamboni sarà costretto a rinunciare, a causa delle pressioni dell’allora vescovo di Brescia Giovanni Molino. Si veda in proposito G. J. GUSSAGO, Memorie intorno alla vita, pp. 26-28.33 Non esiste attualmente una sistematica bibliografia sulla figura dello Zamboni, che fu studioso attento e di rara erudizione. Non è possibile in questa sede passare in rassegna la sua sterminata produzione, lavoro che sebbene interessante ci condurrebbe troppo lontani dalle vicende della biblioteca Martinengo. Ho tentato una prima forma di registrazione delle sue opere a stampa e manoscritte in sede di tesi di laurea e ad essa dunque rimando: A. COTTI, Un caso di erudizione bibliografica nella Brescia di fine Settecento: Camillo Baldas-sarre Zamboni e la Libreria Martinengo, relatore X. Toscani, Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore, a.a. 2005-2006, pp. I-VI.34 Si veda G. J. GUSSAGO, Notizie istoriche sulla vita e sugli scritti di Lodovico Ricci canonico curato di Chiari raccolte dal padre Jacopo Gussago minore osservante, Brescia, Bettoni, 1808. Lodovico Apollonio Ricci (1730-1805) allievo di Zamboni presso il seminario vescovile di Brescia, rimase legato al maestro per tutta la vita, condividendone i numerosi interessi cultura-li, come attesta la fitta corrispondenza tra i due: si veda in proposito ms. E V 8-2. Cfr. V. SAL-VADORI, I carteggi delle biblioteche lombarde, II, Milano, Editrice Bibliografica, 1991, p. 120.35 Ms K V 18. lettera IX. Anche per questo manoscritto si veda V. SALVADORI, I carteggi, p. 121.36 «Io ho rimembrato volentieri questo illustre letterato anche per segno dell’ossequio e della gratitudine ch’io gli professava per la cortese parzialità con cui mi riguardava, e per i molti aiuti che da vari anni degnavasi porgere ai miei studi», in C. B. ZAMBONI, Idea d’un tesoro d’istorie e d’antichità bresciane, p. 15 n. 1.
ALESSIA COTTI162
grazie alle ricerche dello Zamboni venissero stampati ad esclusivo nome di altri autori se l’amico Giovanni Battista Rodella37 in un lettera del 24 agosto 1770 lo mette in guardia dicendo:
Voi fate poca stima delle vostre erudite fatiche e altri se ne fanno poca coscien-za38.
Grazie alla stima della quale godeva, fu assunto come bibliotecario dal pro-curatore Tommaso Querini, che alla fine del 1765 lo convinse a lasciare Brescia per trasferirsi a Venezia39. La collaborazione fu molto breve e particolarmente travagliata: i due infatti dimostrarono ben presto di avere caratteri assoluta-mente incompatibili: il Querini non mancò di criticare e mortificare in più modi l’erudito, che nei primi mesi del 1766 era già di ritorno a Brescia, dove la sua situazione economica apparve subito precaria. Accettando l’incarico vene-ziano, infatti, egli aveva lasciato la cattedra di teologia ed ora si trovava senza una rendita sicura. Lo Zamboni chiese persino l’intervento degli altri due pro-curatori, il Calbo e il Manin, perché agissero in suo favore, consentendogli di conservare la mansioneria e le relative rendite, stabilite per contratto40.
È proprio negli anni immediatamente successivi alla infelice esperienza con il Querini che si colloca il lavoro di riordino della biblioteca Martinengo, come si evince da due lettere di Zamboni all’amico Lodovico Ricci. Nella prima, datata 1 luglio 1767 l’autore afferma:
37 Per la figura e l’opera di Giovanni Battista Rodella (1724-1794) rimandiamo a G. J. GUS-SAGO, Notizie storico-critiche intorno alla vita e agli scritti dell’abate Giambattista Rodella letterato bresciano, raccolte e distese dal padre Jacopo Gussago minor osservante, Padova, stamperia in Scalona, 1804 e G. GUADAGNINI, Lettere, pp. 359-363.38 G. J. GUSSAGO, Memorie intorno alla vita e agli scritti di Baldassarre Zamboni, p. 62.39 Fu lo Zamboni bibliotecario e bibliografo di rare qualità. Studioso attento, dalla cultura vastissima, è ancor oggi annoverato tra gli intellettuali che in modo originale si distinsero nel dibattito, vivacissimo, in merito alla trattatistica bibliotecaria di fine Settecento. Si leg-gano in proposito le belle pagine a lui dedicate da A. SERRAI, La trattatistica bibliotecaria in Italia tra Settecento ed Ottocento, in Storia della bibliografia, IX, Manualistica, didattica, e riforme nel secolo XVIII, a cura di V. STUNIC, Roma, Bulzoni, 1999, pp. 617-653.40 Per tutta la vicenda si veda A. BRUMANA, Baldassarre Zamboni bibliotecario mancato in casa Querini, «Misinta», 26, 2005, pp. 9-28 e «Misinta», 28, 2006, pp. 43-55. Si leggano inoltre 2 fogli, non numerati e conservati nel ms K.V.3 m2, di appunti che Zamboni stese per l’amico Gussago, dove trovano posto le amare confidenze dell’erudito circa il tratta-mento ricevuto in casa Querini e sui quali il biografo elaborò le Aggiunte da farsi alle me-morie zamboniane da me fatte stampare in quest’anno 1798. Le Aggiunte si possono leggere nel ms K V 3 m2 pp. 5-10.
163CAMILLO BALDASSARRE ZAMBONI ORDINATORE DELLA BIBLIOTECA MARTINENGO
Non ho novelle letterarie da darvi, perché non veggo persona, stando chiuso tutto il dì nella libreria del conte Leopardo Martinengo, che sto ordinando41.
Nella seconda, scritta da Montichiari il 21 settembre 1767, Zamboni sotto-linea:
L’occupazione mia in queste vacanze sarà di fare alcune notarelle al Catalogo della libreria Martinengo. Fra esse vi sono alcune opere, ed edizioni, anzi molte, che sono rarissime42.
Il lavoro alla biblioteca si dimostrò particolarmente impegnativo: Zamboni passò in rassegna tutto il vasto patrimonio librario che i Martinengo avevano accumulato nel corso dei secoli, operando una prima netta separazione, a livel-lo classificatorio, tra materiale manoscritto e a stampa43. Di tale minuziosa rico-gnizione rimane prova nel manoscritto H III 6 di 305 x 210 mm. Si tratta di un documento di estremo interesse, ricco di preziose informazioni in merito al metodo usato dallo studioso per catalogare con nuovi criteri l’intera collezione. Manoscritto, potremmo dire di lavoro, estremamente complesso, del quale presentiamo divisione per fascicoli, numerazione per foglio e schematica de-scrizione:
fasc. 122, 28, 36, 42, 56, 61, 71, 86, 92, 103 (2 + il foglio centrale incollato), 112, 122, 132, 144, 153
(2 + il foglio centrale incollato), 164, 174 (lettera con busta e foglio), 188 (4 + 4 fogli sparsi al centro), 192, 202, 212, 222, 231, 244, 2510, 269 (10 con il 9° foglio tagliato), 271, 281, 2921 (22 con il 22° foglio tagliato), 3033 (32 +
il foglio 25° incollato), 3124, 3226, 3320, 3426, 3526 (24 con l’aggiunta dei fogli 16° e 17° incollati), 3618, 375 (6
con il 1° foglio tagliato), 382, 391, 402, 412, 422, 432, 443 (4 con il 1° foglio tagliato).
Fasc. 1 Indice dei codici mss. della libreria Martinengo. <Descrizione dei mss in folio, quarto, ottavo, dodicesimo e
relative segnature> (ff. 1r-21r)Fasc. 2-3 <Appunti per la stesura della dissertazione44 e per l’organizza-
zione dell’Indice dei manoscritti> (ff. 22r-35v)
41 Ms K V 18, lettera X. Il corsivo è nostro.42 Ms K V 18. lettera XI.43 Ricordiamo che sino ad ora gli inventari in nostro possesso non presentavano alcuna distinzione in tal senso.44 Altro modo con il quale Zamboni si riferisce a La libreria di sua eccellenza il nobil uomo signor Leopardo Martinengo patrizio veneziano conte di Barco, condomino di Villanuova, feudatario di Pavone, e signore di Clanesso, cogli uomini illustri della chiarissima famiglia Martinengo umiliata al medesimo cavaliere dalla spettabile comunità di Calvisano, Brescia, Vescovi, 1778.
ALESSIA COTTI164
Fasc. 4-11 <Appunti per la celebrazione di alcuni personaggi illustri della famiglia Martinengo e per la stesura della dissertazione> (ff. 36r-58v)45
Fasc. 12 <Tavola, in francese, tratta dall’Encyclopédie con la divisione delle materie per classi> (ff. 59r-60r)
Fasc. 13-18 <Tavole con nomi di luoghi, personaggi storici, popoli e fami-glie aristocratiche> (ff. 61r-85v)
Fasc. 19 <Appunti su opere a stampa di Ascanio e Tito Prospero Mar-tinengo> (ff. 86r-87v)
Fasc. 20-22 <Appunti per la stesura della dissertazione> (ff. 88r-93r)Fasc. 23 <Appunti sull’organizzazione di una biblioteca tratti dal testo
di Giusto Fontanini Biblioteca dell’eloquenza italiana> (f. 94)Fasc. 24-26 <Appunti con l’Indice delle materie e la divisione in classi> (ff.
95r-117r)Fasc. 27-28 <Elenco di autori.> (ff. 118)Fasc. 29-37 <Spoglio dei volumi presenti nella raccolta Martinengo, osser-
vazioni sulle edizioni, sulle modalità dell’ordinamento e tenta-tivo di una prima segnatura di collocazione. Questa è la sezio-ne che contiene le minute dei cataloghi per materie K II 7 e quello alfabetico per autori G I 10> (ff. 119r-320v)
Fasc. 38 <Lettera dedicatoria originale della dissertazione> (ff. 321r-322v)
Fasc. 39 <Lettera di un musicista non identificato> (f. 323)Fasc. 40 <Lettera in latino con l’epitaffio di Giovanni Francesco Quin-
zano Stoa ed elenco di libri> (ff. 324r-325v)Fasc. 41-44 <Stesura manoscritta della dissertazione> (ff. 326r-334v)
Come si evince dalla descrizione, il documento contiene innanzi tutto l’Indice dei codici manoscritti nella sua versione definitiva. Fortunatamente si è conser-vato anche il manoscritto preparatorio di tale Indice: si tratta un fascicolo all’interno del codice F IV 9 m 6c, cartaceo, di 295 x 210 mm, pp. [2]-34 orga-nizzato in:
p. [1] Spoglio dei manoscritti della libreria di sua eccellenza il signor conte Leopardo Martinengo per ordinare l’Indice di essi.
p. [2] biancapp. 1-34 <Spoglio dei manoscritti.>
Si tratta della prima ricognizione compiuta dallo studioso sul materiale mano-scritto presente nella raccolta Martinengo: compaiono note marginali con i nomi degli autori e la segnatura, identica a quella presente in H III 6. Lo Spo-
45 Tali annotazioni ricompaiono in forma elaborata nella seconda parte del testo di ZAMBO-NI, La libreria, pp. 59-138.
165CAMILLO BALDASSARRE ZAMBONI ORDINATORE DELLA BIBLIOTECA MARTINENGO
glio offre una sintetica serie di annotazioni scritte dallo studioso quando si trovò per la prima volta ad affrontare i manoscritti: li osserva, li descrive e fissa alcune note che poi ricompaiono, elaborate in forma di “scheda catalografica”, nell’Indice vero e proprio.
Ci sembra significativo, per comprendere le modalità con le quali egli lavorò nell’allestire tali strumenti, offrire un esempio. Presentiamo il caso del mano-scritto in foglio Historia dell’assedio di Famagosta di me Nestore Martinengo46.4748
46 L’opera è conservata nel manoscritto I II 27. Per la figura di Nestore Martinengo riman-diamo a V. PERONI, Biblioteca bresciana, II, Brescia 1818-1823 (ristampa anastatica, Bologna, Forni, 1968), pp. 246-247.47 Georg Draud (1573-1635) in A. SERRAI, Vicende e ammaestramenti della Historia litera-ria, in Storia della bibliografia, III, a cura di M. COCHETTI, Roma, Bulzoni, 1991, pp. 64-75.48 L. COZZANDO, Libraria bresciana. N. MARTINENGO, La vraye histoire du siege et de la prinse de Famagoste, Paris, André Wechel, 1572 (ADAMS 722).
SPOGLIO [F IV 9 m 6c]pp. 1-2
Historia dell’assedio di Famagosta di me Nestore Martinengo in foglio.
Questa historia è scritta di mano del conte Nestore, come chiaramente si comprende dall’uniformità del carattere di essa, e di quello, onde da lui fù scritta l’attestazione, che sta in fronte al volume di lettere mss. Il Cozzando nella parte I della Libreria Bre-sciana a carta 174 della edizione in 8° scrive dietro all’autorità di Giorgio Draudio47 che cotesta historia è stata tradotta in lingua francese, e stampata in Parigi presso An-drea Vuechel 1572 in 8°48 […]c. 112 Il conte Nestore vi resta ferito di sasso in fronte.c. 124 Il conte Nestore è malamente ferito […]c. 192 Il conte Ercole Martinengo cugino di Nestore va per ostaggio nel campo turche-sco.c. 193 Capitolazione di Famagosta.c. 200 Il conte Nestore eletto a portar una lettera al campo.
INDICE [H III 6 ]pp. 6-7
Historia dell’assedio di Famagosta di me Nestore Martinengo manoscritto in foglio.
Questa historia è scritta di mano del conte Nestore, come chiaramente si comprende dall’uniformità del carattere di essa, e di quello, onde da lui fù scritta l’attestazione, che sta in fronte al volume di lettere mss. Il Cozzando nella parte prima della Libreria Bresciana a carta 174 della edizione in 8° scrive dietro all’autorità di Giorgio Draudio che cotesta historia è stata tradotta in lin-guaggio francese, e stampata in Parigi pres-so Andrea Wechel 1572 in 8° […]In questo Assedio il conte Nestore tanto bene si diportò, che dopo d’essere stato in due volte malamente ferito fù eletto dopo la capitolazione di Famagosta a portar una lettera al campo turchesco […]
ALESSIA COTTI166
Come già sarà stato notato, il codice H III 6 risulta prezioso anche e soprattut-to perché qui compaiono le minute del catalogo per materie e del catalogo al-fabetico per cognomi degli autori.
Queste mostrano il complesso lavoro di schedatura affrontato dallo Zambo-ni: esso comportò la ricognizione di ogni singolo vestario, armadio, e conte-stualmente, per ogni opera, l’assegnazione di una nuova segnatura di colloca-zione. Al f. 188r possiamo ricostruire materialmente le operazioni compiute dall’erudito, seguendo ancora una volta le sorti del trattato leonardesco: vedia-mo che viene modificata la segnatura precedentemente assegnata al volume attraverso la nuova collocazione che lo porta da G VI a P VI, segnatura che ricomparirà nel catalogo per materie49. Contemporaneamente viene elaborata, f. 187v, una scheda di commento che ricomparirà nel definitivo Catalogo com-pilato per ordine alfabetico dei cognomi degli autori, cioè nel manoscritto G I 10. Sarà forse utile a questo punto visualizzare i diversi passaggi:
Ms H III 6 f. 188r Ms H III 6 f. 187v Ms K II 7 Ms G I 10
Vinci Lionardo da. Trattato della pittura, con la vita dello stes-so autore scritta da Raffaele du Fresne. In Parigi appresso Giacomo Langlois. 1651. In foglio 9v………….........P VI*
* Sotto questa segna-tura si legge chiara-mente: G VI
Edizione per tutti i titoli ele-gantissima, per la forma ma-gnifica, per la bellezza della carta e dei caratteri e per la squisitezza e dilicatezza dei rami. Il ms. del Vinci giaceva in Roma nella libreria Barbe-rina e da esso ne prese una copia il Cavalier Cassiano del Pozzo, sopra la quale il cele-bre Niccolò Pussino riputato l’Apelle della Francia formò gli schizzi e i disegni delle fi-gure. La copia del Cavalier del Pozzo passò nelle mani del signor di Ciantelou, da cui l’ebbe il Dufresne il quale la collazionò con altro esem-plare più corretto prestatogli dal famoso viaggiator francese Tecrenot. V’ebbe mano ancora l’errando celebre disegnatore e dipintore e di questo sono per avventura i ritratti del Vinci e dell’Alberti. Cose tutte che rendono il libro sommamente prezioso.
Classe III [Mate-matiche]
Paragrafo 7Pittura
Vinci Lionardo da. Trattato della pittura P VI
Vinci Lionardo da. Trattato della pittura, con la vita dello stesso au-tore scritta da Raffaele du Fresne. In Parigi appresso Giacomo Lan-glois. 1651. In foglio 9v Questa è un edizione per tutti i titoli elegan-tissima, per la forma magnifica, per la bellezza della carta e dei caratte-ri e per la squisitezza e dilicatezza dei rami. Il ms. del Vinci giaceva in Roma nella libreria Barberina e da esso ne prese una copia il Ca-valier Cassiano del Pozzo, sopra la quale il celebre Niccolò Pussino appellato l’Apelle della Francia formò gli schizzi e i disegni delle figure. La copia del Cavalier del Pozzo passò nelle mani del si-gnor di Ciantelou, da cui l’ebbe il Dufresne il quale la collazionò con altro esemplare più corretto prestatogli dal famoso viaggiator francese Tecrenot. V’ebbe mano ancora l’errando celebre disegna-tore e dipintore francese e di que-sto sono per avventura i ritratti del Vinci e dell’Alberti.; le quali cose tutte rendono il libro sommamente prezioso......................P I 33
49 Manoscritto K II 7 del quale si dirà tra poco.
167CAMILLO BALDASSARRE ZAMBONI ORDINATORE DELLA BIBLIOTECA MARTINENGO
Compiuto il lavoro preparatorio, Zamboni poté realizzare i suoi cataloghi. Il primo sul quale ci soffermeremo è il manoscritto K II 7, cartaceo delle dimen-sioni di 310 x 210 mm, pp. [16]-156-[20], così organizzato:
pp. [1-2] bianchep. [3] Catalogo della libreria Martinengo di Barco, in cui i libri sono
distribuiti secondo le materie, compilato da Baldassarre Zamboni.p. [4] biancap. [5] Avvertimento <metodologico sulle modalità di riordino>p. [6] biancapp. [7-10] Indice delle classi e dei paragrafi.pp. [11-15] Indice alfabetico delle materie.p. [16] biancapp. 1-156 Indice <per classi del catalogo>pp. [157-176] bianche
Lo studioso condusse un lavoro minuzioso di classificazione del vasto materiale che aveva a disposizione, come dimostra la cura nell’allestire l’Indice delle classi, dei paragrafi e delle materie. Ma soprattutto, attraverso l’Avvertimento, stese una significativa pagina di carattere metodologico, che consente di ricostruire ulteriormente le diverse fasi operative messe in atto al momento del riordino:
I volumi di questa libreria erano da prima senza cartellino sul dorso, marcato della scansia e dello scaffale indicato dal Catalogo50. Era perciò d’uopo allora scorrere con molto incomodo e ritardo di tempo tutti i volumi d’uno scaffale per trovar quello che si cercava, il quale facilmente veniva poscia riposto fuori di luogo non avendo il cartellino suddetto che lo indicasse. A questo difetto si è ora riparato, aggiugnendovi inoltre il numero particolare e progressivo del volume; ma questa operazione si è dovuta fare registrando i libri negli scaffali dov’erano, avendo già prima per diversi motivi cambiato di luogo, e in questo incontro si sono anche ordinati possibilmente per ordine di formato. Quindi è che le indica-zioni segnate in margine di questo Catalogo, ora non servono più. Trovato per-tanto su questo stesso Catalogo51 l’autore che si desidera per materia, dovrassi di nuovo ricercarlo sul Catalogo grande disposto per ordine alfabetico de’ cogno-mi52, dal quale verrà indicato la scansia, lo scaffale ed il numero ond’è il volume contraddistinto, colla certezza di poterlo poi sempre riporre nel proprio luogo di prima come si usa, a scanso di confusioni, in ogni ben ordinata biblioteca53.
50 Zamboni si riferisce ad un catalogo precedente al suo intervento, è verosimile pensare che si tratti di uno dei tre codici dei quali abbiamo trattato, ma non è stato possibile stabi-lire con certezza a quale lo studioso stia alludendo.51 Ms K II 7.52 Ms G I 10.53 Ms K II 7 p. 5.
ALESSIA COTTI168
I libri, dunque, nel tempo non solo avevano cambiato più volte collocazione, ma sino a questo momento non avevano mai avuto un preciso numero d’ordine sullo scaffale, lacuna che rendeva il volume difficilmente individuabile all’atto della ricerca, e spesso ricollocato casualmente alla fine della consultazione.
Zamboni riorganizzò il materiale attraverso l’assunzione di otto classi: la Teologia, la Filosofia naturale, la Matematica, l’Etica o Filosofia morale, la Politica, le Belle lettere, l’Istoria e l’Erudizione. Per ognuna di esse predispose una cospicua serie di sottoclassi, all’interno delle quali distribuire l’eterogeneo patrimonio che si era andato stratificando54. Anche in questo caso si trattò di un lavoro alquanto complesso, più volte soggetto a ripensamenti, come è chia-ramente registrato ai ff. 95r-117r del manoscritto H III 6 che attesta le fasi di lavoro messe in atto dallo studioso. Comprendiamo quanto dovesse essere complicato, a fronte di una collezione già formata ma non classificata con precise tassonomie, ricondurre i diversi titoli dando loro una coerente sistema-zione. Ci appare interessante sottolineare la scomparsa, nella versione defini-tiva, della classe denominata Miscellanea55. Il nostro, all’inizio, pensò di ser-virsene come nona classe, ma alla fine decise di non utilizzarla. Nessun docu-mento viene in nostro aiuto per comprendere il motivo che indusse l’erudito a tale scelta, in questa sede è possibile solo un’ipotesi: l’eccessivo carattere “generico” di tale classificazione, in netto contrasto con quella capillare preci-sione nel modo di operare tipica dello Zamboni. Nel catalogo per materie le opere furono registrate riportando cognome e nome dell’autore, titolo, forma-to e parziale segnatura di collocazione. Se prendiamo ancora una volta il no-stro trattato lo troviamo nella:
54 A solo titolo d’esempio presentiamo la classe della Storia: Classe VII, Istoria, §. 1 Crono-logia; §. 2 Geografia; §. 3 Genealogia, blasoneria e storia di famiglie; §. 4 Viaggi per mare e per terra; §. 5 Storia sacra ed ecclesiastica; §. 6 Storia degli Ordini religiosi e militari; §. 7 Storia antica greca e romana; §. 8 Storia moderna dell’Europa; §. 9 Storia civile dell’Italia, di qualche provincia o metropoli di essa; §. 10 Storia delle guerre d’Italia; §. 11 Storia civi-le e delle guerre della Francia, Spagna e del Portogallo; §. 12 Storia civile della Germania e del Settentrione; §. 13 Storia delle guerre della Germania e del Settentrione; §. 14 Storia civile dei Turchi, dell’Asia e dell’Africa; §. 15 Storia delle guerre de’ Turchi; §. 16 Storia dell’America e delle Indie; §. 17 Storia di città e luoghi particolari; §. 18 Storia veneziana; §. 19 Storia di luoghi del dominio veneziano; §. 20 Storia letteraria; §. 21 Vite e memorie di sommi pontefici e cardinali; §. 22 Vite e memorie d’imperatori, re e d’altri sovrani; §. 23 Vite e memorie di personaggi militari; §. 24 Vite e memorie di santi e di persone cospicue nella pietà; §. 25 Vite e memorie d’uomini in qualche genere illustri o famosi; §. 26 Vite e memorie di donne celebri; §. 27 Vite e memorie d’uomini letterati.55 Si veda il f. 98v del manoscritto H III 6.
169CAMILLO BALDASSARRE ZAMBONI ORDINATORE DELLA BIBLIOTECA MARTINENGO
Classe III[Matematiche]
§ 7 PitturaVinci Leonardo da. Trattato della pittura. In foglio P VI
Al Catalogo per materie fece seguito quello alfabetico per cognome degli autori, un vero e proprio piccolo tesoro di erudizione bibliografica: il manoscritto G I 10, cartaceo, di 440 x 290 mm, pp. [6]-318 così organizzato:
pp. [1-2] bianchep. [3] Catalogo della libreria Martinengo di Barco, compilato per ordine alfa-
betico de’ cognomi degli autori, da Baldassarre Zamboni. Una mano posteriore aggiunge: “Avvertenza. Dopo la compilazione
di questo catalogo, e prima che la libreria passasse, per legato del benemerito proprietario, alla Quiriniana, parecchi libri furono tolti alla collezione, e parecchi altri aggiunti, percui il catalogo presente devesi ritenere modificato nei sensi dell’inventario 15 Aprile 1886, N° 1155 del protocollo generale della Queriniana.”56
p. [4] biancap. [5] La prefazione di questo catalogo è già stampata col seguente titolo: La
libreria di sua eccellenza il nobil uomo signor Leopardo Martinengo pa-trizio veneziano conte di Barco, ec. In Brescia presso Pietro Vescovi 1778 in 4°. In essa lo Zamboni rende conto del modo da lui tenuto nell’ordi-nare questa libreria, aggiungendovi in fine gli uomini illustri della pre-lodata famiglia Martinengo. Lo stesso Zamboni compilò pure un altro catalogo per ordine di materie de’ libri oltre a quello de’ manoscritti.
p. [6] biancapp. -318 <Catalogo alfabetico per autori.>
Il volume, in origine compilato interamente dallo Zamboni, compresa la nume-razione delle pagine, presenta oggi la diffusa aggiunta di notazioni marginali a matita; esse si collocano all’epoca del deposito della raccolta presso la Querinia-na, quando «[…] fu fatto un completo inventario, nonché uno schedario copio-sissimo, prelevando i molti duplicati, che risultarono dall’accurato confronto delle nuove opere pervenute, con quelle già esistenti nella Queriniana»57. Tale strumento rappresenta per lo studioso contemporaneo una fonte straordinaria di informazioni; e al tempo stesso un esempio poco comune di erudizione biblio-
56 Ricordiamo che si tratta di quell’Inventario dei libri legati dal benemerito signor conte Leopardo Martinengo alla biblioteca Queriniana, Archivio della Queriniana protocollo n. 1155 del quale abbiamo riferito a p. 154.57 E. FERRAGLIO, Documenti per la storia della Biblioteca: il memoriale sui Trent’anni nella Queriniana (1880-1910) di Filippo Garbelli, «Annali Queriniani», V, 2004, pp. 321-339: 330.
ALESSIA COTTI170
grafica. Il passo che già abbiamo riportato relativo al trattato sulla pittura del da Vinci non è che un minimo esempio, tra gli innumerevoli, che mostrano con quanta perizia e cura venne strutturato questo indice, vero e proprio filo di Arianna nel labirinto della collezione Martinengo. Gli autori sono qui registrati per cognome e nome, ben distinti e identificabili in caso di omonimia58; i titoli delle opere sono riportati per esteso59, sono sempre indicati il luogo di stampa, l’editore60, il formato e la completa segnatura di collocazione. Era questo il cata-logo, insomma, di quella che finalmente poteva essere definita non solo una vera biblioteca, ma soprattutto una biblioteca ben ordinata. Si trattava di una raccolta poderosa: il conteggio delle unità editoriali ci dice che i Martinengo, nel XVIII secolo, vantavano circa 3000 edizioni, numerosissime delle quali, dietro precisa indicazione dello Zamboni, preziose e rare. Netta prevalenza era data alla tipolo-gia dei libri annoverati sotto la classe della Storia, che da sola vantava il 30% dell’intera raccolta61; prevalenza non certo casuale per una ricca, potente e anti-chissima famiglia saldamente radicata nel tessuto cittadino, e che a tale tessuto aveva dato e dava condottieri, uomini politici, letterati e mancate sante mistiche62.
58 Ecco ciò che scrive lo Zamboni a proposito di alcuni membri della famiglia Possevino: «Possevino Antonio. Libro nel quale s’insegna a conoscere le cose pertinenti all’honore ed a ridurre ogni querela alla pace. In Vinegia appresso Gabriel Giolito, 1559 in 4. Era questi mantovano e molto si segnalò entrato che fu nella Compagnia di Gesù col suo zelo per la religione catolica e per varie opere pubblicate. Era fratello di Giovanni Battista e zio dell’al-tro Antonio Possevino e scrisse quest’opera innanzi d’essersi fatto gesuita».59 Quando lo Zamboni decide di abbreviare il titolo, non agisce mai in modo che venga compromessa la piena intelligibilità del trattato sempre perfettamente identificabile.60 L’erudito spesso segnala, nei casi in cui luogo di stampa ed editore siano fittizi, gli estre-mi reali per identificare l’edizione. Bello questo esempio relativo a Paolo Diacono: «Pauli Diaconi, Historie dei fatti de’ romani imperatori fatte volgari da Benedetto Egio, in Vinegia, appresso Gabriel Giolito 1556, in 8. Veramente questa edizione non è stata fatta dal Gioli-to ma dal Tramezzino, comunque chi l’ha venduto abbia proccurato di sostituire a quello del Tramezzino, cassandolo, il nome del Giolito. Questo era tanto più facile perché essendo mancante dell’antico frontispicio ve n’è stato posto uno nuovo con sopra impressovi l’inse-gna de’ Gioliti, ove il titolo è stato scritto a penna. Simili frodi si costumavano ne’ tempi in cui erano ricercatissime le edizioni de’ Gioliti, riputate ornamenti delle biblioteche, le qua-li se sono belle rapporto ai caratteri, non sono sempre le più corrette. Presentemente questo fanatismo si è di molto minorato».61 La Teologia costituiva l’8%, la Filosofia naturale l’11%, la Matematica il 14%, l’Etica o Filosofia morale il 9%, la Politica il 7%, le Belle lettere il 16% e l’Erudizione il 5%. Tale conteggio è stato condotto sul manoscritto K II 7.62 Grande sarebbe la tentazione, a questo punto, di passare in rassegna tutti coloro che da tale biblioteca ricevettero i primi e non solo i primi rudimenti del sapere, ma certo finirem-mo assai lontano rispetto a questa semplice introduzione alla raccolta Martinengo. Ad altra sede rimandiamo dunque tale tentazione.