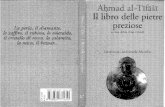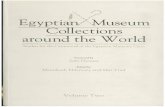La committenza degli Alliata e il ritorno all’ “antico”: un restauro emblematico (trad....
Transcript of La committenza degli Alliata e il ritorno all’ “antico”: un restauro emblematico (trad....
La committenza degli Alliata e il ritorno all’“antico”: un restauro emblematico
Pierfrancesco Palazzotto
L’ascesa sociale di una nobile famigliaIl 1818 segna un nuovo cambiamento di proprietà perPalazzo Termine, ma nel segno della continuità: l’anticamagione, da quel momento, entra nell’orbita della pre-stigiosa e magniloquente famiglia Alliata. Il quarto ducadi Pietratagliata, Giovan Battista Marassi e Cottone (†1808), aveva infatti avuto come successore diretto unafiglia femmina, Cirilla, cui sarebbe pervenuto tutto ilpatrimonio familiare1. L’evento è il degno approdo diun’evidente politica matrimoniale perpetrata da questacome da altre famiglie, “immigrate” e non, appartenential patriziato urbano. D’altronde, al di là della pressochérecente acquisizione del titolo nobiliare, la consistenzadei beni aviti, che sono indicati nei capitoli matrimo-niali2, offriva una base solida per un’ulteriore ascesasociale nella prospettiva di un buon matrimonio per l’e-rede, che in effetti avvenne il 14 ottobre di quell’annocon Luigi Alliata Colonna e Moncada di Villafranca3. Inoccasione di questo evento il duca delle Pietratagliate, ilchierico don Francesco Paolo Marassi e Cottone, zio diCirilla, legò irrevocabilmente agli sposi “tutte le gioie el’infrascritta quadraria della detta famiglia Marassi eCottone, e cioè San Francesco d’Assisi, opera di GuidoReni. / n. sette opere dello Spagnoletto. / Decollazionedi S. Giovanni, opera di Matteo Tomno <MatthiasStom?>. / Un Santo Martire, opera di Rubens. / S. Bar-tolomeo, opera di Pietro Novelli. / San Pietro spergiuro,
141
5 Palazzotto:Gabbia 23x27 19-10-2012 18:35 Pagina 141
opera di Matteo Stomno4. / San Sebastiano, opera diGuido Reni. / Quadro di Passoni, opera dello Spagnolet-to. / La nascita di Gesù Cristo, opera di Scuola Fiamin-ga. / Bambociata di Scuola Fiaminga. / Altro quadro diPassoni del Fiamingo. / Santa Agata, opera di PietroNovelli. / N. due mezzi figure Scuola di Pietro Novelli. /N. sei Paesaggi della scuola Fiaminga. / N. quattro qua-dri di Architettura dello Spagnoletto”. Una piccola masignificativa galleria, anche per le scelte di gusto tuttoorientato sul Seicento.Luigi Alliata era il terzogenito del sesto principe di Vil-lafranca, don Fabrizio Alliata e Colonna, e appartenevadunque a una delle principali casate siciliane, di originepisana e giunta nell’isola nel XIV secolo; in particolareun Raniero Alliata ebbe la cittadinanza di Palermo nel14135 . In definitiva per i Marassi si trattava di un lega-me estremamente rilevante, l’apice di un percorso lun-go un secolo che, vedremo, avrebbe influito in manieradecisiva sulla configurazione di Palazzo Termine-Pie-tratagliata6.Nel corso del terzo-quarto decennio del XIX secolo ilpalazzo fu sottoposto, tra gli altri, a restauro per il terre-moto del 1823, lavori di cui si occupò dal 1828 l’architet-to Nicolò Puglia (Palermo, c. 1772-1865)7, sulla base diun progetto rivolto anche ad ammodernamenti e licen-ziato dal Tribunale Civile di Palermo in quanto finanzia-to da un prestito garantito dalla dote della duchina Ciril-la Alliata Marassi 8. Ma una decisiva svolta nella visionedell’edificio da parte degli eredi avvenne quasi un secolodopo, nel 1908, in quanto probabili lavori di natura sta-tica innescarono una profonda riflessione sul recuperoradicale delle forme medievali, inevitabilmente sacrifica-te alle esigenze di gusto e di funzionalità abitativa nelcorso dei secoli: è il ritorno all’antico.
Fabrizio Alliata Notarbartolo e il contesto culturale nellaPalermo di fine XIX secoloCommittente dei lavori è l’ottavo duca di Pietratagliata,Fabrizio Alliata e Notarbartolo (nato nel 1884), direttodiscendente di Cirilla Marassi, con cui iniziano le lunghetraversie che vedono lo sviluppo dell’edificio condizio-nato da ragioni economiche e dai desideri del commit-tente, che spesso non incontrano il completo assensodagli organi preposti alla tutela e finiscono per trascinar-si lungo un paio di decenni9 . Nel 1908 il duca Fabrizio,appena ventiquattrenne, decide di intervenire sul palaz-zo, a circa ottant’anni dall’ultima sistemazione. Per i
142
lavori fu interessato l’architetto palermitano FrancescoPaolo Palazzotto (1849-1915) che fino a quel momentonon aveva mai svolto funzioni professionali per la casa,ma che era stato coinvolto da molte famiglie aristocrati-che cittadine, non ultime i Moncada e i Notarbartolo,legate al duca; d’altronde all’epoca dell’incarico era unprofessionista più che affermato10. Figlio dell’architettoEmmanuele Palazzotto (1798-1872)11, a sua volta discen-dente da un ramo collaterale agli architetti Palazzotto,originari di Messina e operanti a Catania dai primi annidel XVIII secolo, si era formato nello studio paterno econ l’ausilio del fratello Giovan Battista (1832-1896),anch’egli architetto e con cui per un lungo periodo con-divise l’attività professionale12. Dunque, oltre alla famadi solido professionista, nella scelta potrebbero aver con-sigliato Fabrizio Alliata anche le esperienze dei suoi piùstretti congiunti, tra le quali, fuor di ogni dubbio, la resi-denza costruita per lo zio Luigi Alliata e Moncada: VillaAlliata di Pietratagliata nella contrada palermitana diMalaspina (figg. 1-2).Essa era stata concepita per rappresentare al meglio laprincipale dimora del cavaliere Luigi Alliata, riconosciu-to nel 1903 principe del Sacro Romano Impero13, cadet-to dell’antica famiglia e certamente senza una degnamagione entro le mura cittadine in cui risiedere conBianca Notarbartolo, sposata nel 1876. Con ogni proba-bilità la villa settecentesca si può identificare con la casi-na di proprietà Pietratagliata a Malaspina, ovvero alleTerrerosse, a cui si riferiscono alcuni lavori alla metà del-l’Ottocento14. La forte e decisiva personalità del cavalie-re però non dovette richiedere una generica seppurimportante soluzione architettonica, ma la realizzazionedi un vero e proprio piccolo castello con annesso unmicrocosmo feudo-giardino. In pratica, un luogo fuoridal tempo e dallo spazio ma perfettamente immerso epartecipe del clima culturale locale e internazionale15.Non vi è dubbio che per il cavaliere Luigi Alliata l’esserenato e vissuto in un altro “castello”, quale in qualchemodo si presentava il turrito palazzo di famiglia in viaBandiera, lo abbia invogliato a farsi ricreare un’atmosfe-ra dello stesso tenore, non originale ma a esso somiglian-te. È certo interessante che, a mo’ di rebound, come in ungioco di continui rimandi, i risultati architettonici otte-nuti nella villa abbiano plausibilmente ricostruito nell’i-maginario del giovane nipote Fabrizio la consapevolezzadel necessario e possibile recupero delle importanti for-me medievali dell’antico edificio, forse fino ad allora
143
5 Palazzotto:Gabbia 23x27 19-10-2012 18:35 Pagina 142
1. F.P. Palazzotto, Villa Alliata di Pietratagliata, 1885-1897 circa.Archivio privato Palazzotto, Palermo.
considerato solo “vecchio” e martoriato da manomissio-ni secolari.Le risoluzioni intellettuali dello zio e poi del nipote nonfurono però un episodio sganciato dal contesto; si posso-no infatti oggi comprendere pienamente alla luce di unclima socio-culturale nella Palermo della seconda metàdel XIX secolo, di particolare attenzione al medioevoisolano, per svariate ragioni che certamente non si elido-no a vicenda, anzi si sommano: politiche, di moda, esocio-economiche. Le iniziali affondavano le radici nellaprima metà del secolo, sostenendo in maniera alternati-va, ma con i medesimi esiti linguistici, da un lato l’auto-nomia politica del regno e dall’altro, all’opposto, la legit-tima discesa della corona normanna sul capo dei Borbo-ne. Le esperienze più tarde, che certamente non possonoessere estrapolate da quelle neomedievali precedenti distampo locale, risentono anche del vasto riscontro positi-vo che ebbe in tutta la penisola l’Esposizione nazionaledi Torino del 1884, dove si decise di innovare la sezionestorico-artistica con la creazione di un unicum tardome-dievale che si rifacesse al gotico del XV secolo esistentein Piemonte.I recenti risvolti sociali in Sicilia con l’avvento, se non ilconsolidamento, di una borghesia o piccola nobiltàindustriale e commerciale, che aveva progressivamentescalzato e surclassato alcune delle più antiche famiglie, icui blasoni si potevano far coincidere con la storia stessadella città di Palermo, a partire dalla traumatica abolizio-ne del fidecommesso e del feudalesimo nel 1812 (soprat-tutto per le disastrose conseguenze economiche per gliantichi detentori dei titoli)16, e l’inevitabile miscelazionedel sangue dei primi con i secondi, avevano finito peraprire lentamente ma inesorabilmente, e certamentetalora in maniera traumatica, l’esclusività di un mondoche non poteva più esistere. Da ciò il comprensibile spi-rito di autoconservazione che si esprimeva fissando deidistinguo, alcune verità che non dovevano essere dimen-ticate, per manifestare da parte dei singoli attori, pur nel-la condivisione sociale, chi si era e, soprattutto, da dovesi proveniva.La villa-castello dovette così divenire una sorta di proto-tipo-modello per alcune famiglie aristocratiche palermi-tane ‘neofeudali’, come i Colonna di Cesarò, con il loropiccolo “castello” a Joppolo Giancaxio (Agrigento), cheFrancesco Palazzotto realizzò nel 189417.Non meno importante, e sintomatico del diffuso climacomune a molte famiglie aristocratiche cittadine, fu il
144 145
5 Palazzotto:Gabbia 23x27 19-10-2012 18:35 Pagina 144
Termine, che adeguò alcune parti dello straordinarioPalazzo Forcella alla Marina di Palermo, di sua pro-prietà, facendovi adattare tra il 1885 e il 1891 una vera epropria Sala del Trono (fig. 3) con stalli per i cavalieri eseggio con baldacchino per il principe-barone – primusinter pares –, tutto rigorosamente in osso e di stile goti-co18. Anche nella villa a Malaspina l’ambiente adiacentealla camera dal letto da parata era definito Sala Baronaleo del Trono.Summa di queste istanze a Palermo fu senza dubbio ilTorneo storico nel Parco della Favorita nel 1897, che
2. F.P. Palazzotto, Camera da letto della villa Alliata di Pietratagliata, 1885-97 circa.Archivio privato Palazzotto, Palermo.
coevo contributo del mobiliere, artista, decoratore, anti-quario Andrea Onufrio (1828-1908), cui si deve unamolto interessante produzione, del tutto originale, dimobili neomedievali rivestiti in osso (simulante l’avorio)in cui sono presenti continui rimandi storici alla genealo-gia della corona normanna e alle radici della storia della“nazione siciliana”. Tra i principali clienti di Onufrio vifu il principe Biagio Licata di Baucina, discendente dei
4. Fabrizio e Anna Alliata dei duchi di Pietratagliata a VillaPietratagliata, 1903.Collezione privata, Palermo.
3. Andrea Onufrio, Sala del Trono a Palazzo Forcella-Licatadi Baucina, 1885-91 circa.Biblioteca Comunale, Palermo.
146 147
5 Palazzotto:Gabbia 23x27 19-10-2012 18:35 Pagina 146
vide la presenza della nobiltà locale abbigliata con costu-mi che richiamavano le gesta dei propri avi gloriosi, qua-li si riscontrano in alcune foto all’interno della villa comenovelli tableaux vivants: Fabrizio Alliata e Notarbartolo,figlio del cavaliere Luigi e cugino primo del nostro, si faritrarre nei panni di “Don Giovanni Alliata Nobile Pisa-no venuto in Sicilia al seguito di Re Pietro d’Aragona”,in quanto il torneo rappresentava anche l’entrata a Paler-mo di Pietro III d’Aragona dopo i Vespri siciliani; lostesso, con la sorella Anna, nel 1903 si mette in posa sulsedile della camera da letto della villa paterna (fig. 4)19;Pietro Moncada, principe di Paternò (cugino primo delcavaliere Luigi Alliata e del padre del duca Fabrizio), sifa invece immortalare nelle vesti di don Ugo Moncada,di molti secoli addietro; Maria Alliata di Villafranca nel1910 posa nella maestosa dimora di famiglia con lo sfon-do di una bifora neomedievale, impersonando LaviniaLanfranchi (fig. 5), moglie del medesimo Giovanni Allia-ta interpretato dal lontano cugino20. Dunque, certamen-te nel 1910 e, sembra, già dal 1890 (quindi sincronica-mente all’edificazione di Villa Pietratagliata), i Villafran-ca avevano proceduto almeno in parte, se non del tutto,a trasformare alcuni ambienti del maestoso palazzo sette-centesco a piazza Bologni con una incisiva operazione dicamuffamento neogotico che interessava proprio la fac-ciata interna del primo cortile e lo scalone principale;forse un’ulteriore spinta per il duca Fabrizio che, a diffe-renza dei consanguinei, abitava in un originale edificiodel XV secolo e tale riconosciuto dagli organi preposti,quale monumento nazionale, fin dal 1878 21. Anche inquesto caso, ammesso che fosse confermata la data piùantica di inizio lavori per Villa Pietratagliata, si puòriflettere sulla eventuale coincidenza cronologica con ilriconoscimento pubblico per l’edificio di via Bandiera. Ilvincolo, d’altronde, si rispecchia nel sempre più incal-zante interesse da parte degli organi di tutela verso l’ar-chitettura medievale siciliana, cui si orienteranno difattigran parte degli interventi pubblici di recupero22, il chespiega anche l’incessante interesse per il restauro delpalazzo, che avrà esito positivo solamente quando se neoccuperà personalmente e direttamente il soprintenden-te dell’epoca.
Il lungo cantiere di restauro: l’intervento di FrancescoPaolo Palazzotto (1908-1915)Per schematizzare il lungo iter del cantiere di restauro(circa ventidue anni) possiamo innanzitutto discernere
5. Maria Alliata di Villafranca a Palazzo Alliata di Villafranca, 1910.Collezione privata, Palermo.
148 149
5 Palazzotto:Gabbia 23x27 19-10-2012 18:35 Pagina 148
alcune fasi distinte ma comunque connesse: con la primail duca Fabrizio coinvolge l’architetto Francesco PaoloPalazzotto per la realizzazione di alcune opere all’inter-no e all’esterno del palazzo, forse anche a causa di pro-blemi statici. Contestualmente con buona probabilità, eragionevolmente secondo gli intendimenti iniziali, sidecide di restaurare il palazzo nei prospetti; in seguito aicontrasti sorti tra il duca e la locale Soprintendenza alleBelle Arti, relativamente al progetto da attuare, i lavoriesterni non prendono le mosse e nel 1915 muoreimprovvisamente Palazzotto. Passa quindi circa undecennio prima che si rimetta mano ai progetti per l’in-carico all’architetto e soprintendente ai MonumentiFrancesco Valenti (1868-1953), con il contributo diErnesto Basile (1857-1932); quest’ultimo redige in auto-nomia alcuni disegni, tra cui il progetto per il prospettomeridionale, che non avranno esito esecutivo. I lavori deiprospetti sono condotti a buon fine intorno al 1930 dallostesso Valenti, ma con un carico di polemiche non indif-ferente. Intanto procede anche la “restituzione” dellaSala del Quattrocento o Sala delle Armi, completata oulteriormente restaurata nel 194523.Dall’analisi della documentazione dell’Archivio Palaz-zotto di Palermo si ricava che la prima porzione dei lavo-ri investe lo scalone principale, del cui accesso, in unaprima fase, si ipotizza l’inglobamento entro una strutturaal fine di rendere più agevole l’uso in occasione di intem-perie (fig. 6), iniziativa che non troverà esecuzione. Nel-lo stesso momento prendono le mosse opere che hannoun costo molto rilevante e che dovrebbero essere con-nesse alla pensilina esterna nel cortile (fig. 7), creata for-se già in precedenza come disimpegno per gli apparta-menti privati del duca24. Tali lavori, però, forse coinvol-gono solo quella struttura, che era stata ideata con ferroe vetro in stile neogotico (fig. 8), perché a oggi appari-rebbe mai realizzata; dunque, forse nello stesso momen-to, vengono attuati interventi di ristrutturazione e conso-lidamento all’interno dell’edificio. Certo è che già daquesti progetti iniziali, databili al primo semestre del1908, si evince che fosse chiara l’intenzione di camuffaretutto l’edificio valorizzandone la facies tardomedievaleoriginaria sia nel cortile25, come poi verrà perseguito for-se dal Valenti, rendendo “gotiche” le finestre del pianoammezzato, sia negli esterni, per i quali Palazzotto dise-gnò a mano libera i dettagli dell’unica finestra originaleesterna del medesimo piano e i peducci del portale (figg.9-10), in maniera da utilizzare quegli elementi per la sua
6. F.P. Palazzotto, Riformadello scalone di PalazzoPietratagliata, 1908 circa.Archivio privato Palazzotto,Palermo.
7. F.P. Palazzotto, Riforma della pensilina di Palazzo Pietratagliata, 1908 circa.Archivio privato Palazzotto, Palermo.
8. F.P. Palazzotto, Mensola per la pensilina diPalazzo Pietratagliata, 1908 circa.Archivio privato Palazzotto, Palermo.
150 151
5 Palazzotto:Gabbia 23x27 19-10-2012 18:35 Pagina 150
153
ricostruzione filologica alla Viollet-le-Duc26. In questifrangenti, tra gli ambienti destinatari di operazioni ècompresa con buona probabilità l’attuale cosiddetta Saladel Quattrocento, i cui solai, secondo quanto riferito dalduca nel 1912, erano stati rifatti da non molto tempo27.In effetti, che si propendesse a quel tempo anche perlavori interni è attestato da un altro disegno databile aiprimi anni del XX secolo, in cui è rappresentata la plani-metria del piano nobile28. Come già osservato29, nei loca-li dell’angolo nord-ovest, che impegnavano la Sala delQuattrocento, vengono tirate delle linee a matita contratto molto veloce, con cui l’architetto elimina i tramez-zi che suddividevano l’antica sala in tre vani irregolari
152
9. F.P. Palazzotto, Disegno dei peducci e davanzale della finestrain facciata dell’ammezzato di Palazzo Pietratagliata, 1908 circa.Archivio privato Palazzotto, Palermo.
10. F.P. Palazzotto, Disegno dei peducci del portale di PalazzoPietratagliata, 1908 circa.Archivio privato Palazzotto, Palermo.
11. F.P. Palazzotto, Planimetria del piano nobile con ipotesi progettuale per la Sala Magna di Palazzo Pietratagliata, 1908 circa.Archivio privato Palazzotto, Palermo.
5 Palazzotto:Gabbia 23x27 19-10-2012 18:35 Pagina 152
e ogni finestra piombata portava gli stemmi degli avi(Marassi, Moncada, Alliata e Bajada). Nella medesimamaniera si opererà nella magione principale, a partireforse dal salottino privato inter nos, probabilmente cura-to direttamente da Palazzotto, la cui finestra interna èpraticamente identica a quelle della villa, come pure ilcaminetto in legno, ricalcato dalla Sala del Trono diMalaspina35. Un altro grande camino in pietra sulla stes-sa falsariga sarebbe stato poi collocato all’interno dellaSala Magna, nel punto in cui Palazzotto aveva ipotizzatola chiusura dell’accesso diretto dalla scala, preferendoaprire un nuovo ingresso in asse con la stessa (l’odierno)verso l’attuale saletta-disimpegno che divide la zona dirappresentanza (patet amicis, come vi si legge), a destra, daquella privata a sinistra (inter nos), un tempo prima anti-camera del quarto piccolo36. Anche questa saletta, che hauna configurazione medievaleggiante con il soffitto casset-tonato dipinto e le pareti decorate a stencil con motivigeometrici entro cui è lo stemma Alliata e le tre spade,porzione di quello Marassi, potrebbe essere stata oggettodi elaborazione successiva all’intervento dell’architetto,forse però sulla base di suoi precedenti bozzetti37.Dunque, la prima fase dei lavori interessò il cortile e for-se il prospetto occidentale sullo stretto vicolo Pizzuto, dicui rimane una sezione quotata di Palazzotto che proiet-ta anche le finestre esterne, evidentemente in funzione diuna risistemazione di quella porzione che garantisse ade-guata illuminazione alla nuova distribuzione interna, chesi andava concependo38. Non è però escluso che già siintendesse mettere mano alla facciata principale, vistoche nel maggio 1909 giunge una diffida del Comune perlavori non autorizzati “nel prospetto” (laterale o princi-pale?), contravvenendo agli obblighi scaturiti dal vincolomonumentale apposto tra il 1901 e il 190239. Questo è ilprimo atto documentato relativo a interventi all’esternodell’edificio, cui seguirà un’autorizzazione da parte dellaSoprintendenza alle Belle Arti di Palermo40, forse finaliz-zata esclusivamente alla messa in sicurezza dello spigolonord-ovest, che presentava i maggiori problemi statici. Ilduca a questo punto inizia le pratiche burocratiche perla facciata principale, che era quella vincolata, e per ilprospetto laterale che segue un percorso autonomo e dicui procede subito ai lavori di consolidamento41.Dai disegni dell’Archivio Palazzotto42 si constata che suquesto fronte (fig. 12), rispetto allo stato di fatto ricava-bile dal rilievo citato precedentemente, vengono aggiun-te alcune aperture al pianterreno (sia finestre che un var-
per le esigenze abitative precedenti (fig. 11). Anche se,nello studio, Palazzotto indicava a matita l’ipotesi didividere nuovamente la sala in due saloncini simmetrici,si ritiene che quasi immediatamente sia stata perseguital’idea del recupero del volume originario, cosa del tuttocoerente alla riconfigurazione della facciata. Questoorientamento sarà scaturito dalla sicura scoperta di traviquattrocentesche originali sopra le volte in corso didemolizione per adattarle ai nuovi vani, così come dovet-te risultare contestualmente visibile traccia della singola-re finestra d’angolo, occultata da una di esse. Una voltadeliberata la riapertura dell’alta finestra (a partire dalprogetto del 1909), era certamente naturale ripristinarel’ampiezza originaria del grande salone, e anche inevita-bile, visto che l’apice della sua ogiva si incunea nel soffit-to stesso e non sarebbe stato possibile innestarvi una fin-ta volta che ne avrebbe nuovamente oscurato la granparte. Inoltre, in questo modo, la sala avrebbe avuto lafunzione di vestibolo di simbolica imponenza e antichità,biglietto da visita della famiglia come la facciata turrita30.Anche in questo caso vi è un parallelo nel Palazzo Alliatadi Villafranca di Palermo, ove il grande salone voltatod’ingresso venne trasformato forse già alla fine del XIXsecolo in una sala con soffitto retto da finte travi, più tar-di decorato in stile medievaleggiante (con gli stemmi avi-ti: Alliata, Morra, Valguarnera, Colonna, Di Giovanni eParuta)31, cui si era introdotti attraverso una piccola sala(come oggi a Pietratagliata) chiusa in cima allo scaloneda un’ampia vetrata piombata del 1929, in cui eranoancora sciorinate le armi e onorificenze equestri, a parti-re dalle effigi dei santi di famiglia32. Egualmente i quattroquarti di nobiltà, accompagnati da motti, segnano lemensole e le cornici di coronamento del soffitto ligneodipinto della grande sala del duca di Pietratagliata (Allia-ta, Moncada, Notarbartolo e Pignatelli), guardando qua-si certamente allo Steri, le cui mensole sono il modelloper queste moderne come pure per quelle di Villafranca.L’antica residenza palermitana dei Chiaromonte è unodegli esemplari topici di riferimento, insieme al soffittoligneo dell’aula magna del castello dei La Grua Talaman-ca a Carini, nei pressi di Palermo, che viene sostanzial-mente replicato dal punto di vista compositivo e forma-le33. Nel primo colpiva certamente la profusione di stem-mi34, dunque l’emulazione era naturale, cosa peraltro giàpraticata in quel prototipo che era la Villa Pietratagliata(però senza riferimenti stringenti all’edificio trecentesco),dove gli ambienti erano tutti appositamente cassettonati
154 155
5 Palazzotto:Gabbia 23x27 19-10-2012 18:35 Pagina 154
conscio com’era, pur provando a minimizzare, delledivergenze con l’Ufficio Regionale per la Conservazionedei Monumenti in relazione all’altezza delle finestre daricostruirsi 46. Nel testo compare anche la sua premessaideologica al restauro e che sarà il totem insuperabile permolto tempo: “è in me fermo proposito di ricondurre ilProspetto al suo stato primitivo per quanto possibile inarmonia delle odierne esigenze dell’interno del palaz-zo”47. Si voleva in sostanza un restauro funzionale alleesigenze abitative che dovevano prevalere sulle ragionifilologiche.La zona inferiore con le botteghe sarebbe rimasta immu-tata, sebbene esse fossero ritenute di epoca moderna, inquanto non si potevano abolire per ragioni eco-nomiche48. Il primo significativo atto di ripristino e diaddizione estetica avveniva nell’ammezzato, poiché ilduca rinunciava ai due balconi presenti da tempo imme-more, al cui posto si intendeva replicare il modello-radi-ce storica offerto dalla finestrella quattrocentesca rileva-ta da Palazzotto (con indubbia riduzione di luce e ariaper quei vani, dunque mirando a un obiettivo puramen-te artistico). Egualmente sarebbe stata integrata l’altrapure originale alla sinistra del portone, ma frammenta-ria. Al piano nobile era il cuore del restauro che preve-deva l’eliminazione dei balconi settecenteschi, il ripristi-no delle finestre originarie con la relativa decorazioneflamboyant, ormai perduta, la costruzione di un corni-cione marcadavanzale lungo tutti i prospetti e, soprattut-to, la riapertura della finestra angolare, che poteva appa-rire l’elemento di maggior delicatezza, di cui, il duca pre-cisava, erano evidenti le tracce sia all’esterno che all’in-terno, come a voler prevenire obiezioni sull’originariapresenza della finestra; contestazioni che in realtà nonsarebbero avvenute se non ventuno anni dopo, e feroce-mente, con il citato Nino Basile. In realtà ora sappiamo,come peraltro era alquanto desumibile, che la finestraera sempre esistita ed era stata chiusa nel 167249.Per i ripristini, continuava il duca, ci si era ispirati a unafinestra presente nel fronte posteriore, di cui si chiedevapure la rimozione e il riutilizzo in facciata50; questa fine-stra finirà per divenire una sorta di araba fenice di cuitutti conoscevano l’esistenza e nessuno sapeva dove fos-se. Di fatto sparisce nel momento in cui il Ministerochiede che venga preservata51, il duca infatti risponderàche ormai si era dovuta rimuovere (atto che, certo, nondovette ben disporre le autorità) e da allora, nonostantespecifiche richieste, non ricomparirà mai più52. Difficile
co con arco), nell’ammezzato (una finestra verso la viaBandiera), nel piano nobile (la finestra d’angolo), e nevengono chiuse un paio nel livello superiore a quest’ulti-mo. Il paramento murario è pensato a intonaco coneffetto mimetizzante rispetto ai conci della facciata prin-cipale, viene tirata una cornice marcadavanzale al pianonobile (plausibilmente mai esistita) e delle tre finestredel piano nobile solo la più vicina a quella angolare por-ta trafori in stile, all’interno dell’arco sopraccigliare conmensole figurate (dato che è quella che si apre sul grandesalone). In sostanza, è esattamente ciò che oggi si vede,identico anche nel disegno della decorazione di quellafinestra, con l’unica differenza dell’assenza al pianonobile dell’antica finestra quatra che sembra inserita fuo-ri contesto, o in seguito a successivo ritrovamento inloco, molto probabilmente da Valenti.La facciata principale (fig. 13), come si è detto, segue ilpercorso dell’approvazione ministeriale con l’invio aRoma, tramite la Soprintendenza, del progetto con l’alle-gata relazione firmata dal duca il 14 giugno 190943. Esisto-no anche due disegni: un foglio lucido e un davvero pre-gevole acquerello firmato da Francesco Palazzotto e data-to 1909 (fig. 14)44, ritenuto utile a presentare il restauromolto efficacemente dal punto di vista estetico e per tra-smettere il ritrovato equilibrio originario di austera sem-plicità che l’intervento avrebbe contribuito a restituire45.La relazione del duca allegata al disegno (certamentedettata dal progettista) chiarisce le scelte compositive,
156 157
12. F.P. Palazzotto, Progetto di restauro per il prospetto ovest diPalazzo Pietratagliata, 1909.Archivio privato Palazzotto, Palermo.
5 Palazzotto:Gabbia 23x27 19-10-2012 18:35 Pagina 156
158
13. PalazzoPietratagliata primadei restauri, 1912.Archivio Alliatadi Pietratagliata,Palermo.
15. PalazzoPietratagliata durantei restauri, 1930,Archivio Alliatadi Pietratagliata,Palermo.
5 Palazzotto:Gabbia 23x27 19-10-2012 18:35 Pagina 158
avrebbe finito per accogliere con entusiasmo quasi quin-dici anni dopo. Correva il 1910.Solamente due anni dopo61, forse anche in seguito al solle-cito dell’Assessorato comunale ai Lavori Pubblici, che esi-geva di rimuovere un “puntello” messo a sostegno all’edi-ficio e che ostruiva il passaggio62, il duca, lancia in resta,prende la penna e riapre nuovamente la disputa ottenen-do la riunione del Consiglio Superiore per le Antichità eBelle Arti63 verso quale si muove anche Ernesto Basile, cheperò, mettendo le mani avanti, scrive a Pietratagliata: “ilguaio è che la sezione chiamata a giudicare è composta inmassima parte di archeologi che guardano da punti divista spesso d’una pedanteria estrema”64. In effetti il giudi-zio ricalcò il precedente e fu approvato il progetto “com-pilato dalla Soprintendenza ai Monumenti di Palermo,lasciando poi libera la Soprintendenza stessa d’introdurrequelle modificazioni che nel concretare definitivamentegli studi possano ritenersi opportune”; frase che potevaconsentire margini di azione mediatrice e di successiviadattamenti65. In effetti Salinas di lì a qualche mese scri-ve al duca comunicandogli l’esito e convocandolo insede per “gli opportuni definivi accordi”, come sollecita-to dal Consiglio66. Siamo ormai al 1913 e avviene l’im-ponderabile.L’ingegnere Giuseppe Rao, nel 1909 direttore dell’Uffi-cio Conservazione dei Monumenti della Soprintendenzadi Palermo, si rivolge direttamente a Corrado Ricci,direttore generale per le Antichità e Belle Arti, propo-nendogli come soluzione definitiva di “abbassare di unfilare gli archivolti delle finestre”67. Un mese dopo lostesso Rao informa il duca che il Ministero ha approvatola sua proposta, autorizzando quel progetto, con il plau-sibile e condivisibile sconcerto dello stesso nobiluomo68.Dunque la Soprintendenza e il Ministero, rappresentatida autorevolissime personalità (come Salinas e Ricci),dopo anni di discussioni per il principio della formale everitiera ricostruzione archeologica di qualcosa che nonesisteva più – la cornice marcadavanzale – ora, non soloconsentivano di erigerlo dove era stato indicato dal pro-getto di Palazzotto fin dal 1909, ma, al fine di mantenerel’altezza prefissata delle finestre (anch’essa ipotetica),suggerivano e auspicavano che venissero tranquillamen-te smontati e spostati gli archi sopraccigliari delle fine-stre, tra le poche tracce dell’originale decorazione dellafacciata quattrocentesca, senza porsi alcun problemarelativamente alla sicura e questa volta incontrovertibilealterazione del monumento.
pensare che sia stata distrutta, ma d’altronde non sonostate rintracciate evidenze in merito, se non la colonninaposta in un angolo della Sala del Quattrocento chepotrebbe essere una sua parte53. Certo non può trattarsidella finestra quatra del vicolo Pizzuto, quella dovevainfatti essere curvilinea per adattarsi alle ghiere del pro-spetto principale. Non è neppure riconoscibile nel por-tale interno alla destra dell’androne del palazzo cherisulta essere originale, e in quella sede viene infatti dise-gnato dall’architetto Giuseppe Saverio Palermo (c. 1772-1850) nel 183754, a dimostrazione di un diffuso interessein città per l’architettura medievale siciliana in quel pre-coce periodo, sulla scorta di molte creazioni innovativeche avrebbero fatto scuola55.Ciò che segna l’insormontabile dissidio con la Soprinten-denza è l’altezza delle finestre che quell’ufficio, secondoquanto riportato nella relazione e rispetto alle “dimen-sioni classiche”, riteneva di 3,18 metri, mentre FabrizioAlliata le desiderava più basse di 32 centimetri per poter-si affacciare sulla strada. Infine nella domanda si affer-mava di non tener conto della nuova cornice di chiusuradell’edificio (evidentemente ripresa da Palazzo Abatel-lis) e si richiedeva un contributo per il restauro di circaun terzo della cifra preventivata, che corrispondeva a50.000 lire56.L’esito non fu però favorevole per la prevedibile opposi-zione della Soprintendenza e di conseguenza del Mini-stero che approvò tutto, tranne la questione delle fine-stre connessa al cornicione marcadavanzale, di cui pureil soprintendente Antonino Salinas chiedeva il ripristinoma in un punto diverso e più basso, usando come riferi-mento alcune tracce di risega nel prospetto e il frammen-to ancora visibile nell’estremo est dell’edificio57. Questo,però, non faceva parte del palazzo ab origine, cosa chedeterminò una lunga querelle che qui si tralascia58. Forsea causa di pressioni, o per cercare di trovare una soluzio-ne che venisse incontro almeno in parte alle esigenze del-la proprietà, il Ministero prese una decisione “salomoni-ca” con la quale non recedeva dal mantenimento dellasupposta altezza originaria del cornicione ma consentivadi spezzarlo in coincidenza delle finestre, in maniera chel’affaccio sarebbe stato garantito, come richiesto, e ungiorno, se mai si fosse voluto, si sarebbe potuto comple-tare il restauro chiudendo quella porzione e completan-do il marcapiano59. La giovane età del duca non dovetteprobabilmente suggerirgli maggiore riflessione su questoescamotage che lui rifiutò recisamente60 e che, invece,
160 161
5 Palazzotto:Gabbia 23x27 19-10-2012 18:35 Pagina 160
ni, perorando la causa del duca – con cui a un certo pun-to stringe un chiaro sodalizio e comunione di intenti77– efocalizzando le attenzioni sulla finestra d’angolo, chefino al 1924 non aveva destato tali interessi.Nel maggio 1929 questa viene finalmente aperta78, epoco dopo avviene anche il fortuito ritrovamento all’in-terno di un sotterraneo di un “grande capitello anticorecante uno stemma ad angolo” (Termine) e di quellache si ritenne la relativa base, facenti parte della colonnache doveva occupare il cantone contraffortato79. Anchequesti elementi vengono ricollocati entro la primaveradel 1929 nel luogo da cui si pensava provenissero, unitida una colonna moderna (l’antica e originale forse si puòriconoscere in quella collocata nella nicchia a destra del-l’androne d’ingresso), utilizzando fondi pubblici di som-ma urgenza, data l’instabilità dello spigolo nel momentoin cui fossero stati tolti i pali di legno che lo sostenevano,secondo quanto addotto dalla Soprintendenza80. Ilrestauro della facciata si conclude entro il 4 dicembre1930 (fig. 15), epoca in cui viene pubblicato il brucianteatto di accusa nel “Giornale di Sicilia” che giungerà sinoa Roma sulla scrivania di Corrado Ricci.Alla luce della felice conclusione dell’annoso restauro cisi può chiedere cosa vi sia stato di tanto rivoluzionario ocreativo nel progetto di Valenti, rispetto al precedente,per essere riuscito dove si era fallito? In realtà, per sinte-tizzare, poco o nulla, se non l’inserimento della colonnad’angolo, nonostante l’architetto nella sua memoria del1924 provi a dimostrarsi innovativo nella sua azione,denigrando e sminuendo quella di chi lo aveva precedu-to. Difatti la finestra d’angolo era già presente nel pro-getto Palazzotto del 1909 e i suoi decori, come quelli ditutte le altre finestre che oggi si vedono, sono del tuttoidentici in quel disegno acquerellato81. La cornice marca-davanzale spezzata, come si è visto, era stata già propostadal Ministero nel 1909, ma pure dalla Commissione Edi-lizia di Palermo, auspice e forse suggeritore lo stessoPalazzotto82; lui si limita a sostanziarla con “l’abilissimatrovata”, come la chiama Nino Basile, cioè l’accostamen-to tra Palazzo Pietratagliata e il Palazzo della Giudeccadi Trapani che, per l’appunto, aveva un cornicione ese-guito in quella maniera, e originale, secondo l’architetto.Dunque non possiamo sapere, ammesso che sia essenzia-le come sembra considerare Valenti, chi fosse il primo adaverla immaginata in questo modo83.Le uniche novità, in definitiva, sono la colonna d’angoloinstallata in corso d’opera, il dettaglio dei fianchi delle
Le inevitabili discussioni in successive riunioni fra le partinon portarono per fortuna a nulla. Nel frattempo il 7 mar-zo 1914 e il 24 febbraio 1915 si erano spenti rispettiva-mente Antonino Salinas e Francesco Palazzotto; il 28 apri-le 1915, l’ultimo atto prima di una lunga pausa, il nuovosoprintendente Giuseppe Rao chiede alla duchessa Caro-lina, madre di Fabrizio, che “cosa se n’è fatta della finestrabifora con il timpano a traforo che trovavasi nella facciata[…] in via Chiappara”69. Un capitolo si era chiuso.
La “riscoperta” della finestra angolare e “l’abilissimatrovata” di Francesco Valenti (1924-1930)Dopo il 1915 sembra che tutto taccia, se non fosse per lenotifiche ministeriali di vincolo ai sensi della legge del 20giugno 1909, inviate nel 1915 e nel 1919 ai fratelli Giulia eFabrizio Alliata e Notarbartolo, e ai loro zii Ernesto eCirillo Alliata e Moncada70. In realtà, secondo quantoriportato oralmente dalla principessa Signoretta Licata diBaucina Alliata, nipote del “fondatore” e attuale proprie-taria del bene, si procedette incessantemente e con grandeimpegno di risorse alla sistemazione in stile degli ambientiinterni che oggi vediamo, proseguendo anche oltre laseconda guerra mondiale. Tra i lavori rientravano le gran-di finestre con vetri policromi e piombati per le quali laduchessa nel 1921 contattò la ditta De Matteis di Firenze,con cui vi fu uno scambio epistolare ma che non sembra,almeno in un primo momento, aver portato a nulla di fat-to, forse in favore di altri produttori di Venezia.A un certo punto però qualcosa dovette muoversi a van-taggio dell’architetto Francesco Valenti che, nella nuovaveste di soprintendente di fresca nomina71, il 16 agosto1924 comunica al duca Fabrizio, in seguito a verosimileaccordo precedente, che “il progetto di restauro dellafacciata del Suo Palazzo è stato inviato al Ministero”72.Alla stessa data, in effetti, risale la memoria allegata alprogetto, firmata da Valenti e che si trova all’ArchivioCentrale dello Stato di Roma73.Il “nuovo” progetto viene repentinamente approvato“all’unanimità”74 dal Consiglio Superiore alle Belle Arti,a cui è inviato dal Ministero per l’annosa problematicitàriscontrata75, ma non si giunge all’inizio effettivo deilavori, nonostante varie discussioni e riunioni, se nonnell’ottobre 192776, a causa della notevole lievitazionedei costi e del fatto, di conseguenza, che il duca provi aottenere maggiori finanziamenti pubblici per il restauro,che ormai è del tutto in mano agli organi di tutela. Lostesso Valenti si sarebbe fatto tramite di queste aspirazio-
162 163
5 Palazzotto:Gabbia 23x27 19-10-2012 18:36 Pagina 162
facoltà di una migliore lettura rispetto allo stato prece-dente, pur nello spirito del tempo. Ciò non può che esse-re riconosciuto alla pervicace e costante dedizione delduca Fabrizio. Se riannodiamo i fili della storia, vediamocome il sogno di un ragazzo appena ventiquattrenne nonsia stato spazzato via dalle prime difficoltà. La volontàtesa a restituire dignità alla magione familiare, che eracome renderla a se stessi e al proprio casato, non fuintaccata dalle davvero complesse vicende burocratiche,frutto anche di conflitti tra differenti personalità e orga-nismi (committente, architetti, funzionari delle soprin-tendenze, ministero), e neppure fu frenata dai conse-guenti disagi economici che il lunghissimo cantieredovette certamente causare. Il duca indubbiamente spo-sò l’opera identificandosene e associandola al prestigiodella propria schiatta. Non sono, infatti, scontate l’atten-zione e la cura prestate nei dettagli dei nuovi ambienti:dalle eleganti finestre piombate, al soffitto ligneo dipin-to, sicuramente il più pregevole fra i coevi esempi paler-mitani di neostile, al maestoso camino con lo stemmaAlliata (scolpito anche sulle mostre dei nuovi portali inpietra della Sala Magna, a indicare durevolmente la com-mittenza e la proprietà), fino alle preziose decorazioniparietali di quel salone con uno stencil a rilievo ottenutotramite maschere di cuoio con eleganti iconografiededotte dai repertori medievali e rinascimentali (cheancora si conservano in famiglia) su un sottofondovibrante, di rara efficacia, trattato cromaticamente adaffresco. Non è neppure banale che un privato cittadinonell’edificio di propria abitazione rinunciasse così facil-mente alla luminosità del piano ammezzato, riducendoladrasticamente per ragioni filologiche ed estetiche, chepure guidarono il duca nel voler riaprire la “dimenticata”e peculiare finestra d’angolo, fin dalla prima elaborazioneprogettuale.Le opere proseguirono anche dopo il 1930, come per unprogetto di vita che fu necessariamente sposato dai con-giunti, nonostante gli inevitabili sacrifici, tra cui si distinsela devota e amorevole sorella Giulia, senza la quale non sisarebbe mai giunti ai risultati che possiamo apprezzare.Gli interni del piano ammezzato (definito così per consue-tudine, ma dotato di volumi da piano nobile) furono, peresempio, completati, sempre in stile, nella seconda metàdel Novecento, pare dall’architetto Vincenzo Zanca, e unadelle ultime addizioni neogotiche fu l’edicola nell’andronecon la Vergine e il Bambino voluta dal duca come ex votoper il felice e inaspettato ritorno a casa dopo la guerra nel
finestre corredati da semicolonnine, che lui elabora suquelle del portale interno, e la notevole accortezza nell’a-ver impostato il piedistallo della colonnina non sopra il“davanzale originario” (cioè il nuovo cornicione), comeavrebbe dovuto, ma alla sua base, in maniera da acquisi-re alla luce un altro filare di conci, a cui si sommarono i30 cm del plinto già previsto nel progetto antico; insom-ma alla fine le finestre realizzate dalla Soprintendenzarisultano ancora più lunghe di quelle del progetto Palaz-zotto tanto osteggiato84.In più, la forte personalizzazione del restauro si scontrò,come si è detto, con l’altrettanto pervicace critica diNino Basile che doveva già essere nell’aria nel 1929,allorquando il duca si era dato da fare per trovare in Sici-lia altri esemplari di finestre d’angolo, probabilmenteper preparare la difesa85. Alla luce di un’equilibratavisione generale, nonché dei documenti sulla storia del-l’edificio a partire dal Quattrocento pubblicati infra,bisogna dire però che molte delle affermazioni di ordinecompositivo di Basile non erano fondate (incluse alcunesue ricostruzioni dei fatti) – forse di più quelle relativealla tecnica utilizzata per il restauro, con l’uso disinvoltodel cemento armato cui Valenti spesso indulgeva86– e cheprobabilmente esse erano la cartina di tornasole anche diun crudo risentimento personale.Durante tutti questi frangenti aveva mantenuto un ruoloattivo ma defilato Ernesto Basile, in amichevoli rapporticon il duca almeno dal 1912, che effettuò anche alcunistudi per una finestra del palazzo e per quella che sem-brerebbe la scala lignea della saletta d’ingresso, forse nelperiodo in cui si occupò del restauro nella qualità di tec-nico di fiducia del duca; infatti il progetto era sì dellaSoprintendenza, cui però in teoria spettava non l’esecu-zione dei lavori, ma solo la sorveglianza87.Il disegno per il fronte posteriore, forse il più “quattro-centesco” della produzione di Basile, si può ascriveredunque alla fine degli anni Venti, e avrebbe certo resomolto gradevole anche quel versante che, in una delledue cianografiche conservate nell’Archivio Alliata diPietratagliata, presenta uno schizzo anonimo a matitariguardante la chiusura del cortile posteriore, forse giàrealizzata e che si pensava di rendere monumentale conuna loggia al livello del piano nobile.È innegabile, in conclusione, che questo restauro hagoduto di una ribalta fuori dall’ordinario per decenni ein ragione dell’importanza che giustamente si riconosce-va all’edificio, cui il recupero ha fornito comunque la
164 165
5 Palazzotto:Gabbia 23x27 19-10-2012 18:36 Pagina 164
6 Si rimanda per gli approfondimenti al testo di MassimilianoMarafon Pecoraro, infra.7 Su Nicolò Puglia cfr. A. Abbadessa, Tre allievi di Giuseppe Venan-zio Marvuglia, Palermo 1999, pp. 31-54; G. Lo Tennero, “PugliaNicolò”, in L. Sarullo, Dizionario degli artisti siciliani. Architettura, acura di M.C. Ruggieri Tricoli, Palermo 1993, vol. I, pp. 302-303; P.Palazzotto, “Puglia Nicolò”, in Enciclopedia della Sicilia, a cura di C.Napoleone, Parma 2006, p. 806. Di recente, per un’opera in cui fucoinvolto, cfr. M. Vesco, Identità dimenticate: il convento della Gan-cia e l’ospizio di Beneficenza di Palermo, in “Studi e Strumenti”, Qua-derni dell’Archivio di Stato di Palermo. Scuola di Paleografia eDiplomatica, VIII, Palermo 2010, pp. 93-131.8 Cfr. N. Basile, “Antichi palazzi dei Termine e la falsificazione di unmonumento”, in Palermo felicissima. Divagazioni d’arte di storia diNino Basile, seconda serie, Palermo 1932, p. 258; M. Marafon Peco-raro, infra.9 Fino a oggi la maggior parte delle notizie che hanno informato sul-l’iter della vicenda sono state tratte dal testo fortemente critico del-l’avvocato Nino Basile, diretto conoscitore dei fatti (o almeno così siè sempre ritenuto), pubblicato in tre puntate nel 1930 sul “Giornaledi Sicilia” e due anni dopo negli ancor più noti volumi della collanaPalermo felicissima, titolo che per i palermitani è divenuto un richia-mo nostalgico alla città perduta e rimpianta; si veda N. Basile, Gliantichi palazzi dei Termine in Palermo ed un recente restauro, in“Giornale di Sicilia”, 4, 13 e 20 dicembre 1930; Idem, Antichi palaz-zi dei Termine..., cit., pp. 235-266. Sull’edificio si veda anche il piùrecente testo in A. Zalapì, Dimore di Sicilia, Verona 1998, pp. 84-94.Il presente studio ha invece incrociato la documentazione conserva-ta a Palazzo Pietratagliata, presso la Soprintendenza ai Beni Cultura-li e Ambientali di Palermo, nell’Archivio privato Palazzotto di Paler-mo e nell’Archivio Centrale dello Stato di Roma, rivelando aspettiignoti, ancorché non sempre del tutto chiari, che tracciano una storiamolto più complessa e di certo emblematica. L’incrocio fra la docu-mentazione frammentaria in ognuno di questi archivi, qui ridotta epiù estesamente esposta nell’edizione di approfondimento in corsodi stampa (2012), ha consentito la ricostruzione di un inedito mosai-co che, però, presenta ancora alcune zone d’ombra.10 A quella data aveva già prodotto una davvero notevole mole diopere sul territorio palermitano, alcune insieme al fratello GiovanBattista, tra cui le ville Genuardi, Raineri, Salandra e Scandurra nelviale della Libertà, la riforma di Palazzo Arezzo di Celano su viaRoma, i palazzi Marino (poi Laganà e oggi Planeta; piazza Florio) eMaurigi (via E. Amari), il vasto complesso dell’Ospedale Psichiatricodi via Pindemonte, l’Ospedale dei Sacerdoti in via Bonello (oggiOpera Pia Ruffini), un padiglione all’Ospizio Marino, il tempietto diVilla Tasca, ecc. Su Francesco Paolo Palazzotto cfr. P. Palazzotto,“Palazzotto Francesco Paolo”, in L. Sarullo, Dizionario degli arti-sti..., cit., pp. 333-334.11 Su Emmanuele Palazzotto cfr. P. Palazzotto, “Palazzotto France-sco Paolo”, in L. Sarullo, Dizionario degli artisti..., cit., pp. 332-333.12 Sulla famiglia Palazzotto cfr. P. Palazzotto, “Palazzotto”, in Enci-clopedia..., cit., p. 606.13 Sulla villa si veda P. Palazzotto, Il castello del principe entomologo,in “Kalós. Arte in Sicilia”, a. 4, n. 2, marzo-aprile 1992, pp. 4-11; P.Palazzotto, Esemplari di revivals e arredi neogotici a Palermo nei seco-li XIX e XX. Tra ricerca della modernità e “passatismo”, in “DecArt.
1946 del figlio Pier Luigi.La bellezza degli spazi, dunque, non può essere ritenutafine a se stessa e oggetto di puro narcisismo autoriferito;certo, essa è da legare indissolubilmente al duca, ma nontanto per sé quanto per tutti i suoi. Lo si scorge dalla chia-ra distribuzione degli spazi a seconda dei fruitori, come siè detto, spartiti dal piccolo ingresso al piano nobile trami-te icastici ed efficaci motti, pensati e adottati dal duca stes-so. Egualmente possiamo ritenere che il suo testamentospirituale si possa riconoscere nelle frasi latine reiteratenegli alveoli del soffitto ligneo del principale salone, mistealla decorazione, quasi come elementi calligrafici senzavalore. Questi sembrano voler esprimere, a occhi attenti eavveduti, come tutti gli sforzi compiuti, con indefessa enecessaria tenacia, e come l’amore riversato nella casa nonfossero stati altro che la proiezione del profondo affettoprovato per i propri congiunti e a loro dovuto. Il modoche il duca riteneva più appropriato per dimostrarlo eral’aver lasciato loro un bene recuperato all’antico splendo-re, unmonumentum che narra vicende lunghe secoli e cheera necessario fossero rimembrate. Non possiamo negareche gli attuali eredi abbiano fatto tesoro di questo lascito eabbiano certamente proseguito sulla strada dell’illustreantenato sulla falsariga dell’imperitura stringa: “SUOSPERAMAT QUI DOMUM DILIGIT / OMNIA CONSTANTIAPERFICIT”.
Note
1 Sui Marassi cfr. A. Mango di Casalgerardo, Il nobiliario di Sicilia,Palermo 1912, vol. II, p. 417; F. San Martino De Spuches, La storiadei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia dalle loro origini ai nostri giorni(1925), Palermo 1929, vol. VI, pp. 5-6; e il testo di MassimilianoMarafon Pecoraro infra, cui si rimanda per le precisazioni documen-tarie inerenti alla genealogia familiare che correggono alcuni erroripresenti nei testi citati.2 I capitoli stilati il 28 settembre 1818 sono conservati nell’ArchivioAlliata di Pietratagliata (d’ora in poi AAP).3 Il matrimonio avverrà nella parrocchia di S. Margherita di Palermo;cfr. Archivio Storico Diocesano di Palermo, Stati liberi, vol. 1965(già ) 66, 1818-19, 23 settembre 1818, c. 62v.4 Che si tratti della Negazione di Pietro già nella collezione Ruffo diMessina e oggi in collezione privata fiorentina? Cfr. A. Zalapì, “Ilsoggiorno siciliano di Matthias Stom tra neostoicismo e “dissenso”.Nuove acquisizioni documentarie sull’ambiente artistico straniero aPalermo, in 1570-1670 Porto di mare. Pittori e pittura a Palermo tramemoria e recupero”, cat. mostra (Palermo, San Giorgio dei Geno-vesi, 30 maggio - 31 ottobre 1999) a cura di V. Abbate, Palermo1999, p. 154.5 Cfr. A. Mango di Casalgerardo, Il nobiliario di Sicilia, cit., vol. I, p. 56.
166 167
16. Fabrizio Alliata duca di Pietratagliata, 1905.Collezione Carolina Alliata di Pietratagliata.
5 Palazzotto:Gabbia 23x27 19-10-2012 18:36 Pagina 166
sto corpo, anch’essi del medesimo gusto; cfr. APP, nn. inv. 910, 919.26 APP, nn. inv. 914, 902.27 ACS, Min. PI, Dir. Gen. AABBAA, Div. II, 1925-1928, busta 126,fasc. 31, Palazzo Termine Duca di Pietratagliata.28 APP, n. inv. 907.29 P. Palazzotto, “Esemplari di revivals...”, cit., p. 78, nota 26.30 Peraltro, se si fosse mantenuta l’ipotesi iniziale di realizzare duesaloni gemelli, il primo, con l’apertura della finestra d’angolo, sareb-be stato illuminato da tre finestre sovradimensionate rispetto alla suaquadratura.31 P. Palazzotto, “Esemplari di revivals...”, cit., p. 72.32 Ibidem, p. 73; G. Travagliato, Il palazzo dei principi…, cit., pp. 29 e32, fig. 12.33 P. Palazzotto, “Esemplari di revivals...”, cit., pp. 72-73.34 Ibidem.35 Ibidem, p. 69.36 Ibidem. Per la destinazione d’uso di questo vano si vedano i saggidi Maurizio Vesco e Massimiliano Marafon Pecoraro, infra.37 P. Palazzotto, “Esemplari di revivals...”, cit., p. 71.38 APP, n. inv. 903.39 Diffida del 14 maggio 1909 in AAP.40 AAP, Lettera del duca Fabrizio alla Regia Soprintendenza aiMonumenti con cui rassicura che si sta muovendo nel solco dell’au-torizzazione ricevuta il 25 maggio corrente, 10 giugno 1909.41 AAP, Trascrizione della lettera del duca Fabrizio all’ingegnere G.De Simone dell’Assessorato ai LLPP, 15 giugno 1909; Trascrizionedella lettera del duca Fabrizio all’assessore ai LLPP, 15 giugno 1909;Trascrizione della lettera del duca Fabrizio all’assessore ai LLPP, 2luglio 1909.42 APP, nn. inv. 916-918.43 AAP, Trascrizione del 14 giugno 1909; originale in ACS, b. 126/31.44 APP, nn. inv. 904, 962.45 E. Palazzotto, “Didattica e professione nei disegni dell’ArchivioPalazzotto”, in Designare. Il disegno e le tecniche di rappresentazionenella scuola palermitana, cat. mostra a cura di F. Avella, C. Fiore, M.Milone, Palermo 2007, pp. 54, 57; P. Palazzotto, “Nobili committen-ti: alle origini delle architetture neocarnilivaresche in Sicilia”, inMat-teo Carnilivari Pere Compte 1506-2006. Due maestri del gotico nelMediterraneo, cat. mostra a cura di M.R. Nobile, (Noto, maggio-luglio 2006), Palermo 2006, p. 207.46 AAP, Trascrizione della relazione del 14 giugno 1909; originale inACS, b. 126/31.47 Ibidem.48 Quella alla sinistra dell’ingresso era già esistente, smentendo dun-que quanto affermato come certezza da Nino Basile; cfr. MaurizioVesco, infra.49 Si veda il testo di Maurizio Vesco, infra.50 AAP, Trascrizione della relazione del 14 giugno 1909; originale inACS, b. 126/31.51 Lettera del ministro al sovrintendente ai Monumenti di Palermodel 21 luglio 1909 in risposta alla precedente del 30 giugno 1909,prot. 13900, in ACS, b. 126/31.52 AAP, Lettera del duca Fabrizio al sovrintendente Salinas del 20agosto 1909 in risposta alla precedente del 24 luglio 1909, prot.1330. A questa finestra antica però sembrerà alludere implicitamen-te Francesco Valenti nella relazione allegata al suo progetto del 1924.
Rivista di Arti Decorative (A Magazine for the Decorative Arts)”, n.4, autunno 2005, pp. 65-67.14 Cfr. AAP, Consegna finale dei lavori di diverse classi inservienti allaCasina e Casamento di pertinenza di S.E. il Sig. Duca di Pietratagliatain contrada delle Terrerosse, 9 novembre 1855; Consegna finale deilavori di fabbriciere inservienti alla Casina e Casamento di pertinenzadi S.E. il Sig. Duca di Pietratagliata in contrada Malaspina, 2 giugno1856.15 Cfr. P. Palazzotto, “Esemplari di revivals…”, cit., pp. 61-79.16 Sull’evento storico cfr. Sicilia 1812. Laboratorio costituzionale, gui-da ai luoghi ai fatti ai personaggi, a cura di I. Bruno e P. Palazzotto,Palermo, in corso di stampa, passim.17 Archivio privato Palazzotto (da ora in poi APP), Registro contabi-le dei lavori di Francesco Paolo Palazzotto, p. 11.18 Su Onufrio cfr. P. Palazzotto, “Andrea Onufrio. Declinazioni neo-gotiche in arredi siciliani in osso di fine Ottocento”, inMateriali pre-ziosi dalla terra e dal mare nell’arte trapanese e della Sicilia occidenta-le tra il XVIII e il XIX secolo, cat. mostra a cura di M.C. Di Natale(Trapani, Museo Pepoli, 15 febbraio - 30 settembre 2003), Palermo2003, pp. 343-364. Aggiornamenti e integrazioni sono in P. Palazzot-to, “Une singulière ‘invention’ à Palerme à la fin du XIXe siècle: lemobilier néo-normand”, in Les Normands en Sicile XIe-XXIe siècles.Histoire et légendes, cat. mostra a cura di A. Buttitta e J.Y. Marin(Caen, Musée de Normandie, 24 giugno - 15 ottobre 2006), Milano2006, pp. 96-101; P. Palazzotto, “Esemplari di revivals…”, cit., pp.73-77.19 La fotografia datata è in collezione privata di Palermo.20 G. Travagliato, “Il palazzo dei principi Alliata di Villafranca aPalermo: per secoli monumento e documento di vita quotidiana”, inAbitare l’arte in Sicilia. Esperienze in età moderna e contemporanea, acura di M.C. Di Natale e P. Palazzotto, Palermo, in corso di stampa,pp. 30 e 33, fig. 13.21 Nell’Inventario dei monumenti ed oggetti archeologici medioevaliposteriori alla caduta dell’Impero Romano nella provincia di Palermo,manoscritto e firmato dal prefetto il 16 agosto 1878, al n. 34 è segna-to Palazzo Pietratagliata al Pizzuto con questa nota: “si crede chel’alta torre sia una di quelle che cingevano le varie città murate checomponevano Palermo. L’architettura squisita che dà a questo pala-gio cotanto pregio, è uno splendido saggio della medioevale. È delsecolo XV”; cfr. Archivio Centrale dello Stato di Roma (ACS), Min.PI, Dir. Gen. AABBAA, Div. II, 1860-1890 (I versamento), II Monu-menti, busta 376, fasc. 14-3-5-2.22 Sull’argomento si veda F. Tomaselli, Il ritorno dei normanni. Prota-gonisti ed interpreti del restauro dei monumenti a Palermo nella secon-da metà dell’Ottocento, Roma 1994.23 Il pittore degli ultimi interventi dovrebbe essere tale Griffo; cfr. P.Palazzotto, “Esemplari di revivals...”, cit., pp. 69 e 78, nota 25. Nel-l’APP si conserva anche una lettera senza data (probabilmente deglianni Cinquanta) inviata all’architetto ingegnere Emanuele Palazzot-to (1886-1963), figlio di Francesco Paolo, in cui la duchessa Amaliadi Sarzana, moglie di Pier Luigi Alliata di Pietratagliata, chiede diripensare a una sua disponibilità negata, forse in relazione ad altrilavori per la casa.24 Ibidem, pp. 68, 78, nota 23.25 A ulteriore prova, altri due bozzetti di Palazzotto portano lo studioper i serramenti esterni dei portoni delle carretterie sottostanti a que-
168 169
5 Palazzotto:Gabbia 23x27 19-10-2012 18:36 Pagina 168
prot. d’entrata 14215 (9 settembre 1913), in ACS, b. 126/9095.68 Lettera del ministro al soprintendente di Palermo, 30 settembre1913, prot. 14215, in ACS, b. 126/9095. Cfr anche AAP, Lettera delsoprintendente ai Monumenti Giuseppe Rao al duca Fabrizio, 11ottobre 1913, prot. 2444.69 AAP, Lettera del soprintendente Giuseppe Rao alla duchessaCarolina di Pietratagliata, 8 aprile 1915, prot. 1011.70 AAP, Tre notifiche di vincolo del 13 maggio 1915; Quattro dell’8marzo 1919.71 Valenti, dopo un periodo di reggenza, nel 1924 viene nominatosoprintendente ai Monumenti di Sicilia, dunque con un ruolo didominus; cfr. C. Genovese, Francesco Valenti. Restauro dei monu-menti nella Sicilia del primo Novecento, Napoli 2010, p. 62.72 AAP, Biglietto di Francesco Valenti al duca Fabrizio, 16 agosto1924.73 ACS, Min. PI, Dir. Gen. AABBAA, Div. II, 1925-1928, busta 126,Palazzo Termini duca di Pietratagliata.74 Lettera del ministro alla R. Soprintendenza, 17 ottobre 1924, prot.9095, in risposta alla lettera del 16 agosto 1924 n. 2657, in ACS, b.126. Estratto del verbale della Commissione Centrale per le Anti-chità e Belle Arti dell’adunanza dell’8 settembre 1924, ibidem.75 Lettera del ministro al soprintendente ai Monumenti, 26 agosto1924, prot. 9095, in risposta allla lettera del 16 agosto 1924, prot.2657, in ACS, b. 126.76 La data di inizio dei lavori è dedotta dall’incrocio di documenta-zione negli archivi compulsati, per il cui dettaglio si rimanda allacitata edizione di approfonfimento del volume in corso di stampa(2012).77 Valenti, come lui stesso scrive, si fa latore delle richieste di fondi alMinistero e per ottenere la concessione gratuita del suolo pubblico.Per il suolo pubblico l’esito è positivo, per i fondi invece la sommasarà sempre limitata alle 10.000 lire inizialmente elargite per l’aper-tura della finestra angolare, più qualcos’altro per la colonna d’ango-lo ottenuto con un escamotage. Per il dettaglio, che qui non si espo-ne per brevità, cfr. i numerosi documenti contenuti in AAP, inASOP, fasc. Mon. 281, Palermo, Palazzo Pietratagliata già Termini, ein ACS, b. 126 e ACS, Min. PI, Dir. Gen. AABBAA, I versamento(1860-1890), Div. II, 1929-1933, busta 169 fasc. Palermo, PalazzoTermine dei Duca di Pietratagliata dal 1626 al 1930.78 Si utilizza “pietra della Foresta di Carini intagliata in cinque aspet-ti”, “muratura mista con pietra delle cave dell’Aspra”, per un totaledi 10.000 lire; Soprintendenza di Palermo, Misura ed apprezzo deilavori di restauro eseguiti nel Palazzo Pietratagliata, 28 maggio 1928,in ASOP, Mon. 281.79 Viene inoltrata richiesta di ricollocazione alla Commissione con-servatrice per i monumenti, scavi e oggetti d’arte della Provincia diPalermo che il 15 giugno 1928 si riunisce nei locali della Soprinten-denza di Palermo, presenti Ernesto Basile, presidente (nonché tecni-co di fiducia del duca), Antonio Ugo, Giuseppe La Mantia, A. diRamione, segretario, Rocco Lentini, Enrico Brunelli e monsignorEnrico Perricone, che danno parere favorevole; ASOP, Mon. 281.80 Le operazioni si svolgono dal 10 dicembre 1928 e la rendiconta-zione delle somme spese, dunque a lavori terminati, è del 20 aprile1909; docc. in ASOP, Mon. 281 e in ACS, b. 169.81 Valenti cita un progetto di Palazzotto del 1908 senza finestra ebocciato dalla Soprintendenza su suo suggerimento, dopo aver per-
53 Da approfondire rimane che l’unica finestra con ornato sul fiancooccidentale possiede un traforo e dei peducci che sembrano differi-re, anche per l’usura, da tutti gli altri. Potrebbe essere quella la famo-sa finestra scomparsa? Il serto centrale del traforo è indubbiamentedifferente, ma si tratterebbe allora di un’opera di Valenti o di Palaz-zotto?54 “Porta interna del palazzo del Duca di Pietratagliata nella via delPizzuto in Palermo disegnato dal vero da G. Saverio Palermo nelGennaio del 1837”; Galleria Interdisciplinare Regionale di PalazzoAbatellis, Gabinetto di Disegni e Stampe, inv. A 1113. I dati anagra-fici sono ricavate dall’atto di morte: Giuseppe Saverio Palermo, fuPietro e Accardi Teresa, 3 ottobre 1850, a. 78, S. Agata, vol. 358, n.744; cfr. Archivio dello Stato Civile di Palermo, Indice dei morti peldecennio 1846-1855 (L-Z), Palermo 1902, p. 1016. Sul Palermo cfr.B. De Marco Spata, “Palermo Giuseppe Saverio”, in L. Sarullo,Dizionario degli artisti..., cit., vol. I, p. 338.55 Sull’argomento cfr. P. Palazzotto, “L’architettura neogotica nellaSicilia occidentale nella prima metà del XIX secolo: le ragioni degliartisti e il ruolo della committenza”, in Il Duomo di Erice tra gotico eneogotico, atti della giornata di studi a cura di M. Vitella (Erice,Chiesa di San Giuliano, 16 dicembre 2006), Erice 2008, pp. 95-123,con bibliografia precedente.56 AAP, Trascrizione della relazione del 14 giugno 1909; originale inACS, b. 126/31.57 Lettera del soprintendente Salinas al Ministero del 30 giugno1909, prot. 1173, in ACS, b. 126/31.58 AAP, Lettera del duca Fabrizio al sovrintendente Salinas del 20agosto 1909 in risposta a quella del 24 luglio 1909, prot. 1330 n. dipart. 795.59 Lettera del ministro al soprintendente ai Monumenti di Palermodel 21 luglio 1909 in risposta a quella del 30 giugno 1909, prot.13900, in ACS, b. 126/31.60 AAP, Lettera del duca Fabrizio al soprintendente Salinas del 20agosto 1909 in risposta a quella del 24 luglio 1909, prot. 1330, n. dipart. 795.61 Lettera dell’Amministrazione dei signori Alliata delle Pietrataglia-te all’Ufficio Regionale Conservazione dei Monumenti, 18 ottobre1912, in ACS, b. 126/31.62 AAP, Lettere del 30 agosto 1912, 23 ottobre 1912, 25 marzo 1915,19 gennaio 1915 .63 Lettera “urgentissima” del 7 novembre 1912 del Ministero della PIalla Soprintendenza di Palermo in risposta a quella del 26 ottobre1912, prot. 26978, in ACS, b. 126/31 .64 AAP, Lettera di Ernesto Basile al duca Fabrizio, 19 novembre1912.65 Cfr. Lettera del 20 novembre 1912 del Ministero della PI, Consi-glio Superiore per le Antichità e le Belle Arti, in ACS, Min. PI, Dir.Gen. AABBAA, Div. II, 1925-1928, busta 126, fasc. 9095, PalazzoTermine Duca di Pietratagliata; successiva missiva di Corrado Ricci,presidente della commissione, al soprintendente ai Monumenti diPalermo in risposta a quella del 7 novembre 1912 n. 26378, prot.26978, ibidem.66 Lettera del soprintendente ai Monumenti Antonino Salinas al ducaFabrizio Alliata del 7 febbraio 1913, prot. 329, in AAP.67 Lettera di Giuseppe Rao a Corrado Ricci, direttore generale del-l’Amministrazione per le Antichità e Belle Arti, 7 settembre 1913,
170 171
5 Palazzotto:Gabbia 23x27 19-10-2012 18:36 Pagina 170
sonalmente verificato l’esistenza di tracce della bifora. Non è statarintracciata in nessun archivio alcuna evidenza di questo fantomaticoprogetto.82 La trascrizione del documento della Commissione Edilizia, senzadata, ma databile prima dell’agosto 1909, è in AAP.83 Giova a questo punto rimandare alla sibillina dichiarazione dell’ar-chitetto Rao quando presenta personalmente a Ricci la proposta diabbassare gli archivolti delle finestre, altrimenti “non passerà nem-meno un mese che altri si attribuirà il merito della proposta”; a chi sialludeva all’interno del suo ufficio?84 Le soglie interne delle fineste, che nel primo progetto del 1909,secondo quanto riportato dalla stessa Soprintendenza il 30 giugno1909 (ACS, b. 126), il duca avrebbe voluto a 146 cm dal pavimento(mentre avrebbero dovuto essere a 178 cm), oggi sono 133 cm (fine-stra sul vicolo Pizzuto), 166 cm (finestra d’angolo) e, da lì verso la viaRoma, 103, 98 e 90 cm. In realtà lo stesso duca il 18 ottobre nel ricor-so scrive che se si fosse attuato il progetto della Soprintendenza lesoglie sarebbero state a 146 cm; ACS, b. 126. L’altezza che avrebbe-ro avuto tutte con il vecchio progetto sarebbe stata quella della fine-stra del vicolo, verosimilmente realizzata all’epoca di Palazzotto, chein effetti è la più alta, e la base della colonnina ha la corretta posizio-ne inizialmente prevista.85 In AAP vi sono tre lettere del 20 giugno, 22 giugno e 25 ottobre1929 che riguardano l’interessamento di terze persone per riscontra-re finestre d’angolo a Naro, e si conserva anche la fotografia dellafinestra d’angolo di San Petronio a Bologna.86 Sull’argomento si veda C. Genovese, Francesco Valenti. Restaurodei monumenti nella Sicilia del primo Novecento, Napoli 2010.87 La cosa è confermata da Nino Basile: “L’illustre architetto ErnestoBasile, che con rara modestia accettò di limitare la sua opera a cura-re la sola parte statica del preteso restauro...”; cfr. N. Basile, “Antichipalazzi dei Termine…”, cit., p. 253.
172
5 Palazzotto:Gabbia 23x27 19-10-2012 18:36 Pagina 172





















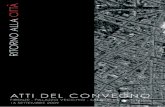

![Anton Pann, Anda' siklipen [Despre învăţătură], trad. Sorin Sandu Aurel](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631329785cba183dbf06f99c/anton-pann-anda-siklipen-despre-invatatura-trad-sorin-sandu-aurel.jpg)