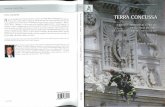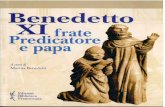Marco FRATI, Gli ospedali medievali in Toscana: osservazioni preliminari, in L’accoglienza...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Marco FRATI, Gli ospedali medievali in Toscana: osservazioni preliminari, in L’accoglienza...
Marco Frati
Gli ospedali medievali in Toscana: osservazioni preliminari
1. Il fenomeno quantitativo
Il fenomeno dell’assistenza nel medioevo è ben conosciuto e gode di una no-tevole fortuna critica, decisamente aumentata negli ultimi anni. In Toscana la po-polarità della via Francigena ha favorito un’ulteriore crescita di studi monografici sul territorio mentre una solida tradizione storiografica ha continuato a occuparsi degli enti ospedalieri e dei loro rapporti con la società e la città mostrandone in pieno l’intreccio, la varietà e la ricchezza.1
Manca però a tutt’oggi una valutazione del fenomeno architettonico nella sua completa articolazione: obiettivo difficilmente raggiungibile nell’angusto spazio di un articolo e che avrebbe bisogno di un propedeutico ampio saggio bibliogra-fico capace di fornire la sintesi dei quadri interpretativi.2 Intanto, sulla base della cospicua letteratura esistente, possiamo tentare una prima valutazione quantitati-va della diffusione degli ospedali nella regione e, successivamente, osservarne la
1. Un bilancio, del tutto provvisorio e da aggiornare, della fortuna del tema è fornito dal Centro Studi Romei al sito http://www.centrostudiromei.eu/index.php?id=310. Vd. anche Venti anni della rivi-sta “De strata Francigena”: 1993-2012, a cura di F. Vanni, suppl. a Bibliografia della via Francigena, a cura di F. Vanni e L. Bassini, «De strata Francigena», 3 (1995), e «De strata Francigena», 20 (2012).
2. Si vedano intanto, per il loro carattere generale, G. Bazin, L’architecture hospitalière, in «L’Oeil», 9 (1963), 100, pp. 26-33, 62; D. Leistikow, Dieci secoli di storia degli edifici ospedalieri, Ingelheim am Rhein 1967, pp. 17-24; I. Moretti, Linee di indagine per lo studio dell’architettura ospedaliera nel medioevo, in I Templari: mito e storia, Atti del convegno internazionale di studi alla magione templare di Poggibonsi (Siena, 29-31 Maggio 1987), Sinalunga 1987, pp. 211-222; Id., Ospedale, in Enciclopedia dell’Arte Medievale, 8 voll., Roma 1991-1997, VIII, pp. 906-917; A. Luttrell, Ordini militari, ibidem, pp. 816-820; Id., Ospedalieri, ibidem, pp. 922-927; T. Szabó, Gli ospedali, in Romei & Gubilei: il pellegrinaggio medievale a San Pietro (350-1350), a cura di M. D’Onofrio, Milano 1999, pp. 127-136; S. Fontana, E. Li Calzi, A. Sandolo, Per una storia dell’architettura ospedaliera, Milano 2002, pp. 49-80. Cfr., per l’impostazione territoriale, i recenti contributi di C. Devoti, M. Naretto, Ordine e sanità; gli ospedali mauriziani tra XVIII e XX secolo: storia e tutela, Torino 2010; E. Molteni, Ospedali e ospizi: carità pubblica e cristiana, in Il Rina-scimento italiano e l’Europa, a cura di D. Calabi, E. Svalduz, Vicenza 2010, pp. 175-195, 750-751; M. A. Crippa, Architettura e arte nella storia degli ospedali lombardi, in «Rivista dell’Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda», 3 (2011), pp. 23-38.
Marco Frati62
consistenza edilizia attraverso l’analisi delle fonti indirette,3 in attesa di una valu-tazione anche delle testimonianze materiali, da rimandare ad altra occasione.4
1.1. Le Rationes Decimarum Tusciae
Com’è noto, le raccolte delle decime dei periodi 1274-1280 e 1295-1304 copro-no praticamente tutto il territorio delle dodici diocesi storiche della Tuscia Annonaria (Lucca, Pistoia, Firenze, Fiesole, Arezzo, Chiusi, Siena, Volterra, Pisa, Massa Ma-rittima, Grosseto, Sovana, a cui si possono eventualmente aggiungere Luni-Sarzana dalla Liguria e Cortona scorporata da Arezzo), regione per la quale la documentazio-ne è fortunatamente sopravvissuta in misura molto maggiore rispetto ad altre.
Nonostante ciò, questi importantissimi registri, conservati presso l’Archivio Segreto Vaticano,5 non possono fornire un quadro esaustivo del fenomeno, rispet-to – per esempio – alle pievi o ai monasteri maschili. Infatti,
oltre alle inevitabili lacune proprie di ogni operazione tendenzialmente sistemati-ca, la taxatio beneficiorum prevedeva espressamente dei casi di piena o parziale esenzione dalla decima: questa non veniva ad esempio applicata sui benefici il cui patrimonio imponibile veniva valutato inferiore ad un livello minimo, così come ne erano esentati quei patrimoni ecclesiastici, o la parte di questi, i cui proventi veniva-no spesi a sostegno dei poveri o dei malati o di quei religiosi che il voto di povertà costringeva a ricorrere all’elemosina.6
Dunque, le Rationes Decimarum non comprendono nei loro elenchi i piccoli ospedali – che, come vedremo, erano tantissimi – e quelli – più rari – che inve-stivano quasi tutto il loro patrimonio nell’assistenza o che formalmente non ne avevano uno perchè legati agli ordini mendicanti.
A un primo sguardo – necessariamente sfocato – risultano esistere nell’ulti-mo quarto del XIII secolo ben 199 enti assistenziali (Tab. 1). Fra questi sono stati inseriti gli hospitales e le più rare domus e mansiones. Al di là della loro bassa frequenza, queste ultime si distinguono per l’esclusività del servizio offerto a categorie particolari di malati (lebbrosi, infetti) o di confratelli (templari, geroso-limitani) o dell’appartenenza a una congregazione (Altopascio).
Gli ospedali appaiono distribuiti in modo diseguale fra le dodici diocesi tosca-ne: 46 a Lucca, 30 ad Arezzo, 27 a Pisa, 23 a Volterra, 21 a Chiusi, 18 a Pistoia, 17 a Firenze, 7 a Fiesole e a Siena, 2 a Cortona, 1 a Massa Marittima, nessuno a Gros-
3. Si fa qui riferimento all’ormai classica tassonomia degli indicatori cronologici dei manufat-ti elaborata da T. Mannoni, Metodi di datazione dell’edilizia storica, in «Archeologia Medievale», 11 (1984), pp. 396-403.
4. M. Frati, Gli ospedali medievali in Toscana: osservazioni preliminari sulla consistenza di un fenomeno architettonico attraverso la documentazione diretta, in «De strata Francigena», in corso di preparazione.
5. Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV: Tuscia, a cura di P. Guidi, M. Giusti, 2 voll., Città del Vaticano 1932-1942.
6. http://archeologiamedievale.unisi.it/asemt/pagine/rationes.html.
Gli ospedali medievali in Toscana 63
seto e Sovana. Dati che non appaiono direttamente proporzionali né all’estensione del territorio né alla sua orografia, né al numero di abitanti né alla loro distribuzio-ne, né alla presenza di altri enti religiosi e neanche alla loro organizzazione.
1.2. Altre ricognizioni territoriali
Il primo dato offerto dalle Rationes può essere integrato da documenti più completi e indagini più estese e capillari. Fortunatamente, ne sono già state pub-blicate diverse per alcune diocesi e città toscane, tali e tante da consentire una proiezione sull’intero territorio regionale.7
Per la diocesi di Volterra disponiamo di una fonte successiva (il Sinodo Bel-forti del 1356)8 e di due studi monografici sugli ospedali medievali9 – ottimi per l’epoca in cui sono stati elaborati e considerati ancora validi10 – che possono es-sere utilmente integrati fra loro, benchè il secondo corregga e contenga il primo. In totale vengono individuati ben 121 enti ragionevolmente databili entro il XIV secolo, sebbene non tutti contemporaneamente esistiti, ovvero un numero pari al 526% di quanto rilevato un secolo prima.
Anche per la diocesi di Lucca si può fare affidamento su di una fonte do-cumentaria estesa a tutto il territorio (l’Estimo lucchese del 1260)11 e su di uno studio monografico,12 benchè poco circostanziato e lacunoso. Pure in questo caso assistiamo a un considerevole aumento degli enti conosciuti fino al 1400, che ascendono a 190 (cioè al 413% di quanto rilevato dalle Rationes) e sono suscetti-bili, come si vedrà, di aumentare ancora.
Anche per il contado fiorentino – formato in gran parte dalle diocesi di Firen-ze e di Fiesole – si dispone di uno studio accurato dell’ospitalità entro il Trecen-to.13 Il territorio analizzato comprende anche località di altre diocesi: espungen-dole, dei 136 enti individuati ne restano pur sempre 128 a cui ne vanno aggiunti altri 44 urbani,14 per un totale di 172 ospedali, pari al 717% di quelli elencati all’inizio dello stesso secolo.
Un dato più approssimativo e soggetto ad aggiornamento è stato elaborato per la diocesi di Pistoia dove sono stati rintracciati almeno 43 ospedali entro il
7. Ringrazio Marco Spennati per la revisione del modello statistico da me elaborato per questo studio.
8. A. F. Giachi, Ricerche storiche volterrane, Volterra 1887, doc. LXXXII, pp. 583-594.9. M. Battistini, Gli spedali dell’antica diocesi di Volterra, Pescia 1932; M. Cavallini, Gli
antichi ospedali della diocesi volterrana, in «Rassegna volterrana», X-XI (1939), pp. 78-117; XIV-XVI (1942), pp. 1-117.
10. S. Mori, Attualità di ricerche, ibidem, LXIII-LXIV (1987-1988), pp. 163-188: 164.11. Rationes decimarum, I, pp. 243-275.12. G. Pisani, La beneficenza in Lucca prima del Mille, Lucca 1907.13. C.M. De La Ronciére, Firenze e le sue campagne nel Trecento. Mercanti, produzione,
traffici, Firenze 2005, pp. 101-124.14. G. Fanelli, Firenze, Roma-Bari 1980, fig. 17, pp. 256-257.
Marco Frati64
1400,15 ovvero appena il 239% di quanti (18) non comparissero già cento anni prima.
Per quanto riguarda le città, qualche dato si può estrarre dalle griglie delle diocesi appena analizzate. Per esempio, a Firenze se ne contano ben 48, il 686% rispetto ai 7 decimati. A Lucca i 51 rilevati sono il 464% rispetto agli 11 delle Rationes.
Per Pisa si dispone di un recente e accurato studio16 dedicato ai luoghi di as-sistenza fuori e dentro le mura, che si può utilmente incrociare con un documento dell’inizio del Trecento in cui si elencano gli ospedali cittadini dichiarandone la capienza in numero di letti.17 I 49 entro la fine del secolo sono il 306% dei 16 decimati: questa deviazione statistica dalle fattispecie delle altre città si spiega proprio attraverso la consistenza degli ospedali pisani, che risultano tutti o quasi ben forniti e dunque capaci di contribuire in molti più casi.
Altri dati sono stati ricavati per la città di Siena che aveva entro le mura una trentina di enti assistenziali, pari al 750% degli appena 4 registrati, ma bisogna avvertire che lo studio18 presenta la situazione corrispondente all’inizio dell’età moderna.
La Toscana, terra di città e di castelli, è disseminata di grossi centri urbani che, pur non avendo lo status di città, ne hanno certamente la dimensione e la complessi-tà. Anche da queste realtà insediative si possono trarre utili informazioni statistiche.
La popolosa terra di Prato costituisce un’enclave nullius dioecesis in quella di Pistoia. Il castello e il suo distretto contano insieme ben 20 ospedali,19 cifra notevolmente superiore (il 667%) ai 3 elencati dalle Rationes e in linea con i dati cittadini.
Il grande castello di San Gimignano ebbe entro le mura almeno 9 ospedali,20 il 450% di quanti (2) erano in grado di pagare le decime.
1.3. Gli ordini religiosi in Toscana
Per un più preciso calcolo degli ospedali in Toscana si deve tenere pure pre-sente che molti enti religiosi erano dotati di un luogo di accoglienza, privo però di personalità giuridica e quindi sconosciuto agli estensori dei documenti. Solo in qualche raro caso la registrazione dell’ospedale segue quella del cenobio o della pieve (Tab. 1) da cui dipendeva. Per qualche ordine monastico – come quelli mili-
15. L. Bargiacchi, Storia degli istituti di beneficenza, d’istruzione ed educazione in Pistoia e suo circondario dalle rispettive origini a tutto l’anno 1880, 4 voll., Firenze 1883-1884, I, n. 1-27, 32, 34-39, 42-45, 47. Cfr. E. Coturri, Pistoia, Lucca e la Valdinievole nel Medioevo: raccolta di saggi, Pistoia 1998, p. 65, che ne conta appena una trentina fino alle soglie dell’età moderna.
16. A. Patetta, Gli ospedali di Pisa: sanità e assistenza nei secoli XI-XV, Pisa 2001.17. A.F. Mattei, Ecclesiae Pisanae Historia, Lucae 1768, II, App., pp. 33-34.18. Moretti, Linee di indagine, p. 213 n. 13. 19. G. Bologni, Gli antichi spedali della “Terra di Prato”, Signa 1994.20. Cfr. Una farmacia preindustriale in Valdelsa: la spezieria e lo spedale di Santa Fina nella
città di San Gimignano, secc. XIV-XVIII, Certaldo 1981, p. 23.
Gli ospedali medievali in Toscana 65
tari (giovanniti, templari ecc.)21 e ospedalieri (antoniani, del tau ecc.)22 – convento e ospedale sostanzialmente coincidevano. Ma per gli altri?
La vocazione all’accoglienza di abbazie e canoniche – alcune centinaia in Toscana – è nota ma poche sono le attestazioni documentarie di questa prati-ca comunitaria nella Toscana medievale. I monasteri più importanti – che fin dall’epoca carolingia erano incaricati dell’assistenza ai poveri e ai pellegrini, rite-nuta un compito di carattere pubblico e quindi di pertinenza regia – avevano uno xenodochium per i viandanti. Non mancano comunque casi di strutture interne ai chiostri prive di personalità giuridica e che, quindi, vanno ad aumentare il nume-ro potenziale di casi da indagare.
Ad esempio, l’idea di un ospedale fu presente a San Salvatore all’Isola fin dall’atto di fondazione (1001) in cui si fa esplicito riferimento alla funzione ricet-tiva del monastero; un ospedale vi è già documentato mezzo secolo dopo, mentre un senodochium, specializzato nell’accoglienza dei pellegrini, vi è citato fin dal 1102, essendo fatto oggetto di cospicue donazioni.23 Restando in Valdelsa, s’in-contrano ospedali anche nel benedettino San Michele a Martùri, fondato nel 1089 dall’abate Uberto «ad refectionem pauperum, ad sustentationem hospitum, ad recreationem mentes et corpora»,24 e nella vallombrosana Santa Maria a Conèo, la cui esistenza si apprende da un registro necrologico dell’XI secolo in cui è rammentato un certo Erito converso e custode dell’ospedale locale,25 in ossequio agli Statuti dell’ordine (art. 1).
Un luogo di accoglienza non mancava nemmeno a Camaldoli fin dall’inizio del XII secolo.26 Più tardi nella ormai cistercense Badia a Settimo fu allestito prima l’ospedale dei poveri, costruito dall’abate Jacopo (1237-1255), e poi il pellegrinaio, organizzato dal priore Ubaldo Berteldi nel 1260.27
Anche le canoniche – tanto appoggiate alle cattedrali e alle pievi quanto isti-tuite presso chiese suffraganee – dovevano esercitare l’accoglienza, in forza della
21. V. Ascani, L’architettura religiosa degli Ordini militari in Toscana, in Monaci in armi. L’architettura sacra dei templari attraverso il Mediterraneo, a cura di G. Viti, A. Cadei, V. Ascani, Atti del I convegno «I Templari e San Bernardo di Chiaravalle» (Firenze, 23-24 ottobre 1992), Firenze 1996, pp. 187-245.
22. E. Coturri, I frati ospitalieri di Altopascio ed i loro ospedali, Pistoia 1955; I. Ruffino, Sto-ria ospedaliera antoniana: studi e ricerche sugli antichi ospedali di sant’Antonio abate, Cantalupa 2006.
23. P. Cammarosano, Abbadia a Isola. Un monastero toscano nell’età romanica, Castelfio-rentino 1993, pp. 50, 184 doc. 4, 228 doc. 23, 271 doc. 43. Cfr. M. Docci, Il monastero dell’Isola: storia, architettura e restauri, in «Miscellanea Storica della Valdelsa», 103 (1997), pp. 7-58: 11 n. 15, che suggerisce l’identità dei due ospedali.
24. A. Neri, Descrizione storico artistica del castello di Badia già di Marturi a Poggibonsi, Castelfiorentino 1901, pp. 167-169, 174.
25. A.M. Bandini, Catalogus codicum latinorum Bibliothecae Mediceae Laurentianae, Firen-ze 1777, IV, pp. 546-551.
26. Regesto di Camaldoli, a cura di F. Baldasseroni, E. Lasinio, L. Schiaparelli, 4 voll., Roma 1907-1928, docc. 641, 644, 645, 646, 647, 653, 660, 829, 830, 838.
27. P. Grifoni, Badia di San Salvatore a Settimo, in Iconografia di San Benedetto nella pittura della Toscana: immagini e aspetti culturali fino al XVI secolo, Firenze 1982, pp. 471-480: 476.
Marco Frati66
regola agostiniana che normalmente vi era seguita.28 Ma non si può parlare con certezza di organismi architettonici specificamente dedicati all’ospitalità, se non quando essi assumono autonomia anche giuridica.
Particolarmente sfuggenti appaiono gli ospizi pertinenti ai nuovi ordini re-ligiosi, esclusivamente accessibili ai membri dell’ordine che li utilizzavano per i frequenti spostamenti da un cenobio all’altro, nei viaggi verso i capitoli e per curare gl’interessi della comunità in città e in campagna. Questi piccoli com-plessi erano spesso privi di personalità giuridica e, essendo esenti dall’autorità vescovile, non risultano nei consueti elenchi di enti religiosi. Se non fosse per l’ampia produzione documentaria interna ai nuovi ordini, difficilmente sarebbero rintracciabili.
I cistercensi, insediatisi in Toscana nella prima metà del XIII secolo come movimento antiurbano, ebbero 6 ospizi, tutti nelle più grandi città della regione.29 I domenicani, inseritisi nello stesso periodo ma nelle città, ne ebbero almeno 22, situati soprattutto nei grossi borghi lungo le strade principali.30
Presso i monasteri si trovava spesso un’infermeria per i monaci malati: se ne ha notizia per i cenobi camaldolesi (a San Pietro a Luco nel 1221, nel chiostro di San Frediano a Pisa nel 1229, dotata di una camera, a Camaldoli e alla Berar-denga nel 1239, a Firenze nel 1260, a Camaldoli per i soli conversi nel 1302)31 e cistercensi (a San Galgano nel 125532 e a Settimo nel 1341,33 probabilmente corrispondente o vicino al calefactorium).
Anche i conventi mendicanti erano dotati di un’infermeria per curare i propri frati, come già accadeva nel monachesimo benedettino. A Firenze se ne trova una per ogni grande complesso: dei francescani nel 1278,34 dei domenicani nel 1292,35 dotata di un proprio chiostro, e dei servi di Maria nel 1357, in una casa definita “nuova” ancora nel 1364.36 Gli agostiniani ne ebbero una a Pistoia nel 1356.37
28. E. Nasalli Rocca, Pievi e ospedali, in Atti del I congresso italiano di storia ospitaliera, Reggio Emilia 1956, pp. 493-507; Id., Ospedali e canoniche regolari, in La vita comune del clero nei secoli XI e XII, Atti della settimana di studio (Mendola, settembre 1959), Milano 1962, II, pp. 16-25.
29. M. Frati, Cistercian Settlements in Tuscany in the Thirteenth and Fourteenth Centuries: Innovations and Adaptations, in «Commentari d’arte», in corso di stampa, table 3.
30. A. Zucchi, Gli Ospizi domenicani in Toscana, in «Memorie domenicane», 61 (1944), pp. 1-19; 62 (1945), pp. 10-31; 63 (1946), pp. 3-25, 90-112; 64 (1947), pp. 49-56, 81-96.
31. Archivio di Stato di Firenze (d’ora in poi ASF), Diplomatico, Luco di Mugello, S. Pietro (monache camaldolesi), 1221 Giugno 20; Camaldoli, S. Salvatore (eremo), 1228 Febbraio 17, 1238 Gennaio 31, 1238 Febbraio 23, 1260 Agosto 31, 1302 Marzo 30.
32. A. Canestrelli, L’abbazia di San Galgano: monografia storico-artistica; con documenti inediti e numerose illustrazioni, Firenze 1896, p. 72.
33. ASF, Diplomatico, Firenze, S. Frediano in Cestello già S. Maria Maddalena (cistercensi), 1341 Luglio 27.
34. Ivi, Marchi (acquisto), 1278 Aprile 1.35. Ivi, Firenze, S. Maria Novella (domenicani), 1291 Febbraio 12.36. Ivi, Firenze, S.ma Annunziata (serviti), 1357 Giugno 10; ASF, Corporazioni religiose sop-
presse dal governo francese, serie 119 (SS. Annunziata), 841, c. 4v.37. ASF, Diplomatico, Pistoia, S. Lorenzo (agostiniani), 1356 Agosto 18.
Gli ospedali medievali in Toscana 67
1.4. Gli archivi
I potenti strumenti di ricerca recentemente installati sui siti dei principali archivi di Stato in Toscana permettono una comoda verifica della presenza degli ospedali nella documentazione medievale, in particolare in quella diplomatica. Tenendo conto della stretta attinenza del contenuto dei fondi al territorio di ri-ferimento, si può trarre qualche altra utile indicazione sulla vitalità degli enti assistenziali.
Dall’Archivio di Stato in Firenze38 emergono ben 6584 diplomi datati fino al 1400 appartenuti agli archivi degli ospedali sugli 85193 conservati, pari al 7,7% del totale. Fra tutte le pergamene, ben 852 hanno data topica contenente il termine ospedale (comprese le sue varianti spedale, ospizio, stale ecc.), quindi esatta-mente l’1%. Fra le 15098 cartapecore datate fino al 1250 solo 62 citano nel testo esplicitamente uno o più edifici ospedalieri, cioè appena lo 0,4% del totale.
Questi dati possono essere messi a confronto con quelli ricavabili da altri istituti di conservazione. Nell’Archivio di Stato in Lucca39 fra le 17069 perga-mene datate fino al 1400 ben 2994 – il 17,6% – appartennero a enti ospedalieri (san Luca, Altopascio), frutto della particolare formazione del fondo diplomatico. Inoltre, per la loro importanza a Lucca, gli ospedali si trovano citati addirittura in 4099 cartapecore entro il 1400, pari al 24% del totale. Invece, fra le circa 7000 pergamene datate fino al 1250 e conservate nell’Archivio di Stato in Siena40 han-no data topica contenente il termine ospedale appena 13 pezzi, pari allo 0,2%.
La disparità delle situazioni consiglia prudenza nel trattare dati non sempre confrontabili fra loro. Ma sembra innegabile, a un primo sguardo superficiale sui fondi archivistici, l’enorme importanza istituzionale, economica e giuridica degli ospedali nelle diverse realtà territoriali toscane.
1.5. Proiezioni e prime considerazioni
Volendo provare a quantificare la consistenza del fenomeno sulla base delle precedenti osservazioni, sembra di poter applicare un fattore di moltiplicazione all’elenco delle Rationes Decimarum.
Nelle diocesi di Lucca, Firenze, Fiesole e Volterra sono esistiti almeno 483 ospedali entro il XIV secolo, cioè 5,19 volte quanto rilevato un secolo prima (93 in tutto). Nelle città di Lucca, Firenze e Pisa se ne conoscono almeno 148 fino al 1400, cioè 4,35 volte gli enti decimati 100 anni prima (34). Facendo una media ponderale dei due fattori si ottiene un valore molto prossimo a 5 (4,97).
Considerando che le diocesi per le quali si dispone di dati completi sono quattro – quindi un terzo del totale – e paiono abbastanza rappresentative delle diverse real-
38. http://www.archiviodistato.firenze.it/pergasfi/.39. http://www.archiviodistatoinlucca.it/.40. A. Lisini, Inventario delle pergamene conservate nel Diplomatico dall’anno 736 all’anno
1250, Siena 1908.
Marco Frati68
tà territoriali sub-regionali (città e campagna, montagna e pianura, costa e interno, settentrione e meridione), si può estendere il fattore a tutto il territorio regionale.
Dunque, moltiplicando per 5 il numero degli ospedali (199) decimati intorno al 1300 si ottiene un valore molto prossimo a mille (995) che deve essere consi-derato comunque per difetto: più di mille ospedali esistiti in una sola regione!
Ricordando poi che la diocesi di Luni – terra di passaggio e di accoglienza ove sono documentati almeno 56 ospedali medievali41 – è stata esclusa dal calco-lo, il dato per la Toscana deve essere considerato ancor più consistente. Si tratta di un fenomeno stupefacente, assai sfuggente per la sua dispersività istituzionale e fragilità economica ma imponente per diffusione. E – prossimo obiettivo della ricerca – per consistenza materiale?
2. Le fonti indirette
2.1. I documenti scritti
La documentazione scritta è particolarmente utile per la descrizione degli usi degli spazi e per la loro datazione. Naturalmente, la sola attestazione di esistenza dell’ente non può essere automaticamente attribuita alla sua attuale consistenza materiale.
La maggior parte degli ospedali toscani è stata fondata da singole personalità attraverso lasciti testamentari. E proprio questo tipo di fonte getta una debole luce sul fenomeno in età longobarda, oltre la quale sembra impossibile poter andare, salvo generiche considerazioni. Fin dall’epoca di Costantino (concilio di Nicea, 325) a occuparsi dell’assistenza in tutto l’Impero furono le città. Successivamen-te (dal VI secolo in poi), con il crollo dell’autorità imperiale e la diffusione del monachesimo benedettino, furono anche i cenobi a dotarsi di infermerie, in osse-quio alla regola del fondatore (cap. XXXVI). Ma nessuna testimonianza specifica abbiamo in proposito per la Toscana.
Che cosa fosse un ospedale in pieno VIII secolo ce lo indicano invece alcuni documenti lucchesi, che mostrano un grande attivismo nel campo dell’accoglien-za da parte di laici e religiosi.42 Nell’anno 720 venne fondato l’ospedale di San Silvestro in Placule a sud di Lucca, appena fuori porta San Pietro.43 La donazione comprendeva una chiesa e la presenza di una comunità monastica a servirlo, il che implica una struttura simile a un cenobio. Una particolare attenzione fu dedicata al livello di comfort da offrire agli ospiti: il vescovo regalò uno stabilimento di bagni e uno dei fondatori donò, fra le altre cose, una caldaia e il necessario per la cucina.
41. E. Salvatori, Presenze ospedaliere in Lunigiana, in Riviera di Levante tra Emilia e Tosca-na: un crocevia per l’ordine di San Giovanni, Atti del convegno (Genova-Chiavari-Rapallo, 9-12 settembre 1999), Genova 2001, pp. 189-222.
42. G. C. Romby, Itinerari dei pellegrini nella città di Lucca, in «De strata francigena», 6 (1998), 1, pp. 119-127, 120-121.
43. Pisani, La beneficenza in Lucca, pp. 33-36.
Gli ospedali medievali in Toscana 69
Nello stesso anno Pertualdo, un pellegrino lucchese tornato da Roma, fon-dava un ospedale nella propria casa in Cipriano (fuori porta San Gervasio) de-dicandolo a san Michele e dotandolo degli edifici circostanti (per abitazione dei monaci), di un orto e di un pigmentarium (farmacia?).44 Evidentemente, la de-cisione maturata durante l’esperienza ascetica del viaggio dovette adattarsi alla contingenza dei beni da lui posseduti, la cui disposizione aveva evidentemente obbedito – se non alla casualità – a istanze diverse da quelle dell’accoglienza. La citazione della spezieria potrebbe poi svelare un’esplicita funzione curativa dell’ospedale, e non solo una generica forma assistenziale.
Solo cinque anni dopo due pellegrini «partibus transpadanis», prete Romual-do e la moglie Rapperga, fondavano un ospedale in una casetta presso la chiesa di San Quirico a Capannori.45 Evidentemente, fra un ospedale urbano e uno ru-rale la differenza dimensionale doveva essere notevole: i viaggiatori longobardi che transitavano per Lucca – già allora «imbuto di devozione», secondo la felice espressione di Giuseppe Sergi,46 oltre che capitale del ducato – potevano contare su complessi ben organizzati e forniti, mentre lungo i percorsi principali trova-vano soltanto poco più che delle semplici baracche. Nella prima metà dell’VIII secolo, del resto, i viaggi a Roma andavano intensificandosi47 e, conseguente-mente, anche il passaggio da Lucca, che si trovava lungo la via Francigena. È significativo che proprio dei romei, che avevano probabilmente esperito l’assenza di una rete di luoghi di accoglienza, abbiano sentito la necessità di istituire degli ospedali intorno alla città lucana, dando quindi vita a un fenomeno fino ad allora poco sviluppato in Toscana, se non del tutto inesistente.
In età carolingia la rete di relazioni ad ampio raggio che la dimensione conti-nentale dell’Impero richiedeva poteva contare su di un già fitto sistema di luoghi di accoglienza, aggregati ai monasteri o ad essi improntati. Ad esempio, l’ospeda-le di Meati comprendeva nel 798 una chiesa, una corte davanti, una sala accanto, un orto dietro.48 Sul modello monastico, anche le diocesi furono obbligate da Ludovico il Pio nel concilio di Aachen-Inden (816-817) a provvedere alla cura.49 Ma ancora una volta nulla si sa della consistenza degli ospedali fondati presso le cattedrali e i domini vescovili.
Con la ripresa urbana e il superamento della crisi dell’Impero nel corso del X secolo, anche in età ottoniana ricominciarono le fondazioni ospedaliere. Ad
44. Ivi, p. 49.45. Memorie e documenti per servire all’istoria del Ducato di Lucca, a cura di D. Barsocchi-
ni, Lucca 1844, IV.1, p. 4 doc. II.46. G. Sergi, Via Francigena, chiesa e poteri, in La Via Francigena. Itinerario culturale del
Consiglio d’Europa, Atti del seminario (Torino, 20 ottobre 1994), Torino 1994, pp. 12-23: 17.47. P. Rajna, Strade, pellegrinaggi e ospizi nell’Italia del medioevo, in «Atti della società
italiana per il progresso delle scienze», Quinta Riunione (Roma, Ottobre 1911), Roma 1912, pp. 99-118, 104-105, 107.
48. Pisani, La beneficenza in Lucca, p. 89.49. F. Schneider, L’ordinamento pubblico della Toscana medievale: i fondamenti dell’am-
ministrazione regia in Toscana dalla fondazione del regno longobardo alla estinzione degli Svevi (568-1268), a cura di F. Barbolani di Montauto, Firenze 1975, p. 303.
Marco Frati70
esempio, nell’atto istitutivo (1001) dell’Abbadia a Isola (Monteriggioni) si fa esplicito riferimento alla funzione ricettiva del monastero, che era tenuto a offrire «largitates bone et hospitalitatis atque helemosine»:50 ma dove, esattamente?
Nell’XI secolo, su impulso della riforma gregoriana, dell’accoglienza torna-rono a occuparsi anche i laici, inquadrati in confraternite, e i canonici, sacerdoti che avevano scelto la vita comune sotto la regola agostiniana (capp. III.18, V.37). Molte sono le notizie dell’esistenza di ospedali in questo periodo (XI-XII secolo), ma rarissimi – e purtroppo reticenti sullo stato materiale – gli atti di fondazione. Un tardo riflesso di questo clima è l’iniziativa del laico Ricovero di Stultone che nel 1207-1210 acquistò sistematicamente case e una piazza presso le mura di Colle di Val d’Elsa per costituire un ospedale, dedicato allo Spirito Santo.51
Nel Duecento, l’empatica spiritualità francescana, inizialmente aggregatasi proprio intorno agli ospedali52 e diffusasi attraverso la predicazione, spinse anco-ra i laici a fondare e gestire luoghi di cura. Come osserva Charles Marie De La Roncière, «i fondatori si limitano più spesso ad assegnare la propria casa, in parte o nella sua totalità, ad uso dello spedale senza richiedere alcuna trasformazione […] Ma può anche accadere che una fondazione dia vita a delle costruzioni spe-ciali […] forse più adatte all’uso collettivo che se ne prevedeva».53
Nel 1288, nell’istituire a Firenze l’ospedale di Santa Maria Nuova, Folco di Recupero de’ Portinari – il padre della dantesca Beatrice – ne descrisse l’entità.54 L’ospedale da lui appena costruito si trovava lungo la via pubblica accanto alla chiesa, alla casa e all’orto di Sant’Egidio dei saccati; accanto all’ospedale si tro-vava un casolare formato da più case – da lui acquistate tre anni prima – di cui una adibita a chiesa con altare, paramenti, libri e suppellettili sacre, e altre arreda-te con un’arca con suppedaneo, dodici letti ben forniti e una caldaia con vasca.
A Volterra nel 1291 Baccio di Federigo Ruffoli della contrada di Sant’An-gelo, rimasto orfano e vedovo, fondò un ospedale in una casa in via Nuova, do-nandogli tutti i propri averi per testamento.55 La sua fornitura fu arricchita da successivi lasciti, come quella nel 1299 di «lectum unum fulcitum cum capezale, copertorio et uno para lentiaminis».56
Del resto, il numero degli assistiti e il tipo di prestazioni nei loro confronti si adattavano alla consistenza degli edifici, che quindi poteva essere giudicata sufficiente. Così nel 1312 Signorello di Martino potè fondare un ospedale a Prato nella propria casa «cum curia, orto et resedio» in Callemala nel borgo a Capo di Ponte sotto la protezione dei frati del Carmine.57
50. Si veda la nota 23.51. Battistini, Gli spedali dell’antica Diocesi, p. 50.52. A Firenze, ad esempio, i frati minori si appoggiarono inizialmente all’ospedale di San
Gallo.53. De La Ronciére, Firenze e le sue campagne, p. 116.54. L. Passerini, Storia degli stabilimenti di beneficenza e d’istruzione elementare gratuita
della città di Firenze, Firenze 1853, pp. 834-839 docc. F-G.55. Battistini, Gli spedali dell’antica Diocesi, p. 26.56. Ivi, p. 28.57. Bologni, Gli antichi spedali, pp. 143-149.
Gli ospedali medievali in Toscana 71
Talvolta l’unica modifica all’immobile donato dal fondatore consisteva in qualche decorazione simbolica, come quelle aggiunte sulle case di Michele di Provenzano nel 1318 dal comune di Volterra, che vi fece dipingere sulla facciata le armi del popolo e del comune.58
Un vero e proprio boom di fondazioni si ebbe con la crisi di mortalità della peste nera (estate del 1348) ma dei numerosi lasciti (a volte poco consistenti) per la costruzione di ospedali solo una parte fu probabilmente utilizzata a questo scopo. E, d’altra parte, l’attività ricettiva poteva risultare compressa dalla presen-za della famiglia dei fondatori, come nell’ospedale voluto da Strenna e costitui-to «de omnibus domibus suis positis Vulterris, in contrata Sancti Angeli in via Nova, in quibus ipse cum sua familia moratur».59
Un’altra fonte assoluta – ma indiretta – è fornita dai documenti di costruzio-ne la cui ‘sincerità’ è garantita dal fatto che si tratta per lo più di atti interni alle amministrazioni che li hanno prodotti, finalizzati proprio a conservare la memo-ria del contenuto meramente economico delle operazioni di cantiere. Purtroppo la documentazione rimasta non precede la fine del XIII secolo60 e quindi da essa si possono ricavare informazioni relative a edifici solo gotici o rinascimentali.
Una cospicua serie di carte circostanzia l’ampliamento dell’ospedale di Santa Maria Nuova di cui finora sono state proposte in via solo ipotetica le fasi e la loro datazione.61 La prima sala venne costruita dopo l’acquisto di case e terreni (1285) e prima della fondazione dell’ospedale (1288) che già allora po-teva contenere una dozzina di letti e accogliere fino a una cinquantina di degen-ti. Subito dopo l’acquisizione del vicino complesso di Sant’Egidio (1312), che serviva da convento degli ospedalieri, fu eseguito un primo ampliamento verso nord, prolungando la prima sala. Nel 1326 è ricordato l’acquisto di un notevo-le quantitativo di pietre da costruzione,62 che si può associare alla costruzione del primo nucleo della sala delle donne lungo via delle Pappe, già in funzione nel 1329. Contestualmente, venne realizzata una pregevole grande bifora sulla facciata sud della sala degli uomini, in modo da illuminare l’ormai raddoppiato spazio longitudinale.63 Sotto lo spedalingo Orlando di Pierozzo da San Cascia-no (1332-1348) venne costruita una nuova ala verso est; nel 1347, dopo questi
58. Battistini, Gli spedali dell’antica Diocesi, p. 29.59. Ivi, p. 30.60. Si veda, fra i più precoci, il pagamento del maestro Mone di Ormanno per la costruzione del
nuovo ospedale presso il borgo di Pontorme nel 1290: ASF, Notarile antecosimiano, 3827, c. 18r.61. Cfr. le diverse proposte di J. Henderson, ‘Splendide case di cura’: spedali, medicina ed
assistenza a Firenze nel Trecento, in Ospedali e città: l’Italia del Centro-Nord, XIII-XVI secolo, a cura di A.J. Grieco, L. Sandri, Firenze 1997, pp. 15-50: 27-32; L. Ciuccetti, Lo sviluppo archi-tettonico dello Spedale di Santa Maria Nuova dalla sua fondazione al XV secolo, in Il patrimonio artistico dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Firenze. Episodi di committenza, a cura di C. De Benedictis, Firenze 2002, pp. 47-61.
62. Si tratta di 405 some di pietre, pari a circa 63 t d’inerti, ovvero 42 mc di muratura. ASF, Santa Maria Nuova, 4390, c. 12v.
63. Ivi, c. 15r (2 maggio 1327).
Marco Frati72
interventi, la capienza dell’ospedale era più che quadruplicata e l’uso intensivo richiedeva frequenti interventi di manutenzione e igienizzazione.64 Nel 1365 più pagamenti si riferiscono a un chiostro dell’ospedale, presumibilmente quello della Samaritana,65 a cui pochissimo tempo dopo (1367-1368) seguirono ingenti opere per il «lavorio dell’acrescimento dello spedale degli uomini» per un valore di circa 300 fiorini:66 al cortile fu dunque addossata un’altra sala, che andava così formando il quarto braccio della croce, voltato. All’incrocio, la “cappella” con l’altare venne sormontata da una volta (forse a crociera) nel 1368.67 Dunque il modello cruciforme, che tanto successo avrebbe avuto nel Quattrocento,68 risul-tava già elaborato poco dopo la metà del Trecento, anche se le prime esplicite testimonianze di tale stato di cose risalgono al 1413. I lavori proseguirono con la costruzione del chiostro grande e del soprastante dormitorio (1395-1397), con nuovi ingenti lavori all’ala est (1409-1410), con il rifacimento della chiesa di Sant’Egidio (consacrata nel 1419 dal papa Martino V) e con la costruzione del contiguo chiostro delle Medicherie (1422).69
Anche per l’infermeria del convento della Santissima Annunziata di Firenze, costruita nel 1364-1366, furono registrati i pagamenti,70 dai quali si evince che l’edificio fu realizzato in muratura rivestita da un paramento pseudoisodomo, con aperture incorniciate in pietra e copertura a volte in mattoni su peducci lapidei.
64. Ivi, 4416, c. 56r (5 settembre 1360).65. Diversi pagamenti per fornitura e conciatura di pietre si riferiscono al chiostro dell’ospe-
dale: ibidem, 4417, cc. 47v (22 marzo 1365, già segnalato da De La Ronciére, Firenze e le sue campagne, p. 19 n. 6), 27r (23 marzo e 30 marzo 1365), 27v (2 aprile 1365). Cfr. E. Diana, Sintesi cronologica della storia dell’Ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze (1288-2000), in Santa Maria Nuova 2006, pp. 17-20, che non prende in considerazione questi documenti; E. Scampoli, Firenze, archeologia di una città (secoli I a.C.-XIII d.C.), Firenze 2010, p. 281 n. 177, che data il chiostro al XV secolo.
66. Oltre al pagamento di 139 fiorini d’oro e 59 lire per la fornitura di pietre conce e di 119 fiorini d’oro per i mattoni e la calce «per lo lavorio dell’acrescimento dello spedale e della chapella del decto spedale degl’uomini» già pubblicato in M. Frati, “De bonis lapidibus conciis”. La costru-zione di Firenze ai tempi di Arnolfo di Cambio: strumenti, tecniche e maestranze nei cantieri fra XIII e XIV secolo, Firenze 2006, doc. 26 (15 agosto 1368), si vedano quelli di laterizi da pavimento e di dettagli lapidei della volta (ASF, Santa Maria Nuova, 4421, cc. 2r, 6r).
67. «Serraglio della volta della chappella ch’è nel lavorio nuovo dello spedale dal lato del-gl’uomini»: ivi, c. 13v (23 luglio 1368).
68. A. Peroni, Il modello dell’Ospedale Cruciforme: il problema del rapporto tra l’ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze e gli Ospedali lombardi, in Florence and Milan: comparisons and relations, a cura di C.H. Smyth, G.C. Garfagnini, Firenze 1989, pp. 53-66; M. Frati, Spazi medievali di accoglienza: ospedali urbani e rurali lungo le strade fra le Alpi e il mare, in I luoghi delle cure in Piemonte, pp. 61-83, 78-79.
69. A. Rensi, Interventi architettonici del primo Quattrocento nello Spedale di Santa Maria Nuova, in Il patrimonio artistico, pp. 63-77; L. Giorgi, P. Matracchi, Le trasformazioni della chiesa di Sant’Egidio nell’Ospedale di Santa Maria Nuova come parte del percorso museale, in Santa Maria Nuova e gli Uffizi. Vicende di un patrimonio nascosto, a cura di E. Diana, C. De Benedictis, A. Coppellotti, Firenze 2006, pp. 39-44.
70. ASF, Corporazioni religiose soppresse dal governo francese, serie 119 (SS. Annunziata), 841, cc. 2v (1-19 agosto 1364), 4v (2 novembre 1364, 6 dicembre 1364), 14r (19 settembre 1366).
Gli ospedali medievali in Toscana 73
L’aspetto dell’ospedale di San Silvestro del Dolce di Prato è ricostruibile grazie alla registrazione delle spese fatte per la sua ristrutturazione.71 Nel 1349 un incendio devastò il complesso che, come si vedrà, era costituito da più fabbricati adiacenti.72 I lavori compresero l’immediata ricostruzione del tetto delle «chase che arsero a dì 11 di gennaio» e, un paio di anni dopo, la decorazione del refet-torio (Cristo e sei santi) affidata al pittore Salvi da Pistoia. Il disastro fu proba-bilmente l’occasione per operare una riorganizzazione degli spazi dell’ospedale, ritenuta però insufficiente, visto che nel 1397 fu fondato e costruito il nuovo pellegrinaio dal maestro Iacopo di Matteo da San Donnino, che ne curò anche le parti decorative (portale). Quest’ultimo ambiente corrisponde all’attuale chiesa della Madonna del Giglio in cui si vedono ancora i portali tardogotici, l’arme di San Silvestro e il pozzo-tabernacolo dell’immagine mariana la cui miracolosità occorse più tardi la trasformazione dell’ospedale in santuario.
Dell’ospedale di San Matteo voluto a Firenze da Lemmo di Balduccio da Montecatini sono conservati i contratti di appalto per la costruzione (1378, 1385, 1387, 1389, 1404) e i computi estimativi per i successivi stati di avanzamento dei lavori (1387, 1390, 1391, 1397, 1401, 1402),73 che documentano la trasformazio-ne del vecchio convento femminile di San Niccolò di Cafaggio e la realizzazione ex novo della grandiosa loggia verso San Marco, la quale aveva profondità doppia rispetto all’attuale ed era dichiaratamente ispirata a quella di messer Bonifacio Lupi in via San Gallo (1377).74
Abbiamo già osservato la sterminata quantità di diplomi che riguardano gli ospedali medievali in Toscana. Da questa documentazione, oltre all’esistenza de-gli enti, si può ricavare qualche scarna notizia sulla configurazione degli edifici, in particolare dalle date topiche che spesso contengono stringate specificazioni di corpi di fabbrica, di spazi esterni o ambienti interni dei complessi.
E così si conosce l’esistenza di case (Passignano nel 1061),75 chiostri (Fucec-chio nel 1112, Altopascio nel 1156, Pistoia nel 1176),76 portici (Pistoia nel 1182, Fasiano nel 1184, Volterra nel 1232),77 cappelle (Altopascio nel 1183, Siena nel 1219).78
71. Archivio di Stato di Prato, fondo Ospedali, 2, cc. 2r, 7r, 25r, 25v; 18, c. 1r, cit. da Bologni, Gli antichi spedali, pp. 100, 108, senza sfruttarne le potenzialità indiziarie.
72. Vedi le note 90 e 92.73. P. Sanpaolesi, Alcuni documenti sull’ospedale di S. Matteo in Firenze, in «Belle arti», 1
(1946), pp. 76-87; A. Rensi, L’ospedale di San Matteo a Firenze: un cantiere della fine del Trecen-to, in «Rivista d’arte», 39 (1987), pp. 83-145, 122-145.
74. E. Coturri, L’ospedale così detto “di Bonifazio” in Firenze, Roma 1959; A. M. Zandri, C. Acidini Luchinat, S. Francolini, Lo spedale di messer Bonifazio, Grassina 1989.
75. ASF, Diplomatico, Passignano, S. Michele (badia, vallombrosani), 1061 Dicembre.76. Ivi, 1112 Aprile 18; Strozziane Uguccioni (acquisto), 1156 Marzo 15; Pistoia, S. Lorenzo
(agostiniani), 1176 Ottobre 1.77. Ivi, S. Bartolomeo apostolo detto badia dei Rocchettini (benedettini), 1182 Giugno 14;
Firenze, S. Maria degli Angioli (camaldolesi), 1183 Gennaio 20. Battistini, Gli spedali dell’antica Diocesi, p. 11.
78. ASF, Diplomatico, Fucecchio, Comune, 1183 Maggio 29; Archivio di Stato di Siena, Di-plomatico, Monastero di S. Petronilla, 1219 Luglio 29.
Marco Frati74
Dell’ospedale fiorentino del Santo Sepolcro, eretto nell’XI secolo da un certo Fiorenzo detto Fosco e donato nel 1068 ai monaci di San Miniato al Monte,79 si viene a sapere che era stato costruito sopra una coscia del Ponte Vecchio.
Una vendita del 1238 distingue il grande complesso ospedaliero di Altopa-scio in tre fabbricati: la mansio, la domus e il pelegrinarium.80 Tale organizzazio-ne appare ancora oggi evidente a una prima lettura planimetrica e stratigrafica.81
Da queste pochissime (in rapporto alle potenzialità dello spoglio dei fondi diplomatici e notarili) evidenze emerge un quadro non dissimile da quello ricava-bile dai dati materiali: spesso gli ospedali si presentavano articolati in più corpi edilizi raccordati da un chiostro e filtrati da un portico verso lo spazio pubblico.
Solo in rari casi questo tipo di fonte offre notizie sul cantiere di costruzione. Ciò avviene per lo più quando si tratta della stipula di un contratto di appalto in cui vengono specificate le prestazioni del maestro. Ad esempio con un atto nota-rile dell’11 ottobre 1295 venivano concessi materiali edilizi per la costruzione del portico dell’ospedale di San Paolo a Firenze.82 Ma questa nuda informazione non garantisce che il manufatto sia stato effettivamente realizzato.83
Più circostanziato è l’ampliamento del convento dell’ospedale di San Lazza-ro di Lucca. Nel 1380 il muratore e maestro di legname Martino di Chele stipulò una convenzione con Pellegrino di Alessio, rettore del lebbrosario, per edificare metà di una casa adiacente all’altra metà già fatta edificare nel chiostro. Martino doveva costruire sui muri che già esistevano dopo averli puliti dalle «spine e dalle male radici» per un’altezza pari alla metà già esistente e coprire il tetto con tegole e s’impegnava a procurare le maestranze, i manovali, gli operai, le funi e i canapi, i ferramenti e ogni altro strumento necessario, mentre il rettore avrebbe dovuto procurare la rena, la calce, le tegole i laterizi, i chiodi e tutto il legname necessario, cioè le travi, le tavole e il legname per i ponteggi.84 L’intervento è sta-to obliterato dalle successive ristrutturazioni, dall’assalto dei fiorentini nel 1433 e dai conseguenti rifacimenti.85
Molti sono gli ospedali di cui si conosce il contenuto a una certa data, grazie agl’inventari, spesso redatti al passaggio da uno spedalingo all’altro, da un’am-
79. Le carte del monastero di San Miniato al Monte (secoli IX-XII), a cura di L. Mosiici, Firenze 1990, doc. 31; L. Artusi, A. Patruno, Gli antichi ospedali di Firenze: un viaggio nel tempo alla risco-perta dei luoghi d’accoglienza e di cura; origine, storia, personaggio, aneddoti, Firenze 2000, p. 386.
80. I. Moretti, Altopascio nell’architettura e nell’urbanistica del medioevo, in Altopascio un grande centro ospitaliero nell’Europa medievale, Atti del convegno (Altopascio, 22 Luglio 1990), Altopascio 1992, pp. 31-68: 39.
81. Altopascio: lo spedale, il castello, la fattoria; una storia archeologica, a cura di G. Ciam-poltrini, Bientina 2011.
82. ASF, San Paolo de’ Convalescenti, 973, c. 22v.83. Cfr. M. Bini, D. Massaria, S. Panetteri, L’ospedale di San Paolo a Firenze tra storia e
rilievo, Firenze 2002; Henderson, ‘Splendide case di cura’, pp. 32-37, che non ne fanno cenno.84. Archivio di Stato di Lucca, Notarile, Notai prima parte, 212, c. 8v (26 gennaio 1380). Cfr.
R. Antonelli, Il Lebbrosario di San Lazzaro a Lucca, http://www.paleopatologia.it/articoli/aticolo.php?recordID=104.
85. E. Coturri, L’ospedale di San Lazzaro in “Coda di Prato”, in «Rivista di Archeologia Storia e Costume a cura dell’Istituto Storico Lucchese delle Seimiglia», 7 (1979), pp. 13-20.
Gli ospedali medievali in Toscana 75
ministrazione all’altra. Oltre a dare un’idea, talvolta anche molto precisa, del funzionamento degli enti di assistenza, questi elenchi di beni mobili riferiscono della distribuzione degli ambienti costitutivi l’organismo degli ospedali, grazie a una descrizione topologica dell’arredo e delle suppellettili.
L’ospedale urbano di Santa Fina a San Gimignano risulta nel 1292 dotato di suppellettili distribuite «in curia conversorum» (prevalentemente derrate alimen-tari e attrezzatura domestica), «in camera conversorum» (arredata con contenitori e letti), «in hospitali» (tavole e panche per mangiare con tovaglie e tovaglioli, una trentina di letti con abbondante corredo di biancheria), «in domo nova» (uno scrigno)86 con un’evidente divisione fra la zona destinata agli ospiti e quella degli ospedalieri riscontrabile nello stesso periodo a Firenze.87 È possibile controllare l’andamento della ricettività della casa sangimignanese grazie a un altro inven-tario88 che nel 1334 la mostra diminuita, attestandovi solo undici posti letto nel pellegrinaio delle donne e diciassette in quello degli uomini, mentre appare au-mentata la ricchezza degli ambienti destinati allo spedalingo, del chiostro (dotato di «una pila di pietra molto bella»), della cantina e del magazzino.
L’inventario del 1298 della casa degli infetti di Prato al Ponte Petrino,89 situa-ta fuori dal castello e gestita dal comune, offre la visione di un lebbrosario rurale: oltre ai nove letti per gli ospiti (fissi, purtroppo per loro) sono elencate masserizie agricole e riserve alimentari come in un podere qualsiasi.
Il confronto fra due inventari dell’ospedale di San Silvestro del Dolce di Prato permette di registrare l’avvenuto cambiamento nelle strutture90 ma anche il mantenimento di una funzione prevalentemente religiosa della cura. Nel 1315 i beni immobili consistevano in
cinque case delle quali una per i pellegrini e una per gli uffici e le altre per abitazione poste in Prato nei confini di Porta Tiezi vicino alla chiesa di San Marco. Tutte queste case, uffici e abitazioni sono unite e confinano con il primo lato con la via pubblica, il secondo con Lapo Pratese di Belnero, il terzo con Giunta di Rustichello e il quarto con la gora. Una casa posta nel medesimo luogo confinante con il primo lato con la via, il secondo con la gora e il terzo e il quarto con il detto ospedale. Sette case appigionate dal detto ospedale situate ugualmente nei sopraddetti confini e luoghi. Tutte queste case confinano con il primo lato con la via e il secondo e terzo e quarto con il sopraddetto ospedale91
formando un gruppo compatto di edifici il cui sedime venne poi utilizzato per rior-ganizzare e ampliare le strutture di accoglienza. Nel 1408-1409 la maggior parte dei beni mobili riguardava oggetti liturgici, concentrati nella chiesa ove si trovava
86. ASF, Diplomatico, San Gimignano, S. Fina (ospedale), 1292 Maggio 22, parzialmente e scorrettamente trascritto da Battistini, Gli spedali dell’antica Diocesi, p. 94 n. 101.
87. Vedi la nota 54.88. Lo spedale all’inizio del Trecento, in Una farmacia preindustriale, pp. 27-29 doc. III.89. Bologni, Gli antichi spedali, p. 201 doc. III.90. Vedi la nota 71.91. Bologni, Gli antichi spedali, pp. 128, 133 doc. I.
Marco Frati76
1 antare murato cho’lla predella e ‘lla prieta sagrata suvi, 1 tavola vecchia dipinta della passione di Christo in su l’antare, 1 croce nuova dipinta in su l’antare,… 1 crocifisso di legno in su la tavola dell’antare,… 2 chandellieri vecchi di legno in su l’antare, 2 chandellieri di ferro in su l’antare, 2 torchie in aste drento torchi di cera quando si celebra il Signore, 2 chandellieri dipinti di rosso in su l’antare da cerotti, 1 leggio chollo isughatoio e ‘lla coregia e ‘l puntale, 1 leggio chol quoio che s’apre e chiude;92
anche nell’infermeria degli uomini si trovavano una cassa per le suppellettili li-turgiche e l’altare, oltre a panche, un tavolino, dodici letti e, memento mori, la bara da morti; la cucina dell’infermeria era arredata con due casse e panconi; l’infermeria delle donne era allestita con undici letti, tre casse e due forzieri.
L’ospedale di Corsena (Bagni di Lucca), a servizio delle fiorenti terme locali, appare assai complesso e fornito, stando all’inventario del 1391,93 che lo presenta come una vera e propria “spa” medievale. Oltre alla chiesa e alla sagrestia, vi si trovavano nove celle, una camera sotto il pellegrinaio, una sala con accanto una camera, un portico con sopra un magazzino, una cucina, una cantina, un dormi-torio con sotto una bottega, un orto, una cantina con sopra un granaio (a cui si accedeva da una rampa di scale in cima alla quale si trovava un ripostiglio), una stalla, un magazzino, una cancellieria sotto le scale, un’altra cancelleria sotto una camera, un atrio a pianterreno sotto una sala vicino a un magazzino dell’olio, un’infermeria con 23 letti, una spezieria (farmacia), un atrio a pianterreno fra l’infermeria e il pellegrinaio, un solaio fra infermeria e pellegrinaio (che eviden-temente avevano doppia altezza), il pellegrinaio degli uomini con 27 posti letto, un (altro?) portico sopra la porta del pellegrinaio, il pellegrinaio delle donne con 23 posti letto, la cucina delle donne, il magazzino delle donne, una camera orien-tata a sud, un’altra camera, due camere per le donne di servizio.
Altri inventari un po’ più tardi rendono conto di modeste realtà urbane e rurali la cui vivacità è suggerita dalla ricchezza della dotazione di suppellettili, come quella dell’ospedale di Asnello a Pisa nel 1398,94 o, viceversa, come quella di San Lazzaro in Gerusalemme a Volterra nel 1413,95 che, però, sono entrambe senza indicazioni della localizzazione.
Inventari pienamente quattrocenteschi riferiscono di situazioni probabilmen-te evolutesi nei secoli precedenti, come quella di Uopini (1440):96 il pellegrinaio con otto posti letto era accompagnato da un ridotto, dalla stalla, da una sala e dalla camera dello spedaliere.
92. Ivi, pp. 136-137 doc. II.93. D. Balestracci, Per una storia degli ospedali di contado nella Toscana tra XIV e XVI se-
colo. Strutture, arredi, personale, assistenza, in La società del bisogno. Povertà e assistenza nella Toscana medievale, a cura di G. Pinto, Firenze 1989, pp. 37-59: 43 n. 38, 44.
94. Patetta, Gli ospedali di Pisa, pp. 120-123.95. Sono registrati tre letti (uno con saccone, uno di penna, uno trito), otto lenzuola, una co-
perta, una tovaglia, sette asciugatoi, tre deschi: M. Battistini, I lebbrosi a Volterra nel sec. XV, in «Rivista di storia critica delle scienze mediche e naturali di Firenze», 11 (1920), 1-2, p. 44.
96. Balestracci, Per una storia degli ospedali, p. 42 nn. 28, 31.
Gli ospedali medievali in Toscana 77
Anche l’ospedale della Scala a Poggibonsi, il maggiore del castello valdelsano, appare ormai nel 1445 articolato fra una zona dedicata agli ospiti e una al personale disposte su almeno tre piani:97 accanto alla sala grande, utilizzata come refettorio (arredata con tavoli, panche e contenitori), stavano una cucina e una camera (dotata di un letto); al piano di sopra si trovava la camera del frate (un solo grande letto e vari contenitori indicano che ci dormiva da solo) e fors’anche la camera del priore (la presenza delle suppellettili liturgiche la indica anche come sagrestia); ancora più in alto (sopra la camera del frate) stava una camera con tre posti letto; sul chiostro davano il celliere, la cantina, la stanza dei tini, la stalla e il pellegrinaio. Quest’ulti-mo aveva dieci letti ed era dotato di un altare, che lo configurava ancora come uno spazio liturgico; verosimilmente al piano superiore, era allestito un granaio.
Particolarissimi elenchi sono quelli di carattere fiscale: estimi e catasti. Fra questi ultimi, le cosiddette “portate” normalmente si limitano alla volutamente reticente dichiarazione del possesso di immobili genericamente descritti, dei red-diti da loro prodotti e delle masserizie ivi contenute. Questa fonte, piuttosto tarda e stringata, è utile se incrociata con altri documenti come nel caso dell’ospedale della Scala di San Gimignano accatastato nel 1428 fra gli enti religiosi della dio-cesi di Volterra nel distretto fiorentino.98
L’influenza dei comuni e, più in generale, del potere civile nella gestione degli ospedali si fece sentire sempre di più, a partire dal XII secolo. La funzione pubblica degli enti di accoglienza, la loro consistenza patrimoniale e il loro graduale passag-gio da un tipo di assistenza prevalentemente religioso a uno anche medico attiraro-no presto sugli ospedali l’interesse degli organismi di governo cittadini e dei grossi castelli. Emblematica a questo riguardo è la vicenda dell’ospedale di Ricovero a Colle di Val d’Elsa. Nel 1217, poco dopo la sua fondazione,99 il comune donò terre «pro eodem hospitale recipienti, pro mansione caritatis et beneficii construenda, pro hedificando et agendo mansionem et hospitium beneficii et caritatis»100 con-tribuendo in modo decisivo alla realizzazione della struttura. Nel 1310, quando il comune era ormai entrato nell’orbita fiorentina e alla pieve era già stato ricono-sciuto di essere nullius dioecesis, l’ospedale fu dichiarato «non esse ecclesiam, nec oratorium nec domum ecclesiasticam» in forza del ruolo del comune nel lancio dell’ospedale: questa presa di posizione del potere civile provocò una reazione dei vescovi volterrani che ne rivendicarono la giurisdizione nel 1349-1365.101
L’interventismo dei comuni in materia di edilizia ospedaliera si può ben os-servare anche a San Gimignano, dove negli statuti del 1255 venne inserita una rubrica sulla manutenzione di Santa Fina.102 Più organica appare l’azione del co-
97. C. Mazzi, Inventario dello Spedale di S. Maria della Scala in Poggibonsi (maggio 1455), in «Miscellanea Storica della Valdelsa», 3 (1895), pp. 39-67.
98. L. Sandri, L’ospedale di S. Maria della Scala di S. Gimignano nel Quattrocento. Contri-buto alla storia dell’infanzia abbandonata, Firenze 1982, pp. 17-38.
99. Vedi la nota 51.100. ASF, Diplomatico, Colle di Val d’Elsa, comunità, 1217 Dicembre 31.101. Battistini, Gli spedali dell’antica Diocesi, p. 52.102. Statuti del Comune di San Gimignano, Libro IV, rubrica 82: L. Pecori, Storia della Terra
di San Gimignano, Firenze 1853, p. 736.
Marco Frati78
mune di Pisa. Innanzitutto, nel 1257 esso fu costretto a istituire un grande ospedale cittadino103 in pegno della propria riconciliazione con il papa Alessandro IV e della consacrazione del vescovo Federico Visconti. Il sito dell’«hospitale novum Mi-sericordie Sancti Spiritus Civitatis Pisane quod Pape Alexandri dicebatur» venne scelto dal legato del papa «iuxta plateam maioris Pisane Ecclesie», cioè davanti alla cattedrale, come a Siena, e il comune s’incaricò di acquistare una «viam que vocabatur Arringum» e scavare una fossa che delimitava visivamente i «confinia dicti hospitalis». Poco dopo si progettò anche la realizzazione del nuovo campo-santo (1260, realizzato dal 1277 in poi), contribuendo alla definizione della piazza “dei miracoli”, la cui situazione urbanistica venne cristallizzata nel 1287-1288 dalla proibizione statutaria di costruire edifici fra il battistero e l’ospedale.
Fin dalla sua istituzione, al nuovo ospedale pisano, esente dal fisco e dalla giurisdizione del vescovo (che si rifiutò poi di consacrarlo), furono riuniti tutti gli ospedali sottoposti «ad Pisanam Ecclesiam», salvo quelli dipendenti dal capitolo, tentando un primo precocissimo intervento sul sistema frammentatissimo d’ospita-lità e assistenza, solo parzialmente realizzato per le immediate reazioni e resistenze degli ordini e degli enti non esenti, anche se al secolo successivo risalgono molte prove di reale obbedienza dei piccoli ospedali cittadini e rurali (in Valdarno, Ma-remma e Sardegna). Sulla scorta di questa esperienza, il comune continuò a occu-parsi dell’accoglienza in città e nel suburbio, stabilendo perfino il numero minimo di letti per ciascun ospedale nel 1304-1312:104 un preziosissimo indicatore delle dimensioni e della ricettività complessiva (503 posti) degli edifici pisani.
Anche il comune di Volterra si segnala per il suo attivismo: non soltanto “marcando” gli ospedali appena ricevuti in dono,105 ma disponendo liberamente perfino della loro ubicazione. Nel 1320-1321 una prima volta ricostruì l’ospedale dei poveri appena fondato da Michele di Provenzano nelle proprie case, per poi distruggerlo nel 1343 per poter realizzare una nuova fortezza e, infine, lo ricostruì di nuovo a Porta a Selci nel 1352.106 Il comune poi perseguì attraverso il vesco-vo una politica di centralizzazione dell’accoglienza con lo scopo di aumentarne l’efficienza ma soltanto nel 1424-1437 ottenne la giurisdizione sull’ospedale ri-unito.107
Una certa influenza sullo sviluppo edilizio degli ospedali rurali e urbani la ebbero anche i vescovi, soprattutto sugli enti sottoposti alla loro giurisdizione. Ad esempio, il vescovo di Arezzo concesse un’indulgenza per la costruzione dell’ospedale di San Pietro a Montepulciano nel 1290.108
103. M. Ronzani, Nascita e affermazione di un grande “hospitale” cittadino: lo spedale nuovo di Pisa dal 1257 alla metà del Trecento, in Città e servizi sociali nell’Italia dei secoli XII-XV, Atti del XII convegno internazionale di studi (Pistoia, 9-12 ottobre 1987), Pistoia 1990, pp. 201-235.
104. Vd. la nota 17.105. Per l’ospedale fondato da Michele di Provenzano, vd. la nota 58.106. Battistini, Gli spedali dell’antica Diocesi, pp. 29-30.107. Ivi, p. 15.108. ASF, Diplomatico, Patrimonio ecclesiastico, 1290 Agosto 11.
Gli ospedali medievali in Toscana 79
Il vescovo di Volterra ebbe un ruolo determinante, d’accordo col comune, nella riunione progressiva degli ospedali cittadini intorno a quello della Miseri-cordia di via Nuova,109 inaugurando un modello organizzativo molto seguito nei secoli successivi. Prima di tutto, nel 1353 il presule riunì gli ospedali di Baccio di Federigo, di Strenna (Santi Giacomo e Giovanni) e di Santa Maria (Spedale Nuovo) in un solo corpo provvisto di cappella per l’ufficio divino e funebre. Nel 1384, su insistenza del comune, all’ospedale della cattedrale furono uniti i tre già confluiti nella Misericordia, quello del comune in contrada Porta a Selci (fondato da Provenzano), quello della fraternita di Santa Maria in contrada Santo Stefano, quello dei Verani a San Cipriano e quello di Montegemoli, mantenendo aperti soltanto gli ultimi tre e con una minima fornitura. L’intera operazione fu confermata dal papa nel 1394.
Le cancellerie vescovili forniscono altre importanti testimonianze, anche se generalmente tarde: le visite pastorali, la cui preziosità per la descrizione degli spazi e delle suppellettili sacre è nota da tempo,110 anche se poco sfruttata per la difficoltà di lettura. Per le diocesi storiche toscane le visite trascritte o anche solo inventariate sono molto poche e, d’altra parte, in questa sede non è stato possibile procedere a uno spoglio archivistico sistematico, che auspichiamo favorito in futuro dall’accesso remoto a riproduzioni digitali dei documenti.
Limitandosi a quanto già edito, si possono fare parziali incursioni nel XIV-XV secolo solo per le diocesi di Fiesole,111 Cortona,112 Firenze113 e Pisa.114 Fra le visite, di gran lunga la più dettagliata è quella apostolica del 1575 che, anche se assai lontana dai fatti che ci interessa descrivere, ha carattere di organicità e com-pletezza e, non per nulla, è già stata impiegata per fare il punto sulla distribuzione degli ospedali medievali in territori particolari.115
109. Giachi, Ricerche storiche volterrane, pp. 612 doc. 91bis, 616 doc. 92; Battistini, Gli spedali dell’antica Diocesi, pp. 12-14.
110. U. Mazzone, Le visite pastorali: analisi di una fonte, Bologna 1985; M. Guasco, Le visite pastorali come fonti per la storia dell’arte, in «Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti», n.s., 43 (1989), pp. 163-175.
111. Per le visite quattrocentesche di una parte della diocesi, M. Barducci, Le visite pastorali dei secoli XV e XVI: annotazioni relative a un comprensorio del Valdarno superiore, in Fonti e documenti per la storia del territorio, a cura di A. Conti, Firenze 1986, pp. 9-71: 16-41, in cui sono inventariati ben ventidue ospedali visitati.
112. Per le visite cortonesi, in cui però non risultano ospedali, N. Meoni, Visite pastorali a Cortona nel Trecento, in «Archivio Storico Italiano», 129 (1971), pp. 181-256; Ead., Visite pasto-rali a Cortona nel Quattrocento, in «Annuario dell’Accademia Etrusca di Cortona», XXII (1985-1986), pp. 111-200.
113. Per la visita di sant’Antonino di Firenze (1446-1447), S. Orlandi, S. Antonino. II. I primi cinque anni di episcopato, Firenze 1960, pp. 75-89, 130-178.
114. Per le visite quattrocentesche, solo genericamente inventariate, L. Carratori Scolaro, Le visi-te pastorali della diocesi di Pisa (secoli XV-XX): inventario e studio, Ospedaletto 1996, pp. 70-77, con l’esplicita menzione del solo ospedale di Santa Maria a Vicopisano e degli altri enti pisani nel 1463.
115. M. Marchetti Gli spedali lungo il tratto senese della via Francigena: da un codice cinque-centesco dell’Archivio Arcivescovile di Siena, in «De strata francigena», 7 (1999), 1, pp. 63-72.
Marco Frati80
2.2. I documenti grafici
Le immagini hanno il pregio di rivelare l’aspetto di manufatti ormai perduti o trasformati in cui le abbondanti indicazioni funzionali fornite dai documenti scritti spesso non trovano una sicura e concreta collocazione.
Non disponendo purtroppo di mappe tardomedievali per le città toscane e i loro territori, si deve ricorrere a opere ormai rinascimentali. Per Firenze una preziosa testimonianza è offerta dalla famosa veduta miniata dal fiorentino Piero del Massaio in tre codici diversi della Geografia di Tolomeo e in uno della Storia fiorentina di Poggio Bracciolini116 nel terzo quarto del Quattrocento ma probabil-mente concepita all’inizio del secolo.117 Fra i monumenti cittadini scelti nelle quat-tro vedute compendiarie dello spazio urbano spiccano gli ospedali di Bonifacio, di Lemmo, di San Gallo, di Sant’Antonio, degl’Innocenti, di Santa Maria Nuova, della Scala e dell’Orbatello. Di essi, spesso ruotati per renderli più riconoscibili, vengono messi in evidenza gli elementi più caratteristici: il portico, le sale, la chie-sa, il giardino, il recinto. Confrontando le quattro versioni, si possono riconosce-re non piccole differenze negli edifici, frutto dell’imprecisione del miniatore ma fors’anche della trasformazione in atto di quelle strutture. La sostanziale fedeltà dell’immagine è confermata dal confronto con i complessi architettonici soprav-vissuti quasi integralmente (Innocenti, Orbatello). Di quelli trasformati si possono osservare gli elementi perduti (i corpi di fabbrica perpendicolari al portico di San Matteo, la chiesa di Sant’Egidio, il portico della Scala). Di quelli distrutti si può riconoscere l’organizzazione: l’ospedale di Bonifacio aveva il lungo e famoso por-tico che anticipava tre corpi trasversali dietro i quali si sviluppava un vasto giar-dino; quello di Sant’Antonio era costituito da una fabbrica circondata da un muro che impediva il propagarsi del “fuoco”; quello di San Gallo appare in due versioni dotato di una tettoia lignea, sostituita nelle altre due da una più ampia struttura porticata non ancora corrispondente al cantiere di età laurenziana.118
Queste considerazioni possono essere confermate da un altro importante do-cumento visivo della Firenze dell’epoca: la Pianta della Catena (in realtà una veduta, unanimemente attribuita a Francesco di Lorenzo Rosselli e databile fra il 1471 e il 1482)119 in cui gli edifici compaiono pienamente inseriti nel loro tessuto urbano e suburbano.
116. Da ultimo, M. Frati, L’ultima cerchia dopo Arnolfo: un progetto di ricerca, in «Bollettino della Società di Studi Fiorentini», XVIII-XIX (2009-2010), pp. 91-97: 92 nn. 13-14.
117. L’opinione di G. Boffito, A. Mori, Piante e vedute di Firenze. Studio storico topografico cartografico, Firenze 1926, pp. 8-12, accettata da tutti gli studiosi, deve essere ancora discussa e approfondita, analizzando la configurazione e la nomenclatura di tutti gli edifici rappresentati.
118. G.C. Romby, Il convento di San Gallo, in L’architettura di Lorenzo il Magnifico, a cura di G. Morolli, Cinisello Balsamo 1992, pp. 164-165.
119. Die Große Ansicht von Florenz; “Der Kettenplan”: Essener Bearbeitung der Großen Ansicht von Florenz des Berliner Kupferstichkabinetts, 2 voll., Berlin 1998; da ultimo, F. Canali, scheda 171, in L’uomo del Rinascimento. Leon Battista Alberti e le arti a Firenze tra ragione e bellezza, a cura di C. Acidini, G. Morolli, Firenze 2006, p. 433.
Gli ospedali medievali in Toscana 81
Per il territorio fiorentino si può fare affidamento a una ricognizione siste-matica della fine del Cinquecento: le carte dei Capitani di Parte Guelfa.120 Questa fonte ormai molto tarda ha comunque il pregio di mostrare gli edifici più signi-ficativi nella loro posizione e forma originale, spesso oggi non riconoscibili. Ad esempio, vi vengono raffigurati la torre di Sant’Allucio sul Montalbano, la chiesa romanica di Cerbaiola (Empoli) ancora sormontata assialmente da un campanile a vela, il perduto ospedale duecentesco della Maddalena a Pontorme (Empoli), il portico ancora aperto del Bigallo all’Apparita (Bagno a Ripoli).
Una più puntuale descrizione degli immobili è offerta dai cabrei, che soli-tamente comprendono mappe di beni agricoli con rilievi e vedute degli edifici annessi. L’ospedale di Sant’Allucio a Campugliano (Pescia)121 si presentava come un’aula monoabsidata con adiacente un fabbricato dotato di portico, forse costrui-to più tardi a scopo produttivo. Quello di San Vincenzo a Camaiore122 consisteva in una chiesa ad aula rettangolare priva di abside e sormontata da un campaniletto a vela; lo spazio era illuminato in facciata da due ampie monofore e nella tribuna da una finestrella cruciforme; accanto gli sorgeva un palazzetto al cui piano supe-riore si aprivano tre bifore. Più modesto, l’ospedaluzzo della Ruota123 appare però ben descritto nelle funzioni di ciascuna stanza, la più grande e lunga delle quali aveva doppia altezza e serviva da pellegrinaio.
Non mancano i rilievi in scala che riproducono minuziosamente lo stato originale dei complessi ospedalieri, come quello dell’Orbatello,124 di Santa Tri-nita125 e del Santo Sepolcro126 a Firenze, o di più semplici edifici, come il San Ber-nardino del Cappone a Legnaia.127 Quest’ultimo era composto da tre sezioni: il portico, l’abituro del custode (su due piani) e l’ospedale vero e proprio, costituito
120. Piante di popoli e strade. Capitani di Parte Guelfa 1580-1595, a cura di G. Pansini, 2 voll., Firenze 1989, per la fonte. L. Guerrini, W. Siemoni, Il territorio empolese nella seconda metà del XVI secolo, Firenze 1987, e M. Frati, Piante dei Capitani di Parte e Carte topografiche a confronto: una base per ricerche di archeologia delle comunicazioni nel territorio comunale di Empoli, in «Milliarium», IV (2002), pp. 36-48, per il suo impiego nella ricerca territoriale.
121. A. Spicciani, Per una storia ospitaliera lucchese nel secolo XII: la fraternità di Allucio da Pescia, in Atti del convegno di studi storici sulla Valdinievole, (Buggiano Castello, giugno 1990), Bologna 1991, pp. 23-54, figg. 3-4.
122. Lucensis ecclesiae monumenta a saeculo VII usque ad annum MCCLX, a cura di G. Con-cioni, C. Ferri, G. Ghilarducci, Lucca 2008, I, pp. 205-208.
123. Artusi, Patruno, Gli antichi ospedali di Firenze, pp. 117-121.124. G. Richa, Notizie storiche delle chiese fiorentine, 10 voll., Firenze 1754-1762, I, infra
pp. 292-299; C. De Benedictis, Vicende e trasformazioni dell’Ospedale di Santa Maria di Orbatello, in «Antichità viva», 26 (1987), 5-6, pp. 28-34; R.C. Trexler, Famiglia e potere a Firenze nel Rinasci-mento, Roma 1990, pp. 255-296; Artusi-Patruno, Gli antichi ospedali di Firenze, pp. 295-300. Si veda anche Orbatello, da asylum a biblioteca. Accoglienza, cultura, arte. Storia del complesso fiorentino dal 1372 a oggi, mostra a cura e in memoria di Miklos Boskovits, Firenze, 5 giugno-5 luglio 2012.
125. G. Orefice, Materiali per una storia degli ospedali fiorentini, in L’ospedale di San Paolo, pp. 13-26: fig. 5.
126. L. Ginori Lisci, Cabrei in Toscana: raccolte di mappe, prospetti e vedute sec. XVI-sec. XIX, Firenze 1978, p. 92, figg. 82-83.
127. Artusi, Patruno, Gli antichi ospedali di Firenze, pp. 37-44.
Marco Frati82
da una stanza riscaldata e dal dormitorio. In origine le due camere degli uomini e delle donne erano separate da un muro che non raggiungeva il soffitto, cosicchè si poteva passare agilmente dall’una all’altra, generando “sconcerti”; la pianta è accompagnata da un prospetto della facciata che la mostra in mattoni o pietra a faccia vista con finestre rettangolari e portico a due fornici a tutto sesto.
Rarissimi e piuttosto recenti sono i rilievi quotati, finalizzati alla conoscen-za e conservazione del bene architettonico ed eseguiti prima della lunga stagione del restauro stilistico: è il caso, ad esempio, della chiesa di Santa Maria della Spina, rilevata prima del suo spostamento,128 o della Magione di Poggibonsi, disegnata da Antonio Canestrelli,129 impegnato nella valorizzazione dell’archi-tettura medievale senese.130
Eccezionale per importanza e antichità era un affresco nel chiostro di Santa Croce ove si trovavano illustrate le storie dei frati prima del loro insediamento a Firenze. Prima che il dipinto si deteriorasse del tutto venne copiato da Stefano Rosselli nel 1655 in un disegno131 che tramanda la facciata della cattedrale di San-ta Reparata preceduta da un portico romanico con sopra una galleria gotica af-fiancata da una svelta torre merlata. Queste strutture appartenevano all’ospedale di San Giovanni Evangelista e furono demolite all’inizio del cantiere arnolfiano (1296), “liberando” il nuovo duomo della funzione caritativa normalmente eser-citata dal capitolo anche di altre città (cfr. la Tab. 1).
Senza giungere a un genere come il vedutismo, troppo lontano dai fatti archi-tettonici di cui qui ci occupiamo per quanto potenzialmente utile,132 si può ricorre-re agli sfondi urbani e rurali che dal Trecento in poi accompagnano la narrazione pittorica: ma si tratta di un tema nel tema a cui qui si può solamente accennare in modo fugace. Quando il soggetto è però l’ospedale stesso, è ovvio che non è pos-sibile prescindere da questo tipo di fonte, come per esempio nel caso dell’affresco Papa Martino V consacra la chiesa di Sant’Egidio a Firenze databile al 1424 e
128. Sulla storia dell’oratorio, cfr. L. Tanfani, Della chiesa di Santa Maria del Pontenovo detta della Spina e di alcuni uffici della Repubblica Pisana, Pisa 1871; sul cantiere gotico, cfr. F. Redi, Pisa com’era: archeologia, urbanistica e strutture materiali (secoli V-XIV), Napoli 1991, pp. 393-395; sui restauri ottocenteschi, cfr. G. Martelli, Sul proposto restauro del Tempio di Santa Maria della Spina di Pisa, Firenze 1871; M. Burresi, Santa Maria della Spina in Pisa, Cinisello Balsamo 1990.
129. A. Canestrelli, L’antica cappella della Magione, presso Poggibonsi, in «Rassegna d’Arte Senese», 4 (1908), pp. 39-44; P. Guicciardini, Due magioni del Sovrano Militare Ordine di Malta presso Poggibonsi, in «Miscellanea Storica della Valdelsa», 37 (1929), pp. 30-46.
130. A. Canestrelli, L’architettura medievale a Siena e nel suo antico territorio, a cura di I. Moretti, Firenze 2004; A. Canestrelli, Genio e misticismo nell’architettura romanica del medioevo senese, in «Bullettino Senese di Storia Patria», 25 (1918), pp. 199-232.
131. Richa, Notizie storiche delle chiese, VI, pp. 10-11, per il testo di Rosselli, che attribuisce l’affresco a Cimabue; F. Gurrieri, La Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze, 2 voll., Firenze 1994-1995, I, p. 22 fig. 1, per il disegno rimasto anonimo, e p. 67 fig. 53, per l’affresco attribuito a Giovanni del Biondo; T. Verdon, Urbanistica sacra: la città e gli ospedali, in «La nuova città», VII ser., 4 (1999), pp. 17-25, in particolare 18-19, per l’interpretazione del disegno.
132. Cfr., per esempio, G. Zocchi, Scelta di XXIV Vedute delle principali Contrade, Piazze, Chiese e Palazzi della Città di Firenze, Firenze 1744; F. Fontani, Viaggio pittorico della Toscana, 3 voll., Firenze 1801-1803, che contiene vedute degli ospedali di Firenze, Altopascio, Pisa, Siena.
Gli ospedali medievali in Toscana 83
attribuito a Bicci di Lorenzo,133 in cui è minuziosa la descrizione dell’arcispedale di Santa Maria Nuova dopo le modifiche e gli ampliamenti tre-quattrocenteschi.
Rinunciando all’analisi dell’immenso corpus pittorico medievale toscano, conviene soffermarsi sulla miniatura coeva e, in particolare, sul famoso “codice Rustici”134 col quale il pellegrino Marco di Bartolomeo volle dare Dimostrazione dell’andata del Santo Sepolcro. Il primo dei tre libri che lo compongono tratta di Firenze e del suo territorio descrivendone visivamente chiese, monasteri e ospe-dali. La sua consultazione è indispensabile, ad esempio, per meglio conoscere l’aspetto tardomedievale di Santa Maria Nuova, di Sant’Antonio, del Bigallo, della Misericordia, dell’Orbatello, di San Giacomo in campo Corbolini, com-patibile con quello offerto da altre fonti iconografiche ma, rispetto a quelle, più dettagliato, quasi si trattasse di un ritratto di volti cari.
In particolare, riappare lo scomparso nosocomio antoniano:135 un grande com-plesso recintato, dominato da una chiesa gotica ad aula unica e facciata a capanna incorniciata da lesene angolari e coronamento ad archetti e illuminata da un rosone, di cui si conoscono l’architetto (Moccio da Perugia) e i pittori (Lippo e Buffalmac-co), che la realizzarono intorno al 1328. Sulla strada si affacciavano le due sale an-ticipate da un portico e, più indietro, il giardino e il convento articolato in due ampi chiostri, forse frutto del rinnovamento voluto dal padre superiore nel 1358.
In misura molto minore – ma potenzialmente in aumento – anche le fotografie possono gettare luce sulla consistenza degli ospedali medievali. Eventi distruttivi naturali (terremoti, inondazioni) e umani (incuria, guerre) possono anche in futuro concorrere alla perdita del patrimonio edilizio ospedaliero. Per esempio, l’aspetto dell’ospedale di Sant’Allucio a Campugliano, gravemente danneggiato dal passag-gio del fronte durante l’ultimo conflitto mondiale, è messo a fuoco da uno scatto che lo mostra non troppo diverso da come appare nei documenti grafici più antichi.
133. B. Berenson, Pitture italiane del Rinascimento, Milano 1936, p. 72.134. L. Gai, «La Dimostrazione dell’andata o viaggio del Santo Sepolcro» di Bartolommeo
Rustici fiorentino (1441-42), in Toscana e Terrasanta nel Medioevo, a cura di F. Cardini, Firenze 1982, pp. 189-234, per il codice; G. Fanelli, Firenze. Architettura e città, 2 voll., Firenze 1973, II, pp. 64-66, per le illustrazioni.
135. Cfr. Artusi, Patruno, Gli antichi ospedali di Firenze, pp. 23-28, che non usano il codice per descrivere l’ospedale.
Marco Frati84
Tab. 1: Ospedali medievali in Toscana (1274-1304)
Un asterisco indica un ospedale dipendente da altro ente (segue l’ente omo nimo nel l’elenco). Una cifra sottolineata indica un ente esente dalla giurisdizione vescovile
Santo e Località Diocesi RDT I RDT II- Alamannorum de Castillione Aretino1. Arezzo 1630- de Fratta Bottachini2. Arezzo 1665- Militiae Templi de Aretio, Domus3. Arezzo 1656- Pontis de Classe4. Arezzo 2123- Pontis de Valle5. Arezzo 2338 2296S. Aegidii de Cerreto6. Arezzo 2268 2221S. Aegidii de Quercia Frassenaria7. Arezzo 1767 2322 2279S. Andreae de Toiano/Troiana8. Arezzo 2369 2332S. Angeli de Genestra9. Arezzo 1765 1900S. Benedicti de Vicemollioli/Guicimiglioli10. Arezzo 1797 1660S. Gulielmi 11. Arezzo 2155 2064S. Herculani de Rivole12. Arezzo 1798 1661S. Herculani et Blasii13. Arezzo 2348S. Iacobi al Prato14. Arezzo 1664S. Iacobi de Montesecco15. Arezzo 2347 2443S. Iacobi et Cristophori de Silce de Aretio16. Arezzo 1658S. Iohannis de Asciano17. Arezzo 1659 2349 2428S. Iohannis de Castillione Aretino18. Arezzo 1632S. Iohannis de Foresto19. Arezzo 1634S. Iohannis de Lucignano20. Arezzo 1640S. Iohannis de Monte Sancti Savini21. Arezzo 1638S. Iohannis de Montebello22. Arezzo 1651 2346 2429S. Iohannis de Montepoleciano23. Arezzo 1642S. Leonardi de Ponte Aiole24. Arezzo 2261 2191S. Luciae de Vanella 25. Arezzo 1766 2015 1901S. Marci de Sietrena26. Arezzo 2018S. Martini de Simperna27. Arezzo 1903S. Michaelis de Monteguarchi28. Arezzo 2014 1900S. Morandae/Marandae29. Arezzo 2087 1987S. Nicolai de Cabue30. Arezzo 2193 2133- Alamanorum de dicto loco (Montichiello)31. Chiusi 2832- Bonaiucte de Radicofano32. Chiusi 2779- de Clançiano33. Chiusi 2862- de Sartiano34. Chiusi 2869- de Segiano35. Chiusi 2815- Iuxta dictam Plebem (S. Silvestris)*36. Chiusi 2838- Leprosorum de Arcidosso, Domus37. Chiusi 2784- Leprosorum de dicto Castro (Plebis), Domus38. Chiusi 2755- Leprosorum de Radicofano, Domus39. Chiusi 2780- Misericordiae de Montichiello40. Chiusi 2840- Novum (de Castro Plebis)41. Chiusi 2753S. Iacobi de Moiano42. Chiusi 2852S. Iohannis de Montichiello43. Chiusi 2833S. Iohannis, Podere Domini Fini submissum 44. Chiusi 2761S. Marci de Castro Plebis45. Chiusi 2728 2873S. Mariae de Clusio46. Chiusi 2699S. Mariae de Lotis47. Chiusi 2815 2746S. Nicolai de Campolasso48. Chiusi 2764S. Peregrinis de Obricolis49. Chiusi 2708 2802S. Petri de Clusio50. Chiusi 2700
Gli ospedali medievali in Toscana 85
Santo e Località Diocesi RDT I RDT IIS. Petri de Radicofano*51. Chiusi 2778S. Iohannis52. Cortona 4668S. Laçari de Plagis53. Cortona 4600- Canonice Florentine*54. Firenze 191 59- de Montebuoni55. Firenze 162 18 797- de Pinti de Florentia56. Firenze 153 8 804- Pontis de Grieve57. Firenze 350 457S. Andreae de Candicolis*58. Firenze 175 12S. Iacobi de Sancto Eusebio, Domus Infectorum 59. Firenze 174 31S. Iacobi/Iohannis de Villiano de Simifonti60. Firenze 32S. Iohannis de Podioboniççi61. Firenze 35S. Leonardi de Cerbaiola62. Firenze 36S. Mariae de Florentia*63. Firenze 169S. Miniatis*64. Firenze 250 127S. Nazarii et Celsi de Combiata65. Firenze 157 13 807S. Nicolai de Cornio66. Firenze 164 20S. Nicolai de Cortenuova/Cortebuona67. Firenze 543 631S. Pancratii de Florentia68. Firenze 158 14S. Petri de Capraria69. Firenze 473S. Salvatoris de Monte Putano70. Firenze 342 230- de Ancisa71. Fiesole 883- de Caporsoli72. Fiesole 882- de Trespiano73. Fiesole 910- Ubaldi del Plano Alberti74. Fiesole 906 877S. Margaritae de Piangnia75. Fiesole 1153S. Mariae de Casingnano76. Fiesole 1039S. Petri de Silvaregia77. Fiesole 917- Burgi de Camaiore78. Lucca 4225 4479 3849 4487- de Cabbi79. Lucca 3886- de Calavorna80. Lucca 4528 3888 4243- Infectorum de Stingniano, Domus81. Lucca 4528- Mansio Templi, Domus82. Lucca 3861 4491- Pontis de Strata 83. Lucca 3923 4427 4113- Pontis Populi84. Lucca 3836 3887- S. Crucis de Ultramare/Appiano, Domus85. Lucca 3868S. Allucii86. Lucca 3863 4492S. Ansani87. Lucca 4329 3998 4197S. Bartholomei de Grominio88. Lucca 4004S. Bartholomei de Saltello89. Lucca 4546 4264 4533S. Bartholomei in Silice*90. Lucca 4212 3836S. Concordii de Colle Asquaio/Ascinario91. Lucca 3889S. Concordii de Rimortori92. Lucca 4011 4338 4008 4508S. Domnini93. Lucca 4046 4466 4159S. Donati* 94. Lucca 3859 4251 3912S. Francisci de Ciuciana/Cruciana95. Lucca 4024 4569 4298 4544S. Georgii de Luca*96. Lucca 4195 3819S. Iacobi de Içola Sancta97. Lucca 4020 4557 4284 4539S. Iohannis de Ceuli98. Lucca 3866 4495S. Iohannis de Malanocte99. Lucca 3865 4494S. Iohannis de Montecatini100. Lucca 3864 4493S. Lazari, Domus Infectorum101. Lucca 4363 4548S. Leonardi de Trepontho102. Lucca 3967 4318 3983S. Marci de Gralliano/Garilliano103. Lucca 4521 3890 4228S. Mariae de Albiano104. Lucca 4512S. Mariae de Buiti 105. Lucca 4537 4530
Marco Frati86
Santo e Località Diocesi RDT I RDT IIS. Mariae de Piscia*106. Lucca 4178 4434 4121S. Mariae de Pontecto*107. Lucca 3891 4283 3944S. Mariae Forisportam*108. Lucca 3849 4240 3901S. Mariae Magdalenae de Albareto109. Lucca 4391 4074S. Mariae/Luciae de Alpe Lucese110. Lucca 4408 4092 4513S. Martini in Greppo111. Lucca 4511 4202S. Martini*112. Lucca 3853 4249 S. Matthaei de Lunata113. Lucca 3898 4298 3959S. Michaelis de Conteçore114. Lucca 4343 4015S. Michaelis in Foro de Luca*115. Lucca 3857 4248 3909S. Pauli de Pietrasancta116. Lucca 3984 4495 4185S. Peregrini de Alpibus117. Lucca 3892 4534S. Petri de Vurno*118. Lucca 3906 4377 4058S. Petri in Campo* 119. Lucca 3924 4422 4110 4517S. Petri Maioris*120. Lucca 3854 4245 3906S. Pontiani*121. Lucca 4202 3826S. Reguli de Monteperpori122. Lucca 3891S. Reparatae*123. Lucca 3852 4243 3904- Mansio Templi de Vignale124. Massa M 3057- Crucis Brandellianae125. Pistoia 1324- de Altopassu de Pistorio, Domus126. Pistoia 1513- de Altopassu de Prato, Domus127. Pistoia 1515- de Spaçavento128. Pistoia 1328- Misericordiae de Pistorio129. Pistoia 1325- Pontis Brane130. Pistoia 1327- Prati Episcopi131. Pistoia 1323- S. Fridiani de Pistorio, Domus132. Pistoia 1514- Toringhelli de Prato133. Pistoia 1155 1261S. Ambrosii de Quarrata134. Pistoia 1316 1442S. Bartholomei de Rotio135. Pistoia 1154 1260 1530S. Concordii de Boçano/Barçano136. Pistoia 1259 1383S. Iacobi137. Pistoia 1189S. Iohannis Ierosolimitani de Pistorio, Domus138. Pistoia 1322S. Iohannis Ierosolimitani de Prato, Domus139. Pistoia 1329 1528S. Lucae140. Pistoia 1188 1294S. Mariae de Hosnello141. Pistoia 1336 1462S. Spiritus142. Pistoia 1326- de Altopascio143. Pisa 3439- de Calci144. Pisa 3439- de Carria Gonella145. Pisa 3439- de Cascina146. Pisa 3801- de Rinonicha147. Pisa 3439- de Spassavento148. Pisa 3439- de Stangnio149. Pisa 3439- de Vada150. Pisa 3439- de Vicascia151. Pisa 3439- Pontis Here152. Pisa 3609 3453S. Andreae in Baractolaria/Kinthica153. Pisa 3642 3513S. Annae154. Pisa 3796S. Asnelli155. Pisa 3538S. Bartholomei de Monte Pisano156. Pisa 3703 3550S. Fridiani*157. Pisa 3493 3599 3438S. Isidorii158. Pisa 3439S. Lazari, Domus Infectorum159. Pisa 3535S. Leonardi de Pratoscello, Cappella*160. Pisa 3452
Gli ospedali medievali in Toscana 87
Santo e Località Diocesi RDT I RDT IIS. Mariae Pisane Maioris Ecclesie, Canonice*161. Pisa 3521 3621 3464S. Mariae Virginis 162. Pisa 3669 3493S. Martini de Guassolungo/Chinthica163. Pisa 3648 3536S. Michaelis de Burgo*164. Pisa 3452S. Nicolai Manni165. Pisa 3700 3439S. Pauli Ripe Arni de Pisis166. Pisa 3489 3601 3433S. Stephani167. Pisa 3439S. Viti et Gorgonii* 168. Pisa 3509 3613 3436S. Zenonis169. Pisa 3597 3439 3814- de Burgo Arbie170. Siena 2516- de Selvitella171. Siena 2517- Mansionis Templi Senensis172. Siena 2518- Petri Fastelli de Senis173. Siena 2523S. Leonardi de Senis, Ordinis Sancti Iohannis Ierosolimitani 174. Siena 2515S. Mariae de Paronçola/Peronça/Porrona175. Siena 2385 2522 2514S. Mariae de Senis176. Siena 2545- Certalla, Domus177. Volterra 3023- de Belforte178. Volterra 3035- de Monteciano179. Volterra 3038- de Monterio180. Volterra 3034- de Padule181. Volterra 3031- de Peccioli182. Volterra 3029- de Podio Romei183. Volterra 3033- de Radicondoli184. Volterra 3036- de Ripamarancia185. Volterra 3037- Ghinibaldi186. Volterra 3039- Mansio Templi de Fruosina187. Volterra 3021- Mansio Templi de Sancto Geminiano188. Volterra 3020- Misericordiae de Vulterris189. Volterra 3082- Pauperum Novissimum de Vulterris190. Volterra 3083- Templi de Montelopio, Mansio191. Volterra 3023S. Iohannis de Bibona192. Volterra 3026S. Iohannis de Carpignano193. Volterra 3027S. Iohannis de Casulis194. Volterra 3032S. Iohannis de Cecina195. Volterra 3030S. Iohannis de Peccioli196. Volterra 3025 3430S. Iohannis de Sancto Geminiano197. Volterra 3022S. Iohannis de Turre198. Volterra 3024S. Mariae de Vulterris199. Volterra 3087 3286 3081