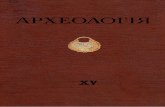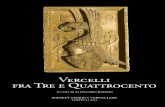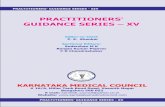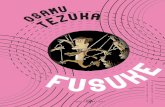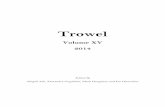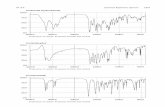Libri della provincia Romana dei Predicatori ad uso dei frati (secoli xiii-xv), AA. VV., Libri,...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Libri della provincia Romana dei Predicatori ad uso dei frati (secoli xiii-xv), AA. VV., Libri,...
EMILIO PANELLA O.P., Libri della provincia Romanadei Predicatori ad uso dei frati.
Relazione tenuta in Roma, 7 marzo 1997, Viale Castro Pretorio 105 (Istituto Centraleper il Catalogo Unico).
A stampa in: AA. VV., Libri, lettori e biblioteche dell’Italia
medievale (secoli IX-XV). Fonti, testi, utilizzazione del libro.
Livres, lecteurs et bibliothèques de l’Italie médiévale(IXe-XVe siècles). Sources, textes et usages.
Atti della Tavola rotonda italo-francese (Roma 7-8 marzo 1997), a cura di G. Lombardie D. Nebbiai Dalla Guarda, Roma (Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Bibl. ital., CNRS Éditions) 2000-2001, pp. 562.
Libri della provincia..., in pp. 277-300:1. Il codice perugino Liber privilegiorum
provincie Romane ordinis Predicatorum, pp. 277-287;
2. Vademecum amministrativo dei provinciali, pp. 287-290;
3. I libri di provincia in concessione, pp. 290-291;
4. Tempi della lista e tempi dei
prestiti, pp. 291-292; 5. Sottoscrizioni dei provinciali, pp.
292-297; 6. Costituzione del fondo librario di
provincia, pp. 297-300.■ Invito ricevuto dalla dott.ssa
Donatella Nebbiai, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes (Paris), lettera 1.VII.1996.
■ Esemplare a stampa ricevuto 7.VI. 2001.
Testo ampiamente rielaborato nella pubblicazione: E. PANELLA, Un vademecum dei provinciali romani (secoli xiv-xv), «Memorie domenicane» 28 (1997) 361-411.
E qui dunque leggi quest’ultimo:
Un vademecum dei provinciali romani (secoli xiv-xv),
«Memorie domenicane» 28 (1997) 361-411.
■ Il titolo Un vademecum riprende e sviluppa Libri della provincia Romana dei Predicatori ad uso dei frati, relazione tenuta alla Tavola rotonda italo-francese (Roma
7-8 marzo 1997), comparsa a stampa Roma-Paris (CNRSÉditions) 2000-2001, pp. 277-300.■ Laddove le due redazioni divergessero, Un vademecum prevale su Libri della provincia.
1Il "Liber privilegiorum provincie Romane OP" | Arch. di Stato di Peruia, CRS, S. Domenico, Miscell.66 | bibliografia
2
Costruzione del libro, storia dell'istituzione| provincie | conventus, Campania et Maritima, b | Sardegna&Corsica | Gui | monasteria | Montepulciano | libri | magistri ordinis | cardinales | provinciales | contributiones | privilegia (creazione della provincia "Regno di Sicilia", papa Celestino V: 1.IX.1294)
3
Vademecum amministrativo dei provinciali| avviato nei decenni '20-'30 del 1300 | dissidi di provincia 1339-44 | b; fine del vademecum 1510-15
4Il fondo libri di provincia
| assegnatari | tempi | sottoscrizioni, b | fondo librario di provincia | ordinatio de meliori libro
5
Appendice- Cronotassi del provincialato di Federico Frezzi
da Foligno| Cortona 14.VI.1404 |
- Giovanni di Domenico da Firenze OP, Tractatus deproprio (1401-04)
1.Il “Liber privilegiorum provincie Romane OP”
Tutt'altro che ignoto. Ma più saccheggiato che descritto. Serbatoio di notizie anziché intreccio di significati. Rimasti sconosciuti gl'intenti del progettatore, destinatari e uso, indefiniti i tempi di costruzione e gli strati di crescita. Un libro invece dalla spiccata fisionomia, che merita d'essere
ripercorso sul filo interno delle sue intenzioni e restituito all'originaria articolazione. Può rilasciare informazioni insospettate, se solo superiamo l'apparente disordine se alle sue reticenze opponiamo complementi e controdocumentazione. Libro, dopo tutto, più d'uso che di lettura, più sussidiario all'atto di governo che inserviente all'organizzazione del sapere. Una finestra sulla prassi amministrativa d'un organismo sociale quale una provincia d'un ordine mendicante, sorpresa al culmine della fioritura, accompagnata lungo la crisi demografica e istituzionale del secondo Tre e primo Quattrocento.
Archivio di Stato di Perugia, Corporaz. relig. soppr., S. Domenico, Miscell. 66 <Liber privilegiorum provincie Romane ordinis Predicatorum>. Membr., 228 x 163, ff. 105, foliazione settecentesca a penna. Coperta membranacea. Fascicolazione:I = bifolio di protezione (ff. 1-2) II5 (ff. 3-12), III6 (13-24), IV5 (25-34), V3 (35-40), VI6 (41-52), VII5 (53-64), VIII5 (65-76), IX3 (77-82), X6 (83-84, ma folio 5° resecato alla piega), XI5 (94-105). Quest'ultimo fascicolo, alquantodifforme, potrebb'essere stato aggiunto in secondo tempo. Per il resto, nonostante la varietà costitutiva dei fascicoli e delle mani al lavoro di scrittura, non si tratta di codice composito. Benché dal contenuto di natura eminentemente evolutiva, il libro mostra la propria unità fisica in un nucleo originario attribuibile al secondo/terzo decennio del Trecento. Accoglie incrementi posteriori e continuati, fino ai primi decenni del XVI secolo. Capilettera ma nessuna decorazione.
All'interno del foglio inferiore di guardia, una mano quattrocentesca ha abbozzato la tabula seguente:
Volumen previlegiorum quod attinet ad provi<n>tiam Romanam.Sunt scripti omnes provintiales Romane provintie.Est etiam inventarium scriptum omnium librorum provintie, quorum nullus reperitur propter negligentiam provintialium.Item scriptus est numerus generalium ordinis.Item notata est quantitas contributionum conventuum.
Itemlasciato così in tronco. Nessuna iscrizione originale. Liber privilegiorum provincie Romane ordinis Predicatorum propone un titolo prossimo al lessico e all'uso del manufatto; «hunc librum in quo sunt copie privilegiorum ordinis» (f. 4v), dice il provinciale Bartolomeo degli Acerbi da Perugia (1404-11).
2. Costruzione del libro, storia dell'istituzione
Più complessa, la struttura del libro, di quanto faccia credere la bozza di tabula quattrocentesca sul foglio di guardia. Dalla quale tuttavia raccogliamo il fuoco d'attenzione: invertendo la sequenza fisica delle carte, l'occhio s'è posato prima sulle bolle pontificie poi sui priori provinciali e libri di provincia. Difatti vero fulcro del libro, la silloge dei privilegi papali, alla nostra più laboriosa lettura; alla familiarità con l'uso del libro, per il compilatore della tabula.
Seguo il filo della stratigrafia paleografica al fine didiscernere il progetto originario del libro e le sue rubriche costitutive (qui di seguito marcate con numerazione seriale i, ii, ecc.), anche quelle sopravvenutesuccessivamente, e di cogliere il nucleo fisico delle origini. Non numerati gl'interventi o incrementi sporadici,credibilmente disorganici alla fisiologia del libro.
ff. 1v-2v: lista dei frati vescovi della provincia Romana (per convento d'origine) e note avventizie sui foglidi guardia di mani quattro-cinquecentesche.
(i) f. 3r: Provincie ordinis fratrum Predicatorum elencate a due colonne, secondo diritto di precedenza nelle due ali del coro.
ProvincieChorus dexter Chorus sinixter
YspaniaFranciaRomanaTheutonia
TholosanaLombardia inferiorRegni Sicilie
PoloniaGreciaAragoniaProvinciaLombardia superior
HungariaAngliaDaciaTerra sanctaBoemiaSaxonia
La mano che redige la primitiva lista include 18 province fino a Saxonia (stadio post 1303, ante 1378); dice Lombardia inferior e non provincia Sancti Dominici, come ridenominata negli anni 1401-10.
■ Poco oltre registra il cambiamento in atto il cronista di Cronicha magistrorum ordinis f. 7v: «Fr. Thomas de Firmo, magister in theologia, fuit bis priorprovincialis in provincia Lombardie inferioris, que nunc vocatur provincia Sancti Dominici… Electus fuit in magistrum ordinis in Utino M°cccc°j°. Obiit Ianue Mccccxiiij die xviiij martii». MOPH VIII, 93/30, 104/8, 111/32, anni 1397-1403. Conferma con valore di tre capitoli nel 1410: MOPH VIII, 134-35, 137.Medesima mano che in f. 4r stende la primitiva lista dei
conventi, incluso Terracinensis (suppone 1318), in f. 5r la lista dei monasteri e in f. 6r i libri provinciali in concessione. Nota fattura delle iniziali maiuscole, di g, a dall'occhiello superiore, secondo tratto di x prolungato insottorigo e poi curvato a destra, s finale caratteristici i tre puntini a castello di fine entrata quasi a marcare l'item rubricato.
Una seconda mano (segue il modello preesistente in modulo medio-grande, ma tradisce alterità grafica nel costruire a b l, impiega punto in luogo dei tre puntini a castello) aggiunge: Trinaclia (istituzione 1378) in coro destro sotto Lombardia superior (suppone 1303), e correlativamente Ybernia (= Hibernia, Irlanda) in coro sinistro sotto Saxonia. Ybernia subisce poi tenue erasione, marcata da frego di penna verso margine destro (provincia
istituita in giugno 1378, soppressa da Urbano VI in agosto dell'anno successivo in risposta a contrasti nazionali e pressioni politiche).
■ MOPH IV, 427/28-34, 442/4-5 confirmatio 1378, 457/10. ASV , Reg. Later. 17, ff. 3v-4r (Bonif. IX, Roma10.IV.1391) «in provincia Trinacrie».MOPH IV, 427/28-34, 442/4-5 confirmatio 1378. Nel 1400 la «natio Hybernica» parte della «provincia Anglie»: ASV, Reg. Later. 81, ff. 50r-51r (21.II.1400); nel 1413 si ribadisce la riconduzione all'Anglia: AFP 26 (1956)293-94, 301 fine § 2. Ricreata provincia nel 1484, risoppressa nel 1491, definitivamente prov. dal 1536. W.A. HINNEBUSCH, The English Dominicans and the Masters General of the late Fourteenth-Century, AA. VV., Xenia Medii Aevi historiam illustrantia oblata Th. Kaeppeli O.P., Roma 1978, II, 460-61. TH.S. FLYNN, The Irish Dominicans 1536-1641, Dublin 1993, 1-11 (Hibernia Dominicana: The Medieval Legacy of Division, 1224-1536). G. VILLETTI, Tracce per lo studio dell'architettura degli ordini mendicanti nell'Irlanda medievale, «Palladio» 7 (1994) 79-96.Sembra diversa, terza mano (confronta D, l), quella che
aggiunge Dalmatia (provincia operante nel 1387-88) sotto Ybernia, a distanza interlineare ridotta nonostante l'abbondante spazio inferiore con intenzione di sostituzione, c'è da credere, prima che Portugalia (1422-25 ca.) venga ad occupare in coro destro il posto ancora libero sotto Trinaclia. Come dire che l'ordo dignitatis nel cororacchiude intenti cronologici mentre detta l'elenco provinciale o conventuale.
■ MOPH IV, 441/17-19 (1378) incoatio; Urbano VI, 3.III.1380, conferma istituzione; scisma in corso; nelregistro di Raimondo da Capua la Dalmazia compare soloa partire dal 1392 (1380 per le altre province); nullanei capitoli generali 1380-91, non menzionata neppure tra le anti-province d'obbedienza romana. Primo provinciale documentato fr. Andreas de Dyrachio (Durrës, Albania 1387-88, poi vesc. di Dubrovnik (1388). S.
KRASIC, Congregatio Ragusina Ord. Praed. (1487-1550), Romae 1972, 41-42; id., Regesti pisama generala dominikanskog Reda poslanih u Hrvatsku (1392-1600), «Arhivski vjesnik» 17-18 (1974-75) 162;. ASV, Reg. Later. 12, ff. 20v-21r (Bonif. IX, 5.III.1391) «pro parte dilecti filii Helyede Duracio prioris provincialis fratrum OP prov. Dalmacie».Nel CG 1413 «Conventui Ulixbonensi provincie Yspanie»,AFP 26 (1956) 305 non nella lista delle province 1421(MOPH VIII, 163-64, 170/18-20). «Prov. Portugalliae» nel cap. gen. 1426 (ib. VIII, 183/18, 189/7-23, 196/36). Le constitutions OP di Siena, Bibl. comunale G.XI.36 (xv2), d'origine ispanica, oltre a molte addizioni costituzionali del 1410, portano in II, 13 (71r) anche addizione 1423 (Fratres vero nostri… presumant vel audeant: MOPH VIII, 181/4-14), e a questa arrestano i propri aggiornamenti conoscono tuttavia solo viginti province (II, 4-5) senza Portugallia. La proposta suddivisione della prov. di Spagna in tre province, Hispanie, Sancti Iacobi, Portugallie (Bullarium OP II, 533-34: 5.II.1418) non ebbe seguito.A destra di Portugalia, sull'ultimo rigo in posizione
media tra le due colonne, una parola erasa: Gentes[2], ovvero Vicariatus societatis peregrinantium inter Gentes. Geniale invenzione(1300 ca.) della predicazione evangelica nell'oriente non cristiano; che sfida le figure giuridiche dell'organizzazione operativa sperimentate in casa. Vicariato, congregazione, mai provincia dal personale trasversale alle province: «Frater Octavianus filius olim Stephani de populo Sancti Iacobi supra Arnum [OP 1318, † 20.VIII.1344]… sotietati fratrum nostrorum inter gentes peregrinantium assignatus, mari transito, per plures annos ibi predicationi et exhortationi fidelium desudavit» (Cr SMN n° 310). La peregrinante mobilità in casa altrui congiura contro la solidità giuridica in casa propria. La Societas fa capolino nella nostra lista, esposta all'erasione. Come la fragilità istituzionale della Societas
la espone a ripetute soppressioni: 1363-73, 1453-64 (R. LOENERTZ, La Société des frères Pérégrinants, Roma 1937, 1-9).
Trinaclia, Ybernia e a seguire Dalmatia, province costituite a scisma aperto della Chiesa e del governo dell'ordine. Modesti e tormentati segni grafici di cancelleria provinciale: impronta speculare di macroscopici conflitti delle istituzioni ecclesiastiche entro la geografia politica dell'Europa delle nuove nazionalità. Sui ritmi rapidi degli eventi, perché non è pensabile che si aggiungesse Ybernia dopo la sua soppressione d'agosto 1379. Parallela la sequenza stratigrafica depositata su un esemplare di costituzioni OP, dist. II c. 4, databili 1380-88, BAV, Vat. lat. 7651 (xiv-xv), f. 24r: il testo elenca 20 province, incluse Ybernie dopo Saxonie, e Trinaclie dopo superioris Lombardie; superioris successivamente barrato, perchéla provincia nel frattempo ridenominata Lombardia, polarmente a Lombardia inferior divenuta provincia Sancti Dominici (1401-10); barrata Ybernie, una mano coeva ma diversa (difforme in a il cappuccio superiore) la richiama al margine destro e la sostituisce con et Dalmacie.
[2] Devo conferma tramite lampada di Wood alla cortesia della dott.ssa C. Del Giudice dell'Arch. di Stato di Perugia (19/12/1996). Un metodico sopralluogo con la lampada potrebbe far parlare molti altri silenzi protetti da erasione.
(ii) f. 4r: Conventus Romane provincie elencati a due colonne secondo diritto di precedenza nelle due ali del coro.
Nota preliminare. Qui e in seguito, la data dei conventi omonasteri proposta tra parentesi è quella (quando conosciuta o stabilita con certezza) dell'istituzione formale, con priore o priora, come volevano le costituzionidomenicane dist. II c. 1:
«Conventus citra numerum duodenarium et sine licentia generalis capituli et absque priore et doctore non mittatur»: R. CREYTENS, Les Constitutions des Frères Prêcheurs dans la rédaction de s. Raymond de Peñafort (1241), AFP 18 (1948) 48; ancora nel 1375 ca., BAV, Vat. lat. 7658 (xiv2), f. 158v: «Conventus citra numerum duodenarium…». «Conventuscitra senarium numerum…» (Vat. lat. 7651 (xiv-xv), f. 20v) dagli ultimi decenni del Trecento per circa un secolo.Conventum mittere nell'antico lessico costituzionale, non
fundare; a designare principalmente i frati che vanno a far convento.
■ Semantica persistente specie in testi legali (conservativi per natura), anche del ramo femminile. Constitutiones sororum ordinis fratrum Predicatorum (1259) c. 12 lectio 4: «Nulli detur licencia loquendi in locutorio… quando conventus dormit vel comedit» c. 13 lectio 2: «et conventus respondeat Amen» c. 23 De creatione priorisse: «Conventus autem qui petit electe confirmationem…» (AGOP XIV A 4, f. 52r, 52v, 55v).Solo così la data riveste condizione utile, e
perentoria, per l'argomento cronologico. A rigore neppurela licentia fundationis presta data assoluta ma solo termine post quem, ché si danno licenze accordate e decreti emanati non seguiti dai fatti; mentre il rito paraliturgico della fundatio demarca la storia edilizia dell'edificio non del convento=comunità. Soltanto conventi di fatto e formalmente costituiti, o monasteri stabiliti sub cura ordinis, intende censire il Liber privilegiorum a beneficio dell'amministrazione provinciale.Non dunque domus locus hospitium. Punto capitale per raccordare senza discrasie l'argomentazione cronologica con gli strati codicologici. Con ricaduta autorevolissimain percorso inverso, dalla testimonianza del Liber privilegiorum al convento/monastero, laddove il caso si presti. Ignoro pertanto la letteratura tradizionale
(riduce spesso in commistione figure canonicamente “progressive” degli insediamenti religiosi, e loro tempi diversi, oppure sollecita datazioni alte a supplemento diprestigio); salvo a tramandare testimonianze insospette della reale costituzione del convento formale.
ASPg, Corp. relig. soppr., S. Domenico, Miscell. 66, f. 4r
Chorus dexter Chorus sinixterConventus
Florentinus Sancte Sabine Romanus
Senensis S. Marie super Minervam
Pisanus Viterbiensis Urbevetanus AretinusPerusinus TudertinusLucanus AnagninusPistoriensis SpoletanusReatinus NarniensisCastellanus PratensisFulginensis EugubinusTiburtinus CortoniensisMevenas SerezanensisSancti Miniatis TerracinensisPipernesis Sancti GeminianiFesulanus Castri FoianiCalliensis Sancti Marci
Civitatis Veteris Sancti Spiritus de Senis
Sancte Marie de Quercu
La prima mano scrive fino a Tiburtinus (1286) in coro destro, Serezanensis (Sarzana 1310: MOPH XX, 177/26, 179/15) e Terracinensis (1318) in coro sinistro.
Tiburtinus. Onorio IV, Tivoli 19.VII.1285, al vescovo diTivoli: «Cum itaque frater dilectus filius Munio magister, Iohannes prior provincialis in Romana provincia et quidam alii fratres eiusdem ordinis,
nobis exponere curaverunt locum in civitate tiburtina non habeant…, humiliter supplicarunt ut de aliqua ecclesia civitatis eiusdem, eis ad hoc competenti, providere sibi paterna sollicitudine curaremus… per apostolica scripta mandamus quatinus… ordini et fratribus supradictis ecclesiam Sancti Blasii civitatis eiusdem cum iuribus et pertinentiis suis, que fratribus ipsis competens et accomoda esse asseritur, studeas sublata qualibet difficultate conferre» (APR, Dipl. 19.VII.1285). Nel 1287 Tivoli appare già convento: MOPH XX, 78/4 (1287), 89/15 (1288).Sarzana (oggi prov. La Spezia, Liguria), convento formale dal 1310, appartenente alla provincia Romana fino al 1504-05, quando viene trasferito alla prov. Lombardia superiore.Terracinensis. MOPH XX, 212/18-25 (CP 1318), esemplare testimonianza d'istituzione conventuale: «Ponimus conventum in Terracena in loco ubi nunc fratres habitant», con assegnazione di 12 frati tot., inclusi priore e lettore, dei quali uno converso. (Entro la sua circoscrizione, la cittadina di Cori). Terracina-Ceprano-Veroli (confini meridionalidelle diocesi Terracina, Ferentino e Veroli)direttrice meridionale delle provinceecclesiastiche Campania et Maritima (diocc.Tivoli, Anagni, Segni, Alatri, Veroli, Ferentino, Terracina) del Patrimonium; confinanti a sud (direttrice Fondi-Pastena-Arce-Arpino) con la Terra laboris, territorio Regni Sicilie e della provincia domenicana del Regno. Vedi RD Latium 514a "Pipernum", 533b "Terracina", e gli studi sulla maremma laziale diCACIORGNA, Marittima medievale.Geografia politico-ecclesiastica indefinita in G. CIOFFARI - M. MIELE, Storia dei Domenicani nell'Italia meridionale, Napoli-Bari 1993, che colloca i conventi
Terracina e Priverno (III, 651a, 656a) in prov. Regni,nonostante le perentorie testimonianze di atti capitolari e registri dei maestri dell'ordine, da tempo a disposizione: MOPH XIX, 271a XVII, Ind. 44*; XXI, 192b, 193b.S. TUGWELL, The evolution of dominican structures of governement..., AFP 75 (2005) 29-94, in particolare Appendix: Provincia Regni, pp. 80-94. Volume AFP 75 (2005)a disposizione in maggio '06.
| Intervallo | Conventi delle province Romana e del Regno negli anni 1307-1310.
Difficoltà oggettive a censire i conventi formali della nuova provincia del Regno (1296: MOPH III, 279/21-30), se non vogliamo accontentarci delle compilazioni settecentesche. Sfugge tuttavia ai summenzionati autori CIOFFARI-MIELE, Storia dei Domenicani I, 21-23, la prima autorevolissima lista dei conventi del Regno, ordinata sulle quattro nationes della geografia politica del tempo, stadio anni 1307-1310, autore Bernardo di Guido da Limoges, Numerus et nomina conventuum OP. Trascrivo qui la lista delle due province confinanti dall'esemplare d'area italica, Bologna, Bibl. Univ. 1535 (xiii-xiv), f. 31r; ometto successive integrazioni tre e quattrocentesche d'altre mani. Veniale l'errore di persistenza Tranenssis (n° 4, prov. Romana), a pochi anni dalla divisione (1294-96) delle province, nonostante lo si riscriva correttamente nellanazione "Apulia". Insidie di talune denominazioni topografiche: Iteranensis, e sue varianti grafiche, era Ternano; Teramano invece era Teramanus (in Terra Abrucii), prima della ripulitura umanistica Interamnis (basta un rapido controllo sulle "Rationes decimarum Italiae"). Adrianus, de Adria = Atri, oggi in prov. di Teramo (convento formale tra 1283 e 1288: MOPH XX,
65/13; 84/1.7). Tieni distinto Teatinus (Chieti, in Terra Abrucii) dall'omeografo Reatinus (Rieti, prov. Romana). Fondi (prov. Regno) non è ancora convento nel1310; lo era già al tempo della translatio corporis sancti Thome de Aquino (1367-68).
Numerus et nomina conventuum OP (1307-1310)
Bologna, Bibl. Univ. 1535, f. 31rin provincia Romana
Conventus Sancte Sabine Ananinus in Minerva Spoletanus Florentinus Pistoriensis Senensis Reatinus [Tranenssis] Narniensis Viterbiensis Tiburtinus Pisanus Castellanus Urbevetanus Agubinus Perusinus Pratensis Aretinus Fulginas Luchanus Curtoniensis
TudertinusCastri in insula Sardinie | [Sancti Benedicti...]
in provincia Regni Cicilie in insula Cicilie in Terra Laboris
Conventus Messanensis Neapolitanus antiquorum
Placiensis Sancti Petri Martiris ibidem in Neapoli
Agustanus Gaietanus Panormitanus Beneventanus Cathaniensis Salernitanus Trapanensis Capuanus Loca nova: Siracusanus Adversanus Agrigentinus Suessanus Su<m>manus
in Terra Abrucii in Apulia
Aquilanus Barolitanus Adrianus Monopolitanus Pennensis Tranensis Teatinus Fogetanus Sulmontinus Barensis Orthonensis Tirantinus Teramanus Brundusinus
Riprendiamo l'analisi del nostro vademecum.Potrebb'essere altra mano (nota -s finale) ma
coeva quella che integra Mevenas (Bevagna 1310:MOPH XX, 177/24-25, 179/19), Sancti Miniatis e SanctiGeminiani (1329-31), Pipernesis (Priverno 1343).
22.II.1329 licenza papale di fondare i conventi San Gimignano, San Miniato e Montepulciano: AFP 64 (1994) 45-46; testo. M. ROSSI CAPONERI - L. RICCETTI, Chiese e conventi degli ordini mendicanti in Umbria nei sec. XIII-XIV. Archivi di Orvieto, Perugia 1987, 32 (26.I.1328). San Miniato è convento già nel 1330: MOPH XX, 253/22, 254/10; San Gimignano nel 1331: ib. XX, 264/13.28, 277/19-21 (1332definizione dei confini della predicazione). P. MORELLI, La nascita del convento domenicano di S. Jacopo in San Miniato: appunti per un'indagine sulle istituzioni ecclesiastiche di un centro minore della Toscana fra Due e Trecento, AA. VV., SS. Jacopo e Lucia: una chiesa, un convento. Contributi per la storia della presenza dei Domenicani in San Miniato, S. Miniato 1995,9-63. Di Montepulciano non se ne farà nulla fino a Quattrocento inoltrato.Pipernesis (Priverno, oggi prov. di Latina). MOPH XX, 347/17-21 (1343) «Facimus locum de Piperno conventum»,e assegnazione di frati 13 tot. Geografia politica medievale della Campania et Maritima del Patrimonium. Importanti notizie del cronista coevo Cr Ov 95-96, ed.129. Precedenti: MOPH XX, 302/17 (1338 locus), 315/3 (1339), 321/14 (1340) IV, 212/1-2 (1331). G.
VILLETTI, L'architettura degli ordini mendicanti a Priverno nel Due-Trecento, «Palladio» 6 (1993) 23-36: dedicata a SanTommaso d'Aquino, la chiesa (e convento) viene edificata in pieno Trecento (p. 30b).La prima mano redige la sua lista conventuale quando
Sant'Anna in Cagliari era già passato alla provincia domenicana d'Aragona (tra 1333 e 1338, stabiliremo subito):convento qui ignorato, censito invece in Quantitas contributionis f. 12v. Scrive posteriormente alla mano che avvia il corpo del codice ovvero i Privilegia, e a quella che stende (primi anni '30 del Trecento) la lista conventuale in Quantitas contributionis f. 12v.
Mani quattro e cinquecentesche integreranno in entrambe le colonne le fondazioni tardive, Fesulanus, Castri Foiani (Foiano della Chiana, pr. Arezzo), Calliensis (Cagli, pr. Pesaro-Urbino) eccetera:
... ...Pipernesis Sancti GeminianiFesulanus Castri FoianiCalliensis Sancti Marci
Civitatis Veteris Sancti Spiritus de Senis
Sancte Marie de Quercu
Fiesole (Fesulanus). S. ORLANDI, S. Antonino, Studi bibliografici II, Firenze 1960, 3-180 (c. I: Il convento di S. Domenico di Fiesole. Dagli inizi alla istituzione del conv. di S. Marco e successiva separazione dei due conventi, 1405-1445); fondamentale, quanto agli inizi storici, il documento VIII in pp. 93-104 = ASF, Corporaz. relig. soppr. dal gov. fr. 102 n° 90 (Libro di ricordanze bianco segnato A), ff. 181-186(copia notarile del 15.I.1627/8 di originale atto giuridico 25.I.1418/9), dove Fiesole non è convento formale.
AA.VV., San Domenico di Fiesole tra storia, arte e spiritualità. Seminario storico in occasione del VI centenario dellafondazione del convento (1406-2006), San Domenico di Fiesole 23 giugno 2007, MD 40 (2009) 3-208, volume in gran parte dedicato al convento fiesolano. Lo ricevo in dono in genn. 2011. Non affronta, mi pare, il delicato problema della formale istituzione del convento (non semplice domus o locus, 1406), indipendente da SMNovella e portatore dell'istanza riformista.Di primaria importanza sarebbe una rigorosa e integrale riedizione di ASF, Corporaz. relig. soppr. dal gov. fr. 102 n° 90, ff. 181-186 (25.I.1418/9, copia notariledel 15.I.1627/8), e di conseguenza una sua rilettura storiografica. Per una rapida valutazione del testo correntemente utilizzato, si raffronti l'onomastica dei frati capitolari 25.I.1418/9 tra ORLANDI, “Necrologio” II, 594-95, ed ORLANDI, S. Antonino II, 99-100.Foiano della Chiana (Castrum Foiani), pr. Arezzo, entro la circoscrizione territoriale del convento di Cortona, poi convento formale tra 1400 e 1428.Firenze, San Marco, 1436-40.Civitavecchia (Civitatis Vetulae/Veteris) 1430 circa.Siena, Santo Spirito, 1448. ASV, Reg. Suppl. 428, ff. 164v-165r (6.VII.1448); 516, ff. 235v-236r (13.XI.1459). ASS, Patrim. resti eccles., Reg. 2348.Cagli (Calliensis/Cagliensis), pr. Pesaro (Marche), città episcopale confinante con le dioc. Gubbio e Città di Castello; convento formale intorno agli anni 1460, assegnato alla provincia Romana. AGOP IV.4, f. 70r (25.V.1478) prior calliensis; 1481, prov. Romana. MOPH XVII, 145 § 274 (a. 1512).Cf. LETIZIA PELLEGRINI, Il convento di Ripatransone e l'apostolato di Giovanni da Pistoia: un saggio sulle Marche dei
domenicani tra XIII e XV secolo, «Studia Picena» 72 (2007) 43-82. L. CINELLI, Insediamenti domenicani nelle Marche (secc.XIII-XV), AA. VV., Gli ordini mendicanti (secc. XIII-XVI), «StudiMaceratesi» 43 (2009) 155-68.Viterbo, Santa Maria della Quercia (de Quercu, Querquensis, Quernus, Cerqua) 1474. MOPH XVIII, 332/2.R. ANTONELLI, L’Ordine domenicano e la letteratura nell’Italia pretridentina, AA. VV., Letteratura italiana I, Il letterato e le istituzioni, Torino (Einaudi) 1982, 702-03, disegna mappadegli "insediamenti domenicani nel 1303" intendi "conventi" (ma Cagliari non lo era ancora).■ Del tutto ignorato Pitigliano (pr. Grosseto): di breve vita, ma vi fu formale convento, anni '60-70 delQuattrocento: → Un convento domenicano in Pitigliano? http://www.e-theca.net/emiliopanella/convento/pitigli.htm
Il convento cagliaritano Sancte Anne de Castello Castri de Sardinea quando passò dalla provincia Romana a quella d'Aragona? Di decisiva valenza sulle raccorciate stratigrafie del Liber privilegiorum. A
tutt'oggi pressoché ignote le sorti trecentesche del convento sardo. Antonino di ser Niccolò Pierozzi da Firenzenel 1453-58 (è arcivescovo cittadino dal 1446) lo censisce ancora tra i conventi della sua provincia religiosa, Chronica III, tit. 23, c. 13 (conventus in provincia Romana): «Rome… et Castri in insula Sardinie» (ed. Lugduni 1543, f. III.179va). Liberiamoci subito dell'inceppo. Il compilatore Antonino, o più verosimilmente il copista-collaboratore dietro sue istruzioni, ricopia precedenti cataloghi dell'orbis dominicanus, solo in parte aggiorna e insufficientemente controlla le singole entrate. In contemporanea le autorità centrali dell'ordine, ivi
▲ Sardegna
Corsica
compreso il fiorentino Domenico di Giovanni da Corella, dettano disposizioni amministrative alla provincia d'Aragona e suo convento sardo.
■ Nella scia delle consuetudini compilatorie: l'elenco Conventus provinciarum vergato a fine Trecento in BAV, Vat. lat. 7651 (xiv-xv, provenienza prov. Saxonie), ff. 67v-72r, ricopia i conventi della prov. Romana (ff. 68v-69r), ordine di successione incluso, da quello di Bernardo di Guido da Limoges (1307-10 ca.); vi compare Castra Castrorum, e il medesimo errore Tranensis di Bernardo (Bologna, Bibl. Univ. 1535, f. 31ra).Registrum litterarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani MO 1380-1399, ed. MOPH XIX (1937): non pervenuti i registri relativi alla province ispaniche; tra i conventi della prov. Romana (pp. 61-123) non compare alcun convento sardo; in pg. 104 n. 431 fra Gregorio provinciale d'Aragonia (23.V.1391). Firenze, Bibl. Medicea Laurenziana, S. Marco 866 (Registrum litterarum Guidonis Flamochetti magistri OP 1451et Dominici Iohannis de Florentia OP vicarii 1452-53), ff. 132r-135v, sezione della Provincia Aragonie. «Item eodemdie <20.VI.1451> fr. Iacobus Lopis fuit assignatus in conventu Castri Calleri. Item eodem die fuerunt concess(a) prima cella et breviarium vacanti(a) in conventu Valencie fratri Iacobo Lopis eiusdem conventus» (f. 132r); «Item eodem die fr. Simoni Corelles concessa fuit cella conventus Castri Calleri sita in introytu dormitorii que vulgo dicitur cella domini Bernardi episcopi» (f. 132v). «Item <20.VI.1451> mandatum fuit fr.Petro Alfonsi sub pena excomunicationis late sententie… quod dimicteret ecclesiam Sancti Caroli de appendiciis Castri Calleri [? = Castri Vallerii?], non obstantibus literis apostolicis aut cardinalium, quas omnes summus pontifex revocavit per bullas pendent(es), ut declaratum fuit in capitulo Lugdunii <1450> celebrato» (f. 132v); «Eodem die <23.VI.1451> fr. Bartholomeus Galia fuit assignatus in conventu Castri Caleri usque ad sequens generale capitulum» (f. 133r).
E liberiamoci ancora da minuscoli micidiali errori di tradizione: “Monastero di S. Sisto e di S. Anna” in connessione con due frati romani (1393), da spoglio settecentesco: da restituire all'originale S. Aura, secondo monastero domenicano in Roma (rione Arenula); non di certo “convento di S. Anna di Sardegna (Cagliari)” (Necr. II, 23 n. 8, 545b anno 1393). L'unica monografia moderna consegna Cagliari alla provincia aragonese nell'anno 1329 (G. MELAS,I Domenicani in Sardegna, R. Univ. Cagliari 1933-34 (ciclostile), p. 13; del buon lavoro del MELAS esiste semplice reprint "Centro giovanile domenicano - Selargius 1994").
Antico locus del convento pisano («locus Sancte Anne de castello Castri» già nel 1305: MOPH XX, 160/3), Cagliari diventa convento formale nel 1310: «Ponimus et assignamus conventum… in castello Castri ubi facimus priorem fr. Franciscum Magioli, lectorem fr. Bartholomeum de Cantone» (ib., 177/24-29). Cr Ov 40/57 registra (1346-48 ca.) il convento cagliaritano. Toponimia coeva: VILLANI X, 210, 10; X, 259, 17-18: «in su la riva del porto di Calleri a pièdi Castello di Castro». N. BÉRIOU, Les sermons et la visite pastorale de Federico Visconti archevêque de Pise (1253-1277), Rome 2001, 1106: "Castellum de Castro" fortezza al centro della città di Cagliari, costruita dai pisani a inizio XIII sec. Le notizie delle origini domenicane le fornisce la Cronica conventus antiqua Sancte Katerine de Pisis (vedi indice alla voce "Sardegna"). Che ci tramanda anche un'anomalia costituzionale, dovuta forse all'emergenza strategica dell'area, contesa militarmente tra pisani e aragonesi, a meno che non si preferisca supporre un'imprecisione (vicario del locus anziché priore del convento) del tardivo cronista (1390-1403 ca.) Domenico da Peccioli: il convento di Pisa «de priore providebat». Che suona pressoché una nomina in luogo della canonica elezione. «Tandem <fr. Stephanus de Vico> in Sardinea diem clausit extremum in gremio Sancte Anne idest in domo quam fratres pisani conventus funditus erexerunt, et auctoritate sedis apostolice et ordinis facto conventu prior pisanus ibi de
priore et fratribus providebat» (Pisa, Biblioteca Cateriniana 78, f. 11r). Nel corso del 1324 i pisani subiscono la pressione aragonese, l'anno successivo sono costretti ad abbandonare Castello di Castro; in giugno 1326 un trattato di pace regola le residue pendenze (VILLANI X, 237; X, 251; X, 259; X, 309; X, 331). A seguito dell'annessione della Sardegna al regno aragonese e a istanza del re, Giovanni XXII da Avignone 30 giugno 1329 dispone che tutti i conventi mendicanti in Sardegna e Corsica, domenicani inclusi, passino alla giurisdizione deirispettivi provinciali d'Aragona e Catalogna (G. MOLLAT, Jean XXII. Lettres communes VIII, Paris 1924, 302-03 n° 45543 = Reg. Vat. 91, ep. 2298; Bullarium OP II, 181-82; cf. MOPH IV, 194/11). Innovazioni di tale portata non hanno luogo sui tempi corti dei decreti - era da sospettare. Di fatto Cagliari non ancora tra i conventi aragonesi nel 1331 (A. ROBLES SIERRA, Actas de los capítulos provinciales de la provincia de Aragón <1327-31>, «Escritos del Vedat» 22 (1992) 131-78). Continua a comparire negli Atti capitolari della provincia d'origine 1329-32; ultimo ricorso 1332: MOPH XX, 250/7 (1329), 253/17, 259/3, 265/21, 271/10 e 277/24 (1332).
Vale esclusione l'assenza nelle sistematiche liste conventuali della provincia Romana, specie nella rubrica "visitatores", degli anni 1338-40: MOPH XX, 302/15-24 (1338), 315/6-15 (1339), 327/9-18 (1340). Gli Atti degli anni intermedi, 1333-37, sono del tutto privi di liste conventuali, e nessuna indicazione se ne può inferire.
Cagliari non compare tra i sistematici lasciti a conventi e monasteri della provincia Romana disposti nel 1340 da Matteo Orsini (S.L. FORTE, Il card. Matteo Orsini O.P. e il suo testamento, AFP 37 (1967) 181-262); non tra i conventi rappresentati al capitolo provinciale Orvieto 1355 o censiti dal registro di Raimondo da Capua 1380-99: M. ROSSICAPONERI - L. RICCETTI, Chiese e conventi degli ordini mendicanti in Umbria nei sec. XIII-XIV. Archivi di Orvieto, Perugia 1987, 128 (11.IX.1355). MOPH XIX, 61-123: prov. Romana. Mentre nel 1348 Cr SMN n° 344 (e ancora una volta una cronica fratrum ci viene in soccorso) così scrive di Piero di Pegolotto degli
Ardinghi da Firenze (OP 1304, † 3.VI.1348): era stato «prior pratensis et Sancte Anne de Sardinea cum adhuc dictus conventus ad Romanam provinciam pertineret»; non "pertinet" più al presente, 1348. Perduti gli Atti capitolari d'Aragona 1332-44; in quelli pervenuti, 1345 ss,Cagliari è convento aragonese:
A. ROBLES SIERRA, Actas de los capítulos provinciales de la provincia dominicana de Aragón <1310, 1312, 1314, 1321>, Valencia 1991, 53-102; Actas de los capítulos provinciales de la provincia de Aragón <1327, 1328, 1329, 1330, 1331>, «Escritosdel Vedat» 22 (1992) 131-78; Actas... <1345, 1347, 1350, 1351>, «Escritos del Vedat» 23 (1993) 258/6, 271 (1345 prima comparizione, sezione delle assegnazioni: «Conventui Calaritano assignamus...»: non domus o hospitius, ma formale conventus), 285 (1347 «Conventui Calaritano assignamus...», nomina del lettore e dell'insegnante di grammatica), 289, 293 ss Actas… <1352, 1353, 1354, 1355>, ib. 24 (1994) 231 (Castri Calleri), 242 Actas… <1357, 1358>, ib. 25 (1995) 346, 367, 371 Actas… <1363, 1365, 1366>, ib. 26 (1996) 100, 104, 115, 117, 132, 136. L'autore ROBLES SIERRA OP mi spediva cortesemente gli estratti con lettera Valencia 10.II.1997, decedeva il 19febbraio successivo - comunicavano l'8 aprile i confratelli valenziani!
Concludiamo il nostro punto: il convento cagliaritano (unico dell'isola fino al San Martino in Oristano 1570) passa alla provincia Aragonie tra gli estremi massimi 1333 e 1338. Non prima del 1335, qualora fossero state applicate le norme delle Const. OP II, 1: trasferimento di convento daprovincia a provincia vuole approvazione di tre CG continui. In eccellente ricongiungimento con gli incastri cronologici delle liste del Liber privilegiorum.
■ E. CRISTIANI, L’arcivescovo Federico Visconti, Pisa e la Sardegna,in N. BÉRIOU, Les sermons et la visite pastorale de Federico Visconti archevêque de Pise (1253-1277), École française de Rome 2001, 9-26.
Per inseguire la toponomastica (mobile e multipla!) tra latino e rielaborazioni romanze: P. SELLA, Rationes decimarum Italiae. Sardinia, Città del Vat. (Studi e testi 113) 1945; Indice nelle pp. 265-95.Sintesi della storia politica della Sardegna del Trecento in «Medioevo. Un passato da riscoprire» 9 (20) sett. 1998, pp. 16-45; «Pisa si sentiva legatissima allaSardegna e in particolare a Castel di Castro. Dopo che nel 1297 Bonifacio VIII infeudò il "Regno di Sardegna e Corsica" a Giacomo II d'Aragona, Pisa si preoccupò subito di avviare trattative diplomatíche al fine di evitare il pericolo di una spedizione catalana» (p. 27a); 9 (80) sett. 2003, pp. 20-49; in p. 25 importante cartina geopolitica "La Sardegna nel XIV secolo". P. CAU, L'assedio di Villa di Chiesa [= Iglesias, 1323-24], ib. p. 36: «Il 13 gennaio 1324 gli assediati [di Villa di Chiesa = Iglesias] concordarono che, se entro un mese non fosserogiunti, da Pisa o dai suoi castelli sardi, aiuti tali dapoter decidere la vittoria con uno scontro, Villa di Chiesa avrebbe aperto le porte a chi rappresentava, in Sardegna, il re catalano aragonese. Ma bastarono tre settimane perché si esaurisse anche l'ultima riserva di cibo, e il 7 febbraio [1324] la città era consegnata, salva la popolazione, i cui combattenti e civili erano liberi di recarsi, con i loro averi, a Pisa o a Castel di Castro [= Cagliari] ancora inespugnata o, previo giuramento di fedeltà a Giacomo II, di restare nelle loro case. L'assedio era durato più di sette mesi».■ Doni di Alberto Fazzini OP, in San Domenico di Fiesoleper il capitolo provinciale, luglio 2017: L. ZORZI, Un manoscritto domenicano bolognese conservato a Cagliari: analisi storico-codicologica, Cagliari (Comunità Domenicana) 2017, pp. 116; M. ARISCI, I domenicani a Serramanna. Il complesso conventuale di San Sebastiano [1631-1858], Cagliari (Comunità Domenicana) 2017, pp. 118; in pp. 20-25 diffusione e fondazioni domenicane in Sardegna, ma non vi trovo novità testimoniali.
E la Corsica domenicana? Pochissimo se ne sa del periodo premoderno. Piste di ricerca:- nel 1329 la Corsica, insieme alla Sardegna, trasferita
per bolla papale alla giurisdizione dei provinciali d'Aragona e Catalogna.
- non campare negli atti dei capitoli provinciali sopravvissuti (1327-1366) della prov. domenicana d'Aragona;che vale pressoché esclusione, a motivo almeno della rubrica dei "visitatores".
- agosto 1347, i genovesi ottengono la signoria di tutta la Corsica; solo un terzo della popolazione sopravvive alla peste (Villani † 1348, Nuova cronica XIII, 100); l'isola sarà ancora a lungo contesa tra genovesi, pisani e aragonesi, con relativi schieramenti dei signorotti locali. I genovesi prevarranno a inizio '500.
- frati còrsi sono a lungo testimoniati nel convento pisano, almeno fino a inizio ‘400. «Fr. Andree de Begulio de Corsica [† dic. 1407] conventus pisani... examinet querelas fr. Nicolai de Arbizola conventus Bonifacii, et utipsum possit restituere ad vicariatum dicti conventus» (MOPH XIX, 110 § 489, sezione prov. Romana, 4.VI.1393). Fr.Andree Marani de Corsica 1414. Dom. di Franc. dalla Corsica1406-13 (MD 1990, 589b). Quando registrati dalla Cronica conventuale, essi vanno ritenuti figli del convento pisano.
- MOPH 21, 24 (1.VII.1469, prov. Lombardiae superioris)«licentia fratri David Corso insulam Corsicam petendi». AGOP IV.11, f. 149v (22.III.1496, sezione della prov. Lombardiae superioris): «fr. Antonius Fortileonis(?) de Bonifatio fit vicarius Bonifacii et totius insule Corsice cum plena potestate; et eximitur dictus conventus a potestate provincialis quia numquam per ipsum visitatur etc. et immediate rev.mo subicitur». MOPH 17, 270 n° 148 (1511, sezione prov. Lomb. sup.): conv. Bonifacii Corsicae.
- il Liber privilegiorum della prov. Romana (fino al primissimo '500) non conosce conventi còrsi. N. BÉRIOU, Lessermons et la visite pastorale de Federico Visconti..., Rome 2001, 1096b. Sintesi di buona divulgazione: AA. VV., La Corsica,
«Medioevo. Un passato da riscoprire» 8 (79) ag. 2003, pp. 28-48.
orbis domenicano (1307 ca.) di Bernardo di Guido da LimogesIl censimento dell'orbis domenicano (1307 ca., con
successivi aggiornamenti) di Bernardo di Guido da Limoges suscita ammirazione, se consideriamo estensione dell'ordinee toponomastica dell'Europa latina: Bologna, Bibl. Univ. 1535 (xiii-xiv), ff. 29r-36v Numerus et nomina conventuum OP.Vedi sopra Conventi delle province Romana e del Regno neglianni 1307-1310. Il penultimo convento elencato "in provincia Romana" è Castri in insula Sardinie (f. 31ra). Veniale l'errore di persistenza Tranenssis (n° 4, prov. Romana), a pochianni dalla divisione (1294-96) delle province, nonostante losi riscriva correttamente nella nazione "Apulia" della "provincia regni Cicilie" (f. 31rb). L'ultimo della lista della prov. Romana, Sancti Benedicti de . . ubi monachi facti sunt Predicatores, anticipa per commistione quanto spetta alla listadei monasteri: «Monasterium Sancti Pauli Apostoli ibidem in Urbeveteri ubi fuerunt olim moniales sub cura monachorum ordinis sancti Benedicti, a quibus resilierunt et habitum sancti Dominici et sub regimine fratrum esse elegerunt tempore domini Latini, quod confirmatum extitit per dominum Benedictum papam xj cum omnibus privilegiis concessis sororibus ordinis anno Domini M°ccciij°» (f. 35rb). tempore domini Latini = Latino di Angelo Malabranca da Roma OP, card. 1278, † Perugia 10.VIII.1294.
(iii) f. 5r: Monasteria sororum de Romana provincia. Testo della stesura originale, numerazione seriale mia:
Monasteria sororum de Romanaprovincia
1) Sancti Sixti de Urbe2) Sancte Crucis de Fossabanda de Pisis[37]
3) Sancti Iacobi de Ripolis4) Sancti Dominici in Florentia5) Sancte Marie de Virginibus Perusii
6) Sancti Georgii in Perusio7) Sancte Agnetis in Reate8) Sancte Marie de Populo Fulgin(ei)[38]
9) Sancti Petri de Urbeveteri10) Sancti Pauli de Urbeveteri11) Sancte Marie de Angelis Luce12) Sancte Marie Novelle de Aretio13) Sancte Lucie de Eugubio14) Sancti Dominici de Narnia15) Sancte Katerine de Senis16) Sancte Marie Novelle de Montepoliciano
Lista primitiva stesa dalla medesima mano di rubriche i-iv. Suppone Sancti Pauli de Urbeveteri (1303) e Sancte Marie Novellede Montepoliciano (sotto la cura dell'ordine dopo 1306-09, come si dirà tra breve).
■ Bened. XI, Laterano 5.XII.1303, nel nostro Liber privilegiorum f. 85r-v. Cr Ov 57, ed. 87, su Pietro di Bonaguida da Orvieto (OP 1271, † 25.IV.1313): «Huius procuratione papa Benedictus monasterium Sancti Pauli de Urbeveteri concessit fratribus Predicatoribus, eorum cure et correctioni subiciens».Due i monasteri fiorentini dalla divisione 1292 (MD 18
(1987) 306-07, 309) fino al San Giuliano 1365. Il presunto terzo, “San Pietro Martire fin dal 1312”, non è che titolo alternativo dell'antico San Iacopo a Ripoli; in fase di trasferimento dal contado fiorentino (ASF, SMN 31.V.1298 «soror Prima, priora monasterii et conventus de Ripolis comitatus Florentie») alla cittadina Via della Scala a inizio Trecento, le monache provarono - senza seguito - a ridenominarsi in onore del secondo santo dell'ordine: «monasterium dominarum Sancti Petri Martiris que fuerunt deRipolis» (ASF, NA 3140, f. 41r).
■ DAVIDSOHN VII, 85, che fa commistione del quattrocentesco San Pietro Martire (fondazione 1418-20, vedi più oltre) con una denominazione titolare del1312: ASF, Dipl. S. Maria Novella 15.VI.1312, tra i lasciti
testamentari di Riccuccio del fu Puccio del popolo SMN, «monasterio dominarum Sancti Dominici de Cafagio…soldos 6 florinorum parvorum monasterio dominarum Sancti Petri Marthiris de Florentia pro candelis noctenatalis Domini… soldos 6 f. p.» - brano omesso in S. ORLANDI, La Madonna di Duccio di Boninsegna e il suo culto in S. Maria Novella, MD 73 (1956) 210-11.ASF, NA 3141 (B 2127), f. 25v (Firenze 27.VI.1306) «murus dictorum fratrum <scil. Sancte Marie Novelle>, qui est iuxta viam qua itur ad monasterium dominarum de Ripolis, usque ad palum infixum in angulo ipsius platee…»: viam qua itur è via della Scala (F. SZNURA, L'espansione urbana di Firenze nel Dugento, Firenze 1975, 80) f. 38r-v (7.IV.1307) «prope ecclesiam Sancte Marie Novelle». ASF, CRS, S. Iacopo a Ripoli 3 n° 97 (27.I.1311/2) «Actum apud monasterium Sancti Iacobi de Ripolis de Florentia siti in populo Sancte Lucie OmniumSanctorum», suo sito definitivo in via della Scala. ASF, Archivio del catasto 603, ff. 134v-137v: censimento catastale (1427-29) del Monistero di Santo Iacopo di Ripoli della via della Schala.ASF, NA 3140 (B 2126), f. 41r (Firenze 27.VII.1301): «Item dominabus monasterii Sancti Dominici de Cafagio soldos 20 f. p. (…). Item dominabus monasterii Sancti Petri Martiris que fuerunt de Ripolis soldos 20 f. p.», fra altri monasteri fiorentini. Ib. ff. 70r-71v (1.VII.1302) fondo fruttifero destinato alla cura dei frati infermi di SMNovella affidato a uno dei due monasteri domenicani, Sancti Iacobi de Ripolis o in subordine Sancti Dominici de Cafagio. Ib. f. 79r-v (17.VIII.1302) «Actum apud monasterium dominarum Sancti Petri Martiris que fuerunt de Ripolis presentibus testibus fratribus Bene et Caro ordinis Predicatorum» la priora Angela loca terreno appartenente al fondo di cui a ff. 70r-71v.
La formula notarile «que fuerunt de Ripolis» ospita simultaneamente intenti ed esitazione. E rimuove ogni imbarazzo. Involontaria commistione tra i titoli dei due monasteri domenicani è invece «Actum Florentie in domo dominarum Sancti Dominici de Ripolis» (ASF, CRS, S. Iacopo a Ripoli 3 n° 87: 1.IX.1310); nel corpo del diploma si ha «recipienti pro monasterio Sancti Iacobi de Ripolis», dove Iacobi è riscritto su Dominici espunto. È solo recente lapsus la “chiesa domenicana San Pietro da Morrone in Firenze” (contaminazione paronimica col “San Pietro Martire”?), da restituire ai celestini di Via San Gallo.
■ S.K. COHN, The Cult of Remembrance and the Black Death, Baltimore-London 1992 [BiblDom-Campo 52.13], 223: «...in Dominican church of San Pietro de Murrone» in Firenze, e p. 359 n. 60. La fonte, ASF, NA 205, ff. 32v-33r (Firenze 1.VII.1365: «dna Gemma vidua, filia condam Fei dni Odaldi dela Tosa et uxor olim dni Simonis de Soli,… sepelliri voluit et iuxit in ecclesia Sancti Petri de Murrone vie Sancti Galli civitatis Florentie, videlicet in cappella quam fieri fecit dictus condam dnus Simon in dicta ecclesia»), non pone nessun rapporto con l'ordine domenicano. Chiesa dei monaci celestini dal 1329 circa, diventata San Giovannino dei Cavalieri nel XVI sec.: G. RICHA, Notizie istoriche delle Chiese Fiorentine divise ne' suoi quartieri, Firenze 1754-62, VIII, 332-35; L. ORIOLI, Le confraternite medievali e il problema della povertà. Lo statuto della Compagnia di Santa Maria Vergine e di San Zenobio di Firenze nel secolo XIV, Roma 1984, 88 n. 14 «sindicho de' frati di San Piero del Murone di Firençe» (1366).Mentre Santa Lucia in via San Gallo e preesistente
fraternita femminile sono dell'ordine della Penitenza di san Domenico, e ancora a lungo. Ramo laicale che il Liber privilegiorum non censisce. Esclusione significativa, perché sprona a distinguere, e aiuta a far chiarezza entro la tradizione compilatoria, irretita nella commistione dei
differenti statuti legali delle compagini satelliti ai mendicanti.
ASV, Reg. Suppl. 378, f. 33r-v (Eug. IV, Firenze 29.XI.1441): «Nuper s(antitas) v(estra) olim monasterium monialium Sancte Lucie Florent(ine) ordinis sancti Augustini, quod domus fratrum Carmelitarum extitit, devotis vestris priorisse et sororibus de Penitentia sancti Dominici nuncupatis Florent(ie) commorantibus, presentibus et futuris, perpetuo donari… concessit». Reg. Suppl. 384, f. 156r-v (Eug. IV, Firenze 21.VII.1442): «Pro parte dev. vestrarum sororum de Penitencia OP in monasterio Sancte Lucie in via Sancti Galli Florent(ine), per sanctitatem vestram eis concesso». ASV, Reg. Suppl. 819,f. 74v (Sisto IV, Roma 29.I.1483): «sororum tertii ordinis Predicatorum in civitate Flor(entie) consistentium sub invocatione Sancte Lucie».AGOP IV.3, f. 59r: sulla medesima carta il maestro dell'ordine dà disposizioni «Priorissis et sororibus monasterii Sancti Iacobi de Ripolis et Sancte Lucie devia Sancti Galli de Florentia» (Bologna 5.IX.1474), e poi (6.IX.1474): «Priorisse et sororibus capituli pinzocherarum in Gualfonda de Florentia fuit factum preceptum sub pena excomunicationis… quod de cetero bona eis ab ordine in usum concessa non dent neque dimictant secularibus sed ad ipsum capitulum omniter pertineant, non obstantibus literis in contrarium, quas revocavit magister».
Nessuna fondazione femminile in Campania et Maritima del Patrimonio.
Altre mani, tutte trecentesche, paleograficamente non dissonanti dai tempi d'istituzione, aggiornano. Un'unica mano verga in cima al margine destro: Sancti Nicholai de Prato (1328-30) e Sancte Lucie de Pistorio (1331-35).
B. ORSI, Il S. Domenico di Prato. Notizie e documenti, Prato 1977, 39-49. ASF, Dipl. S. Niccolò di Prato 1.IV.1331
(Prato, monastero San Niccolò 1.IV.1331): «Pateat evidenter… venerabiles et religiose domine Iohanna de Pilastris priorissa» e monache capitolari nominarono loro procuratori «fratrem Gualganum de Senis, fr. Andream de Reate et fr. Bartholomeum Rigalecti de Pistorio ordinis fratrum Predicatorum, cappellanos venerabilis patris… Matthei card. de Ursinis…».ASF, Dipl. S. Domenico di Pistoia 6.X.1331 (Orvieto 6.X.1331): Giovanni dei Porcari da Roma priore provinciale della prov. Romana, avendo ricevuto la commissione di «monasterium in civitate Pistorii hedificare sub vocabulo Beate Lucie virginis… et… illius monasterii curam gerere et habitum et regulam ordinis Predicatorum observari, prout in quodam privilegio… plenius continetur», ora subdelega «fr. Lucam de Mannellis priorem pistoriensem eiusdem ordinis Predicatorum… ad omnia et singula…, iniungens et commictens eidem quatinus ipsius monasterii… corporalem possessionem et tenutam apprehendat statim post fundationem suprascripti monasterii». P.O. MASCARUCCI, Economia ed ambiente del monastero di S. Lucia e del convento di S. Domenico di Pistoia nel sec. XV, «Bullettino storico pistoiese» n. s. 1 (1959) 9-10, 78 (1.XI.1335:«prioram prefati monasterii Sancte Lucie»). E. GIACONI, Il monastero domenicano di S. Caterina da Siena a Pistoia… (1477-1783). Cronaca e documenti, MD 36-37 (2005-2006) 7-539, in particolare pp. 12-13.Aggiornamenti successivi sfruttano l'interlinea per
annotarvi un nuovo monastero nella medesima città: Sancti Silvestri de Pisis (1336-37) sotto Sancte Crucis;
Creato dalla divisione del monastero Santa Croce in Fossa Banda nel 1336-37: il diploma Firenze 2.VI.1337 (esemplato 16.V.1428) edito da F. BONAINI, «Archivio storico italiano» I ser., 6/II (1845) 560-62, a suo tempo ASF, S. Silvestro di Pisa 2.VI.1337, di fatto registrato nell'antico catalogo generale del
diplomatico, è dei fondi ritrasferiti agli Arch. di Stato della città d'origine (controllo 7.III.1996).S. DUVAL, Chiara Gambacorta...., AA.VV., Il velo, la penna e la parola, Firenze (Bibl. di Mem. Domenicane) 2009, pp. 93-112.Sancte Aure de Urbe (tra 1346 e 1358) sotto Sancti Sixti;ASV, Reg. Suppl. 11, f. 104r (Clem. VI, Avignone 2.VIII.1346): «Supplicat… Leticia civis romana quod cum ipsa intendat in solo proprio edificare et dotare in parrochia Sanctorum Laurentii et Damassi Rome quoddam monasterium sanctimonialium sub regula constitutionibus visitatione et correctionibus fratrumPredicatorum, dignetur s(anctitas) v(estra) eidem concedere de gratia speciali licentiam edificandi monasterium supradictum sub nomine Sancte Auree et quod ipsum monasterium sit incorporatum ordini supradicto»; che abbassa d'un quarto di secolo il “termine post 1320” finora conosciuto: A. ZUCCHI, Roma domenicana, Firenze 1938-43, I, 137; P. PECCHIAI,La chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani e l’antica chiesa di S. Aurea in Via Giulia, Roma 1953, 10, 147-61. I diplomi del monastero Sant'Aurea (Via dei Magistrati, poi Via Giulia) sono confluiti (a seguito della fusione cinquecentesca del monastero medesimo) con quelli di San Sisto, oggi sotto la segnatura: AGOP XII.9000-9003).1358 data il trittico di Lippo di Vanni da Siena per il monastero, Madonna tra i santi Aurea e Domenico (alpresente, apr. 1997, conservato in Sala Riunioni, 1° piano, Univ. S. Tommaso d'Aq. in Roma). Priora e monastero formalmente nella transazione nov. 1367. PECCHIAI, La chiesa 11-12, tav. I, 148. ASV, Reg. Later. 52, ff. 161r-162r (Bonif. IX, Roma 15.V.1398) «monasterio monialium Sancte Auree de Castrosenensi dedicta Urbe sub cura et secundum instituta fratrum OP».E per arricchire lo scarno dossier segnalo ancora:
ASV, Reg. Vat. 561, ff. 6r-8r (24.I.1473); Reg. Suppl. 710,ff. 269v-270r (2.XI.1474); 765, f. 112v (23.III.1478); 768, f. 37v (8.IV.1478); 1145, f. 237v (25.VI.1502).Sancte Margarite de Eugubio sotto Sancte Lucie;Una stessa mano aggiunge Sancte Aure de Urbe e Sancte Margarite de Eugubio. Quest'ultimo non esisteva, o non era OP, nel 1340: AFP 37 (1967) 238, che conosce un solo monastero (Sancte Lucie de Eugubio della nostra listaprimitiva). Ante 1389: MOPH XIX, 96 § 339.Sancti Iuliani prope Florentiam (1365) sotto Sancti Dominici:
“prope Florentiam”, come dire annotato a ridosso del 1365, perché poco dopo luglio 1376 (G. RICHA, Notizie istoriche delle Chiese Fiorentine divise ne' suoi quartieri, Firenze 1754-62, IV, 197-98) San Giuliano a Montaione si trasferì in città, Via di Porta Faenza, pur serbando nel titolo l'originale toponimo suburbano.
ASV, Reg. Suppl. 40, f. 149v (Urbano V, apud Villanovam avinion. dioc., 13.IX.1363) «cum olim in presenti annoquondam Bartholus Cini, mercator et civis florentinus,condens testamentum voluit… quod… in certo proprio fundo suo consistente prope civitatem florentinam, in loco dicto Montaione infra limites plebis Sancti Stephani,… construeretur quoddam monasterium monialiumseu sororum… sub vocabulo Sancti Iuliani, que sub regula et secundum instituta dictorum fratrum Predicatorum viverent», dà licenza di costruzione. In giugno 1365 le monache sono introdotte nel nuovo monastero: Necr. I, 614. Montaione nel popolo (e pieve)Santo Stefano in Pane, presso torrente Terzolle, odierna stazione Rifredi.ASF, NA 1762, f. 42v (Firenze 3.IX.1404) «in monasterio Sancti Iuliani vocato Montaione»; atto capitolare con lista di 12 monache. Ib., f. 43r-v (3.IX.1404): «Actum Florentie in populo Sancti Laurentii de Florentia iuxta gratas monasterii Sancti Iuliani de Montaione de Florentia presentibus fr.
Bartholomeo Marini de Fuligno fratre Sancte Marie Novelle de Florentia»; priora e monache convocate a capitolo tot. 11. Ib. 1771, f. 135v (11.XII.1413): «Andreas Iohannis… vendidit monialibus monasterii Sancti Iuliani et Sancte Marie Urbane de Montaione… unam domum cum puteo et palchis… positam in populo Sancti Laurentii de Florentia prope dictum monasterium, quibus a j° via, a ij° dicti monasterii muro comuni in medio…, a iij° in parte dicti monasterii et in parte ecclesie Sancti Iacobi de CampoCorbolino». ASF, Archivio del catasto 603, ff. 209r-212v: Munistero di San Giuliano a Montaione (1427-29).Sopravvenuto un terzo monastero pisano, l'aggiornamento
è costretto a tornare allo spazio marginale destro: Sancti Dominici de Pisis (1385: N. ZUCCHELLI, La beata Chiara Gambacorta. La chiesa ed il convento di S. Domenico in Pisa, Pisa 1914, 41-49; S. DUVAL, Chiara Gambacorta...., AA.VV., Il velo, la penna e la parola,Firenze (Bibl. di Mem. Domenicane) 2009, pp. 93-112). Lettere minuscole a b g h c ecc. marcano a sinistra le entrate irregolarmente, finché non se ne sveli il codice.
Se mani posteriori aggiornano a beneficio del governo provinciale ben tre nuovi monasteri degli anni '30, difficile credere che la prima mano (intende censire le istituzioni sotto la giurisdizione dei provinciali) scrivesse in anni molto inoltrati del medesimo decennio. Parimenti l'assenza, sia originale che integrativa, di qualsiasi monastero sanminiatese esclude che la Santissima Annunziata di San Miniato (P. MORELLI, La nascita del convento domenicano di S. Jacopo in San Miniato, AA. VV., SS. Jacopo e Lucia: una chiesa, un convento, S. Miniato 1995, 24-25 e nota 137) fosse stata nel corso del Trecento formalmente “sub cura etsecundum instituta OP”. Come esclude che Santa Marta della Misericordia della Spina in Pisa fosse OP in pieno Trecento(F. BONAINI, Chronica antiqua…, «Archivio storico italiano» Iser., 6/II (1845) 513-14. N. ZUCCHELLI, La beata Chiara Gambacorta, Pisa 1914, 255-60), benché ne prenda cura fra
Domenico Cavalca da Vicopisano († dic. 1341); lo era di certo nel primo decennio del Quattrocento.
Cr Ps, f. 23r (n° 168): «Monasterium de Misericordia ipse sua industria et sollicitudine redegit ad locum ubi modo morantur». A fine biografia mano tardo-quattrocentesca aggiunge: «hic convertit meretrices etex eis fundavit monasterium S. Marthae» (-ae = e cedigliata). ASF, NA 450, ff. 345r-346r, da legati dne Vannuccie uxoris olim Francisci filii Tosi cimatoris, testamento 21.VIII.1340/39, f. 345r (Pisa 6.VIII.1340/39) riscuote «fr. Dominicus Cavalca de Pisis de OP pro dominabus Misericordie de Pisis sold. 30».ASV, Reg. Suppl. 125, f. 242r-v (Martino V, Firenze 19.V.1419) «Ex parte… monasterii et conventus monialium Sancte Marte de Misericordia Pisan(e) ordinis sancti Dominici exponitur quod cum monasteriumet moniales predicte fuerint descripte et sint in extimo cleri pisani confecto iam longo tempore…». Non specificata la regula o cura in ASF, NA 788, ff. 86r-87r (18.VIII.1394/3) «Actum Pisis ad retes monasterii Sancte Marte presentibus fratre Ventura condam < . .> ordinis Sancte Katerine».
Perché né la personale cura d'un frate né la participazioneal funerale della fondatrice, o simili, stabiliscono lo statuto giuridico d'un monastero. Lasciamolo dire a loro:
Monasterium <Sancti Georgii de Perusio> non fuit in principio fundatum pro ordine nec a nostris fratribus, sed ab episcopo habebat visitationem regulam et constitutiones. Sed fratre Andrea <de Chatarano † 1300 ca.> procurante et asensu [= assensu] earumdem vadens per diversas provintias ad tria generalia capitula continuata impetravit a magistro ordinis et a diffin<i>entibus ut monasterium antedictum incorporaretur ordini, consentiente perusino episcopo etpetente a monasterio unam libram cere pro censu in festobeati Erchulani, quod et factum est usque ad tempora
sancte memorie pape Benedicti <†7.VII.1304>, ipsas sanctimoniales eximendo a censu annualiter episcopo persolvendo (Cr Pg f. 31r, ed. 46).
Visitatio regula constitutio: declinano l'essere sub cura, giurisdizione costituzionale e disciplinare, che a sua volta genera e definisce l'“appartenenza”. Varietà di figure giuridiche che danno corpo alla custodia, radicale statuto della donna nella società medievale (C. CASAGRANDE,La donna custodita, AA. VV., Storia della donne. Il medioevo, a c. diCh. Klapish-Zuber, Bari 1995, 88-128). Di altro frate la medesima Cronica fratrum di San Domenico in Perugia dice: «exsua industria naturali et procuratione sollicita quasi per totum monasterium Sancte Iuliane est constructum ex sua discreta ordinatione». Ma il monastero è e rimane d'osservanza cistercense, né entra nel Liber privilegiorum.
Cr Pg■ f. 83r/75r, ed. 113; f. 45v, ed. 67-68. G. CASAGRANDE - P. MONACCHIA, Il monastero di Santa Giuliana a Perugia nel secolo XIII, «Benedictina» 27 (1980) 509-71. C.DEL GIUDICE – P. MONACCHIA, Le pergamene due-trecentesche del convento di S. Domenico e del monastero di S. Giuliana di Perugia, Perugia 2000, pp. 109-226 (Santa Giuliana, anni 1156-1399).AA.VV., Il velo, la penna e la parola. Le domenicane: storia, istituzioni e scritture, Firenze (Bibl. di Mem. Domenicane) 2009.
[37] Entrata in parte ritoccata quando ha dovuto far posto dopo disé a Sancti Silvestri de Pisis, con ricaduta grafica anche sulle due successive entrate fiorentine. Riproduzione fotografica in MD 27 (1996) 211-91 Tav. I.[38] Non due monasteri «circa annum 1300» in assenza di testimonianze perentorie: V.M. FONTANA, De Romana provincia ordinis Praedicatorum, Romae 1670, 241.
L'ultimo nominativo della lista incrocia serrati incastri cronologici e controverse appartenenze
istituzionali: Sancte Marie Novelle de Montepoliciano, sotto la prima mano. Monastero e fondatrice Agnese da Montepulciano "nostri", ovvero contesi da opposte tradizioni di famiglia,Servi di Maria e domenicani, nonché dai rispettivi calaloghi agiografici e calendari liturgici.
■ <H.M. CORMIER>, B. Raymundi Capuani, XXIII magistri generalis OP, Opuscula et litterae, Romae 1895, 5 «De Legenda B. Agnetis de Monte Politiano V(irginis) O.P.». R. TAUCCI, Il convento di S. Maria di Montepulciano e i suoi ricordi, «Studi storici dell'ordine dei Servi di Maria» 2 (1934-35) 22-51; cf. ib. 5 (1953) 304-05; 16 (1966) 286. A. ZUCCHI, L'Ordine Domenicano a Montepulciano, MD 61 (1944) 6-19 62 (1945) 10-19: i docc. citati genericamente "dall'Arch. di Stato di Firenze" sono ASF, Dipl. S. Agnese di Montepulciano (vedi Spoglio 39). Catalogus della provincia domenicana di San Marco e Sardegna, Firenze 1949, pp. 18-19. V. ROMANO - I. VENCHI, Catalogus hagiographicus O.P., «Analecta OP» 96 (1988) 58.Il Liber privilegiorum arricchisce il dossier, sollecita a
rileggerlo e sottrarlo all'appropriazione.La licenza di fondare il monastero è rilasciata dal
vescovo aretino Ildebrandino, Arezzo 31 luglio 1306; costuidelega a presiedere gli atti d'istituzione canonica fra Bonaventura di Bonaccorso da Pistoia («Studi storici dell'ordine dei Servi di Maria» 15 (1965) 255-62; 18 (1968)308b), priore dei Servi di Santa Maria in Montepulciano. Bonaventura, in Montepulciano 8 agosto 1306, "nomine et vice dicti episcopi" riceve la professione delle monache, che promettono obbedienza al vescovo aretino e suoi successori «tamquam earum immediate prelato»; il 23 settembre le monache «monasterii Sancte Marie Novelle de Montepolitiano in podio extra portam Graciani» eleggono in loro badessa (non priora!) suor Agnese da Montepulciano; il 20 ottobre 1306 fra Bonaventura, «auctoritate et vice ipsius domini episcopi», introduce suor Agnese, badessa eletta e confermata, «in corporalem possessionem spiritualium et temporalium dicti monasterii». Alla piena
canonica istituzione dunque, ottobre 1306, il monastero poliziano Santa Maria Novella non è "sub cura et instituta"di nessun ordine mendicante, è un'istituzione diocesana; ilservo di Maria fra Bonventura funge da commissario in nome e veci del vescovo aretino, non dei prelati del proprio ordine. E nessun sentore d'adozione delle Constitutiones sororum ordinis fratrum Predicatorum (questa l'iscrizione formale), in vigore dal 1259, né della relativa professionee giurisdizione di prelati domenicani o loro vicari: base reale e legittima della "appartenenza istituzionale".
■ Documenti diplomatici e notarili III-V in R. TAUCCI,Il convento di S. Maria di Montepulciano e i suoi ricordi, «Studi storici dell'ordine dei Servi di Maria» 2 (1934-35) 44-50. Cf. BEATO RAIMONDO DA CAPUA, Sant'Agnese Poliziana, a c. di U. Boscaglia, Firenze 1954, 17 n. 63a, 97-99.Le competenze delegate dal vescovo aretino rispondono alle disposizioni canoniche del Liber sextus decretalium I, 6, 43 di Bonifacio VIII (1298), ed. Ae. Friedberg, Lipsiae 1879-81 rpt Graz 1955, II, 967-69.■ «Incipiunt co<n>stitutiones sororum ordinis fratrum
Predicatorum…»: AGOP XIV A 4, ff. 49r-57v (xiv1); ed. P. Mothon, «Analecta OP» 3 (1897-98) 338-48; in c. 23 (p. 346a) De creatione (non electione) priorisse: «Sorores autem post professionem suam» (non «Sorores anno post professionem suam», commentato in p. 338 n. 1): ms XIV A 4, f. 55v.
Constitutiones sororum OFP, c. 16 De professione: «Modus faciendi professionem talis est: Ego N. facio professionem et promitto obedientiam Deo et beate Marie et beato Dominico et tibi N. priorisse, vice N. magistri ordinis fratrum Predicatorum, secundum regulam beati Augustini et institutiones sororum quarum cura predicto ordini est commissa, quod ero obediens tibi aliisque priorissis meis usque ad mortem» (AGOP XIV A 4, f. 53v).
R. CREYTENS, Les Constitutions primitives des soeurs dominicaines de Montargis (1250), AFP 17 (1947) 41-84, specie pp. 48-67; Le «Directoire» du Codex Ruthenensis conservé aux Archives générales des frères Prêcheurs, AFP 26 (1956) 124; Costituzioni delle monache domenicane, «Dizionario degli istituti di perfezione» 3 (1976) 190-94. A. DUVAL, Les soers dominicaines, «Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique» 18 (1977) 1410-26.■ Nella delega di fondazione di Santa Lucia in Pistoia, ASF, Dipl. S. Domenico di Pistoia 6.X.1331: «… monasterium construendum fr. Iohanni de Porcariis romane provincie priori provinciali commiserit et iniunserit ipsi priori provinciali illius monasterii curam gerere et habitum et regulam ordinis Predicatorum observari, prout in quodam privilegio… plenius continetur, ipse fr. Iohannes prior provincialis predictus, volens mandatum sibi factum a dno legato supradicto executioni mandare, fr. Lucam de Mannellis priorem pistoriensem eiusdem OP sibi constituit et substituit omni iure… syndicum et procuratorem ad omnia et singula…, iniungens et commictens eidem quatinus ipsius monasterii… corporalem possessionem et tenutam apprehendat statim post fundationem suprascripti monasterii. Actum fuit hoc in civitate urbevetana in loco fratrum Predicatorum de Urbeveteri…».Per altro verso l'accettazione alla cura ordinis di
monastero preesistente esigeva, dal 1257 in poi, l'approvazione di tre capitoli generali consecutivi; che abbassa il termine post almeno al 1309. Agli anni 1346-48, redazione della Cronica fratrum Sancti Dominici de Urbeveteri, il monastero poliziano risulta già ridenominato e sub cura OP: fra Giovanni di donna Buona da Orvieto (OP 1288, † 22.VII.1330) «in singnum sincerissime castitatis prefectus est dominabus Sancte Angnetis monasterii nostri de Monte Policiano»; cose fatte, anzi, entro luglio 1330, se fossimo
certi che il cronista non riformuli in retroproiezione (titolo Sant'Agnese retrodato, insinua la cronologia della nostra lista).
■ Constit. OP II, 1: H. DENIFLE, Die Constitutionen des Predigerordens in der Redaktion Raimunds von Peñafort, «Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters»5 (1889) 549, che riproduce testo costituzionale 1258 ca. MOPH III, 84/11-15 (1257).Cr Ov 72-73, ed. 105-06 (Montepulciano allora in diocesi d'Arezzo e nella praedicatio del convento orvietano). Parallelamente al Campione (XIV sec.) del convento pisano, se la redazione fosse coeva al decesso: Gherardo della Spina da Pisa OP «morì a Montepulciano al monistero di Sancta Agnese, tornando da Orbivieto MCCCXLIX, die XXIV o XXV di luglio» (F. BONAINI, Chronica antiqua…, «Archivio storico italiano» I ser., 6/II (1845) 574 n. 256)Sulle carte del Liber privilegiorum la stessa mano che a
medio Trecento aggiunge Sancte Aure de Urbe, muta il titolo: espunge Marie Novelle, sovrascrive Agnetis, e ottiene in economia Sancte Agnetis de Montepoliciano. Nel 1365-66 Raimondo delle Vigne da Capua OP redige la Legenda della fondatrice e prima badessa Agnese da Montepulciano († 1317), designandola «soror ordinis fratrum Predicatorum».
Incipit legenda beate Agnetis virginis de Monte Politiano de Ordine Predicatorum: mi servo del testo critico messomi cortesemente a disposizione dall'editrice Silvia Nocentini, in corso d'allestimento per la stampa. Legenda III, 8: «Anno enim Domini MCCCLXII, qui quidem annus quartus fuit ante presentem»: composizione anno 1365 se contava alla romana (Cr SMN n° 311 «anno tertio sui provincialatus» conta nov. 1342 - nov. 1344); dopo maggio 1364 (III, 12: «in anno enim Domini MCCCLXIIII, prima die maii, venit ad me quidam vir»); poco dopo il decesso di Paolo di ser Piero da Firenze OP (III, 12), «prior in monasterio de Monte Politiano, ubi diu
permanens infirmatus et Florentiam reversus non post multos dies defu<n>ctus est anno Domini Mccclxv» (Cr SMNn° 453). A.W. VAN REE, Raymond de Capoue, Éléments biographiques, AFP 33 (1963) 166-67, 230-31. SOPMÆ III, 288-89.Di certo il monastero, col titolo originale Santa Maria
Novella, è già sub cura OP entro il primo lustro degli anni '30, attesta perentoriamente la nostra lista.
■ Monastero, non la fondatrice Agnese, la cui appartenenza OP sconosciuta alle fonti diplomatiche coeve è affidata alla tardiva convinzione di Raimondo.La successiva transizione del monastero alla cura OP ha trainato con sé anche la fondatrice? per istintiva fedeltà alla "solidarietà organica" del medievale - quant'è del corpus si predica anche del caput e viceversa - anziché per appropriazione fraudolenta? «Accessorium naturam sequi congruit principalis», «In toto partem non est dubium contineri», nel De regulis iuris in calce al Sextus decretalium.Per iniziativa d'Agnese (tra 1306 e 1317), asserisce cinquant'anni dopo Raimondo (Legenda II, 2: «Insuper et post alicuius temporis spatium, primo ab ipso episcopo, deinde a quodam apostolice sedis legato, ut divina dispositio impleretur, obtinuit ut cura ipsius monasterii ordini Fratrum Predicatorum committeretur plenarie et omnino, in cuius rei testimonium extant privilegia sigillata»), alquanto reticente sulle "origini" del monastero, benché tenga a dichiarare di fondarsi su deposizioni certificate da notai.Le stratificazioni grafiche sul Liber privilegiorum
inseguono mutazioni istituzionali in corso e permettono d'inferire che tra 1335 circa e 1348 il monastero polizianoaveva anche mutato nome. Giusto un secolo dopo, la deplorevole condotta delle monache portò alla soppressione del monastero e trasferimento delle superstiti a San Paolo d'Orvieto (1435) - alla praedicatio orvietana apparteneva
Montepulciano. Il titolo Santa Agnese lo eredita l'erigendoconvento maschile.
ASV, Reg. Suppl. 156 ff. 45v-46r (Martino V, Roma 24.X.1421): «Cum sorores in monasterio sive domo Sancte Agnetis de Montepoliciano sub cura et secundum institutaordinis fratrum Predicatorum viv(entes) refuge regularis discipline vitam ducant enormem et penitus dissolutam…, supplicatur s(anctitas) v(estra) pro parte…Leonardi generalis dicti ordinis quatinus sibi ut sorores… ad alia regularia loca mulierum vicinia… transferre… - Fiat ut petitur». ASV, Reg. Later. 330, ff. 282v-283v (Eug. IV, Firenze 21.V.1435).■ Fondo archivistico del convento OP Santa Agnese di Montepulciano in ASF, Comp. rel. soppr. da Pietro Leopoldo 3414-3433 (vedi Invent. N/128, pp. 21 ss).Notevole ASF, Comp. rel. soppr. da Pietro Leopoldo 3420: enorme faldone che rilega insieme pezzi numerati 7-12.ASF, Comp. rel. soppr. ... 3420 ins. 8. Questo inserto cuce a sua volta (in parte smembrati) tre pezzi che originariamente dovevano essere tre distinti libri amministrativi. Riconoscibili (da miei appunti presi in febbr. 1997):I) <Libro delle possessioni dello spidale di Santo Pietro>. 1° fasc. rilegato a inizio del blocco centrale (= III); entro questo fasc. 1° c'è un foglio staccato e smembrato appartenente a II, come conferma la successione seriale della numerazione laterale delle ricordanze. Fol. 2r (1.II.1457): Libro delle possessioni dello spidale di S(anto) Pietro overo a Santo Luca . «Questo libro fo ordinatonel tempo del provincialato di maestro Paulo d'Orvietoprovinciale <1455-59> nell’ordine di santo Domenico nella provincia Romana, el quale fu ordinato per le mano di frate Simone di Viterbo, incomenzando lo inventario di tutte le possessioni». Stessa mano che scrive ff. 2r-3v.
II) <Ricollecta di tutti i beni del convento 1498>. Fol. 1bis smembrato e incollato entro il 1° fasc.; suo seguito attualmente appeso come fasc. finale di III.Fol. 1bis r (15.XI.1498): «<I>o frate Lionardo d'Antonio di Tici da Pistoia, frate di santo Domenico e figliuolo del conv. di Santa Angnese da Montepulciano e asegnato in decto convento pe·llo rev.do padre generale maestro Giovachino Turriano da Venetia (…). Fummi commesso dallo procuratore nominatodi sopra <scil. Francescho da Firenze procuratore di tutto l’ordine> ch'io facessi una ricollecta di tutti i beni e quali al decto convento, mobili cioè terreni e altre cose apartenente al dicto convento. E così quidi socto si nomineranno cosa per cosa e peço per peço…».Fol. f. 5r: «Ricordo come questo dì sopra scripto <15.XI.1498?>…, e tutti i frati e quali erano a quellotempo in convento, incominciando dal priore videlicet fr. Nicholaus Iacobi de Regno prior dicti conv., fr. Leonardus Antonii de Pistorio, fr. Marchio Allexandri della Magna, fr. Antonius Iuliani de Pistorio sacristamaioris ecclesie catredalis (sic), fr. Sebastianus Thomasi de Pistorio, fr. Antonius de Regnio, fr. Iohannes Vincentii Arberti de Lucha, fr. Gierolimus deMonte Policiano, tutti presenti al dicto contratto».III) Liber catasti et locationum signatus B, con propria foliazione romana ff. I-CCXXVIII, più carte bianche. «... questo libro è intitulato liber catasti et locationum signatus B. Faremo nota di tutti li beni immobili di decto nostro convento... Questo libro fu facto nuovamente sotto dì xvj° febraio nel 1523 dalli ven.dipadri della provincia Romana post ingressum ipsorum indictum conventum, nel quale fu addì vj di novembre nelMDxxxj°» (non foliato).
■ →www.academia.edu/11210931/Per_la_storia_di_Montepulciano_1991_
(iv) f. 6r: Isti sunt libri quorum proprietas spectat ad Romanam provinciam.
Una medesima mano scrive originariamente rubriche i-iv (tutto entro l'attuale 2° fascicolo) nel caso di Isti sunt libri, l'intera lista libraria della pagina. Collaziona A, N, P, coda inferiore di g (qui in verità chiude in sottorigo più economicamente girando dal basso in alto nelle liste conventi e monasteri il maggior spazio a disposizione le consente più ampia curva calligrafica a chiusura in basso?) complemento a destra della sezione superiore di l, b. Redazione della lista libraria confinata entro gli anni '30 del Trecento concorde con le liste dei conventi e monasteri, che vogliono anch'esse il medesimo decennio.
ff. 6r, 4v, 5v: Sottoscrizioni autografe dei provincialialla lista dei libri della provincia. Mani diverse, coeve all'attestazione, dal 1342 al 1411 tutte scrivono minuscola documentaria.
Rubrica e sottoscrizioni studiate specificamente più oltre.
(v) ff. 6v-8r: Cronicha magistrorum ordinis.
Un'unica mano, anch'essa in minuscola documentaria ma diversa dalle precedenti (confronta g, prolungamenti sottorigo), avvia sia Cronicha magistrorum ff. 6v-7r (blocco n° 1-16 fino a Ugo de Vaucemain, «obiit Moiijcxl», di fatto † agosto 1341) che Cronica provincialium f. 11r-v (fino a Stephanus de Cumba e Iohannes de Sancto Iuvenali, 1369-70 ca.; ignoro ripassi e minuscoli complementi d'altre mani); e a ff. 31r-32r trascrive la bolla di Benedetto XII, Avignone 17.VI.1335. Nota S maiuscola, g, nota tironiana 7, x. Lavora nel medio Trecento. La sottoscrizione autografa «Ego fr. Stephanus de Cumba…» (1370) alla lista libraria di f. 6r
non sarebbe retrocessa a f. 5v se f. 6v non fosse già statooccupato da scrittura.
Una seconda mano redige (a inizio Quattrocento?) le notizie n° 17-24 dei maestri dell'ordine, da Geraldus de provincia tholosana (1342) a Thomas de Firmo… electus… in Utino M°cccc°j°, cui altra mano appende Obiit Ianue Mccccxiiij die xviiij martii. Altri aggiornano fino al n° 27 (1450).
(vi) ff. 8v-9v: Cardinales ex ordine Praedicatorum assumpti.
Rubrica aggiunta tardivamente, da un'unica mano quattro-cinquecentesca. Si riserva due righi per ogni nominativo, con indicazione del titolo cardinalizio e luogo di sepoltura. Arresta il lavoro a n° 24 Iohannes de Ragusio († 1443).
ff. 10v, 32v-34v, 105v. Utilizzando queste carte interstiziali delle rubriche e ancora bianche, nel 1380 fraGiovanni dei Maiensi da Viterbo vi raccoglie notizie catalogistiche sul convento viterbese Santa Maria in Gradi; arruffate e commiste, hanno riscosso credito superiore al merito. In Viterbo il libro era depositato in quegli anni: «et librum hunc reposui in capsa communis librarie» (f. 32v). Per breve tempo, se Domenico da Peccioli (Pisa) e Iacopo degli Altoviti fiorentino vi lasciano ripetute testimonianze autografe del loro provincialato (1378-88). Sullo scorcio del Quattrocento fraGiovanni Nanni da Viterbo chiosa di proprio pugno le note del Maiensi, in ricerca fervida e finanche allucinata delleorigini mitiche della propria città; il libro ancora in Viterbo a seguito del viterbese Ludovico d'Angelo?, provinciale nel decennio 1484-94 (f. 12r n° Lx).
Cronaca antica di Santa Maria in Gradi di Viterbo...,■ AFP 65 (1995) 189-214. Su Giovanni Nanni (ib. 197-204) integra con E. FUMAGALLI, Un falso tardo-quattrocentesco: le pseudo-Catone di Annio da Viterbo, AA. VV., Vestigia. Studi in onore di Giuseppe Billanovich, Roma (Storia e lett. 162) 1984, I, 337-63 (mia cartella, Iohs Nannis de Viterbio).
(vii) ff. 11r-12r, 10r: Cronica provincialium Romane provincie.
Chi avvia la rubrica (vedi sopra Cronicha magistrorum ordinis) perviene fino a Stephanus de Cumba e Iohannes de Sancto Iuvenali, intorno agli anni 1369-70. Semplice lista nominativa e numero seriale di successione; qualche tentativo si riscrittura e minuti complementi posteriori. Altre mani, passando dalla nuda lista nominativa a breve notizia cronografica dal n° 50 (1437), proseguono in f. 12r; esauriti anche gli spazi marginali della carta, retrocedono a f. 10r. Il tutto protratto fino a inizio Cinquecento, provinciale n° Lxiiij fr. Sebastianus Angeli de Perusia (1510-15).
(viii) f. 12v: Quantitas contributionis que singulos conventus contingit hec est. In primis:
<Quantitas contributionis singulorum conventuum>
1) < * * >um Sancte Anne de Sardinia florenos decem[85]
2) Conventum Sareçanensem florenos tres3) Conventum Pisanum florenos quindecim4) Conventum Lucanum florenos novem5) Conventum Pistoriensem florenos sex6) Conventum Pratensem florenos sex7) Conventum Florentinum florenos viginti8) Conventum Sancti Miniatis florenos tres9) Conventum Sancti Geminiani florenos tres10) Conventum Senensem florenos quindecim11) Conventum Aretinum florenos septem12) Conventum Castellanum florenos quatuor13) Conventum Cortoniensem florenos quatuor14) Conventum Perusinum florenos quindecim15) Conventum Eugubinum florenos octo16) Conventum Tudertinum florenos octo17) Conventum Narniensem florenos sex
18) Conventum Mevenatem florenos quatuor19) Conventum Fulginatem florenos quatuor20) Conventum Spoletanum florenos septem21) Conventum Reatinum florenos septem22) Conventum Urbevetanum florenos undecim23) Conventum Viterbiensem florenos undecim
24) Conventum Sancte Marie super Minervam florenos quindecim
25) Conventum Sancte Sabine florenos quatuor26) Conventum Ananinum florenos quinque27) Conventum Tyburtinum florenos tres28) Conventum Terracenensem florenos quatuor
Un'unica mano, regolatissima libraria primotrecentesca, verga l'intera lista Quantitas contributionis (a chiusa del quinione ff. 3-12) e le tabule al primitivo nucleo del codice ovvero ai Privilegia ordinis. I conventi di Quantitas contributionis (in senso geografico nord-sud) includono San Miniato (1329-30), San Gimignano (1329-31), Terracina (1318), le più recenti istituzioni. Originariamente anche <Convent>um Sancte Anne de Sardinia, primo della lista successivamente in parte eraso e barrato. Cagliari, convento formale 1310, passa tra 1333 e 1338 alla provinciad'Aragona, a seguito dell'annessione dell'isola al regno aragonese, come stabilito sopra a proposito della lista conventuale di f. 4r ignorato dalla susseguente nuova contribuzione del provinciale Piero degli Strozzi. Non compare Priverno (1343). Quantitas contributionis fotografa la geografia conventuale della provincia Romana del 1330-35, insieme con la capacità contributiva dei singoli conventi redatta anteriormente, benché di poco, alla lista conventuale di f. 4r che ignora il convento sardo.
Fiorini 217 il gettito totale previsto per le casse provincializie. I contribuenti più ricchi: Firenze 20 fiorini, Pisa Siena Perugia Ninerva 15, Orvieto Viterbo 11,Lucca 9 ecc. I territori conventuali suddivisi in tre
collettorie facenti capo rispettivamente alla Minerva di Roma, Perugia e Firenze contributo da devolvere in due soluzioni annuali, Natale e Pasqua (MOPH XX, 318/12-19: 1339; 329-30: 1340; 348/19-25: 1343). A continuazione del rigo rubricale Quantitas contributionis, ma oltre l'area scrittoria verso il margine destro, si legge flor(eni) ccvi (ccvii?). Son venuti meno nel frattempo i 10 di Cagliari? Lo aggiunge altra mano (confronta i nessi di flor. e la s finale), libraria trecentesca anch'essa. La medesima che sul margine sinistro apre in colonna una tassazione ridotta, Quantitas nove contributionis quam diminuit magister Petrus.flor(eni) clxvi, con notazione numerale rispondente al convento della lista preesistente. Sorvola il primo - il cagliaritano passato nel frattempo all'Aragona - e iniziaritassando il secondo, Sarzana ij, poi Pisa xij, ecc. La registrazione della nuova tassa sul nostro codice suppone il magistero in teologia del fiorentino Piero degli Strozzi(magister Petrus), conseguito in Parigi febbraio-marzo 1342 (PIANA 50. MOPH XXII, 140 n. 4); a favore dunque dei tempi del suo secondo provincialato 1345-56. Ma a rigore non si può escludere che la disposizione amministrativa, adottata sullo scorcio del primo provincialato di Piero 1333-38, fosse stata riportata con qualche ritardo sul Liber privilegiorum; ignora anch'essa infatti il convento Priverno (1343).
■ Per gli estremi del secondo provincialato ignora MASETTI, Monumenta I, 330, e vedi Necr. I, 505-11 SOPMÆ IV, 239. Volterra 2.V.1356, Filippo Belforti vesc. di Volterra: «patri fr. Petro de Strocis de Florentia, sacre theologie magistro ac in Romana provincia fratrum ordinis Predicatorum priori provinciali, amicho karissimo» lo sollecita ad appoggiare presso Simone <da Langres> maestro dell'ordine domenicano la richiesta d'assegnare un religoso in socio a fr. Paolo <dei Bilenci> da FirenzeOP vesc. calcedonense, coadiutore di Volterra consegni la lettera per Simone «fratribus vestris euntibus ad capitulum generale traddatis et imponatis
eisdem ut sollicitudine debita eas assignent et responsivam procurent cum obtentu gratie supradicte» (Volterra, Bibl. Guarnacci ms 5832 (LII.6.6), Registrumomnium literarum dni Philippi de Belfortibus episcopi vulterrani, ff. 95v-96r).
(ix) ff. 13r-20r (I), 25r-30v (II): Tavole ai Privilegia ordinis. Tavola I inizia su f. 13r, primo dell'attuale 3° fascicolo tavola II inizia su f. 25r, primo del 4° fascicolo. A fine del singolo lapidario regesto, si annota Bullat(um) Pisis Perusii ecc., oppure magister ordinis, procurator: convento o ufficiale che serba esemplare della lettera pontificia; autentico o autenticato, «sive sint cum bulla papali seu alias in autentica forma» stando alle minuziose istruzioni sui privilegia dettate ai priori dal capitolo 1343 (MOPH XX, 343/11-24), e come riscontriamo nei testimoni diplomatici.
Esempi. «Quod episcopi lucanus senensis perusinus et reatinus sunt conservatores privilegiorum nostrorum quo ad fratres Romane provincie. Bullatum Senis et Luce. Benedictus. Clxxvj» (f. 19v), relativo testo f. 87r-v. Un esemplare della bolla (proveniente da convento OP) ASV, Fondo Domenicani n° 135 (Bened. XI, Laterano 10.III.1304) «venerabilibus fratribus lucano senensi perusino et reatino episcopis salutem. Super egenum nuper intendentes…». Cf. ASF, SMN 16.IV.1311: «Frater Rogerius miseratione divina senensis episcopuset iudex delegatus ac conservator a sede apostolica deputatus fratribus OP in Romana provincia privilegiorum et immunitatum… (a testimonianza alla fine incorpora la bolla Super egenum di Bened. XI, 10.III.1304)… Datum Senis in aula episcopali anno Domini 1311, indict. IX, die 16 aprelis». Anche Arch. di Stato di Rieti, Raccolte e miscell., S. Domenico n° 9 (Siena 10.VI.1306) incorpora Bened. XI, 10.III.1304.ASV, Fondo Domenicani n° 143 (Orvieto, cap. provinciale1344): «Universis presentes licteras inspecturis
notifico ego fr. Andreas de Gallo, fratrum OP in Romana provincia prior provincialis indignus, me recepisse licteras in<* *>lusi tenoris munitas sigillopendenti reverendi patris fratris Petri magistri ordinis nostri, quarum tenor talis est» maestro Pietro de Baume-les-Dames a sua volta, dal cap. gen. Le Puy-en-Velay 23.V.1344, attesta autenticità e notifica ai frati lettera di Clemente VI, Avignone 6.II.1344. «In quorum omnium premissorum et robur testimonium atque fidem, sigillum nostrum in pendenti duximus apponendum. Datum in Urbeveteri in nostro provinciali capitulo anno quo supra».Numerazione seriale delle bolle raccorda tavole con
testo guida alla consultazione e al rapido reperimento di quanto compendiato nel regesto.
(x) ff. 35r-104v: Privilegia ordinis. Silloge dei diplomi papali concernenti l'ordine dei Predicatori e relativi privilegi, con speciale interesse all'area amministrativa della provincia Romana, specie per i monasteri affidati alla cura della provincia. Mani molteplici al lavoro di trascrizione, tutte in minuscola documentaria di primo Trecento.
Lettere secondo ordine cronologico di papato (con qualche irregolarità, ff. 74v ss) a partire da Onorio III (1216-27). Includono Benedetto XI (1303-04) e l'incipiente papato di Clemente V, Lione 11.I.1306 (f. 80r-v); CelestinoV divide la provincia Romana creando quella del Regno, 1.IX.1294 (ff. 88r-89r); ancora Clem. V, dalla sola data topica Lugduni (1306), sono quelle rubricate 189-191 (ff. 92r-93r). Mentre l'ultima di questo blocco originario n° 192 Clemens episcopus dilecto filio Armengaudo militi (f. 93r-v) e ultima censita dalla tabula (f. 30v: Responsio data petenti consilium), va identificata Clem. IV da Perugia 19.IV.1266 (bolle di questo papa in ff. 63v-70r). Dopo stacco di mezzorigo a fine lettera ad Armengaudo (= Ermengaudus Leuterii Castrensis (Castres, Tarn) OP, † 1286: MOPH XXIV, 292a: 1271-
86), la stessa mano aggiunge: «Ambo isti scilicet pater et filius ordinem nostrum intraverunt et professi sunt, et filius vivebat adhuc anno Domini M°c°c°c°v° in augusto» (f.93v). E qui, su f. 93v ultimo di fascicolo 10°, si arresta il primitivo blocco di lettere pontificie ff. 35r-93v. Limite documentario della compilazione coincidente col trasferimento della sede papale ad Avignone. La mezza cartarimasta bianca sarà tardivamente utilizzata da altra mano per una inserzione volante, Bened. XII, Avignone 12.VII.1335.
Attuale ultimo fascicolo, quinione ff. 94-105, fisicamente alquanto difforme dai precedenti. I ff. 98r-103r tramandano in regolare minuscola trecentesca un bloccoomogeneo di regesti pontifici relativi al monastero romano San Sisto; anch'essi privilegia, nel lessico del tempo:
«et quia sic aprobatus fuit de mangna honestate et sincerissima vita, venerabilis pater magister et prior provincialis nostre provincie voluerunt ipsum <scil. fr.Hugolinum de Aviriano seu de Arce † 1344> habere curam super monasteria nostra in quantum se extendunt privilegia ordinis ad spiritualia, scilicet ipsas informandas et corrigendas ut sibi videretur expediens esse» (Cr Ov 86, ed. 120-21). Poco dopo «Fuit etiam prior in Tibure, Cortone et Ananie»: Corneto di ed. 121,anziché Cortone, crea un convento inesistente.Fino a Benedetto XI (15.XII.1303): ed. VL.J. KOUDELKA,
Le «Monasterium Tempuli» et la fondation dominicaine de San Sisto, AFP31 (1961) 72-81. Materiale, c'è da credere, non facente parte della primitiva silloge pontificia del codice: per ladifformità fisica del quinione, non del tutto rimossa dallarifilatura; perché né prima né seconda tavola ne censisconoil contenuto; perché, dettato da differenti criteri documentaristici, non riproduce le lettere papali ma ne redige sostanzioso regesto del dispositivo legale. Quinionesopravvenuto però di buonora. Potrebbe avere a monte la compilazione di Benedetto da Montefiascone degli anni 1315-18 (KOUDELKA, Le «Monasterium Tempuli»… 42-43). Una copia del lavoro di fra Benedetto appesa successivamente al
prontuario dei provinciali quale appendice documentaria delmonastero romano? Le carte eccedenti rimaste bianche furonoriempite da mani di poco posteriori con lettere dei papi Innocenzo VI (1358), Giovanni XXII (1317, 1325), Urbano V (1367), da metà f. 103r a f. 104v chiuse in f. 105v dalle note memoriali 1380 di Giovanni dei Maiensi.
E ricordiamo altre inserzioni estemporanee che sfruttanopagine di transizione:
a) ff. 20v-21r (Martino V, Firenze 19.II.1420), mano quattrocentesca;
b) ff. 21v-22r (Martino V, Roma 9.IV.1426), mano cinquecentesca;
c) ff. 31r-32r (Bened. XII, Avignone 17.VI.1335) della stessa mano trecentesca che avvia la Cronicha magistrorum ordinis ff. 6v-7r;
d) un'unica mano tardo-trecentesca trascrive f. 93v (Bened. XII, Avignone 12.VII.1335), ff. 94r-97v (Clem. VI, Avignone 24.IX.1346), f. 97v (Giov. XXII, Avignone 14.II.1317).
[85] Entrata parzialmente erasa e barrata. Numerazione seriale mia.
3. Vademecum amministrativo dei provinciali
Proviamo ad articolare una bozza di sintesi sul Liber privilegiorum provincie Romane OP: intenti e tempi di confezione, sviluppi, destinatari, uso,abbandono.
a) Secondo/terzo decennio del Trecento: messa in cantiere del libro e realizzazione del suo nucleo originario, i Privilegia, base legale del governo dei provinciali della provincia Romana. Decenni della massima
floridezza della popolazione conventuale; subito dopo, i primi sintomi di crisi, a partire dal 1340 l'avvio del crollo demografico. Sul primitivo corpo legislativo raccolto in sei fascicoli, ff. 35-93, vien elaborata una prima, quindi una seconda e definitiva tavola repertoriale,ciascuna rinchiusa entro un proprio fascicolo, 3° e 4°, ff.13-34. Non molto tempo dopo accede l'attuale ultimo fascicolo ff. 94-105, regesti papali relativi al monastero romano San Sisto; materiale non censito nelle tavole.
b) Intorno a questo corpo di diritto papale, ben presto il libro vien crescendo, per addizione di materiale catalogistico e documentario, in sussidio al governo dei provinciali. Entro gli anni '30, si approntano prospetti delle pubbliche istituzioni: province, conventi della provincia Romana e loro contribuzioni, monasteri sottopostialla giurisdizione dei provinciali, libri di provincia e loro concessionari. Il tutto entro il quinione ff. 3-12 reale primo fascicolo della costruzione fisica del libro, se sorvoliamo il bifolio di guardia. Complemento catalogistico - dobbiamo arguire - previsto dal progettatore del libro, perché una medesima scrittura libraria verga sia la Quantitas contributionis in f. 12v, ultimodel 2° fascicolo, sia le tavole dei Privilegia nei due fascicoli susseguenti; qualunque fosse la tecnica di confezione, ovvero la reale sequenza tra fascicolazione scrittura e rilegatura, che non siamo in grado di raggiungere.
c) In questa fase ed entro il quarto decennio del Trecento il libro ha di fatto raggiunto la sua piena fisionomia, e definito il rapporto struttura-uso. Gl'incrementi successivi sono di sviluppo omogeneo e prevedibile, in gran parte attesi.
In spazi rimasti fortunosamente liberi si sono inserite addizioni sporadiche e annotazioni disorganiche; frastornano il lettore moderno in prima lettura ma non stravolgono l'impianto del libro.
d) Un'assenza significativa. Nessuno spazio, nel manualedei provinciali, riservato alle fraternite dell'ordine della Penitenza aggregate ai domenicani: fratres vel sorores de Penitentia beati Dominici, de ordine seu habitu fratrum Predicatorum. Che pure avevano nel priore provinciale, insieme col maestro generale, l'istanza superiore di giurisdizione (Regula fratrum et sororum ordinis de Penitentia beati Dominici (1285), ed. MEERSSEMAN, Dossier 155 § 57-58). In una fase di vasta diffusione nei territori conventuali dell'Italia mediana. Nella prassi corrente i provinciali delegavano in tutto i priori locali? nominavano propri vicari?
■ Il caso segnalato in Quel che la cronaca conventuale non dice..., MD 18 (1987) 311-12, implica dirette competenzegiurisdizionali, coperte dal priore conventuale. Attuale segnatura del doc.: ASF, Notar. antecos. 3143 (già B 2129), ff. 15v-16v: 24. XII.1319.Tardivamente: «fr. Antonius Nardi de Viterbio magister, fuit factus magister et prior mulierum de tertio habitu et quod eas ad habitum recipere possit…» (AGOP IV.3, f. 52r: 4.VI.1474).Troppo estesa la rete delle fraternite per trovar
accoglienza nel Liber privilegiorum? Un po’ dell'una e po’ dell'altra ragione. Ma in radice il sostrato mobile della configurazione giuridica di tali fraternite entro le compagini ecclesiastiche: frastornante rapidità nel mutare referente istituzionale di "appartenenza e obbedienza", spesso per ricaduta della concitata politica cittadina. Instabilità fisiologica, in parte condivisa anche dai monasteri femminili. Materia instabile e refrattaria alla solidità delle pubbliche istituzioni che ha in vista il vademecum di governo Liber privilegiorum.
e) Priori provinciali nell'arco di formazione del Liber privilegiorum; taluni di loro dovettero esser coinvolti nellaprogettazione, messa in cantiere del libro, e originaria fisionomia rifinita sull'uso.
1319-22 Giovanni Boccanera da Spoleto1322-26 Matteo di Orso degli Orsini da Roma
1326-28 Tramo di messer Corrado dei Monaldeschi da Orvieto1328-30 Giovanni da Poppi (pr. Arezzo), figlio del convento fiorentino (il Casentino superiore, allora, distretto della repubblica fiorentina)1330-32 Giovanni dei Porcari da Roma1333-38 Piero di messer Ubertino degli Strozzi da Firenze (1345-56 secondo provincialato)1338-39 Giovanni dei Porcari da Roma1339-41 Andalò da Ozzano (Bologna), originario della prov. Lombardia inferiore (A. D'Amato, I domenicani a Bologna, Bologna 1989, I, 257-58), nominato vicario dal capitolo generale, poi provinciale eletto1341-42 vicariati ed elezioni contestate, nel corso della grave crisi 1339-44 che investe il vertice del governo provinciale; all'anno 1344 si arrestano gli Attidei capitoli provinciali a noi pervenuti1342-44 Andrea di Vanni del Gallo da Firenze.
f) Natura e ragioni reali dei dissidi al vertice della provincia negli anni 1339-44 restano tuttora in ombra. Protette dalla reticenza della cronica provincialium del Liber privilegiorum e delle consorelle Cr Pg ff. 20r-21r e Cr Ov 42b-43a, ed. 61-63. Restituiamo tuttavia la semantica della forma, entro cui gli atti ufficiali rinchiudono il dissidio; ché testi in circolazione offuscano finanche la superficie giuridica che dettava le regole del gioco: secundum antiquarum constitutionum consuetudinem venerabilem vicarium (?) Andream… imponere provincialem (Necr. I, 65; I, 388). Leggi: «Hic <scil. fr. Iohannes de Pilastris de Florentia, † 1347> existens de numero electorum provincialis in conventu Senarum <nov. 1342> una cum duobus aliis antiquioribus inter electores, secundum antiquarum constitutionum tenorem, venerabilem virum fratrem Andream de Gallo ibidem concorditer electum, in priorem provincialem Romane provincie confirmavit» (Cr SMN n° 321).
Precedenti: provinciale eletto in Perugia 1341, vacante il maestro dell'ordine (tra decesso di Ugo de Vaucemain † 6.VIII.1341 ed elezione di Gerardo de Daumar maggio 1342): «Hic <scil. fr. Ubertinus de domo de Phylippa de Vacchareccia> in discordia in priorem provincialem Romane provincie electus licet a minori parte, per confirmatores tamen [non tantum di ed.] confirmatus, per summum pontificem depositus est» (Cr SMN n° 376; si ricordi che il cronista fiorentino redige la notizia in contemporanea col decesso, luglio 1348). Brano del capitolo generale 1343 riletto nel testimone B (origine fiorentina), con presunzione di precedenza per l'antroponimia dell'area:
«Cum in provincia Romana in capitulo provinciali Perusiicelebrato <1341> fratres Dominicus de Collaçone, Petrus de Tructa [non Fructa] et Andreas de Sancto Antonio, electum in provincialem a minore parte longe confirmaverunt in provincialem et electum a maiori partecassaverunt indebite, et similiter in provincia Aragonie…, predictos sex fratres confirmatores et casssatores dictarum electionum citamus perhemptorie ut ipsi compareant personaliter ad sequens capitulum generale» (AGOP XIV A 1 (xiv, provenienza fiorentina), f. 327v = MOPH IV, 290/1-12).a) Domenico da Collazzone, fl. 1288-1341. MOPH XX, 372b.Collazzone (oggi pr. Perugia) era nel territorio settentrionale della dioc. di Todi (RD Umbria II, 43a), verosimilmente nella predicazione todina. Non compare néin Cr Ov né in Cr Pg.b) Pietro di Giovanni della Trotta da Viterbo, fl. 1292-1343: AFP 65 (1995) 209 n. 129.c) Andrea da Santo Antonio, perugino. Sul suo nome s'interrompe (1345 ca.) Cr Pg f. 60r. MOPH XX, 273/20. Tutt'e tre i casssatores appartengono al territorio politico del Patrimonio.
A fronte di queste, e poch'altre testimonianze contestuali (sufficienti tuttavia a sottrarre il conflitto a mero errore di procedura)[10], possiamo individuare
Constitutiones OP dist. II c. 3, lectio 5-6: dispositivo di procedura dei confirmatores e cassatores in caso d'elezione durante la vacanza del magistero dell'ordine, in uno stadioevolutivo della legislazione domenicana anteriore al 1348, e suoi immediati emendamenti. Do il testo costituzionale invigore nel 1316-17:
Biblioteca Apostolica Vaticana, Borgh. 242 (xiv1), membr., 345 x 253, ff. 107. Silloge di regole religiose;Giovanni papa XXII (1316-34) ha vergato di propria mano note marginali nelle carte finali, relative alla regola OFM. Cf. A. MAIER, Codices Burghesiani Bibliothecae Vaticanae, Città del Vat. (Studi e testi 170) 1952, 290-92. Const. OP ff. 8r-18v: conosce 18 province in II, 4-5 (1303); haemendamento costituzionale 1308 in I, 20 (MOPH IV, 32/3-6), 1316 in II, 5 (MOPH IV, 87/20-26); non ha emendamenti successivi.Annoto soltanto l'addizione confermata dal capitolo
generale 1328: «Quod si magister ordinis sive capitulum generale aliquem fratrem illius provincie vicarium instituerit in eadem, volumus ipsum vicarium in predicta electione vocem habere» (MOPH IV, 177/23-27); disposizioni sugli aventi diritto al voto attivo, che precedono immediatamente quelle qui di seguito riportate.
Constitutiones OP, dist. II c. 3, De electione prioris provincialis, BAV, Borgh. 242, f. 13va-b:
§ 5. Tres autem priores conventuales qui primitus habitum nostri ordinis susceperunt, disquirant et requirant vota fratrum. Unus autem de illis duobus electoribus illo anno in socium prioris conventualis ad provinciale capitulum eligatur, si tunc fuerit celebrandum. Quod si electores vel eorum alterum impediri contigerit ante quam iter ad eundum ad electionem arripuerint, conventus alium vel alios possiteligere loco ipsorum qui fuerunt impediti. Idem dicimus de socio prioris conventualis euntis ad capitulum provinciale electo.
§ 6. Statuimus ut prior provincialis in capitulo generali a magistro et diffinitoribus premissa diligentiexaminatione confirmetur vel amoveatur. Poterit nichilominus eum magister ordinis confirmare vel amovere. Quod si ordo magistrum non habuerit, tres de ipsis electoribus aliis ab electo, qui primitus habitum nostri ordinis susceperunt, ipsum confirmandi et conpellendi ad officium habeant potestatem. Quod si non concordaverint, duorum sententia prevalebit.Si vero electum non confirmaverint, ab eisdem electoribus ad electionem iterum procedatur, et ad tres antiquiores secundum formam predictam confirmatio pertinebit. Si autem magistrum ordinis mori vel amoveri contigerit ante quam electio ad ipsum pervenerit vel quam electum confirmet, in hoc casu tantum ad vicarium ordinis confirmatio pertinebit. Si vero post confirmationem, ante quam ad electum confirmatio ipsa pervenerit, magistrum mori vel amoveri contigerit, nichilominus confirmatio suum sortiatur effectum.■ Il brano «Si autem magistrum ordinis mori vel amoveri… nichilominus confirmatio suum sortiatur effectum» è addizione costituzionale 1303: MOPH III, 320/1-8.Il capitolo generale 1343 prima, poi efficacemente
quello del 1346 aveva avviato l'iter d'un emendamento costituzionale, definitivamente confermato nel 1348. Stantela vacanza della suprema magistratura dell'ordine, il provinciale eletto vien confermato non più da membri del collegio elettivo (normativa del 1258, MOPH III, 90/8-16) - conferma risultata paludosa nell'area[15], macchinosa nel percorso - ma da un'istanza esterna, dal vicario dell'ordine.
Iter costituzionale: MOPH IV, 285/17-24 (1343 incoatio),293/23-29 (1344 approbatio); nessun cap. gen. nel 1345 a motivo del decesso di maestro Pietro de Baume-les-Dames;307/6-8 (1346 incoatio), 313/2-4 (1347 approbatio), 322/7-10 (1348, «et hec habet tria capitula»). Un esemplare caso d'esercizio costituzionale dell'ordine, con riscontro esterno e in risposta a dissidi in corso aivertici amministrativi delle province.
Il corpo centrale di § 6, sopra in corsivo, risultò così semplificato: «(…). Poterit nichilominus eum magister ordinis confirmare vel amovere. Quod si ordo magistrum non habuerit, ad vicarium ordinis confirmacio pertinebit. Si vero post confirmationem…». Sull'esemplare di costituzioni in vigore intorno al 1333, Siena Bibl. comunale F.VI.3, ff.127r-162r (xiv med), l'aggiornamento non s'è accontentato d'espungere o di chiudere tra va-cat il brano abrogato dal capitolo 1348 ma l'ha efficacemente eraso, ed integrato al margine il sostitutivo ad vicarium ordinis confirmatio pertinebit (f.145r).
■ Leggibile in edizioni che fotografano le costituzionidegli anni 1358-63: G.R. GALBRAITH, The constitution of thedominican order, 1216 to 1360, Manchester 1925, 231; W. HOOD, Fra Angelico at San Marco, New Haven - London 1993, 285a; pp. 279-90 riproducono BNF, Conv. soppr. J.IX.24, ff. 153-207v (non Conv. soppr. J.IX.8: p. 322 n. 1); «Whatever the exact date of the manuscript, the text isclose to that used by Fra Angelico <† 1455> and his brethren… in the mid-fifteenth century», p. 279 senza motivare. No di certo. Il testo di II, 4-5 conosce 18 province (post 1303), ignora Trinacria 1378 e Dalmatia 1380-88; II, 7 non ha addizione costituzionale 1363 (MOPH IV, 398/10-18), né II, 17 del 1374 (MOPH IV, 426-27); assente II, 18 (1402); mentre II, 3 reca addizione 1357 ed emendamento 1358 (MOPH IV, 375/30-36, 382/11-18). Conv. soppr. J.IX.24 tramanda costituzioni in vigore negli anni 1358-63; anteriori d'un quindicennio a quelle di BAV, Vat. lat. 7658, ff.139r-184v (1375 ca.). La datazione d'un ms non data leopere da esso trasmesse!«Secundum antiquarum constitutionum tenorem», diceva il
cronista fiorentino nella biografia di Giovanni dei Pilastri, deceduto tra settembre 1347 e aprile 1348. Tra cadenze temporali sorprendentemente raccorciate. Perché qualsiasi costituzione, foss'anche di "ier l'altro", era antiqua constitutio a petto di quella "ora" vigente.
Contrariamente alle nostre assuefazioni lessicali e bibliografiche.
g) Nella cancelleria provinciale prestano servizio fratiesperti in diritto, ars dictaminis, copia professionale. Francesco di Bernadino da Orvieto, in religione dal 1287, deceduto il 12.VI.1329: «Hic quia fuit dotatus bonitatibus et gratiis pluribus, extitit in romana curia sotius procuratoris nostri ordinis longo tempore necnon cum prioreprovinciali nostre provincie ex eo quod in sua scriptura etdictamine gratus illis erat».
■ Cr Ov 73; in ed. 106 leggi Franciscus Bernadini non Bernardini; ricompare Berradini in assimilazione progressiva caratteristica dell'area (G. ROHLFS, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti. Fonetica, Torino 1966, 340): Bolsena 4.I.1318, «fr. Franciscus Berradini de Urbeveteri, fr. Iohannes Matthei <Caccia> de Urbeveteri» OP (ed. G. SANSEDONI, Vita del beato Ambrosio Sansedoni da Siena, Roma 1611, 230), sebbene a monte potesse avere il formalizzato Bernardinus (M. ROSSI CAPONERI - L. RICCETTI, Chiese e conventi degli ordini mendicanti in Umbria nei sec. XIII-XIV. Archivi di Orvieto, Perugia 1987, 77: 9.XII.1294).Bonfantino di Pazzo dei Bonfantini da Firenze, in
religione dal 1288, † marzo 1338: «Fuit etiam bonus dictator et scriptor, propter quod et multorum provincialium sotius extitit, literarum conventus compositor et scriptor» (Cr SMN n° 280). Lotto di messer Ottavante dei Rigaletti da Firenze, in religione dal 1310, † 6.VI.1348: «Hic Bononie de studio iuris civilis receptus ad ordinem. Aliquandiu fuit de sotietate fratrum peregrinantium inter gentes; tandem reversus Florentiam, cum esset pulcer dictator et scriptor, plurium provincialium sotius factus est» (Cr SMN n° 348, dove in ed. correggi anche consumatis in ordine annis xxxviij, non XXXVII).Lo ritroviamo, fra Lotto, collettore delle contribuzioni conventuali alle casse provinciali (MOPH XX, 318/19: 1339; 330/4-5: 1340).
[10] MOPH XX, 330/10-26 (1341), 338/19-24 (1341), 340-41 (1342), 341/12-30 (1342 con riferimento a CP 1341), 342-43 (1342); IV, 283/25-32 (1342), 304/3-16 (1344).[15] Non necessariamente perché dal basso, visto che aveva retto perben novant'anni, piuttosto perché nel Trecento inoltrato i processiselettivi del ceto dirigente sembrano turbati da pressioni esterne, consortili o signorili, sia laiche che ecclesiastiche.
h) A cavallo dei decenni 1360 e '70 si avviano nel nostro Liber privilegiorum concise cronache dei maestri dell'ordine ff. 6v-8r e dei provinciali romani ff. 11r-12r,10r. Tutto dentro il 2° fascicolo. Materiale cronachistico,al pari di quello conventuale, per natura aperto agl'incrementi. Si utilizzano carte lasciate bianche per gli sviluppi a venire. Risultate tuttavia insufficienti, cosicché talune integrazioni posteriori o retrocedono o saltano carte in cerca di spazio disponibile, spezzando la sequenza topo-cronografica della crescita.
i) Materiale catalogistico. Ma non neutro. Sottoposto a scrutinio paleografico e a riscontro esterno può svelare sedimenti grafici di storie civili e ecclesiastiche d'ampiaportata. Conflitti giurisdizionali e interferenze padronalinel corso delle istallazioni di conventi e monasteri, in intreccio di competizione multipla; capovolgimenti amministrativi di ricaduta dall'egemonia politica o dalla pressione diplomatica; reciproche contestazioni di legittimità, alla deriva d'una respublica christiana in dissoluzione. Elia Raymond, per la nostra Cronicha magistrorum ordinis f. 7v, maestro dell'ordine dal 1367 al 1380. Lo stile cronografico proclama lo schieramento in attocon la geopolitica d'obbedienza romana; per la quale il governo avignonese d'Elia 1380-89 non è mai esistito. Negliinterstizi della neutralità catalogistica risuonano apostrofi di antimagister e antiprovincialis. «Fr. Thomas de Firmo.. conservavit ordinem in libertate sua, licet multam
habuerit repugnantiam» (f. 7v). Incompromessa superficie della lettera, che non dissimula del tutto l'aggravante delterzo papato, d'elezione pisana 1409, col quale si ritrova Tommaso; dissidenti i riformati veneti, sull'autorità postuma di maestro Raimondo da Capua († 1399): «Hic ordinavit quod in qualibet provincia esset unus conventus in quo possent morari fratres volentes servare regulam et constitutiones ordinis nostri» (f. 7v). Dove la discrezionesul primo quindicennio del Quattrocento rasenta copertura, se non è pudore dello smarrimento: indefinito provincialatodi Federico Frezzi da comporre con gli esiti reali della nomina episcopale; Bartolomeo degli Acerbi che fa sapere agli amici riformati «qualiter provincialis romanus vult tenere provincialatum usque ad consecrationem suam» (TOMMASO D'ANTONIO DA SIENA OP, Tractatus de ordine fratrum et sororum de Paenitentia sancti Dominici (1402-07), ed. M.H. Laurentet F. Valli, Firenze 1938, 83, lettera Roma 10.II.1404); susseguente elezione dello stesso Acerbi giugno 1404, confidenzialmente data per certa due mesi prima dal riformatore fiorentino Giovanni di Domenico (M.-T. CASELLA - G. POZZI, B. Giovanni Dominici OP. Lettere spirituali, Friburgo 1969, 177 «e debesi elegere il nostro frate reverendo padredegli A<cerbi>»; TOMMASO D'ANTONIO DA SIENA, Tractatus…, ed.cit., 87: «noveritis, sine fallo, fratrem Bartholomeum, vicarium Ytalie, nostre Romane provincie priorem futurum…» (lettera Firenze 27.IV.1404); nomina papale (luglio 1409), non elezione, d'un secondo provinciale Leonardo dei Dati, concorrente per alcuni anni con l'Acerbi.
j) Tra fine Quattro e primo Cinquecento si ritaglia spazio per una nuova rubrica, il catalogo dei cardinali dell'ordine ff. 8v-9v. Più frutto del gusto di complemento catalogistico che risposta a reali esigenze dei provinciali. Per costoro il libro aveva digià esaurito i propri servizi.
k) Progettato come sussidiario legale e amministrativo dei provinciali (soci e vicari), con loro viaggia, formato tascabile. Un vero vademecum dei provinciali romani. Che vi
lasciano fitte attestazioni autografe, a testimoniare l'usocontinuato del libro lungo due secoli interi. Ultima in assoluto quella di Sebastiano d'Angelo da Perugia, in carica 1510-15. Durante qualche sosta nei conventi, intermedia alla peregrinanza dei provinciali, il libro raccoglie materiale disorganico ed estraneo ai suoi scopi: le note viterbesi di Giovanni dei Maiensi (1380) e relativechiose di Giovanni Nanni (ultimo decennio del '400). Disorganico anche in rapporto all'incipiente storiografia conventuale, che ha appreso a metter su in proprio la cronica fratrum, libro rigorosamente costruito e vero raccoglitore della memoria conventuale.
l) In verità non tutti i rami del ricco prontuario restano vivi fino all'abbandono definitivo del libro. Come continuare ad aggiornare l'enorme e crescente corpo delle bolle papali senza far esplodere fisicamente uno strumento leggero e portatile? La lista delle contribuzioni, destinate a rapidi aggiornamenti, non trova séguito sulle carte del libro (MASETTI, Monumenta I, 326 leggeva «in antiquo Codice Contributionum Provinciae» dell'archivio conventuale di Perugia; cf. ASPg, CRS, S. Domenico, Miscell. 62-64, solo appunto da catalogo archivistico). Perfino l'essenziale lista dei conventi cessa d'esser metodicamenteaggiornata nel secondo Quattrocento (le controverse giurisdizioni degl'insediamenti riformati sfidano la versatilità dello strumento?).
Quella dei monasteri "sub cura provincialium" si estingue ancor prima, non varca il 1400; benché anch'essi talvolta debitori di tributi antichi, tenacemente inseguitidalla contabilità provinciale.
■ ASF, SMN 31.V.1298: «priora monasterii et conventusde Ripolis comitatus Florentie,… capitulum totum et universitas dicti monasterii,… constituerunt… procuratores… ad petendum et recipiendum… a fr. Nicolao de Prato priore provinciali fratrum Predicatorum Romane provincie, executore testamenti… bone memorie patris dni Ugonis <de Billiomo OP †
28.XII.1297> ostiensis episcopi cardinalis,… 300 florenos auri quos… dns Ugo prefatus legavit seu ordinavit quod, secundum consilium prioris provincialis dicti ordinis Romane provincie supradicte, de bonis suis darentur alicui monasterio dicti ordinis…, quod monasterium ad dandum annuatim capitulo provinciali dicte provincie 12 florenos auri se perpetuo obligaret… Actum in ecclesia dicti monasterii de Ripolis…». Soluzione di 300 fiorini fatta da «fratre Ugone de Losanna penitentiario dominipape», Roma 31.V.1298 (ib., seconda pergamena).ASF, CRS, S. Iacopo a Ripoli 3 n° 137 (25.IX.1330; in Firenze in occasione del CP dell'anno?): «Noverint universi presentes licteras inspecturi quod ego fr. Guillelmus, prior fratrum OP de Perusio, fateor et assero me recepisse viii florenos auri de summa xii florenorum quos monasterium sororum de Ripolis tenebatur dare capitulo provinciali Perusii celebrato <1328> pro anima domini Ugonis cardinalis, et dico michi esse solutum ex integro, remictens eis residuum propter devastationem rerum et incomoda que passa suntillis diebus, de assensu fr. Iannocti prioris urbevetani, tunc vicarii provincie; nec volo quod ab alio possint de cetero molestari. In cuius testimoniumsigillum mei prioratus duxi presentibus apponendum. Anno Domini M°ccc°xxx° die xxva septembris». Sul retrotraccia sbiadita del sigillo. Giannotto da Orvieto, priore nella città natale, diventato vicario di provincia ope legis (cf. Constit. OP II, 4; II, 7) al decesso del provinciale Giovanni da Poppi († Perugia 23.I.1330: Cr SMN n° 258) fino ad elezione del nuovo provinciale.ORLANDI, Necr. II, 437-38: (Firenze 15.X.1354) «Io frate Ghisello da Santo Miniato del’ordine de’ frati P(re)dichatori, sindico e prugolatore [= procurator!] de convento di Santo Iacopo Apostolo di Santo Miniato,sì dico e confesso e scrivo di mano mia ch’io abbo
auto e ricieuto in mia mano dalle monache de· monestero di Santo Iacopo da Ripoli, dentro alle mura di Fiorença abitano, fiorini d’oro dusciento sesanta p(er) lo convento de’ frati P(re)dichatori di Santo Miniato, e detti cclx fiorini aveano auti le dette monache dalla provincia Romana, ed era obbrigato lo detto monestero di dare alla provincia ongni anno xij fiorini d’oro p(er) una pietanza a’ chapitolo provinciale. E io fr(ate) Ghisello, sì chome sindico eprugolatore dee detto convento, auti li detti fiorini d’oro, obbrico lo detto convento alla detta provincia e chapitolo di dare e pagare ongni anno dodici fiorinid’oro. E detti fiorini d’oro io ricevi e ebbi dentro da detto monestero di mano di suora Andrea delli Ardingheli priora, presente le monache…»; leggo riproduzione fotografica del doc. in Necr. I, 528bis, Tav. XXII. Ghisello da San Miniato, converso?: MOPH XX, 276/5 (1332); MD 18 (1987) 232 n. 7, 300b n° 63 (Firenze 1333 tra i procuratori eletti).Un'inserzione sporadica utilizza sì ff. 20v-21r,
intermedi alle due tabule, per Copia privilegii monialium Sancti Petri Martiris de Florentia (Martino V, Firenze 19.II.1420); ma nessuno inserisce il nuovo titolo San Pietro Martire (1418-20) nella lista dei monasteri f. 5r, che pure dispone d'ampi spazi bianchi nell'area destra della pagina.
■ ASV, Reg. Later. 203, ff. 201v-203r (Martino V, Mantova 18.XII.1418); Reg. Suppl. 139, ff. 282v-283r (Martino V, Firenze 19.II.1420). Necr. II, 151-52. ASF,Archivio del catasto 603, ff. 54v-57v: Munistero di Santo PieroMartiro (sic) di Firenze dentro alla porta di San Piero Ghattolino (1427-29).E nessuno depenna quello perugino San Giorgio, non più
sotto la cura provinciale dal 1419-20, come ben sapevano frati eminenti, fequentatori del nostro libro.
ASV, Reg. Suppl. 136, ff. 87r-88v: Martino V, Firenze 22.XII.1419, accoglie la supplica della priora e
monache «monasterii Sancti Georgii prope Perusium ordinis sancti Augustini, sub regula et secundum instituta OP viventium», d'unirsi a quello benedettinoSan Tommaso Apostolo e vivere «sub regula et professione beati Benedicti».ASPg, Corporaz. relig. soppr., S. Domenico, Miscell. 5, f. 27r (tra maggio e luglio 1420 nella successione delle ricordanze): «Conventus Sancti Dominici de Perusio fecit syndicum et procuratorem me fr. Bartholomeum de Acerbis de Perusio ad compromittentum in dominum Matheum Feliciani doctorem utriusque iuris de omni lite et contraversia (sic) vertente inter conventum perusinum ex una parte, et monasterium Sancti Thome Apostoli et monasterium Sancti Georgii de prope Perusium ex alia parte, occasione cuiusdam unionis facte inter monasterium Sancti Thome Apostoli et monasterium Sancti Georgii». Atto di quietanza e di fine lite, ib. f. 29v bis (7.II.1421).Saturazione fisica del codice, specie del fascicolo
destinato al materiale catalogistico; indipendenti sillogi dei privilegia ordinis (origine del Bullarium: cf. D. PLANZER, DeCodice Ruthenensi miscellaneo in Tabulario Ordinis Praedicatorum asservato, AFP 5 (1935) 99-123; Die Tabula privilegiorum ordinis fratrum Praedicatorum…, AFP 10 (1940) 222-57), presto a stampa; moltiplicazione e specializzazione dei libri amministrativi (ricordanze, libri delle contribuzioni ecc.): mettono fuori corso il Liber privilegiorum provincie Romane.
m) Uscito dall'uso, il Liber privilegiorum rimane nell'archivio conventuale di San Domenico di Perugia. Lì verosimilmente depositato dal suo ultimo utilizzatore, il provinciale Sebastiano d'Angelo da Perugia:
«lxiiij. frater Sebastianus Angeli de Perusia, sacre theologie profexor, fuit ab omnibus unanimiter electus in provintialem Romane provintie anno Domini M°ccccc°x° in capitulo provintiali Cortonii celebrato in festo sancto Pentecosten xviiij mai, et per rev.mum generalem
magistrum Tomam de Vio de Cayeta Rome confirmatus die < . . >» (f. 10r). = 31.V.1510 (MOPH XVII, 153 § 205), qui spazio in biancoAl pari del suo registro provincializio (1510-15), oggi
ASPg, Corporaz. relig. soppr., S. Domenico, Miscell. 140 ins. 6. E in Perugia Timoteo di Nicolò Bottoni († 1591), Reginaldo Boarini (1781), Pio Tommaso Masetti (1864), leggevano il Liber privilegiorum (AFP 65 (1995) 190, 193). Passato all'Archivio di Stato cittadino in occasione delle soppressioni ottocentesche.
n) Chiosa lessicale. "Cronica provincie, provincialium…"insinua alle nostre assuefazioni semantiche prodotti letterari fortemente strutturati, costruiti intorno a nuclei biografici, dilatati a persone e istituzioni sussidiarie in rapporto satellitare, dentro il modello prosopografico. Esemplare la Cronica ordinis, scandita sulla periodizzazione dei maestri dell'ordine, e diffusa alla lettura corrente perché appesa ai testi normativi. Al contrario, il nostro Liber privilegiorum ci dice inequivocamente, in sintonia con Cr Pg e Cr Ov, che era cronica anche una nuda lista nominale, nulla più che un catalogo dei provinciali. Guida semantica da rammentare, quando volessimo o rappresentarci le cronache perdute o individuare le smarrite; se non addirittura riconoscere quelle da tempo sotto i nostri occhi.
Cronice provincie o provincialium non pervenute. O non individuate. Fra Ugo dei Borgognoni da Lucca († 1322) «composuit provincie cronicam», attesta Simone da Cascina 1402 (AFP 12 (1942) 203; SOPMÆ II, 253 IV, 122). Riferisce il cronista pisano (1390-1403): «Quod in cronica provincialium Romane provincie, que inter secreta scripta provincie reservatur, sic me legisse recordor: fr. Synibaldus de Alma <fl. 1253-81> qui numquam silentium, postquam fuit in ordine, fregit…» (Cr Ps f. 8v, n° 38). Cr Pg f. 61r, sezione cinquecentesca: «Hunc et septem alios sequentes repperi in quodam libro provincie Romanae»; f. 63r: «Magister Leonardus de Mansuetis de Perusia… non modo Romanam provinciam gloriose rexit, existens in ea
provincialis prior <1443-50>, ut ex chronicis patet huius provinciae, sed ex sua eximia scientia et virtutibus magister sacri palatii fuit…».
■ Più posato studio meriterebbe la silloge provincializia trasmessa da Roma, Bibl. Vallicelliana F.28 (xiii-xiv), membr., 195 x 135, ff. 185, in specieff. 179-185: d'una sola mano corsiva documentaria di medio Trecento, diversa dalla restante libraria del ms; "Cronica romana" è titolo convenzionale proposto da H.Ch. Scheeben (Accessiones ad historiam Romanae provinciae saeculo XIII, AFP 4 (1934) 99-143, testo 102-23).
4. Il fondo libri di provincia
A) Libri di provincia e loro assegnatari, f. 6r
Isti sunt libri quorum proprietas spectat ad Romanam provinciam.
1. Primam partem secunde sancti Thome, et primum secundum et tertium eiusdem in uno volumine, habent ad usumfratres Petrus et Iacobus Pratenses.
2. Item Contra gentiles in uno volumine habet ad usum fr. Accursus Casciani de Luca.
3. Item unum volumen sermonum quadragesimalium habet ad usum fr. Iacobus Nalli Urbevetanus.
4. Item unum volumen sermonum gallicorum habet ad usum fr. Carus Florentinus.
5. Item primam secunde et tertium sancti Thome habet ad usum fr. Ricculdus Florentinus.
6. Item librum Sententiarum habet ad usum fr. Nicolaus Romanus de Sancto Angelo.
7. Item aliud volumen Sententiarum habet ad usum fr. Stephanus de Sezia.
8. Item quasdam questiones super libros naturales habet fr. Iacobus de Fusignano.
9. Item quasdam questiones super Sententias habet fr. Petrus Ardengi.
10. Item quartum sancti Thome habet fr. Angelus de Tibure.
11. Item aliud volumen Sententiarum habet fr. LaurentiusViterbiensis.
12. Item comentum Averoys super librum Phisicorum habet fr. Ptolomeus Lucanus.
13. Item librum de ortu scientiarum et tertium super Sententias in uno volumine habet fr. Franciscus Viterbiensis.
14. Item originalia quorundam sanctorum habet fr. Franciscus Viterbiensis.
■ Numerazione seriale mia (ad essa rinviano qui di seguito le note identificative). Precedenti trascrizioni: MASETTI, Monumenta I, 140-41. Cronica di Santa Caterina in Pisa..., MD 27 (1996) 227-32.n° 1. Piero da Prato OP: MOPH XX, 102/3, 122/1, 155/20(1291-1305); IV, 104/7-10 (1317). Iacopo da Prato OP: MOPH XX, 155/20, 178/9, 182/6, 188/20 (1305-13). Per ifrati concessionari non commentati in nota vedi oltre nel paragrafo di datazione della lista.n° 2. Antroponimo completo in ASL, Notarile n° 32 (Paganello Bonaiuti), reg. 3°, f. 101r (Lucca 17.II.1300) «fr. Accurso Iacobi Cassian(i) eiusdem ordinis», teste in atto di quietanza di Tolomeo da Lucca OP e Gherardo da Porcari OP. Nel 1299 studente in arte nuova, MOPH XX, 133/2 «Accursum Cascianum». VERDE-CORSI 575: «Accursus Cassiani» lettore in Lucca 2.XII.1314.n° 6. MOPH XX, 78/15-16, nel 1287 lettore in Anagni. Un indistinto Nicolaus Romanus: MOPH IV, 67/5-14 (punito 1313 de Anglia rediens); SOPMÆ III, 183-84. AFP 33 (1963) 255; Firenze 1333: MD 18 (1987) 299a n° 27.
n° 7. Stefano da Sezze OP: MOPH XX, 397b (anni 1304-05); zio per parte di madre di Roberto da Sezze OP: Thomae Aquinatis vitae fontes praecipuae [sic], a c. di A. Ferrua, Alba 1968, 290-91 (dic. 1318); MOPH XX, 396a. Sezze (oggi pr. Latina) (RD Latium 530b) territorio della prov. Romana: nel 1327 castrum Sezzie assegnato alla predicazione d'Anagni (MOPH XX, 243/3-5); trasferito da quella di Terracina, conv. dal 1318 (Niccolò da Sezze tra i vescovi del conv. Terracina: CrOv 38, ed. 51); infine nella predicazione di Priverno quando qui nel 1343 fu istituito il convento?n° 13. De ortu scientiarum (1250) di Roberto da KilwardbyOP? Cf. MD 12 (1981) 74-75.
B) Tempi della lista e tempi dei prestiti
Un'unica regolatissima mano trecentesca in minuscola documentaria scrive l'intera lista, la stessa mano - abbiamo detto - che redige anche rubriche i-iv. Nessuna correzione o aggiornamento sul testo.
Estremi cronologici massimi: dopo 1323, canonizzazione di Tommaso d'Aquino («sancti Thome» n° 1, 5, 10); prima del1342, inizio del provincialato d'Andrea del Gallo da Firenze, come vuole la nota marginale «Ego fr. Andreas de Gallo… nichil repperi nec aliquid scio» (f. 6r marg. sup.; vedi trascrizone completa più oltre).
La formula habet ad usum, habet, convoca tutti i frati concessionari a uno stesso indistinto presente. Un rapido scrutinio biografico rivela che il redattore della lista non sta annotando prestiti in corso. Piero da Prato (n° 1) era deceduto nel 1316 sulla via di ritorno dal capitolo generale tenuto in Montpellier (MOPH IV, 104/7-10); Caro dimesser Iacopo di Belloccio da Firenze (n° 4), in religione dal 1279, † 23.VII.1316 (Cr SMN n° 215); Riccoldo da Monte di Croce (n° 5) in religione dal 1267, † 30.X.1320 (Cr SMN n° 222; SOPMÆ III, 308-10; IV, 262-65). Altri eran diventati vescovi, e nessuna cancelleria si sarebbe sottratta al titolo (dominus, dominus episcopus) voluto dalle
norme dell'ars dictaminis. Tolomeo dei Fiadoni da Lucca (n° 12) viveva in Avignone dal 1307-08, vescovo di Torcello (Gradi-Aquileia) dal 1318, ivi deceduto nel 1327 (SOPMÆ IV,318-25). Iacopo da Focignano (Roma, n° 8) vescovo di Lucera(pr. Foggia) 1308-22, di Methone in Peloponneso 1322-33 (SOPMÆ II, 321-22; IV, 133); Lorenzo da Viterbo (n° 11) compare la prima volta studente di logica vetus 1291, vescovo di Tempio Pausania (pr. Sassari) 1329-44.
■ Lorenzo da Viterbo. MOPH XX, 385a (anni 1291-1344). T. KAEPPELI, Dalle pergamene di S. Maria in Gradi di Viterbo, AFP 33 (1963) 254. Cr Ov 36, ed. 51. Vescovo civitatensis(= Tempio Pausania) 1329-44: HC I, 188; P. SELLA, Rationes decimarum Italiae. Sardinia, Città del Vat. (Studi e testi 113) 1945, 113 n° 1083 (17.X.1342). ASF, NA 3140 (B 2126), ff. 70r-71v (Firenze 1.VII.1302). ASF, NA 1815, ff. 80v-81r (Pisa 17.VI.1340/39): «fr. Laurentius, Dei gratia episcopus civitatensis» nomina procuratore in qualsiasi lite possa avere con ecclesiastici o secolari. «Actum Pisis in domo ecclesie Sancti Simonis ad Parlascium posita iuxta ecclesiam Sancti Simonis suprascripti, presentibus presbitero Iohanne rectore ecclesie Sancti Simonis suprascripti et fr. Simone de Spoleto ord. fratrum Predicatorum et Vannuccio condam Barduccii clerico».Taluni usuari esigono estremi cronologici più
ravvicinati. Iacopo di Nallo da Orvieto (n° 3) nel 1305 eraappena studente in logica nuova, muore in Roma 20.VIII.1343.
MOPH XX, 157/12 (1305 studente in logica nuova), 212/24, 265/4, 277/10 (anni 1305-32). Cr Ov 85-86, ed.119-20.Piero di Pegolotto degli Ardinghi da Firenze (n° 9) in
religione dal 1304, † 3.VI.1348 (Cr SMN n° 344).Angelo da Tivoli (n° 10) studente di filosofia naturale
in Perugia 1295, assegnato allo studio parigino 1301, lettore, predicatore generale, priore fiorentino 1318-19;
deceduto durante il provincialato di Matteo degli Orsini 1322-26, presumibilmente in Firenze, se in aprile 1340 pendeva ancora la vertenza tra i conventi tiburtino e fiorentino sul diritto ai suoi libri.
MOPH XX, 122/5, 141/17, 155/8, 182/23, 188/18 (1295-1313). C. CARBONETTI VENDITTELLI, Il fondo pergamenaceo del convento domenicano di Tivoli conservato nell'Archivio generale dell'ordine (secc. XIII-XVII), AFP 54 (1984) 157, 159. MD 17 (1986) 282. AFP 60 (1990) 237-38, 310. S.L. FORTE, Il card. Matteo Orsini O.P. e il suo testamento, AFP 37 (1967) 206,237.Francesco da Viterbo di n° 13-14: la toponimia invita a
riconoscervi «fr. Franciscus de Plano Viterbiensis», assegnato studente a Parigi 1317, in Firenze 1321, lettore viterbese 1330 e perugino 1331, predicatore generale 1332; anziché «fr. Franciscus de Tuscanella» (1317-42), territorio della predicazione viterbese.
■ MOPH XX, 204/24, 263/30, 259/13, 278/1 (1317-32). MD18 (1987) 297: Firenze 30.XII.1321 (n° 14) «fr. Franciscus de Viterbio».■ Francesco, o Cecco, da Toscanella (oggi Tuscania, pr. Viterbo). Assegnato studente a Montpellier 1317, lettore, socio capitolare, priore ecc., fino all'ultima data conosciuta 1342. MOPH XX, 375a; XXII, 115 n. 7. AFP 15 (1945) 145 n. 4; 33 (1963) 251; 64 (1994) 99. MD 18 (1987) 299 n° 8. ASF, Dipl. S. Domenico di Pistoia 6.X.1331: «Actum fuit hoc in civitate urbevetana in loco fratrum Pred. de Urbeveteri presentibus fr. Giannocto priore Sancti Dominici de Urbeveteri, fr. Francisco de Toscanella lectore urbevetano,…».
Redazione della lista libraria concorde con quelle dei conventi e monasteri, anni '30 del Trecento, della medesimamano; sguarnita di giunte, modifiche, barre d'estinzione. Perché, come detto, essa non sta tenendo nota di prestiti in corso. Intende piuttosto inventariare i libri di
proprietà provincializia. Nel compilare il Liber privilegiorum a vademecum dell'amministrazione provinciale, la cancelleriacensisce il suo fondo librario; spogliando - dobbiamo credere - e riordinando note di prestiti anteriori, inclusi i non recentissimi e non estinti. Di certo note nonperfettamente aggiornate ai movimenti dei libri e loro assegnatari, come proclama l'assenza di qualsivoglia nota marginale o interlineare. Per oggettiva difficoltà d'inseguire le sorti dei singoli prestiti tra popolazione eterritori vasti; in parte anche per incuria dei provinciali, come trapela dai ripetuti "non so" delle dichiarazioni autografe che costellano la lista. Il cardinal Matteo degli Orsini chiede venia per omissione d'ufficio: quando provinciale in carica non s'era curato d'attribuire il lascito librario d'Angelo da Tivoli; disposto ora nel testamento 1340 a risarcire chiunque ne fosse rimasto dannificato (S.L. FORTE, Il card. Matteo Orsini…, AFP 37 (1967) 237). Durante mezzo secolo, dalla stesura dell'inventario al decennio 1380 incipiente, i provinciali nulla sanno dei libri né riescono a recuperarli. Smarrimento occorso presto: dopo il provincialato di Giovanni Boccanera da Spoleto, nel corso del ventennio 1322-1342; nell'entrare in carica, novembre 1342, Andrea del Gallo dichiara che né ha trovato né sa alcunché di siffatti libri.
Le sottoscrizioni alla lista tuttavia testimoniano l'intento d'assicurare lo stato patrimoniale del fondo, finanche quando si è costretti a denunciare dispersione e smarrimento.
C) Sottoscrizioni dei provinciali
Mani diverse, coeve all'attestazione; tutte scrivono minuscola documentaria e personalizzata. Cercano spazio dove possono, perché siffatti interventi non erano previstidal rubricatore o progettatore del libro. Il risultato è unarruffato accumulo con se stesse e rubriche preesistenti. Numerazione seriale mia, in ordine restituito di successione temporale.
1) Ego fr. Iohannes de Spoleto predictas concessiones reperi scriptas et factas sicut[18] supra continetur (f. 6r marg. inf.).Il sottoscrivente non si dice provinciale, e lascia
perplessi circa l'identità (MD 27 (1996) 229 n. 93). Da identificare con Giovanni Boccanera da Spoleto? Già in religione nel 1274, lettore in Firenze 1291 e Spoleto 1292,predicatore generale 1297, priore in Santa Sabina (Roma) 1314, provinciale dal 1319 al 1322 (frater Iohannes Bocchanera de Spoleto, nella lista di f. 11v); anno di decesso sconosciuto.
Non Boccaccini: MASETTI, Monumenta I, 311. ASL, Dipl. S. Romano 11.V.1274. MOPH XX, 100/4, 106/17-18, 127/14, 193/7, 217/30. H.F. DONDAINE - H.V. SHOONER, Codices manuscripti operum Thomae de Aquino I, Romae 1967, 324-25.San Domenico d'Arezzo..., AFP 64 (1994) 96, e 98 n. 87-88 per omonimi.Le caratteristiche paleografiche non obiettano, il
tenore della nota lo insinua; e peraltro il senese Iacopo da Sant'Andrea, 1364, non sarebbe stato costretto ad acrobazie scrittorie sulle estremità del marg. superiore destro se avesse trovato spazio disponibile in quello inferiore. Ma se del provinciale Giovanni fosse siffatta sottoscrizione, costui l'ha vergata a libro confezionato (ofascicolo composto): dopo la canonizzazione 1323 di Tommasod'Aquino, a provincialato scaduto, anni '30, quasi ritardata consegna ai successori; primo intervento che commenta la vicende amministrative dei libri, e dà il via alla sequenza delle attestazioni autografe.
2) Ego fr. Andreas de Gallo[22] prior provincialis de infrascriptis libris nichil repperi nec aliquid scio (f.6r marg. sup.).3) Ego fr. Iacobus de Sancto Andrea[23] quando fui factusprovincialis et res provincie recepi, nullum de infrascriptis libris repperi. Anno <Domini?> 1363 die 24ianuarii[24] factus fu<i> provincialis in Fulgineo (f. 6rmarg. sup. in scrittura compressa tra precedente
dichiarazione d'Andrea e primo rigo della lista, proseguita a discesa su spazio ritagliato nell'estremo marg. destro).4) Ego fr. Stephanus de Cumba fui factus vicarius in provincia Romana ordinis fratrum Predicatorum in capitulo generali Brugis celebrato anno Domini M°c°c°c°lxix, et recepi nova et[25] literas dicti vicariatus xiij die iulii. Postmodum vero electus fui inprovinciali capitulo Narnie celebrato dominica in oct(ava) sancti Martini[26] in priorem provincialem dicteprovincie, et nova ac literam confirmationis dicti provincialatus recepi Rome secunda die marcii anno a nativitate Domini M°c°c°c°lxx°.De libris vero subscriptis nullum reperi (f. 5v, righi 1-7, primo terzo superiore del foglio, originariamente bianco; torna indietro, Stefano de la Combe, a trovar spazio libero su f. 5 perché ff. 6v-7v erano stati già occupati dalla Cronicha magistrorum ordinis a partire dal 1340 ca.).5a) Ego fr. Iohannes de Sancto Iuvenali de Urbeveteri[27]
recepi a reverendo patre fr. Helia[28] magistro ordinis literas confirmationis in priorem provincialem Romane provincie die xxij mensis decembris anno Domini M°ccc°lxx°. De libris vero qui in sequenti folio scriptisunt, nullum inveni nec habui (f. 5v, attuali righi 10-14, originariamente a seguito della dichiarazione di Stefano de la Combe, essendo righi 8-9 inserimento posteriore di Domenico da Peccioli; segue uno spazio di rigo in bianco, e la medesima mano interviene di nuovo, qualche tempo dopo).5b) Ego fr. Iohannes supradictus, prior[29] provincialis,recepi infrascriptos libros ad provinciam Romanam pertinentes videlicet:- Unam bibliam parvam et parvi valoris.- Unum breviarium antiquum.- Unum missale parvum in quo est officium misse notatum.
- Concordantias biblie quas habebat fr. Lucas de Aretio[30] sub pignore (f. 5v, righi 15-21).6) Ego fr. Dominicus de Peccioli recepi preceptum obedientie confirmationis provincialatus in forma[31] in die epiphanye 1378[32] et non habeo aduch aliquem librum de infrascriptis nisi breviarium (f. 5v, righi 8-9, alquanto compressi tra sottoscrizione di Stefano de la Combe e primo intervento di Giovanni da San Giovenale).7) Ego fr. Iacobus de Altovitis ordinis Predicatorum, sacre theologie humilis professor, fui electus in provincialem Romane provincie anno Domini Mccclxxx in vigilia Omnium Sanctorum in capitulo eadem die celebratoin Fulgineo, confirmationem vero recepi et preceptum sancte obedientie in die beati Iohannis evangeliste, quod festum fuit feria v[33]. Nullum autem librum reperi de infrascriptis. Alii etiam sunt sub pignore apud fr. Dominicum de Peccioli magistrum; quando rehabebo et quos, scribam in precedenti carta (f. 5v, ultimi 7 righidel terzo inferiore della carta, a seguito della secondasottoscrizione di Giovanni da San Giovenale. Di fatto l'avvenuto recupero dei libri vien registrato nel "precedente foglio" - l'unico ancora bianco nelle vicinanze - non dall'Altoviti bensì da Domenico da Peccioli).
[18] sicut: sunt(?) sequ. anticipo logico del verbo, poi non cassato quando sostituito da continetur?[22] Andrea di Vanni del Gallo da Firenze († 5.XI.1344), provinciale nov. 1342 - nov. 1344. SOPMÆ IV, 25-26. Correggi cronologia in MASETTI, Monumenta I, 329-30, compromessa dall'errore «anno Domini MCCCXLVII» (I, 330); leggi «anno tertio sui provincialatus post longam egritudinem quievit in pace Florentie anno Domini M°ccc°xliiij° die va novembris» (Cr SMN n° 311).[23] Iacopo da Siena († 1378), del popolo o parrocchia urbana Sant'Andrea (W.M. BOWSKY, Un comune italiano nel Medioevo. Siena sotto il regime dei Nove 1287-1355, Bologna 1986, 46): SOPMÆ II, 338-39, dove aggiorna gli estremi del provincialato 1364-69, non 1364-68; IV,
136. Succede a Niccolò da Corneto († maggio 1363), provinciale sett. 1356 - maggio 1363. È il nostro Iacopo da Sant'Andrea il "mag. Iacobus de Senis OP" in C. PIANA, La facoltà teologica dell'università di Firenze nel Quattro e Cinquecento, Grottaferrata 1977, 38 (1369), 52 (25.V.1365, "fr. Iacobo priori provinciali"), 524b; licenza del magistero, Urbano V, Avignone 24.V.1364 (MASETTI, Monumenta I, 332).[24] Foligno 24.I.1364, dato in anno senese dal senese Iacopo. Provinciale da genn. 1364 a maggio 1369; assolto dalla carica dal cap. gen. Bruges 1369, attesta frammento capitolare recuperato da H.CH. SCHEEBEN, Handschriften IV, «Archiv der deutschen Dominikaner» 4 (1951) 164 tra le "absolutiones"; qui erroneamente identificato con Stephanus de Cumba (p. 166 n. 6), dietro suggestione di MASETTI,Monumenta I, 333, che a sua volta data Bruges 1368 anziché 1369. Estremi ristabiliti in coerente incastro con quanto dichiara il successore Stefano: vicario nominato dai capitolari di Bruges, ne riceve notizia il 13.VII.1369, provinciale eletto 18.XI.1369, confermato 2.III.1370.[25] et in nota tironiana 7 barrata orizzontalmente, come nella tradizione grafica dell'area franco-germanica. Stefano: «conventusBellividere [Belvès, Dordogne, provincia Tolosana], oriundus de Dunio castro de Vigna Rupe, prope Bellumvidere, de manso vocato laComba, alias la Cumba»: G.-G. MEERSSEMAN, Études sur l'ordre des frères Prêcheurs au début du Grand Schisme, AFP 25 (1955) 218, 443b. MOPH XXIV,29, 300b.[26] = Narni 18.XI.1369 domenica, coincidente nel calendario dell'anno con l'ottava della festa liturgica (11 nov.) di san Martino.[27] Giovanni da Orvieto, rione San Giovenale, provinciale in carica 1370-77; MASETTI, Monumenta I, 338-39.[28] Elia Raymond da Tolosa, maestro dell'ordine domenicano 1367-80, e nell'obbedienza avignonese 1380-89, † Avignone 31.XII.1389. MOPH VII, 27, 60.[29] prior: pro prem. et del.[30] Luca di Ventura da Arezzo OP. MOPH XX, 385b (1338-44 studentee poi lettore in logicalibus); IV, 401/4, lettore biblico a Firenze 1363. ASF, NA 10915, f. 27r (Arezzo 31.I.1362) «presentibus religiosis viris fr. Lucha olim Venture et fr. Francischo Aquisti de Aretio OFP seu sancti Dominici testibus». ASV, Reg. Vat. 259, f. 87r (Urbano V, Viterbo 18.VIII.1369): licenziato da poco, Luca ottiene consueti privilegi e immunità dei
maestri in teologia. Conventuale in Lucca 1382: MD 21 (1990) 378b n° 11. Reggente nel convento della città dove risiede la curia romana («regens curie») 1388-89: MOPH XIX, 29-30 § 213, 247a; AFP 12 (1942) 51. Muore tra 1405 e 1407: AFP 22 (1952) 200.[31] forma? ] Roma?[32] = 6.I.1378. Domenico da Peccioli (pr. Pisa), provinciale genn.1378 - ott. 1380, ad apertura dello scisma, † dic. 1408. Ampiamente su Domenico in Cronica di Santa Caterina in Pisa. Copisti autori modelli, MD 27 (1996) 211-91.[33] = giovedì 27.XII.1380. Iacopo di Tommaso degli Altoviti da Firenze († 1408), provinciale 1380-88, eletto in Foligno 31.X.1380. SOPMÆ IV, 138-39.
8) Isti sunt libri quos ego fr. Dominicus de Peccioli reperi quando fui factus provincialis Romane provincie, et pertinent ad Romanam provinciam:1. Unum breviarium grossum non magni valoris.2. Una biblia parva.3. Concordantie in parvo volumine satis pulcre.4. Missale parvum et notatum et valde completum.5. Unum diurnum magnum.6. Item fr. Nicholaus Gilielli[34] fecit sibi concedi a magistro ordinis condam fr. Helya[35] aliud diurnum parvum, cuius proprietas remanet provincie Romane.7. Item quedam parva volumina ubi sunt copie privilegiorum ordinis, interpretationes constitutionum[36], pontificale pro velamine sororum, miracula sancti Thome noviter facta[37].8. Item inveni in capsa provincie in Florentia testamentum Bonifatii[38].Et nota quod provincia consuevit habere unum magnum volumen antiquorum actorum[39] ordinis, quod ego in aliquo loco invenire non potui (f. 4v, righi 1-14 nella metà superiore della carta, originariamente bianca, numerazione originale 1-8 sull'estremo marg. sinistro; f. 5r era occupato dalla lista Monasteria sororum).
9) Ego fr. Bartolomeus de Acerbis de Perusio[40] fui factus provincialis romanus anno Domini M°cccc°iiij° de mense iunii in conventu cortoniensi in capitulo provinciali, et repperi infrascriptos libros et non plures, quos assignavit michi magister Federichus de Fulgineo nunc episcopus fulginas[41], videlicet:- unum breviarium.- formularium.- constitutiones fratrum et sororum, que dicuntur pertinere ad conventum florentinum.- hunc librum in quo sunt copie privilegiorum ordinis (f. 4v, seconda metà del foglio; resto in bianco, con residui di scrittura sotto erasione).
E su quest'ultimo item di rinvio al nostro Liber privilegiorum si chiudono le reazioni alla lista libraria. Annotiamo, lungo la catena delle sottoscrizioni autografe dei provinciali, le assenze più notevoli: Piero di messer Ubertino degli Strozzi da Firenze, secondo provincialato 1345-56; Niccolò da Corneto (oggi Tarquinia, pr. Viterbo) 1356-63: ASF, CRS 102 n° 444 <Liber recordationum Bernardi Bernardonis de Florentia OP> f. 64r: «Anno Domini 1356 fr. Nicholaus de Corneto fuit electus in priorem provincialem Romane provincie ab omnibus electoribus unanimiter, semptembris die septima in vigilia nativitatis beate Virginis, existente vicario provincie fr. Petro de Stroççis, Prati in capitulo provinciali»; Bartolomeo di Domenico da Siena 1388-97; Michele di ser Tino della Casa da Firenze 1397-1401; Federico Frezzi da Foligno 1402-04. Etace Leonardo di Stagio dei Dati da Firenze: il terzo papa appena eletto in Pisa, Alessandro V, in luglio 1409 lo nomina provinciale sovrapponendolo a Bartolomeo degli Acerbi (fedele al veneziano Gregorio XII in sintonia con i riformatori veneziani?), e il capitolo generale 1410 d'obbedienza pisana lo dichiara «vero provinciale della provincia Romana» (ASV, Reg. Later. 136, ff. 298v-299r: Aless.V, Pisa 28.VII.1409; MOPH XIX, 143/22-23: 1410).
La seconda sottoscrizione di Domenico da Peccioli (f. 4v) non reca data cronica. Ma contrariamente alla cronologia delle cariche, da credere posteriore alla confermata elezione del successore Iacopo degli Altoviti 27dicembre 1380. Perché Iacopo non riceve alcun libro in consegna, mentre sa di libri ancora in pegno presso il suo predecessore. Perché Domenico parla del proprio provincialato (gennaio 1378 - ottobre 1380) in passato («quando fui factus provincialis», «invenire non potui») contro il presente nel primo intervento («non habeo»). E infine perché non avvia il secondo intervento sotto quelli di Giovanni da San Giovenale in f. 5v, come volevano successione cronologica e utilizzo razionale dello spazio, ma in cima a carta 4v: segno che questa era l'unica rimastabianca dopo che l'Altoviti aveva colmato il residuo spazio inferiore di 5v. «A magistro ordinis condam fr. Helya», scrive Domenico in item n° 6; "dal fu Elia" († Avignone 31 dicembre 1389), a morte avvenuta? Più attendibile intendere"dal fu maestro": ovvero già legittimo, ora non più, a scisma consumato (antimagister si apostrofavano reciprocamente; lo stesso Iacopo degli Altoviti era un antiprovincialis per la parte avversa: MOPH IV, 23/28, 24/33-34: 1386). Elia Raymond fu maestro dell'ordine unito 1367-80, poi del ramo avignonese 1380-89. Ma per la Cronicha magistrorum ordinis nel vademecum dei provinciali romani, gli anni di governo avignonese d'Elia non sono mai esistiti. Così il cronista d'obbedienza romana si rappresenta a inizio Quattrocento la sequenza legittima alla guida dell'ordine (f. 7v, di un'unica mano, prossima a quanto racconta):
Fr. Helyas de provincia tholosana, magister in theologia, electus in Avinione M°ccc°lxvij°. Hic anno Domini M°ccc°lxviij° impetravit corpus sancti Thome de Aquino et recuperavit de manu secularium quorundam comitum auctoritate domini pape Urbani vti, et transtulitipsum eadem auctoritate Tholosam et locatum est ibi eodem anno de mense decembris in ecclesia fratrum Predicatorum cum maximo cleri populique favore[45].
Fr. Raymundus de Capua de provincia Regni[46], magister in theologia, electus Bononie M°ccc°lxxx°, obiit in Nurimbergha M°ccc°lxxxxviiij°. Hic ordinavit quod in qualibet provincia esset unus conventus in quo possent morari fratres volentes servare regulam et constitutiones ordinis nostri.Fr. Thomas de Firmo, magister in theologia, fuit bis prior provincialis in provincia Lombardie inferioris, que nunc vocatur provincia Sancti Dominici[47]. Vicarius generalis ordinis existens conservavit ordinem in libertate sua, licet multam habuerit repugnantiam. Electus fuit in magistrum ordinis in Utino M°cccc°j°. Obiit Ianue Mccccxiiij die xviiij martii[48].Ignorati i successori d'Elia sul ramo avignonese. I
diciotto mesi tra decesso di Raimondo da Capua ed elezione di Tommaso da Fermo, novembre 1399 - maggio 1401, apparivano nulla più che vacatio magisterii alla fazione d'obbedienza romana (MOPH VIII, 108/28).
D) Costituzione del fondo librario di provincia
Poca cosa, dopo tutto, il fondo librario di provincia nella lista del Liber privilegiorum. Ma va subito detto che il soggetto ordinario di beni librari, sussidiari allo studium conventuale, vita intellettuale e attività pastorale dei frati, è l'istituzione "convento". È il convento che amministra l'armarium e i suoi libri, secondo competenze e autonomie fissate dalle costituzioni domenicane. Al convento d'origine tornano i libri, insieme con gli altri beni, trovati a disposizione del frate all'atto di morte o di promozione ecclesiastica.
Clemente IV, Viterbo 9.VI.1268, dispone che i frati OP promossi a prelature ecclesiastiche rendano libri e benial convento dal quale era stati assunti; escludendo «quaternulos et illas cartulas vel membranas in quibus dicti fratres sibi certa notabilia cum aliquibus privatis sermonibus collegerunt» (APR, Dipl. 9.VI.1268).
Così almeno, senza restrizioni di sorta, agli inizi e nel primo secolo di vita dell'ordine. Gl'inventari delle biblioteche degli ordini mendicanti sono principalmente inventari conventuali, incorporati d'abitudine entro quellopiù ampio dei beni "mobili" del convento; da tempo oggetto di ricerche.
■ a titolo di primo orientamento: W.A. HINNEBUSCH, Thehistory of the dominican order, II: Intellectual and cultural life to1500, New York 1973, 191-230; D. NEBBIAI DALLA GUARDA,I documenti per la storia delle biblioteche medievali (secoli IX-XV), Roma 1992, 77-84.
Cosicché la valutazione della lista del Liber privilegiorum non ricade sulla consistenza libraria bensì sul suo peculiare statuto patrimoniale: libri di competenza della provincia non dei conventi. Si conoscono altri inventari di libri di provincia?
Raccogliamo quanto permetta d'intravvedere l'origine legale di tale fondo provinciale, il suo costituirsi, le destinazioni, le relative competenze amministrative.
A partire dal 1286 un paragrafo finale di Constitutiones OP dist. II c. 3 De electione prioris provincialis, così regolava idiritti di proprietà all'espirare della carica provincializia. Riproduco testo costituzionale del 1316-17:
Priores provinciales cum fuerint absoluti, ad illos conventus pertineant de quibus fuerint assumpti, nisi persuperiores suos fuerit aliter ordinatum. Si vero in provincialatu decesserint, libri et alia que habuerint per provisionem ordinis a provincia antequam essent provinciales vel ab aliquo conventu, ad provinciam vel conventum simpliciter pertinebunt. Alia vero omnia que habuerunt, sint illorum conventuum de quibus assumpti fuerunt. Ea vero que adquisierunt tempore provincialatus, ad provincias quarum erant priores spectabunt (BAV, Borgh. 242 (xiv1), f. 13vb).■ prima proposizione, Priores provinciales… ordinatum, è addizione costituzionale 1279 (MOPH III, 200/10-13); il
resto, Si vero… spectabunt, del 1286 (MOPH III, 231/11-17).Un emendamento avviato dal capitolo generale 1328 fu
confermato nel 1330:MOPH IV, 195-96 (1330): «Si vero in provincialatu decesserint, libri et alia que habuerunt per provisionemordinis a provincia vel conventu aliquo antequam essent provinciales vel in ipso provincialatus officio, ad provinciam vel conventum unde habuerunt simpliciter pertinebunt. Alia vero omnia que habuerunt, sint illorumconventuum de quibus assumpti fuerunt». Precedenti ib. IV, 177/1-8 (1328), 189-90 (1329).Che mutò il dettato costituzionale in:Priores autem provinciales cum fuerint absoluti, ad illos conventus pertinebunt de quibus fuerint assumpti, nisi per superiores suos aliter fuerit ordinatum. Si vero in provincialatu decesserint, libri et alia que habuerunt per provisionem a provintia vel conventu aliquo antequam essent provinciales vel in ipso provincialatus officio, ad provintiam vel conventum undehabuerunt sinpliciter pertinebunt. Alia vero omnia que habuerunt, sint illorum conventuum de quibus assumpti fuerunt (Siena, Bibl. comunale F.VI.3 (xiv med), f. 145vfine capitolo, che riproduce costituzioni 1333-34).Questa la formulazione ancora in vigore nel 1358-63; e
parimenti nei testi 1375 e 1380-88, che recuperano l'asserto finale «Ea vero que acquisierunt tempore provincialatus, ad provincias quarum erant priores spectabunt».
■ costituzioni 1358-63: G.R. GALBRAITH, The constitution of the dominican order, 1216 to 1360, Manchester 1925, 231, che però ha per permissionem ordinis provincie in luogo di per provisionem <ordinis> a provincia.1375: BAV, Vat. lat. 7658 (xiv2), f. 164r. Il testo delle costituzioni ff. 139r-184v porta modifiche 1358,1363, costituzioni papali 1374. Numera 18 province, non conosce Trinacria e Hibernia 1378, né Dalmatia 1380-
88. Non reca addizione 1397 (MOPH VIII, 94/8-16), né (f. 183v) la clausula «… totum sit irritum et inane» confermata nel 1376 (MOPH IV, 428/2-3; presente in BAV, Vat. lat. 7651, f. 38v).1380-88: BAV, Vat. lat. 7651 (xiv-xv), f. 24r, in margine, frutto della ricognizione susseguita al cap. gen. Nürnberg 1405. «Nota quod iste constitutiones correcte fuerunt in conventu nurenbergensi provincie Theutonie anno Domini M° quadringentesimo quinto de mense iulii, post generale capitulum illo anno ibidem celebratum, per sacre theologie doctores fratres Thomam de Firmo magistrum ordinis…» (f. 1r).
L'ordinatio de meliori libro. Il capitolo provinciale Orvieto 1300 inventa un'articolata provvisione intesa a costituire un fondo riserva a sostegno di giovani frati inviati allo studio parigino (una vera borsa di studio), o per altre urgenze di provincia. Dispone:
1°) il provinciale prelevi dai diritti conventuali il libro più prezioso tra quelli trovati in uso a ciascun frate in atto di morte;
2°) se di valore superiore a 30 fiorini d'oro, il convento d'origine del defunto è autorizzato a riscattare il libro (redimere) versando 30 fiorini d'oro alle casse provinciali;
3°) lo studente assegnatario della borsa riserverà il danaro all'acquisto di libri necessari;
4°) in caso di morte dell'assegnatario, siffatti libri tornano al fondo di provincia;
5°) il provinciale vigili contro qualsivoglia furberia ofrode a danno del fondo, «et inventarium habeat ad predictaspecialiter deputatum» (MOPH XX, 137-38).
Previdente, l'ordinazione. Ma refrattaria all'esecuzione: persone molteplici e mobili, tempi lunghi eindefiniti («post mortem suam», ovvero dell'assegnatario), luoghi distanti e disparati; a fronte del rapido avvicendarsi degli ufficiali conventuali e provinciali, ai
quali spettava l'applicazione, il vaglio dei requisiti, il controllo delle condizioni. Sta il fatto che il capitolo 1313, anch'esso in Orvieto, revoca l'ordinazione "de meliori libro dando priori provinciali" (MOPH XX, 187/28-30). In sintonia col governo generale, che nel 1308 revoca simili, ma meno articolate disposizioni del CG Parigi 1306 (MOPH IV, 18/21-25; 32/29-32).
Non doveva esser tutta incuria dei provinciali se nel 1340 pendeva ancora ingiudicata la vertenza sui libri rimasti in Firenze alla morte di fra Angelo da Tivoli (1322-26): al già intricato triangolo degli aventi diritto,Tivoli Firenze e provincia, si aggiungeva una lettera del maestro dell'ordine a suo tempo indirizzata a fra Angelo a favore del convento tiburtino (AFP 37 (1967) 237).
È difficile tuttavia sottrarsi alla suggestione che la provvisione Orvieto 1300, con obbligo d'inventario, sia di contestuale pertinenza con la lista libraria del Liber privilegiorum e che in quest'area amministrativa si debbano ricercare istituzione destinazione e alimentazione del fondo librario di provincia. O alle sue varianti, una voltaabbandonata la provvisione 1300; quelle che la prassi di governo inventa o semplicemente mette in atto in risposta alle evenienze.
■ MOPH IV, 410-11 (1369): i beni del frate incarceratouna seconda volta, o anche la prima volta per delitti gravissimi, sono di spettanza o del provinciale o del convento d'origine a seconda delle consuetudini di provincia.La rilettura della lista rileva prevalenza di libri di
testo, ordinati ai bisogni di studenti e lettori. E tali sono i frati usuari dei quali la lista serba i nomi. Non contraddice il ricorso dell'autore Tommaso d'Aquino tra così pochi item librari. Somme e commentario alle Sentenze (queste le opere tomasiane menzionate, di primaria ordinazione didattica) non sono ancora libri di testo, ma la politica culturale dell'ordine a inizio Trecento prende esplicita posizione nell'ambito dell'attività scolastica:
«Volumus et districte iniungimus lectoribus et sublectoribus universis quod legant et determinent secundumdoctrinam et opera venerabilis doctoris fratris Thome de Aquino, et in eadem scolares suos informent» (MOPH IV, 38/23-26: 1309).
E a complemento, bisognerebbe ripercorrere con occhio nuovo, puntato alla redemptio librorum e alla presenza del provinciale, il corpus di note di possesso apposte ai libriconventuali. Dove il provinciale non sia denotazione cronografica, né solo garante esterno della transazione. Esempi: «Iste liber est fr. Thome episcopi senensis, quem fr. Sinibaldus prior provincialis dedit conventui florentino» (POMARO, Censimento I, 399-400): Tommaso di Fuscone della Berta da Roma OP vescovo di Siena 1253-73, e Sinibaldo da Alma (pr. Grosseto) provinciale 1268-78 (SOPMÆIV, 278-79); ricalca il caso di beni a uso di frati promossia prelature ecclesiastiche.
■ Thomas Fusconis de Berta Romanus OP. MOPH XXII, 87-88. HC I, 182, 446. MEERSSEMAN, Ordo fraternitatis II, 1029-34; III, 1349a, 1389a. P. TORRITI, L'iconografia del beato Ambrogio da Siena, «Bullettino senese di storia patria» 100 (1993) 231 «per dominum T(homasum) Dei gratia episcopum senensem et fr. Ambrosium…» (17.IV.1266). Per il ceppo familiare C. CARBONETTI VENDITTELLI, Le più antiche carte del convento di San Sisto in Roma (905-1300), Roma 1987, 103 n. 1, 509b, 549b«Iste liber est <conventus> fratrum Predicatorum de
Florentia, cuius usum concessit fr. Philippus prior provincialis fr. Remigio magistro in theologia in vita sua pro quodam libro de proprietatibus rerum que<m> dictus frater dedit dicto conventui quantum ad proprietatem et quantum ad usum in vigilia beati Augustini», 27 agosto 1312 del provinciale Filippo da Pistoia (MD 10 (1979) 260, Tav. VI AFP 60 (1990) 273). «Iste liber est fr. Lapi de Prato ordinis fratrum Predicatorum, quem ipse emit a fr. Iohanne de Spoleto quando erat provincialis» (H.F. DONDAINE - H.V.
SHOONER, Codices manuscripti operum Thomae de Aquino I, Romae 1967, 324 n° 894), Giovanni in carica 1319-22.
«Iste liber est conventus Sancte Marie super Minervam concessus michi fr. Petro de Ylperinis <† 1383> per reverendum magistrum Iacobum priorem provincialem». Nota dipossesso databile 1380-83, se in magistrum Iacobum vediamo il fiorentino Iacopo degli Altoviti, licenziato in teologia1378-79, provinciale 1380-88 (T. KÄPPELI, Antiche biblioteche domenicane in Italia, AFP 36 (1966) 61 n° 14-15; SOPMÆ III, 77: 2851, per l'anonimo autore del sermonario). Ma databile 1364-69, se si trattasse dell'omonimo senese Iacopo da Sant'Andrea, provinciale gennaio 1364 - maggio 1369, anch'egli maestro in teologia da maggio 1364 (del diploma magistrale, Urbano V, Avignone 24.V.1364, notizia in MASETTI, Monumenta I, 332 «adhuc superest in Bibl. Senensi»); e più congruamente, visto che il romano fra Pietro degli Ilperini o Alberini († 20.VII.1383) non porta alcun titolo, mentre fu vescovo d'obbedienza romana di Marsiconuovo (pr. Potenza) da 1374 a 1383, residente in curia, maestro già nel 1378; che potrebbe definitivamente liberare paternità e tempi del sermonario dall'ipoteca "Leonardo Dati" (in religione dal 1375 circa, † 1425) imposta da tardiva attribuzione in f. Iv.
■ M.-H. LAURENT, Fr. Marco da Montefalco et les Evêques de Marsico Nuovo à l'époque du Schisme d'Occident, «Archivum Franciscanum Historicum» 53 (1960) 455-56; marsicensis (= Marsiconuovo, pr. Potenza) non marsicanus (= dei Marsi o della Marsica, in prov. dell'Aquila, oggi con sede in Avezzano): A. DI PIETRO, Catalogo dei vescovi della diocesi dei Marsi, Avezzano 1872, 120-22. G. PALMERIO - G. VILLETTI, Storia edilizia di S. Maria sopra Minerva in Roma 1275-1870, Roma 1989, 57, 63, 171. <H.M. CORMIER>, B. Raymundi Capuani, XXIII magistri generalis OP, Opuscula et litterae, Romae 1895, 33. A.W. VAN REE, Raymond de Capoue. Éléments biographiques, AFP 33 (1963) 182. SOPMÆ III, 233-34; IV, 231.
Note siffatte potrebbero arricchire non poco le scarse notizie sui libri di provincia, talvolta indicarne la sortefinale. E colmare, forse, i vuoti di questo primo tentativodi definire il fondo librario della provincia Romana dei frati Predicatori, e d'abbozzarne le vicende trecentesche.
[34] Nicholaus Gilielli de Tuderto OP. Conventuale in Viterbo 1362, prioredi Tivoli 1390, di San Sisto in Roma 1393, 1396: AFP 33 (1963) 255; 46 (1976) 6, 11n; MOPH XIX, 100 § 375 e 379, 111 § 500; S. PAGANO, L'archivio del convento dei SS. Domenico e Sisto di Roma, Città del Vat. 1994, 65 n° 68. Da identificare(?) con fr. Niccolò da Todi, detto anche da Chio: Martino V, Roma 19.VI.1426, «Dilecto filio Nicolao de Chio alias de Todi OFP», lo nomina vicario della chiesadi Chios con piena giurisdizione vescovile (ASV, Reg. Later. 261, ff.195v-196r); vescovo di Fokia in Asia Minore 1427: R. LOENERTZ, La Société des frères Pérégrinants, Roma 1937, 51 n. 93 (anno 1447), 64. Altri è «Nicolaus quondam Catalani de Accis de Tuderto, militis natus, OFP», che ottiene licenza di passare ai benedettini (ASV, Reg. Later. 144, f. 180r-v: Giov. XXIII, Bologna 4.VII.1410).[35] helya scritto (in seconda istanza?) con punta di penna più fine[36] constitutionum scritto (in seconda istanza?) con punta di penna più fina[37] «noviter facta»: non dispongo di riscontri cronologicamente significativi, posteriori alla traslazione del 1368 (SOPMÆ III, 281: 3394-95; IV, 244) altrettanto J.-P. Torrell (Fribourg 01/02/1997).[38] A titolo di pista identificativa, cf. AA. VV., Libraria nostra communis, Pisa 1994, 41: il ms Pisa, Bibl. Cateriniana 3 (xiv-xv),composito, contiene tra l'altro: copia del testamento e codicillo di Bonifazio Novello conte di Donoratico 19.VII.1338/7, 23.XII.1341/0. R. PAESANI, L'archivio e il fondo pergamenaceo di S. Caterina in Pisa, «Bollettino storico pisano» 42 (1973) 100. S.K. COHN, The Cult of Remembrance and the Black Death, Baltimore-London 1992, 113-14.[39] actorum: p add. et del.
[40] Figlio di Paoluccio: «ego fr. Bartolomeus Paulutii de Acerbis» (ASPg, Corporaz. relig. soppr., S. Domenico, Miscell. 5, f. 37r, anno1423; ib. Miscell. 96 ins. 9: 12.V.1418). Provinciale 1404-11, † 1423: SOPMÆ I, 143; IV, 41.
[41] Federico Frezzi da Foligno OP, provinciale 1401-04, vescovo di Foligno 16.XI.1403, † 1416: SOPMÆ I, 403-05; IV, 89.[45] Cf. SOPMÆ III, 281: 3394; IV, 244. Confronta con la continuazione della cronaca orvietana: Autografi di Bartolomeo..., AFP 62(1992) 173-74.[46] «de provincia Regni»: coeva attestazione della provincia d'appartenza di Raimondo delle Vigne da Capua, consonante con l'altra (indipendente) segnalata in AFP 62 (1992) 173 n. 79, e su cui non è più ragionevole discettare.[47] «nunc vocatur… Sancti Dominici»: MOPH VIII, 93/30, 104/8, 111/32 (anni 1397-1403): conferma con valore di tre capitoli nel 1410: ib. VIII, 134-35, 137.[48] Obiit… martii add. alia manus
5. Appendice. Cronotassi del provincialato di Federico Frezzi (= Federico o Frederico di Frezzo) da Foligno († 1416)[autunno 1402 - febbraio 1404, estremi più probabili]
Nulla di più frustrante che inseguire nella letteratura repertoriale i tempi del provinciale Federico. Scarsa documentazione, sospetta sovrapposizione con l'espiscopato folignate, scisma in corso e obbedienze multiple. Ma anche errori di data cronica, diffusi da lungo tempo. Collettore delle dissonanti tradizioni MASETTI, Monumenta I, 402, 407-09 (1400-1404); II, 323. Qui di seguito una secca griglia cronologica che isola ed accoglie solo testimonianze dirette, controllate alla fonte. Mira a sbrogliare il viluppo antico e persistente. Altre testimonianze potranno accedere con medesimo criterio, e contribuire a far emergere intenzioni e significati d'un governo accidentato,esercitato in contesto di dissimulata conflittualità.1397-1401. Provincialato di Michele di ser Tino della Casa
da Firenze († 1415). Cr SMN n° 573. Necr. II, 51-52. SOPMÆ IV, 200.
tra decesso di Raimondo da Capua ed elezione di Tommaso da Fermo, novembre 1399 - maggio 1401, vacatio delmaestro dell'ordine nel ramo d'obbedienza romana; nessun capitolo generale durante il triennio 1398-1400.
Firenze 28 febbraio 1401. Priora e suore del monastero San Iacopo a Ripoli chiedono licenza, in materia ereditaria edotale d'una suora, «a venerabili religioso viro magistroMichaele ser Tini della Casa, fratre Sancte Marie Novellede Florentia OP beati Dominici, totius dicti ordinis provinciali». ASF, NA 1757, 2° fascicolo foliato f. 115/2r-3v (28.II.1400/1).
14 agosto 1401, provinciale è ancora Michele di ser Tino: PIANA 56-57. capitolo provinciale Firenze 1400?, Prato 1401?: Necr. II, 549b, 550b, da spoglio settecentesco; id., Note per unaserie dei capitoli provinciali della Provincia Romana (1333-1500), AFP 18(1948) 331. Ma la cronotassi dei capitoli tra fine Tre e inizio Quattrocento attende testimonianze coeve. Confermail capitolo provinciale in Orvieto sett. 1399: M. ROSSI CAPONERI - L. RICCETTI, Chiese e conventi degli ordini mendicanti in Umbria nei sec. XIII-XIV. Archivi di Orvieto, Perugia 1987, 64, 114.
Lucca 25 luglio 1402, sermone Quantum debes domino di Simone di Filippo da Cascina OP († 1420 ca.) tenuto nel capitoloprovinciale. «Sermo quem feci Luce in provinciali capitulo ubi fui factus diffinitor generalis capituli, etibi fuit generalis. Quantum debes domino scribitur Luce 16 <, 5> in evangelio concurrentis dominice» (BAV, Barb. lat. 710, ff. 42rb-43rb). (…) At ego adiciam nunc super omnem laudem suam laudando eum specialius in eius almo apostolo Iacobo, cuius laudes hodierna die per universum orbem populorum ora diffundunt (f. 42va)… Quia dicitur Quantum debes domino plane hic demostro potestatem triplicem regularem scilicet nostri reverendissimi generalis, romani provincialis et diffinitorum capituli actualis (f. 43ra)… Si autem dicatur Quantum debes domino scilicet provinciali dominanti et regenti provinciam,
etiam dico multum; cui pro gratiis dicam cum Virgilio [Bucol. V, 76-78]: Dum iuga montis aper, fluvios dum piscis amabit | dumque timo pascentur apes dum rore cicade | semper honos nomenque tuum laudesque narrabunt (f. 43rb). Nessun'altra notizia esplicita circa il provinciale.Espressamente nominati papa Bonifacio IX (1389 - 1.X.1404), e Paolo Guinigi (signore di Lucca 1400-30): AFP 12 (1942) 202-03. Tommaso da Fermo, maestro dell'ordine, in luglio 1402 è in Lucca: TOMMASO D'ANTONIODA SIENA OP, Tractatus de ordine fratrum et sororum de Paenitentia sancti Dominici (1402-07), ed. M.H. Laurent et F. Valli, Firenze (Fontes vitae s. Cath. Sen. Hist. XXI) 1938, 54. Luc. 16, 1-9, è vangelo di dom. IX post Trin. (= X post Pent.) nella liturgia OP, di dom. VIII post Pent. nella liturgia romana: M. O'CARROLL, The Lectionary for the Proper of the year in the Dominican and Franciscan rites of the thirteenth century, AFP 49 (1979) 79-103. Nel 1402 san Iacopo (25 luglio) cade martedì dopo dom. IX post Trin.
Prato 6 settembre 1402. «Fr. Michael ser Tini de Florentia sacre theologie humilis professor ac in Romana provincia vicarius generalis ordinis fratrum Predicatorum» rispondea lettera dei Conservatori di pace d'Orvieto; ed. Autografi di Bartolomeo..., AFP 62 (1992) 167-68. Data annuale1402 aggiunta da altra mano coeva (al di sopra d'ogni sospetto?). il vicario generale Michele allude a decisioni capitolari: «Placuit diffinitoribus et michi non absolvere…, constituimus…, Dedimus…» (p. 168). Constitutiones OP in vigore negli anni 1380-1405, dist. II c. 3 (De electione prioris provincialis): «Statuimus ut mortuopriore provinciali vel amoto, prior conventualis illius loci in quo primum capitulum provinciale fuerit celebrandum vicem eius obtineat quousque prior provincialis eiusdem provincie sit electus et confirmatus, et ipse vel ille cui vices suas commiserit presens in provincia extiterit. (…) Quod si magister ordinis vel capitulum generale aliquem fratrem illius
provincie vicarium instituerit, volumus in eadem ipsum vicarium in electione predicta vocem habere» (BAV, Vat. lat. 7651, ff. 22r-v, 23r-v); dist. II c. 7 (De capitulo provinciali): «Quilibet autem vicarius generalis provincie, per quemcumque modum legitime fuerit institutus, locum provincialis teneat, Fidelium dicat, loquendi licentiam tribuat, et possit concedere literas de beneficiis illiusprovincie durante capitulo provinciali dumtaxat» (ff. 27v-28r); il dispositivo è un'addizione costituzionale del 1363 (MOPH IV, 398/10-18); capitolo generale 1410 aggiunge immediatamente: «Vicarii vero particulares sive nationum sive conventuum…» (MOPH VIII, 136/20-23). Il tutto ancora in vigore nel 1507. Il vicarius generalis provincie coesistente col provinciale? locum provincialis teneatpuò supporre anche assenza, non necessariamente vacanza del provinciale? AGOP IV.10, f. 83v (22.V.1494): «magister Iohannes Caroli de Florentia fit vicarius generalis provincie in absentia provincialis».
Firenze 6 settembre 1402. Priore e capitolo conventuale di Santa Maria Novella (tot. 29 capitolari) nominano procuratori: «magistrum Lionardum Stagii, magistrum Michaelem ser Tini, magistrum Ubertinum Bartholomei de Albiçis, fratrem Çenobium magistri Francisci, fr. IacobumBanchi, fr. Iohannem ser Gini, fr. Francischum Iohannis, fr. Petrum Tori, fr. Filippum Maçuoli, fr. Petrum Nicholiet fr. Pinuccium Iohannis de Chortonio, omnes fratres dicte ecclesie» (ASF, NA 1760, ff. 91r-92r); magistrum Michaelem ser Tini, senz'altro titolo, tra i procuratori eletti, non nella lista dei capitolari.
23 novembre 1402. C’è un provinciale romano in carica, innominato: TOMMASO D'ANTONIO, Tractatus de ordine fratrum et sororum…, ed. cit. 58-59.
Firenze 31 gennaio 1403 (31.I.1402 indiz. XI, stile fiorentino) «magistro Federigo de Fulgineo provinciali Romane provincie OP»: A. GHERARDI, Statuti della Università e Studio fiorentino dell'anno MCCCLXXXVII, Firenze 1881, 377-78 (ed. e regesto dei testi conservano stile originale,
preavverte Pref. XX). PIANA 30 cita sotto data 31.I.1402; correttamente Necr. II, 137 n. 19.
2 aprile 1403, muore Onofrio Trinci vescovo folignate: G. ROTONDI, Federico Frezzi. La vita e l’opera, Todi 1921, 123. Medesima data anche in HC I, 256. ■ Ma Mario Sensi, in «Bollettino storico della Città di Foligno» 12 (1988) 104 n. 7, segnala registro di notaio vescovile: «ultimo atto, presente il vescovo Onofrio, reca la data 6 novembre 1403». Ne vengo a conoscenza in genn. 2007.
Firenze 1 settembre 1403, capitolo di Santa Maria Novella. «Magister Lionardus <Stagii> prior una cum eis, asserens se habere licentiam et mandatum a patre < . . . >[4] provinciali totius dicti ordinis…, considerantes fr. Iacobum Angeli de Florentia, fratrem dicte ecclesie SMN et dicti ordinis sancti Dominici, ex certis iustis et rationabilibus causis dicto domino priori expressis et per ipsum fr. Iacobum enarratis et maxime quia videt quodalibi vitam suam et quoad fructum anime melius poterit profi<ci>sci, ex causis ut predicitur expositis, velle adartiorem vitam vel saltem parem transire, ingredi, et se a dicta ecclesia… et conventu segregari», danno consenso,per quanto loro spetta, a che fr. Iacopo di Angelo possa tornare al suo primitivo stato legale, rientrare in pienodiritto d'ogni suo bene, passare ad altra regola. ASF, NA1761, ff. 63r-64r; frati capitolari del conv. fiorentino,tot. 21.
Roma 16 novembre 1403, Bonifacio IX. ASV, Reg. Later. 112, f. 215r-v: «Bonifacius etc. dilecto filio Frederico de Fulgineo electo fulginat(i)[5] salutem etc. (…) Dudum siquidem bone memorie Honofrio episcopo fulginate regimini ecclesie fulginatis romane ecclesie immediate subiecte presidente, nos, cupientes ipsi fulginati ecclesie cum vacaret per apostolice sedis providentiam utilem et idoneam presidere personam, provisionem eiusdemecclesie ordinationi et dispositioni nostre duximus ea
vice specialiter reservandi… Postmodum vero dicta ecclesia per[6] ipsius Honofrii obitum qui extra romanam curiam clausit extremum vacante, nos vacationi huiusmodi fidedignis relatibus intellecta, ad provisionem ipsius ecclesie celerem et felicem de qua nullus preter nos ea vice se intromittere potuerit[7] sive p(ossi)t reservatione et decreto obsistentibus supradictis, ne ecclesia longeva vacatione exponeretur… post deliberationem… diligentem demum ad te ordinis fratrum Predicatorum professorem, in sacra theologia magistrum etin sacerdotio constitutum, direximus oculos nostre mentis… teque illi preficimus in episcopum et pastorem, curam et administrationem ipsius ecclesie… plenarie committendo (…). Datum Rome apud Sanctum Petrum sextodecimo kalendas decembris anno quinto[8] decimo». Diffondono date errate F. UGHELLI, Italia sacra, ed. 2a, cura Nicolai Coleti, Venetiis 1717-22, I, 702 (17.X.1403 senza esplicita indicazione di fonte; sezione di testo risalente all'ed. originale Romae 1644-62); Bullarium ordinis fratrum Praedicatorum, Romae 1729-40, II, 453, pubblicatesto di Reg. Later. 112 (da copia in "Archivo Ordinis") con data annua 16.XI.1402, «anno quarto decimo», dando origine a una lunga tradizione inquinata. Frastornato MASETTI, Monumenta I, 402, 408; II, 323. In HC I, 256 (16.XI.1403) "Bon. IX, a. 15, Lat. litt. 160 f. 216" è l'odierno ASV, Reg. Later. 112, f. 215r-v (216 dell'antica foliazione); nessun indizio dunque d'unaseconda lettera papale circa la nomina (non "conferma d'elezione") episcopale.
Roma 16 novembre 1403, Bonifacio IX. ASV, Reg. Later. 112, f. 215r-v, immediatamente dopo la precedente lettera indirizzata a Federico, seguono: (2) «Simili modo: Dilectis filiis capitulo ecclesie fulginati… Datum ut supra. (3) Simili modo: Dilectis filiis clero civitatis et diocesis fulginatis… Datum ut supra. (4) Simili modo: Dilectis filiis populo civitatis et diocesis fulginatis… Datum ut supra». Comunica nomina
episcopale di Federico ai rispettivi destinatari. PIETRO CANNETI, Dissertazione apolologetica, in FEDERIGO FREZZI, Il Quadriregio, ed. Foligno 1725, vol. I in fine, paginaz. propria 26-27, pubblica diploma folignate, dalladata cronica «XVI kal. decembris… anno quintodecimo» (= 16.XI.1403); diploma "in extenso" corrispondente all'imbreviatura (4) di Reg. Later. 112, f. 215r-v.
Roma 21 novembre 1403, Bonifacio IX. ASV, Reg. Later. 112, f. 223r-v: «Bonifacius etc. dilecto filio Frederico electo fulginati salutem (…). Datum Rome… undecimo kalendas decembris anno quinto decimo». Il papa aveva assegnato ilmonastero benedettino Santo Stefano a Parrano (dioc. Nocera Umbra) in commenda a Onofrio vescovo di Foligno dopo dichiarazione dell'abate Nicola di rinuncia ai diritti; ora l'assegna al nuovo vescovo Federico. Letteredel medesimo tenore indirizzate al monastero in questionee al vescovo nocerino.
Roma 22 novembre 1403. Bartolomeo degli Acerbi da Perugia OP, vicario d'Italia, «narrat de quampluribus, utpote de electione provincialis romani ad episcopatum fulginatensem et institutione vicarii Romane provincie» (TOMMASO D'ANTONIO, Tractatus 73).
Foligno 17 gennaio 1404. Primo atto legale del neo eletto vescovo folignate Federico registrato dal notaio vescovile: M. Sensi, «Bollettino storico della Città di Foligno» 12 (1988) 104 n. 7.
Roma 10 febbraio 1404. Lettera di Bartolomeo degli Acerbi «in qua inter alia scribit qualiter expectatur unus vicarius magistri ordinis pro provincia Romana… Etiam narrat ibidem qualiter provincialis romanus vult tenere provincialatum usque ad consecrationem suam» (TOMMASO D'ANTONIO, Tractatus 82-83).
Foligno 10, 13 e 17 febbraio 1404. Federico riceve pubblicamente da Ugolino dei Trinci signore della città le lettere apostoliche di nomina a vescovo (10.II), prende possesso della sede e casa episcopale (13.II); e (17.II) «in sua consecratione iuravit… iuxta formam
iuramenti litterarum apostolicarum» (atti ufficiali rogati dal notaio, ed. ROTONDI, Federico Frezzi 126-27; «Bollettino storico della Città di Foligno» 12 (1988) 104-05n).AA.VV., Il vescovo e il notaio. Regesti e trascrizioni dai protocolli (1404-1410) di Francesco d'Antonio, notaio del vescovo Federico Frezzi daFoligno, Spello 2011.
Roma 1 marzo 1404. Lettera di Bartolomeo degli Acerbi vicario d'Italia: «finaliter dicit qualiter provincialis romanus dominica prima in quadragesima consecratus est inepiscopum fulginaten.» (TOMMASO D'ANTONIO, Tractatus 85). dominica prima in quadragesima = 17.II.1404 anno bisestile
Firenze 27 aprile 1404. Giovanni di Domenico da Firenze OP scrive a Tommaso d'Antonio da Siena OP: «noveritis, sine fallo, fratrem Bartholomeum, vicarium Ytalie, nostre Romane provincie priorem futurum, ad cuius electionem cumcapitulo ordinandam Cortonii septima iunii ante mensem mittor…» (TOMMASO D'ANTONIO, Tractatus 87). M.-T. CASELLA - G. POZZI, B. Giovanni Dominici OP. Lettere spirituali, Friburgo 1969, 177: «ora mi conviene… andare a Cortona dove si fa capitolo provinciale e debesi elegere il nostro frate reverendo padre degli A<cerbi>». Lungimiranza o elezione predefinita?
Cortona giugno 1404. «Ego fr. Bartolomeus de Acerbis de Perusio fui factus provincialis romanus anno Domini M°cccc°iiij° de mense iunii in conventu cortoniensi in capitulo provinciali, et repperi infrascriptos libros et non plures, quos assignavit michi magister Federichus de Fulgineo nunc episcopus fulginas» (Liber privilegiorum f. 4v).Cortona 15 giugno 1404, lettera da Bartolomeo «non amplius vicario sed provinciali romano noviter creato»: TOMMASO D'ANTONIO, Tractatus 88. Lista capitolare del convento San Domenico in Cortona 14.VI.1404, quorum legale due terzi nella tradizione cittadina: «fratre Marsilio <olim Iacobi de Senis priore> predicto, fr. Andrea Ducii subpriore [= Cr
SMN n 630?], fr. Iohanne domine Geve [Gene?] de Cortona,fr. Andrea olim Iohannis de Palaria districtus Pisarum, fr. Christofaro Nicolai de Yanua, fr. Iacobo Iacobi de Pisis, fr. Petro Antonii[9], fr. Bartholomeo Leonardi[10], fr. Michaele Restori[11], fr. Blaxio Silvestri [Cr SMN n° 628], fr. Petro olim Petri et fr. Dominicho Nicolai de Florentia, fratribus in dicto ordine professis et conventualibus dicti loci»; priore e capitolo nominano loro procuratore «fr. Alanum olim Angeli Nucii de Cortonadicti ordinis et conventualem dicti loci» (ASF, NA 18906 (già S 474), ff. 73r-74r, 2° fascicolo, dal primo atto a nativitate 19.XI.1403 ind. XI; il 3° fasc. f. 93r inizia a nativitate 11.IV.1405 ind. XIII). Correggi data "14.VI.1405"e onomastica in S. ORLANDI, S. Antonino, Studi bibliografici I, Firenze 1959, 32, debitore a R. MORÇAY, Saint Antonin, Tours-Paris 1914, 28.
Giovanni di Domenico da Firenze OP, Tractatus de proprio (1401-04), manifesto teologico-disciplinare della riforma conventuale. Composto in risposta alla consultazione teologica promossa dal provinciale Federico da Foligno? «tu pater proponis sacrae sophiae magistris, subditis tibi Romanae provinciae, et michi cum illis discipulo nequaquam perito, an liceat fratribus Praedicatoribus in communi vel particulariter possessiones habere»: G.M. LÖHR, Die Mendikantenarmut im Dominikanerorden im 14. Jahrhundert, «Divus Thomas» (Freib.) 18 (1940) 418. In p. 417 Löhr stabilisce la composizione del Tractatus tra 1401 e 1 ottobre 1404, decesso di Bonifacio IX; identificato poi l'anonimo "provinciale" con Federico Frezzi sull'insospetto inizio 1400 del provincialato di costui, restringe di conseguenza il termine ante: «der <Fridericus> im August 1400 gewählt und am 16. Nov. 1403 Bischof von Foligno wurde. Damit ist der Termin der Abfassung des Traktates näher auf die Jahre 1401-1403 festgelegt» (417 n. 2). Passato a R. CREYTENS, L’obligation des constitutions dominicaines d’après le Bx. Jean Dominici O.P., AFP 23 (1953) 197: tra 1401 e 1403 «à la demande de
Frédéric Frezzi de Foligno, provincial romain». SOPMÆ II, 409 § 2283.
Non così stringente siffatta identificazione, a ripercorrere i punti fermi della nostra cronotassi. Per molteplici dissonanze. Anzitutto Giovanni non parla di provincialis ma di pater e subditis, che conviene anche a un vicario. L'elezione di Federico a provinciale va certamenteretrocessa a dopo il 14 agosto 1401; forse da rinviare ad autunno 1402. Provincialato breve, il suo, affollato di vicariati. Anche a ridosso della nomina episcopale, il vicario d'Italia Bartolomeo degli Acerbi raccoglie la voce «de institutione vicarii Romane provincie» (22.XI.1403); prevalse l'intenzione di Federico d'esercitare in pieno l'ufficio provincializio «usque ad consecrationem suam» (17.II.1404)? La chiusa infine di art. V del Tractatus de proprio, là dove il riformatore Giovanni torce sbrigativamente la grazia evangelica in coazione legale: «Ergo tu, pater, qui olim ob amorem pauperrimi Crucifixi opes deseruisti multas et pingues, possessionibus renuntiare coge subditos tuos, ne alieno malo dampneris» (ed. CREYTENS, L’obligation 235). A chi si addice? La miglior biografia di Federico confessa di nulla sapere sulla sua famiglia: del cognome "Frezzi" non v'è traccia alcuna, nessun membro notabile nella storia civile di Foligno, assoluta oscurità delle origini e vicende (ROTONDI, Federico Frezzi 11-12). In realtà tutte le testimonianze a disposizione convergono in Fridericus Fricci (Frizzi, Frecci ecc.), mai de Friccis, de Frizzis (inequivoca flessione grammaticale di ceppo familiare); che rilancia l'interpretazione già del Salvini (cf. ROTONDI 12 n. 4) d'un genitivo patronimico anziché cognominale: Fricci ipocoristico vernacolare di Federico? Una recente testimonianza lucchese: «Federicus quondam Federici de Fulgineo prior» (16.III.1384): VERDE-CORSI 378; cioè "Federico figlio del fu Federico da Foligno". Ma a parte l'antroponimia, il prelato interlocutore del De proprio aveva abbandonato opes multas et pingues quando entrato religione. Di famiglia notabile. Federico da Foligno? O non piuttosto il fiorentino Michele
di ser Tino della Casa? «tam progenitorum meritis quam virtutibus propriis toti florentino populo gratus», a dettadei priori cittadini (PIANA 57; cf. Necr. II, 112 n. 158).
■ giunta. C. DEL GIUDICE – P. MONACCHIA, Le pergamene due-trecentesche del convento di S. Domenico e del monastero di S. Giuliana di Perugia, Perugia 2000, 75 n° 94 «fr. Federico Federici de Fulgineo» (Perugia 20.VII.1375); 96 n° 135«fr. Frederici Freççi … vicarii provincialis» (Perugia20.IX.1392), 254b, 256a. Preziosa conferma della testimonianza lucchese surriportata; e prezioso incastro antroponimico: "Federico (figlio) di Federico", oppure "Federico di Frezzo".21.VI.2014. DHN 20 (2011) pp. 211-212.
Sui della Casa: M. CASSANDRO, Per una tipologia della struttura familiare nelle aziende toscane dei secoli XIV, XV, AA. VV., I ceti dirigenti nella Toscana tardo comunale, Firenze 1983, 29-30 e n. 32 rinvia a: id., Due famiglie di mercanti fiorentini: i della Casa e i Guadagni, «Economia e storia» 21 (1974) 289-308. G. BRUCKER, Dal Comune alla Signoria. La vita pubblica a Firenze nel primo Rinascimento, Bologna 1981, 351 n. 44. Alle bocche della piazza, Diario di anonimo fiorentino (1382-1401), a c. di A. Molho e F. Sznura, Firenze 1986, 184 (Attaviano di ser Tino della Casa, 1396).
Sconosciuto alle fonti conventuali fr. Marianus della Casa deFlorencia OFP che nel 1434 ottiene licenza papale di passare all'ordine di San Benedetto: ASV, Reg. Suppl. 297, f. 43v (Eugenio IV, Firenze 24.VII.1434).
[4] Spazio destinato al titolare del provincialato e lasciato bianco nell'originale.
[5] fulginat(i): qui e di seguito altri scioglievano fulginat(ensi), chesuppone il compendio fulginaten. Aggetivo etnico fulginas -tis in RD Umbria I, 323; II, 60-61.
[6] per: obitum sequ.
[7] potuerit in parte sotto macchia e d'incerta lettura; riprendo la formula potuerit sive possit da altri ricorsi in formulari affini
[8] Solo a lettura frettolosa leggibile quarto. Tutto il registro dell'anno quinto decimo. Regolare la successione cronologicaprecedente e susseguente.
[9] = fr. Petrus Antonii Cecchi de Florentia: SOPMÆ IV, 224; il suo noviziato cortonese dovrà essere anticipato almeno al 1403.
[10] = fr. Bartholomeus Leonardi de Monte Rappoli: Cr SMN n° 640; Libri di ricordanze, MD 26 (1995) 349-52, 526b.
[11] «fr. Michaele Michaelis Restori de Florentia»: ASF, NA 18906, ff. 159v-160r (Cortona 11.I.1406). Cr SMN n° 600.
finis
http://www.e-theca.net/emiliopanella/governo/vade.htm
http://archivio.smn.it/emiliopanella/governo/vade.htm