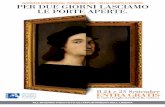IL PAESAGGIO DELLA PIANURA PONTINA: EVOLUZIONE STORICA E SCENARI DI RECUPERO
Transcript of IL PAESAGGIO DELLA PIANURA PONTINA: EVOLUZIONE STORICA E SCENARI DI RECUPERO
LAZIO TRA LE DUE GUERREMiscellanea storica del territorio
PALOMBI EDITORI
€ 39,00Lazio
trale
dueG
uerre
Un progetto editorialedi Alessandra Maria Sette
© 2007Tutti i diritti spettano aPalombi & Partnervia Timavo, 1200195 Roma
Progettazione, realizzazione graficae assistenza redazionalea cura della Casa Editrice
ISBN 978-88-6060-113-1
In copertinaDemolizione della torretta del Quadraro e edificazione del municipio di Littoria, 1932(Archivio Consorzio di Bonifica dell’Agro pontino - Fondo Bortolotti)
La macchina a vapore inglese Fowler usata per la prima volta nella Campagna romana(Archivio Associazione “99 fontanili”)
La casa editrice si impegna a soddisfare eventualirichieste di aventi diritto sulle immagini pubblicateladdove non fosse riuscita a raggiungerli
REGIONE LAZIOAssessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport
Assessore alla Cultura, Spettacolo e SportGiulia Rodano
Direttore Regionale Beni e Attività Culturali, SportEnzo Ciarravano
Dirigente Area Valorizzazione del Territorio edel Patrimonio CulturaleFlaminia Santarelli
Dirigente Ufficio Valorizzazione eSviluppo del Patrimonio CulturaleClaudio Cristallini
Responsabile LR 27/2001Luigi Prisco
PROVINCIA DI ROMA
Assessorato alle Politiche Culturali,della Comunicazione e dei Sistemi Informativi
Assessore alle Politiche Culturali,della Comunicazione e dei Sistemi InformativiVincenzo Maria Vita
Direttore Dipartimento Beni Servizi e Attività CulturaliGiuliana Pietroboni
Responsabile U.O. Attività CulturaliGiovanni Aiello
Testi diFederico CalzolariCarlo Fabrizio CarliLuisa ChiumentiMaria Teresa CutrìGiuseppina GhiniStefano GizziAntonella GrecoAlfredo PasseriLuigi PriscoSimone QuiliciLuigina Romaniello
ArchiviConsorzio di Bonifica dell’Agro pontinoArchivio Associazione “99 fontanili”Archivio fotografico - Fondo Giovanni BortolottiArchivio Novecento - LatinaArchivio Storico Quadriennale, RomaArchivio Ucelli - SBALArchivio Carli
9
INTRODUZIONE 11Luigi Prisco
Architetture “effimere” a Roma e nel Lazio tra le due guerre.Il ruolo dell’allestimento di mostre e spettacoli 15
Carlo Fabrizio Carli
Valorizzazione e rifunzionalizzazione di siti archeologicie architettonico-urbanistici lungo il percorso delle vie consolari 29
Luisa Chiumenti
Il Museo delle navi romane a Nemi 37Giuseppina Ghini
Rilettura di un’architettura di Ballio Morpurgo:il Museo delle navi romane 51
Stefano Gizzi
Il paesaggio della pianura pontina:evoluzione storica e scenari di recupero 67
Simone Quilici
Nascita di Ostia Nuova: il doppio di Roma al mare 89Antonella Greco
La forma della città moderna 109Luigina Romaniello
INDICE
a pianura pontina è stata oggetto di tentativi di bo-nifica che risalgono, come noto, al Cinquecento – se si esclu-de l’epoca romana – ma è stata definitivamente modificatain età contemporanea, più precisamente tra la seconda metàdegli anni Venti e la prima metà degli anni Trenta. In que-sto stretto periodo di tempo si è realizzata una trasformazio-ne radicale di un’ampia porzione del paesaggio laziale. Lepaludi e le immense foreste planiziali, di cui rimane un pic-colo lembo nel Parco nazionale del Circeo, hanno lasciato,nell’arco di pochi anni, il posto ad ampi spazi coltivati, de-limitati ed inquadrati da una trama ortogonale di strade, ca-nali e filari di eucalipti.
«[…] Il disegno delle colture agricole ha dato alla pia-nura una trama come di tessuto ruvido che la lucefa risaltare nelle sue latenti geo-metrie in netto contrasto conl’imprevedibile, disordinatoapparire di stagni e vened’acqua naturali, che anco-ra punteggiano le pendicidelle montagne, prima digiungere a quella linea do-ve il movimento delle acqueè imbrigliato e la trama ri-lucente diventa anch’essageometrica.
Una nuova bellezza, quindi, prodotta dal lavoro, che delresto rievoca tempi ancor più remoti, quando le acque nonavevano ancora generato le paludi e l’agricoltura aveva persecoli garantito l’equilibrio utilizzando le risorse idriche perfinalità produttive. Uno spettacolo, quello della pianura pon-tina, della “Città Pontina” che ci ricorda che non c’è geo-grafia senza storia e che un paesaggio con i suoi equilibri,anche quando muta profondamente la sua apparenza tieneferme certe caratteristiche che ne costituiscono, per così di-re, lo scheletro resistente»1.
67
IL PAESAGGIO DELLA PIANURA PONTINA:EVOLUZIONE STORICA E SCENARI DI RECUPERO
Simone Quilici
Lestra a Molinadelle Capre, 1928
(Archivio Consorzio diBonifica dell’Agro pontino -
Fondo Bortolotti)
L
LAZIO TRA LE DUE GUERRE - MISCELLANEA STORICA DEL TERRITORIO
Il paesaggio naturale preesistente alla bonifica è sche-maticamente riconducibile a tre fasce legate alla morfolo-gia del territorio2 ancora oggi parzialmente riconoscibili,nonostante le pesanti alterazioni della bonifica. Una primafascia costiera, particolarmente vulnerabile e oggi minac-ciata e in gran parte compromessa dall’urbanizzazione dellitorale, formata dalle dune recenti, alte fino a venti metrie ricoperte dalla macchia mediterranea, alle spalle dellequali si sviluppa un sistema di quattro laghi dalla forma al-lungata parallelamente alla costa, residuo di un’antica la-guna costiera. La seconda fascia è costituita dalla pianurainterna, collocata ad una quota tra i 20 e i 40 metri s.l.m.e il cui suolo è formato dalle dune quaternarie, che era ri-coperta da fitti boschi, oggi superstiti solamente all’inter-no del parco del Circeo. La terza fascia, compresa tra lapiana interna e i Monti Lepini, era quella più intensamen-
te interessata dal fenomeno dell’impaludamento, in quan-to posta a quota più bassa e con sorgenti situate ai piedidei rilievi calcarei.
Questo paesaggio originario era ancora pienamente ri-conoscibile agli inizi del Novecento.
«Colpiva, e colpisce tuttora, la lettura delle cartografiedell’Istituto Geografico Militare (IGM). La prima, tardo ot-tocentesca, riferita a Cisterna, evidenzia il carattere palu-doso e quasi inabitato del territorio in cui sarebbe sorta di lìa cinquant’anni, Littoria, città di fondazione. Un territorioincorniciato dalla duna (che lo separa dal mare) e dai primirilievi appenninici; ricco d’acqua e ancor più ricco di ac-quitrini. Ma anche bosco e macchia che si intercalano al se-gno modesto della presenza umana: tracce di capezzagne,mentre l’Appia quasi scompare. Un territorio “romantica-mente” suggestivo nelle vedute pittoriche di fine Ottocento,
68
Allagamento presso il Quadrato, 1928 (Archivio Consorzio di Bonifica dell’Agro pontino - Fondo Bortolotti)
IL PAESAGGIO DELLA PIANURA PONTINA: EVOLUZIONE STORICA E SCENARI DI RECUPERO
senz’altro di maniera, ma anche vero – autentico – nella lu-ce dorata del tramonto»3.
Sul paesaggio naturale si sono sovrapposte nel tempo nu-merose tracce dell’attività umana. Il segno antropico per ec-cellenza del paesaggio pontino è costituito dal tracciato del-la via Appia, prima via militare costruita ex novo dai Ro-mani e prima via censoria. Fu realizzata nel 312 a.C. – nelperiodo della seconda guerra sannitica e della conquista ro-mana della Campania – dal censore Appio Claudio Cen-temmano, detto il Cieco, per congiungere Roma con Capua– allora terza città della penisola in ordine di grandezza, do-po Roma e Taranto – entrata nel 340 a.C., durante la primaguerra sannitica, in lega con Roma. La funzione originariadell’Appia fu infatti quella di congiungere – ancora primadi collegare secondo una logica strategica – i centri che l’e-spansione militare di Roma, a partire dalla prima guerra san-
nitica (342 a.C.), aveva sottoposto al proprio dominio. I con-giungimenti avvennero per fasi. Prima rettificando tratti esi-stenti, ricalcando soprattutto lungo i tratti montani dell’Ap-pennino irpino e lucano antiche vie di transumanza dell’I-talia centro-meridionale, poi potenziando il tracciato colle-gandolo con le colonie maritimae di Minturno e Sinuessa,poi, ancora, da Capua a Taranto, attribuendogli un ruolo disupporto allo sfruttamento dei territori appena conquistati.Infine, prevalendo Brindisi come sbocco marittimo, la me-tropoli Taranto-Taras, venne sostituita dal nuovo porto di col-legamento della penisola con l’Oriente.
In termini generali, l’intersezione della linea di una stra-da con i segni del palinsesto paesaggistico – come strade mi-nori, canali, filari o siepi – determina una vasta serie di for-me più o meno complesse nel territorio. Nel caso dell’Appiail rapporto della strada con il paesaggio è notevolmente dif-
69
Ponte sul fiume Cavata a Foro Appio, 1928 (Archivio Consorzio di Bonifica dell’Agro pontino - Fondo Bortolotti)
LAZIO TRA LE DUE GUERRE - MISCELLANEA STORICA DEL TERRITORIO
70
Apertura stradale della litoranea presso il vallone San Giuseppe, 1931(Archivio Consorzio di Bonifica dell’Agro pontino - Fondo Bortolotti)
IL PAESAGGIO DELLA PIANURA PONTINA: EVOLUZIONE STORICA E SCENARI DI RECUPERO
71
Escavatori sul canale delle Acque Alte presso il Fosso di Campomaggiore, 1930(Archivio Consorzio di Bonifica dell’Agro pontino - Fondo Bortolotti)
LAZIO TRA LE DUE GUERRE - MISCELLANEA STORICA DEL TERRITORIO
72
Demolizione della torretta del Quadrato e edificazione del municipio di Littoria, 1932(Archivio Consorzio di Bonifica dell’Agro pontino - Fondo Bortolotti)
IL PAESAGGIO DELLA PIANURA PONTINA: EVOLUZIONE STORICA E SCENARI DI RECUPERO
73
Ponte Novella in costruzione sul rio Martino, 1930(Archivio Consorzio di Bonifica dell’Agro pontino - Fondo Bortolotti)
LAZIO TRA LE DUE GUERRE - MISCELLANEA STORICA DEL TERRITORIO
74
Strada Migliara 49 a lato della Selva di Sabaudia, 1934(Archivio Consorzio di Bonifica dell’Agro pontino - Fondo Bortolotti)
Ponte della via Appia sul collettore delleAcque Alte, 1934 (Archivio Consorzio diBonifica dell’Agro pontino - Fondo Bortolotti)
ferenziato, se ci si allontana dalla pianura pontina e si con-sidera l’intero tracciato da Roma a Brindisi: in molti trattil’Appia taglia i segni del territorio, in altri li asseconda, inaltri ancora ne costituisce la traccia ordinatrice. Vi sono inol-tre numerosi casi in cui il palinsesto paesistico ha cancel-lato la strada stessa o vi ha sovrapposto nuovi elementi, insintonia o in contrasto con la traccia sottostante.
L’esempio del tracciato della via Appia nell’Agro pon-tino è un caso significativo di strada che taglia in diago-nale con un unico rettifilo, per motivi di massima rapiditàdi percorrenza da parte delle truppe romane, la strutturaagraria a maglie ortogonali di epoca precedente: la centu-riazione romana, che era disposta secondo un orientamen-to nord-sud ed est-ovest e ruotata di 45 gradi rispetto altracciato della strada. La successiva opera di bonifica pon-tificia che comportò la realizzazione delle “miliare” – in-siemi di canale e strada posti ortogonalmente alla via Ap-
pia alla costante distanza di un miglio – costituisce inve-ce un esempio di come la strada abbia costituito la tracciaordinatrice della nuova strutturazione agraria dalla carat-teristica forma “a pettine”, che cancellò quella di epocaromana, ruotata di 45 gradi rispetto alla nuova. È interes-sante notare come la bonifica di epoca fascista abbia ri-preso ed esaltato, nell’impianto generale, la struttura del-le “miliare”, proseguendo alcune di queste fino alla fasciacostiera di Latina e Sabaudia.
In numerosi casi l’inserimento di nuovi elementi costi-tutivi dei caratteri del paesaggio ha esaltato il segno dellastrada. È questo il caso, ad esempio, della piantata a dupli-ce filare degli olmi effettuata nell’Agro pontino all’epoca deirestauri tardo-settecenteschi della via Appia. Verso la finedegli anni Venti, all’epoca della costituzione dell’Aziendaautonoma statale delle strade e dell’adeguamento della viaAppia come Strada Statale n. 7, agli olmi si sostituirono, in
IL PAESAGGIO DELLA PIANURA PONTINA: EVOLUZIONE STORICA E SCENARI DI RECUPERO
75
Canale delle Acque Medie con il ponte della strada Dormigliosa-Mazzacornuta, 1933(Archivio Consorzio di Bonifica dell’Agro pontino - Fondo Bortolotti)
Podere n. 169dell’Opera Nazionale Combattentiassegnato ai nuovi coloni, 1933(Archivio Consorzio di Bonificadell’Agro pontino - Fondo Bortolotti)
LAZIO TRA LE DUE GUERRE - MISCELLANEA STORICA DEL TERRITORIO
76
Interno dello stabilimento idrovoro di Mazzocchio, 1934 (Archivio Consorzio di Bonifica dell’Agro pontino - Fondo Bortolotti)
IL PAESAGGIO DELLA PIANURA PONTINA: EVOLUZIONE STORICA E SCENARI DI RECUPERO
77
Stabilimento idrovorodi Mazzocchio, 1934
(Archivio Consorzio di Bonificadell’Agro pontino - Fondo Bortolotti)
Sostegno attraverso il canaledelle Acque Medie, 1938
(Archivio Consorzio di Bonificadell’Agro pontino - Fondo Bortolotti)
Canale Allacciante Astura, 1935(Archivio Consorzio di Bonifica
dell’Agro pontino - Fondo Bortolotti)
LAZIO TRA LE DUE GUERRE - MISCELLANEA STORICA DEL TERRITORIO
linea con la retorica fascista del mito dell’antica Roma, i pi-ni che ancora oggi fiancheggiano la strada4.
Altre piantate di alberi tuttavia caratterizzano ancora piùfortemente il paesaggio pontino: è il caso dei filari di euca-lipti che dividono gli appezzamenti e che fiancheggiano lestrade e i canali della bonifica fascista. Questo tipico ele-mento del paesaggio costituisce il raccordo tra le varie com-ponenti del palinsesto antropico, caratterizzato dalla sequenzacittà di fondazione-borghi rurali-poderi.
La prima città di fondazione fu Littoria, realizzata nel1932 come nucleo urbano di servizio ai poderi limitrofi. Erasituata in una posizione baricentrica rispetto all’area di bo-nifica ed era collegata alla via Appia, alla ferrovia, a Cisternae al mare da una raggiera di strade lungo le quali era situa-ta la maggior parte dei borghi agricoli, nati come villaggioperai per i lavori di bonifica5.
«Se si guarda la mappa IGM del 1932, si nota (pur nel-l’astrattezza del disegno topogeografico) come anche l’im-pianto di Oriolo Frezzotti – già impresso nella carta conte-
stualmente alla sua costruzione – voglia radicarsi ad alcunitracciati preesistenti e presenti nella mappa ottocentesca,senza rinunciare a un disegno geometrico, quanto comples-so. Una forma chiusa. Un perimetro che, al contrario del sol-co tracciato dal mitico aratro d’argento per fondare Roma,invece di chiudere si apre verso la campagna. […] In breve,Littoria è una città di campagna, costruita ex novo in un con-testo agricolo organizzato ma non “urbanizzato”. È impor-tante sottolineare questo aspetto. La rete di strade, l’orditu-ra dei “borghi”, alcune preesistenze, la città stessa, restanoancorate alla campagna, alla terra che non sarà mai del tut-to bonificata»6.
Altre quattro città di fondazione sorsero nel giro di po-chissimi anni nell’Agro pontino e nella Campagna romana asud della città7, collegate dall’infrastrutturazione principale,costituita dalla via Appia, dalla via Litoranea e dalla via Me-diana, che dal 1937 si decise di agganciare al tracciato del-la via Imperiale che doveva collegare Roma con il quartieredell’Esposizione Universale prevista per il 1942 e il mare.
78
Littoria, completamento del nucleo urbano centrale visto dal campanile della chiesa, 1934(Archivio Consorzio di Bonifica dell’Agro pontino - Fondo Bortolotti)
IL PAESAGGIO DELLA PIANURA PONTINA: EVOLUZIONE STORICA E SCENARI DI RECUPERO
79
Il canale delleAcque Alte sotto Norma
(foto S. Quilici)
Il canale delleAcque Alte verso la foce
(foto S. Quilici)
Il canale delle Acque Alte(foto S. Quilici)
LAZIO TRA LE DUE GUERRE - MISCELLANEA STORICA DEL TERRITORIO
La rete delle strade e l’orditura dei borghi e dei poderirispondevano a criteri sia urbanistici che agricoli. La strut-tura territoriale predisposta dai consorzi di bonifica e dal-l’Opera Nazionale Combattenti era costituita da maglie qua-drate che racchiudevano unità poderali dalla superficie me-dia di circa 20 ettari. Un determinato numero di unità fa-ceva riferimento ad un centro aziendale, collegato ai borghiagricoli.
Tuttavia il paesaggio della bonifica era ed è segnato, an-cor più che dalla trama dei poderi della bonifica agricola,dalle linee dei corsi d’acqua naturali, come il fiume Sisto, edei canali principali e secondari della bonifica idraulica. Ilavori di sistemazione idraulica furono più complessi di quel-li stradali. Con il progetto Marchi (1918) si impostò la riso-luzione dello scolo delle acque interne mediante la realiz-zazione di tre collettori principali, a cui si sarebbero rac-cordati i canali secondari: il canale delle Acque Alte, rino-minato “canale Mussolini”, il canale delle Acque Medie equello delle Acque Basse. Il primo si formava a monte del-
le sorgenti di Ninfa e convogliava le acque superiori che in-cludevano il fiume Astura, con sbocco a Foce Verde. Il ca-nale delle Acque Medie, che si sviluppa per 32 chilometri,partendo da Ninfa perpendicolarmente ai monti Lepini pie-ga poi nei pressi di Littoria e si innesta nel rio Martino, ilquale sfocia in mare con un porto canale che fiancheggia illago di Fogliano. Chiuse di sbarramento lungo il percorsoconsentono l’uso delle acque per irrigare i poderi limitrofi.A sud, quasi in parallelo, c’è il collettore delle cosiddetteAcque Basse, lungo 27 chilometri, che nasce anch’esso dal-le sorgenti appenniniche nei pressi di Ninfa e che conflui-sce nel fiume Ninfa per poi diventare fiume Sisto.
Lungo i canali minori furono realizzati diversi manufattiidraulici per il sollevamento dell’acqua: tra questi di note-vole importanza è l’idrovora di Mazzocchio, realizzata nel1934 nel territorio di Pontinia, che al momento della sua rea-lizzazione era la pompa ad elica più potente d’Europa.
«L’acqua, magari mefitica, infetta di miasmi come la raf-figura Cambellotti, era una presenza determinante nella pa-
80
Il canale delle Acque Alte a Foce Verde (foto S. Quilici)
IL PAESAGGIO DELLA PIANURA PONTINA: EVOLUZIONE STORICA E SCENARI DI RECUPERO
minima parte del territorio. L’unica eccezione è costituitadalle fasce di rispetto previste dalla legge Galasso relativeal litorale, ai laghi costieri e ai corsi d’acqua. Una presso-ché totale assenza di vincoli è invece riscontrabile nell’en-troterra dell’Agro pontino, il cui valore storico-paesaggisti-co legato all’attività di bonifica svolta sin dal Cinquecentonon è ancora stato riconosciuto.
Le uniche aree sottoposte a un particolare regime di tu-tela sono quelle del monumento naturale di Ninfa, dove ori-gina la gran parte del fitto reticolo idrico dell’Agro ponti-no, e del Parco nazionale del Circeo, che occupa gran par-te della fascia costiera dei territori di Sabaudia e di Lati-na. Su questa area vigono, fino all’approvazione del pianod’assetto del Parco, le disposizioni contenute nelle normedei piani territoriali paesistici vigenti9 relativamente ai di-versi livelli di tutela, nonché quelle contenute nel regola-mento del Parco.
Da questa osservazione può derivare l’ipotesi di indi-viduazione di “corridoi ecologici” che colleghino la fascia
81
lude. Ancor più determinante con la Grande Bonifica, in cuiviene “strutturata” organizzata e resa “produttiva” con i col-lettori. L’acqua, dunque, è sempre stata una presenza in-trinseca a questa terra. Solo negli ultimi decenni ha perdu-to il suo ruolo. È stata accantonata; è ritornata ad essere unapresenza ingombrante. Un fastidio, quando tracima. Da can-cellare, “tombandola” quando ostacola. Il cartesiano dise-gno dei canali e degli scoli, dei fossi e dei fiumi, è diventa-to un intrico non sempre leggibile e con funzioni non sem-pre manifeste.
Lo sviluppo del cemento ha alterato un’orditura che ri-tornando ad essere opportunamente ripristinata (e disin-quinata) potrebbe costituire nuovamente una presenza ca-ratterizzante tutto l’ambiente. Sia quello costruito, sia quel-lo naturale»8.
È su questa struttura permanente, retaggio della natu-ralità originaria e della successiva stratificazione della bo-nifica, che si deve fondare un ipotetico progetto di recupe-ro del paesaggio pontino. I vincoli esistenti interessano una
Il canale delle Acque Medie presso Ninfa (foto S. Quilici)
LAZIO TRA LE DUE GUERRE - MISCELLANEA STORICA DEL TERRITORIO
82
Chiusa lungoil canale delleAcque Basse(foto S. Quilici)
IL PAESAGGIO DELLA PIANURA PONTINA: EVOLUZIONE STORICA E SCENARI DI RECUPERO
costiera con l’entroterra lungo i principali corsi d’acqua,risalendo dalle foci sino alle sorgenti situate nel territoriodi Ninfa. I corridoi ecologici si possono sviluppare lungo iprincipali corsi d’acqua dell’Agro pontino: i canali delleAcque Alte, delle Acque Medie/rio Martino, delle AcqueBasse/fiume Sisto. Tale progetto costituisce l’occasione perla creazione di una rete di greenways di valenza ecologicaper il sistema abiotico (acque) e biotico (vegetale, fauni-stico), che colleghi tra loro le aree naturali protette esi-stenti: il Parco nazionale del Circeo, il monumento natu-rale dei Giardini di Ninfa, i vari siti di interesse comuni-tario. Oltre ad una serie di opere di restauro del paesaggio,come il ripristino delle parti degradate dei filari di euca-lipti con l’uso di differenti specie che garantiscano il piùpossibile la biodiversità, e di sistemazione a scopo ricrea-tivo delle sponde dei canali si può prevedere una serie diinterventi sulla vegetazione ripariale e sui corsi d’acqua,finalizzati al potenziamento della naturalità del sistema. Itipi di intervento sono riconducibili alle categorie della ve-getazione in alveo, dell’ombreggiamento, del riseziona-mento, della vegetazione fuori alveo, delle aree golenali,della fitodepurazione, delle casse di espansione, delle zo-ne umide e delle fasce tampone10.
Se la proposta di “eco-corridoi” costituisce l’occasioneper la creazione di una rete di greenways di valenza ecolo-gica relativamente al sistema abiotico e biotico, la serie di
percorsi ciclo-pedonali che si possono snodare all’internodi tali corridoi, riveste invece una notevole importanza eco-logica relativa al sistema biotico-antropico, grazie alla fun-zione ludico-ricreativa di tipo sostenibile. Alla rete ecolo-gica si può sovrapporre, infatti, una rete di percorsi ciclo-pedonali tracciati sulle strade d’alzaia dei canali di bonifi-ca lungo i quali si può inoltre ipotizzare la realizzazione diun sistema di aree di sosta attrezzata. Ad oggi esistono quat-tro percorsi ciclabili, di cui uno a Latina che unisce la cittàal mare, e tre a Sabaudia, che collegano il Parco nazionaledel Circeo con il mare e la litoranea con la città. L’esisten-za di un’articolata rete di percorsi lungo gli argini dei ca-nali di bonifica, legati alle esigenze di manutenzione da par-te del Consorzio di bonifica, suggerisce l’ipotesi di un re-cupero delle strade di alzaia ai fini ciclo-turistici, nell’otti-ca generale della valorizzazione di un turismo di tipo so-stenibile. Questo tipo di intervento è già stato positivamen-te sperimentato in altre realtà italiane ed europee11. I per-corsi ciclabili esistenti possono dunque essere integrati daun itinerario da realizzare lungo i principali corsi d’acqua,che si conformerebbe come un grande “anello” tracciato in-torno alla città di Latina12 e che collegherebbe un buon nu-mero di elementi paesistico-ambientali e storico-architet-tonici di valore, tra cui il Parco nazionale del Circeo, il mo-numento naturale dei Giardini di Ninfa, le città di fonda-zione, i borghi agricoli.
83
Il canale Linea Pio(foto S. Quilici)
IL PAESAGGIO DELLA PIANURA PONTINA: EVOLUZIONE STORICA E SCENARI DI RECUPERO
Note1 Portoghesi P., Città Pontina, in Capellini L., Portoghesi P., Le città del si-lenzio. Paesaggio, acque, architetture della regione pontina, Latina 1984.
2 Una dettagliata descrizione del paesaggio pontino, qui in parte ripresa,è contenuta in Nardinocchi A., Paesaggio e progettazione sostenibile, Te-si di dottorato in Sviluppo Urbano Sostenibile, XVII ciclo, (relatore: prof.Alessandro Anselmi; correlatore: prof. Vieri Quilici), Facoltà di Archi-tettura, Università Roma Tre.
3 Cervellati P., Relazione del Piano Urbano Comunale Generale di Latina,2000.
4 Numerosi furono i lavori relativi alle alberature stradali nei primi annidi attività dell’A.A.S.S.: «Durante il quadriennio della sua attività l’a-zienda ha pure iniziato e rapidamente proseguito importanti lavori di al-beratura stradale. L’alberatura è considerata come un elemento essen-ziale della strada italiana, specie per le regioni centrali e meridionali,dove al beneficio dell’ombra al viandante aggiunge quello di una mi-gliore conservazione della bitumatura. Perciò, oltre che a proseguire nel-le già iniziate alberature, si è cercato, specie nell’ultimo biennio, di nor-malizzare anche questo ramo di servizio, come già si era fatto per gli al-tri. Si è cominciato col selezionare accuratamente le specie legnose dicui servirsi, e col precisare quelle alle quali circoscrivere la scelta. Neè risultato, pertanto, un numero limitato di specie di alberi, ma tutte ca-paci di fornire, oltre che ombra e protezione alla strada, fusti di pregio,che potranno riuscire un giorno di apprezzabile valore. Particolari curesi sono poi rivolte alla tecnica delle piantagioni, mentre la sorveglianzadei cantonieri, unita a quella della Milizia Stradale, ha oggi anche qua-si eliminato i sistematici danneggiamenti, che in primo tempo si sonodovuti deplorare; e la visibile maggiore cura delle alberature ha finitoper contribuire all’educazione del popolo al rispetto dell’albero. Perquanto riguarda le alberature preesistenti, purtroppo in condizioni as-sai precarie, l’Azienda ha provveduto a curarle, cercando di rimetterlein buono stato di vegetazione. Di pari passo con il programma delle al-berature è stata curata la parte statistica, per avere, con sistematica pe-riodicità, il catasto delle vecchie e nuove piantagioni catalogate per es-senza, età e dimensioni. Nel complesso, a cura dell’Azienda sono statipiantati circa 500.000 alberi per 4000 chilometri di sviluppo di albera-ture» (cfr. Ministero LL.PP., Opere Pubbliche. 1922-1932, Roma 1933).L’importanza del tema delle nuove alberature stradali nel corso degli an-
ni Trenta è confermata dalla pubblicazione nel 1938, sotto gli auspicidell’Azienda autonoma statale della strada, dell’ancora insuperato ma-nuale di Paolino Ferrari (Ferrari P., Alberature stradali, Roma 1938).
5 I borghi agricoli realizzati nell’Agro pontino tra il 1927 e il 1935 furonocomplessivamente diciassette: Podgora (1927), Sabotino (1929), Grappa(1929), San Michele (1929), Doganella (1929), Isonzo (1931-33), Piave(1931-33), Carso (1931-33), Pasubio (1932-33), Bainsizza (1932-33),Faiti (1932-33), Latina Scalo (1933-34), Flora (1933-34), San Donato(1933-35), Vodice (1934-35), Hermada (1934-35), Montenero (1934-35).
6 Cervellati P., Relazione del Piano Urbano Comunale Generale di Latina,2000.
7 Sabaudia (1933-34), Pontinia (1934-35), Aprilia (1936-37), Pomezia(1938-39).
8 Cervellati, cit.9 Fino all’approvazione del nuovo PTPR (Piano Territoriale Paesistico Re-gionale) i piani paesistici vigenti sono: il PTP n. 10 (Latina) e il PTP n.13 (Terracina-Ceprano-Fondi).
10 Cfr. Progetto Life ECOnet: «Il progetto Life ECOnet, finanziato dall’U-nione Europea, si propone di verificare, insieme agli stakeholder (tutticoloro che potenzialmente sono interessati o possono collaborare allarealizzazione del progetto) della Contea del Cheshire (Regno Unito) edelle Regioni Abruzzo ed Emilia-Romagna, le modalità migliori per lacreazione di habitat naturali e la loro connessione per mezzo di corri-doi e di dimostrare come sia possibile utilizzare le reti ecologiche persviluppare una pianificazione e una gestione territoriale sostenibili. Ipartner della Contea del Gelderland (Olanda), all’avanguardia nello svi-luppo di reti ecologiche, forniscono una consulenza al progetto».
11 Ad esempio, in Veneto, il Consorzio di bonifica Valli Grandi e MedioVeronese è impegnato nella realizzazione di percorsi turistico-natura-listici, recuperando vecchie strade alzaie e le sommità arginali, con pic-cole aree per la sosta e il ristoro che consentono la fruizione e la per-corribilità ad una utenza di tipo pedonale, ciclabile ed equestre.
12 Vedi il progetto per la realizzazione di una rete ecologico-turistica del-l’Agro pontino redatto nel 2004 dagli architetti Pierluigi Milone e Si-mone Quilici per conto del Comune di Latina, nell’ambito degli inter-venti finanziati dalla LR 27/2001 (Interventi volti alla conoscenza, alrecupero e alla valorizzazione delle città di fondazione).
85
a realizzazione di ferrovie, strade e altre infra-strutture ha visto in tutta la regione e in particolare intor-no a Roma una netta accelerazione nel periodo compresotra le due guerre, legata anche all’alta valenza simbolicache il regime aveva deciso di conferire alla “modernizza-zione” del paese.
Sono gli stessi anni in cui si comincia a studiare un as-setto territoriale per la Capitale. Nel settembre del 1929 sitiene infatti a Roma il Congresso della Federazione Inter-nazionale dell’Abitazione e dei Piani Regolatori, dove si di-batte della creazione dei piani regolatori regionali. Di que-sto problema parlano urbanisti di fama internazionale, tracui spiccano i nomi di Raymond Unwin e Patrick Aber-crombie.
Parallelamente al Congresso, viene allestita al Palazzodelle Esposizioni una Mostra di Piani Regolatori, dove ven-gono esposti alcuni piani per Roma destinati a dare un con-tributo alla stesura del Piano regolatore del 1931. Si delinealo scontro tra due opposti orientamenti: uno di stampo pas-satista e l’altro più decisamente moderno. Il primo è rap-presentato dalla proposta del gruppo “La Burbera”, capeg-giato da Gustavo Giovannoni, il secondo è costituito dal pro-getto del Gruppo Urbanisti Romani (il GUR, composto dagiovani architetti e ingegneri quali Piccinato, Lenzi, Nico-losi, Lavagnino, Fuselli, Dabbeni, Scalpelli, Valle, Cancel-lotti), facente capo a Marcello Piacentini.
Il piano del GUR comprende uno “schema di piano re-gionale” in cui si propone lo schema “aperto” come alterna-tiva all’espansione “chiusa” e compatta della città, secondole volontà di disurbanizzazione del regime. Treni e tramvieelettriche celeri avrebbero dovuto collegare nuovi ed esistenti
nuclei alla città, mentre sarebbero dovute sorgere «qua e lànello spazio che intercorre tra la città propriamente detta equeste cittadine, altre borgatelle rurali, sportive, militari: gliaeroporti, ecc. E infine, negli spazi liberi, zone verdi, a par-chi, a ortaggi, a campi, a giardini». Vengono stabilite due prin-cipali linee di sviluppo: quella verso il mare – e per questa èconfermata la vocazione industriale, con la realizzazione deidue porti, fluviale e marittimo – e quella verso i Castelli. Insubordine è indicata una terza direttrice verso Tivoli.
Negli anni successivi si succederanno una serie di pro-poste di pianificazione territoriale: nel 1931 verrà allegatouno Schema di Piano Regionale al Piano regolatore di Ro-ma (stralciato in sede di approvazione definitiva), nel 1935l’Istituto di Studi Romani si farà promotore di un Piano Pro-vinciale della Capitale, nel 1938-40 lo stesso Istituto pro-porrà un Piano Territoriale per i Castelli romani e nel 1941la Provincia di Roma presenterà uno Schema delle direttri-ci di traffico del Piano regolatore stradale della Provincia,che prefigura una sorta di raccordo anulare ancora più gran-de di quello che verrà realizzato negli anni Cinquanta. Maalle proposte urbanistiche, per lo più destinate a rimaneresulla carta, si affiancherà l’effettiva realizzazione di una lun-ga serie di infrastrutture, spesso non previste dai piani stes-si, alla cui inaugurazione parteciperà quasi sempre Musso-lini. Tra queste sono da ricordare:
• Ferrovia Roma-Ostia lido: inaugurata il 10 agosto 1924• Idroscalo Carlo Del Prete ad Ostia: inaugurato nel mar-
zo del 1926• Ferrovia Roma-Formia-Napoli: inaugurata il 28 ottobre
1927
86
LE INFRASTRUTTURE DEL LAZIO TRA LE DUE GUERRE:VERSO UNA NUOVA DIMENSIONE TERRITORIALE DELLA CAPITALE
Simone Quilici
L
• Potenziamento delle strade statali e provinciali intornoa Roma ad opera della Azienda Autonoma Statale delleStrade (AASS), istituita nel 1928
• Aeroporto del Littorio (oggi dell’Urbe): inaugurato il 21aprile 1928
• Via del Mare (autostrada Roma-Lido): inaugurata il 28ottobre 1928
• Ferrovia Civitavecchia-Orte: inaugurata il 1° novembre1928
• Ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo: preesistente, mail cui nuovo tracciato viene inaugurato il 27 ottobre 1932
• Via dei Laghi e relativo piano paesistico (arch. Terenzio,soprintendente ai monumenti del Lazio): inaugurata il27 maggio 1936
• Via Imperiale (oggi Cristoforo Colombo): inaugurata neitratti iniziale e finale il 28 ottobre 1939 e completata nel1954
• Via Litoranea e Via Mediana (oggi Pontina): realizzatetra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta
• Acquedotto Imperiale IX Maggio (oggi del Peschiera):inaugurato agli impianti dalle sorgenti nel 1940 e com-pletato nel 1949
87
Le direttrici di traffico nel piano regolatore stradale della provincia di Roma(da G. Fraschetti, La Provincia di Roma e il Piano territoriale dell’Urbe, Roma 1942)































![La Camera di Commercio tra sviluppo locale e scenari del nuovo millennio [The Chamber of Commerce between local development and the scenarios of the new millennium]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633e355d67ec3dabb20d902b/la-camera-di-commercio-tra-sviluppo-locale-e-scenari-del-nuovo-millennio-the-chamber.jpg)