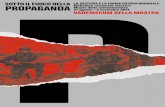Sotto il fuoco della propaganda. La Svizzera e la prima guerra mondiale
La necropoli di Remedello Sotto e leta del Rame nella pianura a nord del Po
Transcript of La necropoli di Remedello Sotto e leta del Rame nella pianura a nord del Po
301
La necropoli di Remedello Sotto e l’età del Rame nella pianura padana a nord del Po
Raffaele Carlo de Marinis
Il sito
La necropoli eneolitica di Remedello fu scoperta nel Vigneto Cacciabella / Campo Dovarese, 1,5 km a sud di Remedello Sotto (Brescia). Il mag-
gior numero delle sepolture venne alla luce tra l’attuale strada provinciale n. 76 Brescia-Asola e il bordo della scarpata del paleoterrazzo del fiume Chiese, che in questo punto ha un’altezza di 4-5 m. L’area d’interesse archeologico si estendeva per ca. 500 m da nord a sud, tra le cascine Dossello di Sopra e Dossello di Sotto, ma proseguiva anche a ovest della strada provinciale. La larghezza massima dell’area archeologica, ca. 200 m, è verso nord, mentre a sud si restringe fino a 60 m in corrispondenza della necropoli eneolitica.
La scoperta e storia delle ricercheLa storia della scoperta e delle successive ricerche condotte a Remedello Sotto è stata ricostruita e am-piamente narrata da Ottavio Cornaggia Castiglioni (1971), sulla scorta di numerose fonti archivistiche inedite conservate principalmente al museo di Reggio Emilia e all’archivio parrocchiale di Asola, per cui la riassumeremo per sommi capi. All’inizio del 1884 i lavori agricoli per l’impianto di un vigneto portarono alla scoperta – e conseguente distruzione – di una sessantina o forse un centinaio di tombe a inumazione in semplice fossa. I materiali che facevano parte del corredo di queste sepolture andarono dispersi, tranne alcuni che furono recuperati dal dr. Girolamo Bonati e dal cav. Andrea Terzi, entrambi di Asola, e dallo stesso proprietario del fondo, il cav. Pietro Feltrinelli, della nota famiglia imprenditoriale lombarda. Di queste scoperte fu informato Gaetano Chierici, dapprima da
Fig. 1 - Ritrovamenti dell’età del Rame nel territorio tra Oglio, Chiese e Castel Goffredo. Cerchi: ritrovamenti dell’età del Rame 1 e 2 (3400-2500 a.C.), quadrati ritrovamenti della tarda età del Rame (periodo campaniforme, 2500-2200 a.C.). 1. Castellaro di Gottolengo; 2. Remedello Sopra, loc. S. Angelo;3. Acquafredda, letto del Chiese; 4. Castel Goffredo, loc. Perosso; 5. Casalmoro; 6. Remedello Sotto, loc. Vigneto Cacciabella/Campo Dovarese; 7. Volongo campo Panesella; 8. Volongo Dos de Grom; 9. Fontanella Mantovana, fondo La Pista; 10. Asola, campo Rus;11. Isorella; 12. Gambara; 13. Remedello Sotto, loc. Roccolo Bresciani; 14. Ca’ di Marco; 15. S. Cristina di Fiesse; 16. Fiesse, loc. Malpensata; 17. Fontanella Mantovana, cave Sandrelli.
302
parte del suo collaboratore dr. Giovanni Bandieri e poco dopo da don Luigi Ruzzenenti, parroco di Asola. Chierici comprese immediatamente l’importanza della scoperta e si fece promotore di una cam-pagna di scavi per conto del museo di Reggio Emilia, diretta da Bandieri e Ruzzenenti dal 10 marzo al 4 aprile 1885. Gli ultimi due giorni videro la partecipazione diretta del Chierici. Questa prima campagna di scavo fruttò 16 tombe, di cui 11 con corredo, queste ultime andarono ad arricchire le collezioni del Museo Patrio di Reggio Emilia1. Una seconda campagna fu condotta da Giovanni Bandieri, dapprima per conto dell’Ateneo di Brescia e del museo preistorico di Roma diretto da Luigi Pigorini, ma senza risultati, quindi di propria iniziativa e poi per conto del museo di Reggio, dal settembre fino al 23 dicembre 1885. Dal 9 al 12 dicembre Chierici volle essere presente sul campo, nonostante le condizioni climatiche avverse, e diresse i lavori di scavo e recupero di alcune sepolture. Come è noto, l’insigne studioso si ammalò e venne a mancare il 9 gennaio 1886 a causa di una broncopolmonite. G. Bandieri spedì al museo di Reggio 21 casse di materiali e si accinse a stendere una relazione sulle scoperte effettuate. Nel gennaio-marzo 1886 Ruzzenenti scavò altre tombe per conto del museo preistorico-etnografico di Roma e dei musei di Brescia e di Viadana, indagando l’area a sud del cd. riparto sud del Bandieri.I primi studi sulla necropoli di Remedello si devono a G. Chierici, che pubblicò due articoli sul Bullet-tino di Paletnologia Italiana (10, 1884; 11,1885), relativi il primo alle scoperte occasionali dell’inverno 1884 e il secondo ai risultati degli scavi del marzo-aprile 1885. G. Bandieri, divenuto conservatore del museo di Reggio Emilia dopo la morte di Chierici, curò la sistemazione dei materiali di Remedello nel Museo Patrio e stese un’ampia relazione sulla necropoli eneolitica e sulle tombe della prima età del Ferro, corredata da 25 tavole2. Morto improvvisamente il Bandieri nel 18903, il compito di rendere note le importanti scoperte di Remedello per quanto riguarda la necropoli eneolitica fu assunto da Giuseppe Angelo Colini (1857-1918), ispettore e poi vice-direttore del museo preistorico-etnografico di Roma. L’ampio studio sulla necropoli di Remedello e sull’età del Rame in Italia fu pubblicato a puntate sul BPI, tra il 1898 e il 1902, un testo di quasi 500 pagine, corredato da dieci tavole fuori testo e 120 figure nel testo, lavoro che a un certo punto rimase interrotto e non sappiamo per quali motivi. Colini poté utilizzare come base del suo studio il Ragguaglio redatto da Bandieri, manoscritto tuttora inedito, contenente la descrizione delle scoperte effettuate a Remedello e comprendente dodici tavole con le planimetrie generali e di dettaglio dell’area della necropoli e i disegni dei principali materiali. La pubblicazione di Colini, grazie anche all’importante apparato iconografico, attirò l’attenzione degli studiosi europei, da V. G. Childe a O. Menghin, da N. Åberg a J.E. Forssander. In questa sede non possiamo soffermarci, per motivi di spazio, sulle valutazioni espresse da questi studiosi (a cui si deve la prima definizione di cultura di Remedello) e da altri ancora, tema che ha interesse quasi esclusivamente per la storia della ricerca. Dovevano passare molti anni prima che i paletnologi italiani tornassero ad affrontare seriamente il tema Remedello. Il problema della cultura di Remedello fu ripreso nel 1956 da O.M. Acanfora e nel 1971 da O. Cornaggia Castiglioni, che ha pubblicato un’ ampia selezione ragio-nata dei materiali della necropoli eneolitica. Verso la metà degli anni ’70 materiali campaniformi (uno scodellone e un vaso campaniforme ansato) sono stati raccolti in superficie circa 100 metri a nord-ovest della necropoli eneolitica (Perini 1976). A seguito di queste scoperte, L.H. Barfield ha condotto due campagne di scavo nel 1986 e 1987 nel terre-no immediatamente ad ovest delle necropoli eneolitica, etrusca e gallica indagate un secolo prima. Nella
1 Cfr. Chierici 1885. Cinque tombe erano prive di corredo, le rimanenti undici furono numerate da Chierici da 1 a 11, in seguito rinumerate da G. Bandieri. Si tratta delle tombe 106 (1), 73 e 97 (2 e 3), 74 (4), 94 (5), 86 (6), 69 (9), 70 (10), 72 (11). 2 Le tavole comprendono anche il materiale della necropoli gallica e sono così ripartite: I, mappa generale dell’area archeologica, II-XII necropoli eneoli-tica, XIII-XVI, materiali delle tombe etrusche, XVII-XXV, materiali delle tombe galliche.3 G. Bandieri, esperto agronomo, si recò nel 1889 in Eritrea insieme a un gruppo di contadini reggiani per realizzare un progetto di colonizzazione agricola e vi morì improvvisamente il 29 novembre 1890.
303
prima area di scavo, ubicata nella zona di affioramento dei materiali campaniformi e ca-ratterizzata da quattro crop marks circolari (fig. 2), è stato scoperto un fossato circolare del diametro di 10 m, con se-zione a V, il cui riempimento conteneva materiali della pri-ma età del Ferro (VII-VI se-colo a.C.). Nella seconda area di scavo, all’incirca nei pres-si delle tombe 74-76, sono venute alla luce una tomba a fossa ovale con scheletro ran-nicchiato sul fianco sinistro e corredo costituito da una cuspide di freccia in selce, una sepoltura di neonato e una di bambino, quest’ultime prive di corredo e quindi di datazione incerta, ma pertinenti verosimilmente all’età eneolitica4. Gli scavi hanno conferma-to la prosecuzione della necropoli dell’età del Rame anche a ovest della strada Brescia-Asola.Una scheda sintetica su Remedello, corredata da una tavola di materiali ridisegnati da Colini, è stata pubblicata da H. Müller-Karpe nel terzo volume del suo manuale di Preistoria5. Negli anni ’70 e ’80
4 L.H. Barfield, Remedello di Sotto: ricerche 1986, relazione inviata alla Soprintendenza Archeologica della Lombardia. Lo scavo è ancora inedito. Per tutti i dati sui vecchi scavi rimandiamo ai lavori di Chierici (1884, 1885), Colini (1898-1902) e Cornaggia Castiglioni (1971). 5 Cfr. Müller-Karpe 1974, scheda a p. 902 e tav. 439. Nella tavola sono erroneamente attribuiti a Remedello il pugnale di Castello di Vecchiano, quello di Poggio Aquilone e un vaso di Fontanella Mantovana.
Fig. 2 - Remedello Sotto, località Campo Dovarese. Foto aerea dell’area a ovest della necropoli gallica, con le strutture circolari del VII-VI secolo a.C. Da quest’area provengono frammenti di ceramiche campaniformi (da Odone 2005).
Fig. 3 - L’area archeologica della località Dovarese secondo G. Bandieri ms, tav. I. A. Necropoli eneolitica; B. tombe del VII-VI secolo a.C.; C. necropoli gallica; D. sepolture eneolitiche senza corredo e tracce di strutture d’abitato; E. resti di strutture d’abitato. L’asterisco segna il punto del ritrovamento in superficie di ceramiche campaniformi. Rielaborato da Colini 1898 con modifiche.
304
Fig. 4 - Remedello Sotto, località Dovarese. La planimetria della necropoli eneolitica da Bandieri ms, tav. II. Scala ca. 1: 1000.
305
del secolo scorso numerosi riferimenti a Remedello sono contenuti nei lavori di B. Bagolini e L.H. Barfield dedicati all’età del Rame in Italia settentrionale e nella penisola, ma una vera e propria svolta nella ricerca si è realizzata nel settembre 1991 con la scoperta dell’uomo del Similaun, che ha obbli-gato a una revisione critica delle nostre conoscenze, a cui hanno fatto seguito la “riscoperta” da parte dell’Autore della planimetria della necropoli eneolitica con l’ubicazione di tutte le tombe6 e le datazioni radiocarboniche effettuate su alcune delle tombe conservate al museo di Reggio Emilia7.
La necropoli eneolitica si trova al centro di una vasta area archeologica che si estende da nord a sud per almeno 500 m e che ha restituito materiali dell’antica età del Bronzo, del VII-VI secolo a.C. e del II-I secolo a.C.8 (fig. 3). L’area con la massima concentrazione di tombe dell’età del Rame è estesa poco meno di 5000 m2 (90 x 52 m)9 ed è stata suddivisa da Bandieri in due rettangoli chiamati riparto Nord e riparto Sud, separati da una fascia profonda circa 7 m priva di tombe.Altre tombe eneolitiche sono state scoperte a sud e a ovest e probabilmente anche a nord di quest’area centrale. Infatti, ca. 300 m a nord, nei pressi della via Dossello Sopra, sono venute alla luce tombe che avevano i caratteri di quelle eneolitiche, ma del tutto prive di oggetti di corredo. Verso ovest, al di là della strada Remedello-Asola, furono scoperte le tt. 72-74, 114-116 e più recentemente le tombe dello scavo Barfield. A sud del riparto Sud la necropoli si estendeva ancora per almeno 55 m: dal lato est della strada Remedello-Asola furono scavate le tt. 111-113 e 117-119, mentre più a est e più a sud vennero alla luce altre tombe, in particolare quelle inviate ai musei di Brescia e di Viadana da parte di Ruzze-nenti. Infine, nel 1898 ca. 50 m a nord del limite settentrionale della necropoli eneolitica fu scoperta, presente Ruzzenenti, una tomba con scheletro rannicchiato sul fianco sinistro, orientato verso sud, “la suppellettile funebre consisteva in un coccio di impasto nero presso le gambe”10. Nella planimetria allegata al Ragguaglio di G. Bandieri sono numerate 119 tombe, mentre altre 35 sono riportate senza numerazione11 (fig. 4). Due dei numeri utilizzati dal Bandieri non sono però sepolture12. Almeno 7 tombe furono scavate o comunque recuperate da L. Ruzzenenti nel gennaio-marzo 188613 e 3 da L.H. Barfield nel 1986. Il totale assomma quindi a ca. 164 tombe14, che certamente costituiscono solo una parte della effettiva consistenza originaria della necropoli, in gran parte distrutta dai lavori agricoli, in parte forse ancora da scavare. Il Bandieri valutava a circa 300 le tombe della necropoli, comprendendo nel numero anche quelle distrutte dai lavori agricoli. Secondo Bandieri le due zone dette riparto Nord e Sud avevano la configurazione di due dossi dell’al-tezza di 75 cm rispetto al piano di campagna circostante e con l’ asse maggiore orientato esattamente
6 La planimetria è stata pubblicata per la prima volta in de Marinis 1992, 400, fig. 10.7 Cfr. de Marinis 1997a, 1997b.8 Dalla zona più settentrionale del Campo Dovarese proviene un frammento di scodellone tipo Barche di Solferino (cfr. de Marinis 2003, 51 e ss., fig. 35). Qui nei pressi dell’orlo del paleoterrazzo del Chiese il Ruzzenenti scavò alcuni fondi di capanna, caratterizzati da “terra nera e sucida come pece cui sono frammisti ossami d’animali infranti e in parte carbonizzati, cocci di vari oggetti della ceramica caratteristica delle terremare” (Ruzzenenti, in Commentari Ateneo di Brescia, f. 30, 1886). I materiali della necropoli di VII e VI secolo a.C., sono stati oggetto di una tesi di laurea da parte di A.C. Cattaneo, sotto la guida dell’Autore. Per la necropoli gallica cfr. G. Vannacci, Le necropoli preromane di Remedello Sotto e Ca’ di Marco di Fiesse, Reggio Emilia, 1977, e M. Tizzoni, I materiali della tarda età del Ferro al museo civico di Brescia, Bergamo, 1985, 30 e ss. 9 Le misure riportate dal Colini (1898) sono inesatte. La scala della mappa topografica, ripresa dal Ragguaglio del Bandieri, non è 1: 7000 bensì circa 1: 4000/4300. La mappa dell’area archeologica (tav. I del Ragguaglio) e quella della planimetria della necropoli eneolitica (tav. II) non coincidono perfet-tamente, in particolare per quanto riguarda l’andamento della scarpata del paleoalveo del Chiese. Inoltre, le distanze tra le cascine Dossello di Sopra e Dossello di Sotto e tra i vari incroci stradali non coincidono con quanto è verificabile sul terreno.10 Colini, “Notizie diverse”, in BPI, XXIV, 1898, 301.11 Bandieri stesso precisa che “nella tavola II … ho avvertita l’esistenza di sepolcri manomessi, dei quali non ho tenuto conto in questa nota; ritenni accen-narli nella tavola perché, sebbene manomessi, valgono a dare un’idea precisa dell’ordinamento della necropoli e sue divisioni; non ritenni tenerne calcolo qui, perché affatto inutile il far cenno di tutti i sepolcri scoperti in tale stato e spogli d’ogni avanzo di corredo”.12 Tomba 47: scheletro completo di un cavallo di giovane età; tomba 110 pozzetto di probabile età neolitica.13 Due inviate incassate al museo di Brescia più le ceramiche di altre due tombe, una incassata inviata al museo di Viadana più il materiale di un’altra tomba. Una tomba, già incassata per il museo preistorico di Roma, fu poi manomessa.14 Compresa la tomba del 1898 e quella con un pugnale di rame scoperta prima del 1884. Cfr. infra.
306
est-ovest15. La loro natura fu giudicata artificiale da Bandieri, secondo il quale tutt’intorno sarebbe stato praticato uno sterro che circondava ciascun dosso, formando come una depressione. Se così fosse, i due “riparti” sarebbero stati due tumuli di forma forse ellittica, destinati a ospitare numerose sepolture. Nulla di tutto ciò è più verificabile, poiché le due culminazioni segnalate da Bandieri non sono più visibili sul terreno, quasi certamente del tutto spianate dai lavori agricoli. Nella sua mappa della necropoli eneolitica Bandieri ha delimitato a tratteggio due aree rettangolari, ciascuna di ca. 51 x 42 m, perfettamente orientate N-S ed E-W, ma non c’è alcuna indicazione relativa alla depressione che le circondava. I due dossi erano separati da una striscia di terreno della larghezza di 6-7 m, risultata del tutto priva di sepolture, tranne una fossa all’estremità orientale, indicata come t. 47, in cui vi era lo scheletro di un cavallo, sulla cui età non è più possibile pronunciarsi e di conseguenza non è dimo-strabile la sua contemporaneità alla necropoli. All’angolo sud-occidentale del riparto Sud fu rinvenuto un pozzetto di forma tronco-conica contenente ossa di bue, frammenti ceramici di impasto nero, un frammento di macina, un lisciatoio di arenaria e numerosi ciottoli. Non essendo i materiali reperibili, anche in questo caso non è possibile formulare una datazione e si può solo ipotizzare che si trattasse di un pozzetto neolitico.Comunque, l’ipotesi Bandieri di due dossi artificiali, che non potrebbero essere stati altro che due tumuli, non appare suffragata, anzi sembra improbabile. L’unico dato relativamente sicuro sembra la maggiore profondità delle tombe rispetto al piano di campagna procedendo da nord verso sud. La tomba del 1898 sarebbe venuta alla luce alla profondità di soli 30 cm dal piano di campagna, mentre la tomba detta BS I, scoperta ca. 155-160 m a sud della precedente, fu rinvenuta alla profondità di 1,60 m. Si deve poi tener conto del fatto che la zona fu frequentata per tutto il corso dell’età del Rame, nell’antica e media età del Bronzo, nel VII e VI secolo a.C., in età medio e tardo La Tène e in età romana. Uno scavo scientificamente condotto avrebbe potuto identificare strati o strutture negative posteriori alla necropoli eneolitica, che non saranno certamente mancati, e quindi rendere conto del fatto che nel febbraio 1884 nell’area della necropoli eneolitica furono raccolti una ciotola dell’avanzato VI secolo a.C. e un frammento di una ciotola con piccola ansa canaliculata del BA II16.È forse utile spendere qualche parola sul metodo con cui furono condotti gli scavi e sulla planimetria definitiva della necropoli eneolitica redatta da Bandieri. Innanzitutto, è bene ricordare che negli anni anteriori al 1884 i lavori agricoli avevano già intercettato tombe della necropoli eneolitica e che secondo Ruzzenenti qualche anno prima nello stesso campo era stata scoperta una tomba con un pugnale di rame collocato al fianco dello scheletro17. Nel febbraio 1884 erano già stati scavati su un’estensione di ca. 300 m da sud verso nord 75 fossi per l’impianto del vigneto, ciascuno largo 2 m e con una fascia di 2 m risparmiata tra un fosso e l’altro18. Quando iniziarono gli scavi Chierici, Bandieri e Ruzzenenti, dal 10 marzo al 4 aprile e poi dal settembre fino al 23 dicembre 1885, “le esplorazioni si limitarono a circa la metà della necropoli stessa, mentre pel resto ben presto m’accorsi che era affatto vano il tentare ogni ricerca, in quantoche l’agricoltore aveva manomesso e sconvolto ogni cosa” (Bandieri ms). Nella prima campagna si operò aprendo al centro delle fasce di terreno risparmiato dal vigneto una fossa larga da 60 a 80 cm, che poteva essere ampliata qualora fossero state intercettate delle sepolture per poterle scavare completamente19. Nella seconda campagna, diretta dal solo Bandieri in stretto contatto
15 “il cui asse maggiore corre da Est ad Ovest, in guisa da formare colla linea dell’ago magnetico un angolo retto” (G. Bandieri, Ragguaglio).16 Chierici 1884, 139-140, tav. VI, 9. Mentre Bonati, Ruzzenenti e Bandieri ritenevano la ciotola coeva alle sepolture a inumazione, insistendo sul fatto che fu rinvenuta nell’area delle tombe eneolitiche, Chierici, da esperto conoscitore dei materiali archeologici, la giudicò subito dell’età del Ferro. Per il frammento del BA II, cfr. Chierici 1884, 140 e Barfield 1979, fig. 23 n. 8. Al museo di Reggio attualmente questo frammento è esposto su un’assicella con l’indicazione di tomba LXI, indicazione certamente errata.17 Chierici 1884, 137.18 Lettera di L. Ruzzenenti a G. Chierici del 24 febbraio 1884.19 Lettera di L. Ruzzenenti a G. Chierici del 22 marzo 1885.
307
con Chierici, si procedette sempre nelle fasce risparmiate “praticando fosse parallele della larghezza di m 1,50 e della profondità di m 1,20 in direzione da Est verso Ovest” (Bandieri, Ragguaglio). Lo scavo era condotto da contadini o badilanti del luogo, assoldati da Bandieri, che sorvegliava le operazioni di sterro. Una volta riconosciuta dal colore del terreno l’esistenza di una tomba, si abbandonava la vanga e si procedeva con la spatola a mettere in luce il cranio, che rappresentava la parte più rilevata rispetto al fondo della tomba, quindi si proseguiva fino a effettuare lo scavo completo della sepoltura (Bandieri, Ragguaglio). Della mappa dell’area archeologica esistono tre versioni: una redatta da Bandieri e datata 26 agosto 1885, la seconda datata 12 settembre 1885, mentre la terza costituisce la prima tavola alle-gata al Ragguaglio del Bandieri e ripresa da Colini nel 1898. La tavola II del Ragguaglio presenta invece la planimetria di dettaglio della necropoli eneolitica in scala ca. 1: 1000. Quando nel 1887-1888 il Bandieri scrisse il suo Ragguaglio e redasse la planimetria, rinumerò tutte le tombe partendo da nord verso sud e questa è rimasta la numerazione definitiva, utilizzata sia per l’esposizione museale che per lo studio del Colini. La planimetria della necropoli è stata pubblicata per la prima volta dall’Autore nel 1992 e in seguito aggiornata includendo anche le tombe scavate da Ruzzenenti nel 188620. Per valutare l’attendibilità di questa planimetria è necessario tenere presente che su metà della superficie della necropoli le tombe eventualmente presenti erano già state distrutte dall’impianto del vigneto e che nelle fasce risparmiate larghe 2 m e tra loro parallele non sempre si rinvennero delle tombe. Alla ripresa degli scavi nell’autunno 1885 Bandieri inizialmente operava per conto dell’Ateneo di Brescia e di Luigi Pigorini, ma non furono trovate tombe, per cui i committenti si ritirarono dall’iniziativa e Bandieri proseguì le ricerche a sue spese, ben presto con il pieno sostegno di Chierici. Se ne deduce che nell’ambito dei due “riparti” vi erano sicuramente ampie zone prive di tombe o con poche tombe. Al contrario, nella parte più meridionale e centro-occidentale del riparto Sud le tombe erano relativamente addensate. Secondo Bandieri le tombe erano disposte lungo allineamenti E-W, ma questo sembra più che altro il risultato dello scavo costretto a procedere nelle fasce risparmiate tra un filare e l’altro del vigneto, mentre in base alla planimetria si potrebbe sostenere la tesi che le tombe fossero disposte lungo allineamenti N-S, ma poiché dalla planimetria mancano le tombe distrutte dai lavori agricoli agli inizi del 1884, forse un centinaio, non è possibile formulare alcuna indicazione attendibile sull’organizza-zione della necropoli, se non ricorrendo all’analisi tipologica dei materiali dei corredi funerari e allo studio delle loro associazioni.
I riti funerariLe tombe erano semplici fosse per lo più di forma ovale, scavate nella sabbia sottostante il terreno ar-gilloso superficiale e spesso raggiungevano e attraversavano un livello di concrezioni calcaree posto tra i 75 e gli 80 cm dal piano di campagna, affondando nel sottostante strato sabbioso-ghiaioso. La profon-dità delle tombe era in genere tra 0,50 e 0,80 cm, ma solo per poche viene fornita l’indicazione. Il rito funerario esclusivo è quello dell’inumazione individuale. Da questo punto di vista Remedello prosegue la tradizione neolitica dell’area padana e nello stesso tempo fa parte della vasta area delle sepolture in-dividuali che nella piena età del Rame con la diffusione della cultura della Schnurkeramik fino ai Paesi Bassi e all’altopiano elvetico abbraccia tutta l’Europa centrale e orientale. L’area padana si contrappone non solo all’Europa occidentale e alla penisola italiana, in cui prevalgono le sepolture collettive, ma anche alle vicine regioni subalpine e alpine dell’Italia settentrionale, in cui la cd. facies di Civate è ca-ratterizzata da sepolture collettive in caverne naturali o in ripari sotto-roccia o nel caso di St. Martin de Corléans in monumenti megalitici. Il riparo Valtenesi di Manerba del Garda e i ripari Cavallino e
20 de Marinis 1997a, 269 nota 23 e fig. 4.
308
Persi a Monte Covolo si trovano soltanto a una quarantina di km di distanza da Remedello Sotto verso nord. Certamente si tratta di due visioni della vita e della morte molto diverse tra loro. Nelle sepolture individuali si sottolineano le differenze di età, di sesso e di ruolo sociale attraverso l’assenza o presenza di un corredo funerario e quando presente attraverso la sua diversificazione quantitativa e qualitativa. L’identità culturale e il ruolo sociale dell’individuo sono conservati anche dopo la morte, anzi vengono ulteriormente rimarcati e in un certo senso resi definitivi. Nelle sepolture collettive l’individuo entra a far parte del mondo degli antenati e la sua identità si annulla in una superiore identità collettiva. Prevale in questo caso il rito della doppia sepoltura, ma i riti possono essere molto lunghi e complessi, variare da zona a zona e non sempre è possibile ricostruirli partendo dal record archeologico21.Ritornando a Remedello, bisogna subito dire che la nostra conoscenza dei riti funerari che vi erano praticati, al di là del fatto che siamo di fronte a sepolture individuali, al massimo bisome (tombe 46 e 50), rimane molto lacunosa e ciò dipende dalla natura della documentazione di cui disponiamo. Vi erano rigide norme che codificavano la deposizione del defunto e l’orientamento della tomba a seconda dell’età, del sesso e del ruolo sociale, come si verifica in molte culture coeve, prima fra tutte la cultura della Schnurkeramik ? Difficile dare risposte sicure. G. Bandieri, che ha diretto lo scavo della maggior parte delle tombe della necropoli, scrive: “gli scheletri di massima quasi tutti giacevano sul fianco sini-stro, colle gambe violentemente contratte, colle braccia or ripiegate sul petto ora a portata del mento ed ora distese lungo il tronco, ma in guisa però che ben di rado il braccio destro riscontrossi nell’identica posizione del sinistro. Alcuni scheletri del resto giacciono supini, colle braccia distese lungo il tronco … tanto nel riparto Sud quanto nel riparto Nord come fuori della necropoli gli scheletri giacenti sul fianco sinistro avevano di regola il capo a NO e qualche volta a O-NO, quelli invece supini giacevano col capo a Est”. Nell’elenco delle tombe, che segue alle osservazioni generali, alla tomba n. 13 così scrive Bandieri: “sepolcro scoperto intatto con scheletro di adulto, giacente sul fianco sinistro, col capo a Nord-Ovest, colle gambe gravemente contratte, col braccio destro ripiegato sul ventre e col sinistro disteso lungo il tronco” e poi specifica in nota: “Di regola generale gli scheletri vennero scoperti in tale giacitura, per evitare quindi inutili ripetizioni, d’ora in poi accennerò soltanto se il sepolcro venne scoperto o meno intatto e del come stava disposto il relativo corredo; degli scheletri parlerò sol quando si presentino in condizioni affatto diverse da quelle ora descritte”. Tuttavia, scorrendo l’elenco del Bandieri si può costatare che solo in tre casi viene data l’indicazione che lo scheletro era in giacitura diversa dalla regola generale e in particolare in giacitura distesa e supina (tt. 24, 72, 76), mentre Colini annovera ben dodici casi del genere22. Inoltre Colini segnala che in tre tombe gli scheletri erano rannicchiati sul fianco destro23. È probabile che Colini abbia potuto disporre di una relazione del Bandieri aggiornata rispetto alla prima versione conservata nell’archivio del museo di Reggio Emilia.Le considerazioni sui riti funerari e sui corredi finora formulate da vari autori, compreso chi scrive, si sono basate sui dati pubblicati dal Colini, che riprende la relazione inedita del Bandieri, dalla quale tut-tavia, come abbiamo sottolineato poco sopra, in diversi casi si discosta, mentre in altri aggiunge notizie, non sappiamo da quali fonti attinte. Tuttavia, il problema è ancora più ingarbugliato per il fatto che da un’analisi completa dei dati disponibili emerge con chiarezza che Chierici, Bandieri e Ruzzenenti non sempre hanno saputo definire con precisione la posizione del cadavere nella fossa, sia per l’alto numero di tombe già parzialmente o del tutto manomesse dai lavori agricoli sia forse per essere rimasti vincolati
21 Il sito più significativo per quanto concerne le sepolture collettive e secondarie, anche perché oggetto di una edizione completa dello scavo, è certa-mente il Riparo Valtenesi di Manerba del Garda (Barfield 2007).22 Tombe 14, 24, 39, 43, 45, 58, 59, 64, 72, 74, 76, 105. Forse anche la tomba 70 va aggiunta a questo elenco, poiché Colini specifica che si tratta della tomba X in Chierici 1885, dal cui elenco si evince la posizione supina. 23 Tombe 46, 69 e 86.
309
a uno schema semplice di contrapposizione tra inumati rannicchiati sul fianco e inumati in posizione distesa sul dorso, mentre di fronte a inumati con la parte superiore del corpo supina e le gambe flesse e ripiegate verso sinistra o verso destra hanno optato per la definizione “rannicchiato sul fianco” oppure “in posizione supina” a seconda dei casi. Non essendoci i rilievi planimetrici di ogni singola sepoltura, diventa molto arduo ricostruire con esattezza quell’aspetto così importante dei riti funerari che è la posizione del defunto nella fossa.Le fonti di cui disponiamo sono le 14 tombe trasportate intatte nei musei: 10 al museo di Reggio Emilia (tt. 27, 34, 40, 56, 65, 73, 75, 76, 78, 83), 2 al museo di Brescia (BS I e II), 1 al museo Pigorini di Roma (t. 79) e 1 al museo di Viadana. Inoltre, vi sono gli schizzi planimetrici di tre sepolture di pu-gno dello stesso Chierici (tt. 1, 93 e 100)24 e i cartoni con gli acquarelli di 21 sepolture eseguiti o fatti eseguire dal Bandieri e collocati nel 1886 nelle vetrine IX e X del museo di Reggio Emilia, con fissati i materiali del relativo corredo. Che questi cartoni siano stati collocati nel 1886 risulta con chiarezza dalla relazione di Bandieri, Situa-zione del Civico Museo Preistorico e di Storia Patria di Reggio Emilia nell’anno 1886, datata 28 Maggio 188725. Il passo che concerne i materiali di Remedello è il seguente: “… I ricordati sepolcri, i citati ma-teriali, vennero ordinati e disposti in vetrine, poste sopra piedestallo, parte sulla linea mediana, e parte al fianco sinistro della galleria, che si affaccia a chi entra nel Museo Preistorico, nel seguente modo: nelle prime otto vetrine stanno rinchiusi altrettanti sepolcri, del periodo Eneo-litico, a cadavere inumato, conservati intatti; nella vetrina IX ho disposto i corredi di sedici sepolcri, dello stesso periodo, esplorati all’atto della loro scoperta, ed ho consociato ad ogni corredo, il tipo del relativo sepolcro, da rappresentare in tal guisa le cose, come vennero da me osservate all’atto della relativa esplorazione [corsivo dell’A.]; nella vetrina X si veggono i tipi dei sepolcri di minor importanza, scoperti fuori della necropoli, non che frammenti di corredi di sepolcri manomessi nel compiere lavori campestri e rifiuti della lavorazione della selce, frammenti di vasi e d’ossa umane e di bruti, che mi parve potessero costituire un indizio delle abitazioni del periodo Eneo-litico.…”. Nella vetrina X vi sono anche i cartoni con la planimetria
24 Cfr. R. Macellari in questo volume.25 Archivio dei Musei Civici di Reggio Emilia, Doc. Car. Ia, B, 8. Cfr. il contributo di R. Macellari in questo volume.
Fig. 5 - Remedello Sotto, località Campo Dovarese. Tombe con il defunto in decubito dorsale e capo e gambe flessi verso sinistra: da sinistra tomba BS I, tomba 78 e tomba 65.
310
di cinque tombe. Le tt. 4 e 2 erano fosse senza traccia dello scheletro, la prima con un importante cor-redo, la seconda priva di corredo. La t. 62 è quella scoperta agli inizi del 1884 e la ricostruzione è fatta seguendo le indicazioni del soprintendente ai lavori agricoli, F. Fissardi. Due tombe furono scavate da Ruzzenenti (tt. 86 e 106), altre due da Chierici (tt. 1 e 100). Per le rimanenti 16 tombe di cui esistono i cartoni acquarellati la fonte delle notizie non può che essere lo stesso Bandieri, che nel corso dello scavo doveva aver preso appunti dettagliati o eseguito schizzi planimetrici. La posizione del defunto che risulta da questi acquarelli è quella con la parte superiore del corpo supina, il capo volto verso sinistra e le gambe flesse e piegate verso sinistra, quindi la posizione nota in letteratura come Rückenhocker. Prima di valutare l’attendibilità di questi cartoni, esaminiamo le tombe incassate e trasportate nei musei: nelle tt. 34, 65, 78, 79 e BS I secondo Colini lo scheletro era rannicchiato sul fianco sinistro, ma al contrario la posizione delle braccia, delle vertebre, delle costole e del bacino ci dice che il corpo era stato deposto supino, con la faccia piegata verso sinistra e le gambe flesse e piegate verso sinistra (fig. 5). Questo tipo di giacitura è riconosciuto da Bandieri e Colini soltanto per la t. 83, con il capo piegato verso sinistra, ma le gambe flesse e ripiegate verso destra. Nel caso delle tt. 40, 56, 73, BS II e Viadana il corpo era rannicchiato sul fianco sinistro (fig. 6), in accordo con la relazione del Colini. Se mettiamo a confronto le planimetrie del Chierici per le tt. 1, 93 e 100 con le descrizioni del Colini, possiamo verificare che per la t. 93, con il corpo rannicchiato sul fianco sinistro, i dati coincidono, ma per la t. 100 dal disegno del Chierici appare chiara la posizione in decubito dorsale con gambe flesse a sinistra, mentre Colini parla di rannicchiato sul fianco sinistro. La t. 1 è di un bambino rannicchiato sul fianco sinistro nel disegno del Chierici, mentre Colini non riferisce la posizione del corpo.Da questa verifica emerge che l’utilizzo di Bandieri e Colini per ricostruire i riti funerari della necropoli di Remedello è molto problematico, poiché quando i nostri Autori scrivono rannicchiato su un fianco oppure supino, in assenza del riscontro di altre fonti (le tombe trasportate intatte nei musei o gli schizzi
Fig. 6 - Remedello Sotto, località Campo Dovarese. Tombe con il defunto in posizione rannicchiata sul fianco sinistro: da sinistra tombe BS II, 40 e 56.
311
planimetrici), non possiamo sapere come stessero effettivamente le cose. Su 14 tombe di Remedello conservate con lo scheletro nella presumibile posizione originaria, a cui possiamo aggiungere le tre tombe rilevate da Chierici, abbiamo la seguente casistica:
8 tombe con scheletro rannicchiato su un fianco (tt. 1,40, 56, 73, 75, 93, BS II, Viadana) -7 tombe del tipo - Rückenhocker (tt. 34, 65, 78, 79, 83, 100, BS I)1 tomba con ossa non più in connessione anatomica (t. 27) -1 tomba con scheletro in posizione supina (t. 76) -
A Remedello la giacitura del tipo Rückenhocker si riscontra nel caso delle tombe con i corredi di mag-giore prestigio, comprendenti asce o pugnali in rame, o riferibili a soggetti di età adulta matura (tt. 34, 65, BS I). L’unica sepoltura conservata di Volongo presenta lo stesso tipo di giacitura del cadavere e così pure l’unica tomba con pugnale di rame di Fontanella Mantovana (t. 11), pertinente a un soggetto adulto maschile, con pugnale di rame e ascia di pietra levigata26. Della necropoli di Fontanella si conservano 11 sepolture trasportate nei musei di Milano, Cremona, Mantova e Roma (museo Pigorini). Sei sono deposizioni di rannicchiati, 4 sul fianco sinistro e 2 sul fianco destro, due sono supini con gambe ripiegate verso il ventre, due sono del tipo Rückenhocker, uno è supino con le gambe ripiegate a formare un rombo (t. 12). Quest’ultima disposizione del defunto nella fossa è caratteristica dell’area nordpontica e da lì si diffonde lungo le direttrici della cd. migrazione Jamnaya, in particolare in Bulgaria27.Considerando unitariamente i 29 dati disponibili tra Remedello, Volongo e Fontanella28 possiamo
26 Cfr. la fotografia in Corrain, Gallo 1968, fig. 9. Le relazioni di Locatelli e M.O. Acanfora definiscono il defunto rannicchiato sul fianco sinistro (Acanfora 1956, 325 e 328). Per una foto delle tombe di Volongo e di Remedello 79, conservate al museo Pigorini, ringrazio la dr.ssa Loretana Salvadei.27 A questo proposito cfr. Häusler 1974, tavv. 4.3, 5.6, 11.7, 13.8, 16.17, 33.6, 47.5; Primas 1996, 35 e ss., fig. 3.11 e tabella 3.1.28 Per le tombe 1, 93 e 100 di Remedello il dato è fornito dal rilievo di G. Chierici.
Fig. 7 - Cartoni delle tombe 100, 102 e 117 eseguiti o fatti eseguire da G. Bandieri e collocati nelle vetrine IX e X del Museo Patrio di Reggio Emilia per cura del Bandieri stesso.
312
concludere che la giacitura più diffusa (48 %) è quella rannicchiata su un fianco, seguita dalla posizione supina sul dorso e gambe ripiegate di lato (35 %). Non è presente nessun chiaro esempio di deposizione distesa sul dorso con braccia lungo i fianchi29, che è la posizione di norma per il gruppo di Spilamberto. Per quanto riguarda i rannicchiati, la posizione sul fianco destro è più rara (Remedello tt. 46, 69, 86, se vogliamo prestar fede alle descrizioni del Colini; Fontanella Mantovana t. 13, bisoma con maschio adulto maturo e donna adulta giovane30, esattamente come la t. 46 di Remedello). Tuttavia, se utilizziamo le planimetrie dei cartoni collocati da Bandieri nelle vetrine IX e X, la situazione cambia (fig. 7). La t. 100 è riferita da Colini a un adulto rannicchiato sul fianco sinistro, ma il disegno di Chierici e l’acquarello di Bandieri mostrano lo scheletro in decubito dorsale con le gambe flesse e piegate a sinistra. Al contrario per la tomba 1 il disegno Chierici mostra un bambino rannicchiato sul fianco sinistro e l’acquarello Bandieri la posizione Rückenhocker. È bene rimarcare che i disegni fatti o fatti eseguire da Bandieri non sono un modello stereotipato ripetuto più volte, ma sono diversi uno dall’altro, anche se la posizione del defunto è sempre del tipo Rückenhocker, la posizione delle braccia, la disposizione degli oggetti di corredo, le dimensioni dello scheletro – giovane o adulto – sono di-verse a seconda della tomba. Se eliminiamo i casi delle tt. 62, 106 (scavata da Ruzzenenti, defunto in posizione inginocchiata), 1 (scavata da Chierici) e 2 e 4 (fosse vuote), le rimanenti 16 tombe sono da aggiungere al numero dei defunti in decubito dorsale e gambe flesse e ripiegate a sinistra, per cui i dati si modificano nel seguente modo:
8 tombe con scheletro rannicchiato su un fianco (tt. 1, 40, 56, 73, 75, 93, BS II, Viadana) -22 tombe del tipo - Rückenhocker (tt. 13, 34, 41, 45, 60, 63, 65, 74, 78, 79, 83, 85, 86, 94, 100, 102, 104, 107, 109, 110, 117, BS I)1 tomba con ossa non più in connessione anatomica (t. 27) -1 tomba con scheletro in posizione supina (t. 76) -1 tomba con scheletro in posizione inginocchiata (t. 106) -2 fosse senza scheletro (tt. 2 e 4) - 31
In Italia la deposizione del corpo in posizione supina ma con gambe flesse e ripiegate da un lato non è una peculiarità limitata all’ambito remedelliano. Nella cultura del Gaudo la posizione dei morti rin-venuti ancora in connessione anatomica è nella maggior parte dei casi quella che Voza ha denominato “supino-rattratta”, corrispondente al tipo Rückenhocker, mentre i rannicchiati sul fianco sinistro o destro sono in numero minore32. È opportuno ricordare che nella necropoli del Gaudo sono presenti quattro spilloni in osso del tipo con testa a T33. La posizione del cadavere nella fossa del tipo Rückenhocker era ampiamente diffusa nell’area delle steppe nordpontiche fino ai Carpazi34, in particolare nell’ambito della cultura Jamnaya35, ma anche successivamente nella cultura delle Catacombe36. Questo specifico costume funerario è proprio uno degli elementi che ha permesso di riconoscere la penetrazione di gruppi Jamnaya dalla Moldavia lun-go il Danubio e la Tisza37. Nella tomba centrale del tumulo di Velika Gruda (nel golfo del Cattaro/Kotor, Montenegro), studiata da Margarita Primas, il defunto era stato deposto in questa posizione e tra i confronti che l’autorevole studiosa propone vi è proprio Remedello (Primas 1996, 36, tab. 3).
29 La tomba 76 di Remedello è una sepoltura anomala, cfr. infra.30 Cfr. foto in Corrain, Gallo 1968, fig. 10 e Acanfora 1956, 325 e 328.31 Colini 1898, 20 segnala un’altra fossa vuota, non numerata, accanto alla tomba 18 nel riparto Nord.32 Cfr. a questo proposito Bailo Modesti, Salerno 1998, 173 e ss. e fig. 71.33 Bailo Modesti, Salerno 1998, 140 e fig. 59.34 A questo proposito cfr. Häusler 1974, 1976 e 1985.35 Pit-grave culture, Grubengrabkultur.36 Si tratta di deposizioni in grotticelle artificiali, da qui il nome di Katakombenkultur, ricoperte comunque da un tumulo. 37 Cfr. Harrison, Heyd 2007, 193 e ss., figg. 43-44.
313
L’infiltrazione di persone originarie dall’area delle steppe fin verso il cuore dell’area della Schnurkeramik è dimostrata dalla ben nota tomba di Bleckendorf (Sachsen-Anhalt, D), in cui alla posizione del corpo del tipo Rückenhocker, si accompagna uno spillone con testa a T in osso38.Nel caso di Remedello non credo che si possa parlare di gruppi provenienti da est, tutto porta a rite-nere che si tratti di influssi culturali, di una semantica transculturale che nel corso dell’età del Rame si diffonde ampiamente, al pari del fenomeno delle statue-stele e delle stele antropomorfe.Tuttavia, non si può trascurare il fatto che la posizione del defunto in decubito dorsale con gambe flesse e ripiegate di lato compare già nella cultura VBQ in Emilia, dove rappresenta circa il 15 % dei casi39. Non avendo finora necropoli del Neolitico tardo (Chassey-Lagozza), non è possibile verificare la continuità tra VBQ e Remedello per questo aspetto dei riti funerari. Considerato lo stato della documentazione, appare molto problematico definire i motivi per cui i morti erano seppelliti in decubito dorsale con gambe flesse e piegate di lato oppure rannicchiati su un fianco oppure in posizione supina. Tutte le tombe con il più ricco corredo di armi erano senza dubbio del tipo Rückenhocker, ma anche alcune tombe di rannicchiati sul fianco sinistro avevano pugnale di selce e cuspidi di freccia40. Di un certo numero di tombe di armati, che secondo Bandieri e Colini erano rannicchiati su un fianco, non abbiamo la possibilità di una verifica41. Non ci sono associazioni sicure tra ceramiche e armi, per cui è probabile che le ceramiche siano l’indizio di una sepoltura femminile. Anche per comprendere il significato delle due tombe vuote, del tutto prive di ossa umane, non abbia-mo molti elementi a disposizione. Nella t. 2 furono ritrovati una scheggia e due nuclei di selce, nella t. 4 un ricco corredo comprendente un pugnale di selce, tre cuspidi di freccia, un’ascia di rame a margini rialzati, un dischetto di arenaria, una lama o scheggia di selce. La fossa aveva forma ovale, orientata N-S, e tutti gli oggetti erano lungo il lato orientale: verso nord la rondella, le frecce e l’ascia, più giù, verso il centro del lato, la scheggia o lama e poi il pugnale. L’ascia e il pugnale erano rivolti verso est, quindi verso il margine della fossa, le frecce avevano la punta verso ovest, quindi verso il centro della fossa. Nel complesso sembra che gli oggetti di corredo fossero nella posizione che avrebbero occupato se fossero stati deposti insieme al defunto, di cui però non è stata trovata alcuna traccia.L’interpretazione come cenotafio per un individuo di rango elevato perito lontano dal villaggio o di cui comunque non è stato possibile recuperare la salma, non sembra un’ipotesi molto convincente. È forse più probabile l’ipotesi di una riesumazione delle ossa per l’esecuzione di alcuni riti e per una loro seconda e definitiva sepoltura altrove. D’altra parte qualche indizio dell’esistenza anche nella necropoli di Reme-dello del rito della doppia sepoltura o meglio della manipolazione delle ossa dei defunti è fornito dalla t. 27, le cui ossa furono ritrovate disarticolate e in disordine, pur essendo la fossa intatta. In una serie di tombe ritenute da Bandieri intatte, lo scheletro non era completo. Nella t. 76 lo scheletro di un adulto in posizione supina e orientato verso E/NE, era privo della mandibola, dell’avambraccio sinistro, di tutta la parte destra. Che non si tratti di dispersione provocata da agenti naturali o da animali, è dimostrato dal fatto che, secondo Bandieri, le vertebre erano tagliate a metà. Siamo quindi di fronte a un caso di mutilazione, certamente post mortem, ma il cui significato è difficile da comprendere. Si possono avanzare solo ipotesi, dal cannibalismo rituale al vampirismo42, ma nessuna è ovviamente verificabile.I casi di mutilazione sembrano frequenti tra gli adulti inumati in posizione supina (sempre secondo
38 Harrison, Heyd 2007, 201 e fig. 49, con bibliografia precedente.39 Cfr. Bernabò Brea et Alii 2010, tabella III e fig. 18.4, fig. 31 B 5-B.40 Tombe 40, 56, 73, BS II, tomba conservata a Viadana. Di conseguenza l’ipotesi espressa in forma dubitativa da M. Primas 1996, tab. 3.1 che a Remedello la posizione rannicchiata sul fianco fosse per le donne e quella Rückenhocker per gli uomini non può essere accolta.41 Ad es., le tombe 81, 82, 95, 97, 99.42 Una delle cause delle mutilazioni post mortem può essere la credenza che i soggetti colpiti da morte prematura o “cattiva”, cioè in seguito a violenza, o i soggetti dotati in vita di poteri “soprannaturali” divenissero vampiri e di notte uscissero dalla tomba per succhiare il sangue ai vivi. I morti sospettati di vampirismo venivano mutilati o bruciati. Queste credenze erano ampiamente diffuse nel mondo slavo. Cfr. a questo proposito Gasparini 1957, in particolare 30-33.
314
Colini 1898). Infatti, oltre a quello appena citato, ricordiamo ancora le tt. 24 e 43, entrambe prive di corredo come la t. 76. Nella t. 24 mancava il femore destro, nella t. 43 mancavano il braccio destro, parte delle costole e il femore destro. A proposito di queste tombe il Bandieri ha scritto: “A tutta prima si ritennero manomessi, ma dopo un attento esame, si riconobbe che le mutilazioni più o meno gravi dello scheletro erano il prodotto del compimento di una cerimonia, di un rito inerente alla religione dei sepolcri”.
Bandieri, ripreso da Colini, per definire l’età degli inumati utilizza i termini di bambino, giovane, adolescente, adulto e vecchio, quest’ultimo solo in due casi (tt. 32 e 35). Il problema è capire cosa in-tendesse per giovane. Infatti, il termine giovane utilizzato dal Bandieri e ripreso dal Colini è piuttosto ambiguo, poiché nel linguaggio comune può applicarsi a individui all’inizio dell’età puberale (ca. 10-13 anni), ad adolescenti che hanno già raggiunto la maturità sessuale ma non hanno concluso il processo di crescita (da 14 fino a 20/21 anni) o addirittura ad individui che si trovano all’inizio dell’età adulta. Ovviamente non è più possibile alcuna verifica dell’uso effettivo che è stato fatto del termine dal Ban-dieri caso per caso (né sappiamo quali fossero le sue competenze antropologiche), a parte un’eccezione, la t. 56, conservata intatta al museo di Reggio Emilia, in cui il soggetto, definito “persona di giovane età” da Bandieri, è certamente non adulto, trattandosi di un ragazzo dell’apparente età di 12-13 anni, a cui è già spuntato il secondo molare43. Utilizzando quindi le indicazioni del Bandieri, integrate con i dati degli scheletri conservati, possiamo osservare come si ripartiscono, a grandi linee, le classi di età: bambini (= infans I e infans II) 12 soggetti (12,76 %), juvenes 14 (14,8 %), adulti 66 (70,2 %), senili 2 (2,1 %). Il dato che colpisce è l’alta percentuale della classe “juvenis”. Infatti, in tutte le popolazioni è questa la classe in cui si registra il minimo di mortalità, per cui in un quadro della mortalità di una popolazione la sua percentuale dovrebbe essere al di sotto del 3%. In altre parole ciò significa che la consistenza originaria della necropoli doveva essere di gran lunga maggiore, e ammettendo che i morti in età neonatale o nei primi anni di vita non avessero accesso alla necropoli, si può proporre un ordine di grandezza intorno alle 400 unità.
Analisi dei materialiA. CeramicheLa deposizione di ceramiche come corredo funerario nella necropoli di Remedello è, così come in quella di Fontanella Mantovana, poco frequente, e del tutto assente a Volongo – ma in questo caso il campio-ne è di sole tre tombe – e in altre tombe coeve dell’area padana, a differenza di quanto si verifica nelle tombe del gruppo di Spilamberto o nelle culture di Rinaldone, del Gaudo e di Laterza. A Remedello soltanto sedici tombe hanno restituito vasellame ceramico44, ma soltanto in dieci casi il vaso si conserva più o meno integro o la sua forma è graficamente ricostruibile. Bandieri nel suo Ragguaglio tratta sin-teticamente di alcune ceramiche, fornendo comunque i disegni di cinque vasi e due frammenti, mentre Colini avendo interrotto il suo ampio lavoro su Remedello non arrivò a trattare delle ceramiche, per cui non abbiamo notizie sullo stato di conservazione delle ceramiche a distanza relativamente breve dalla loro scoperta. Dobbiamo a Cornaggia Castiglioni (1971) la prima pubblicazione quasi integrale del materiale ceramico conservato, ma solo con fotografie, mentre Barfield nel 1979 pubblicò i disegni dei vasi delle tt. 65, 71, BS III e BS IV. Recentemente è stato pubblicato lo studio integrale delle ceramiche di Remedello da parte di C. Longhi (2010)45.
43 La stima effettuata da Loretana Salvadei definisce il soggetto come un individuo maschile di ca. 13-14 anni.44 Tombe 36, 37, 42, 45, 46, 64, 65, 70, 71, 72, 75, 93, 105, BS III, BS IV, tomba anno 1898.45 Il valore dello studio, pregevole per quanto concerne l’accurata disamina dei dati d’archivio, la descrizione dei materiali e la bibliografia, è inficiato da
315
La maggior parte delle ceramiche di Remedello sono forme profonde, contro tre soli casi di forme aperte di secondo grado. Queste ultime comprendono una tazza con corpo a calotta, fondo piano-convesso ombelicato e ansa a gomito con ponticello orizzontale e apice leggermente rilevato (t. 42) (fig. 8), una tazza a profilo carenato (t. 70) e una piccola coppa tronco-conica con piede a tacco di forte spessore (t.
errori nella presentazione grafica dei materiali: per quanto riguarda il vaso biconico della tomba 46 né nel disegno né nella descrizione viene evidenziato il fatto che lungo l’orlo vi sono due coppie di fori esattamente in corrispondenza delle due linguette perforate verticalmente; nella tazza della tomba 42 il ponticello superiore dell’ansa appare inclinato verso il basso, mentre è orizzontale; nella ricostruzione del vaso della tomba 75 non si è compreso che i tre frammenti rimontati dall’ultimo restauro (Longhi 2010, fig. 5 in basso a sinistra), non hanno alcun punto di attacco e che il frammento a destra è pertinente al fondo ed è stato assemblato invertendo il basso con l’alto, mentre il frammento a sinistra appare ruotato di alcuni gradi (il fascio di linee parallele che dovrebbe essere orizzontale appare in posizione obliqua). Infine per la tazza della tomba 70 è necessario rifarsi al disegno pubblicato dal Chierici, dal momento che in seguito la maggior parte dei frammenti sono spariti e anche tenendo conto della grande affidabilità del Chierici come disegnatore. Comunque il disegno pubblicato in Longhi 2010, fig. 4, non corrisponde perfettamente neppure all’attuale rimontaggio dei pochi fram-menti superstiti. Non ci sono elementi per ritenere che il diametro all’orlo fosse superiore rispetto a quello alla carena, anzi è il contrario.
Fig. 11 - Remedello Sotto, località Campo Dovarese. Vaso della tomba 71.
Fig. 8 - Remedello Sotto, località Campo Dovarese. Tazza con ansa a gomito dalla tomba 42.
Fig. 9 - Remedello Sotto, località Campo Dovarese. Ceramiche delle tombe 42, 72 e 70. Scala: 1/3 della gr. nat. Disegni e lucidi di Marta Rapi. Per la tomba 70 è riportato il disegno pubblicato da Chierici, in cui è evidente l’attacco inferiore dell’ansa.
Fig. 10 - Remedello Sotto, località Campo Dovarese. Ceramiche delle tombe 71 e 93. Scala: 1/3 della gr. nat. Disegni e lucidi di M. Rapi e R.C. de Marinis.
316
72)46. Il disegno della tazza della t. 70 fu pubblicato dal Chierici, che ne diede anche una descrizione47 (fig. 9). Aveva fondo piatto, corpo a carena bassa e parete concava leggermente rientrante. Dell’ansa, di tipo nastriforme, si conservava soltanto la parte inferiore impostata lungo la massima espansione coincidente con la carena, l’attacco superiore era sull’orlo, ma non possiamo stabilire se l’ansa fosse del tipo a gomito, semicircolare, sopraelevata o altro. Cornaggia Castiglioni tentò un restauro ispirandosi al disegno del Chierici48. Nel corso del tempo la maggior parte dei frammenti è sparita e l’attuale ricom-posizione dei pochi frammenti superstiti49 non è da ritenersi del tutto attendibile alla luce del disegno pubblicato da Chierici. Tra le forme profonde vi sono piccoli recipienti troncoconici a parete leggermente bombata e orlo for-temente rientrante a profilo leggermente concavo, fondo piatto a spigolo arrotondato, presette a doppia perforazione verticale collocate lungo la carena da entrambi i lati (tt. 93 e BS IV) oppure con coppie di fori passanti sull’orlo in posizione tra loro diametralmente opposta (tomba 71)50 (figg. 10-12). A questo gruppo appartiene il vaso della t. 75, la cui ricostruzione è molto problematica soprattutto per quanto riguarda la parte superiore, dall’orlo fino alla massima espansione con le presette perforate51. Il vaso della t. 71 presenta una decorazione di tre fasci di linee orizzontali incise, rispettivamente 5, 6 e 8, collocate subito sotto l’orlo, a metà altezza e verso la base. Quello della t. 93 è inornato, mentre il vaso BS IV ha una decorazione di tipo metopale a leggere solcature, probabilmente eseguite a pettine come già riconosciuto da Cornaggia Castiglioni, sia subito sopra la massima espansione del vaso sia a metà altezza (fig. 12). La ricostruzione della decorazione del vaso della t. 75 è incerta a causa dello stato di conservazione troppo frammentario, sembra che fosse costituita da due fasci di cinque linee orizzontali incise subito sotto la massima espansione e verso la base, dal fascio superiore si dipartivano gruppi di sei linee incise che scendevano obliquamente verso destra e verso sinistra e il loro incrocio nella parte
46 La proposta di vedervi un coperchio (Longhi 2010) non mi sembra verosimile. Va chiarito che mentre esistono fogge vascolari che sono esplicitamen-te dei coperchi – e il vaso della tomba 72 non rientra in queste fogge – qualunque coppa o ciotola poteva essere usata anche come coperchio collo-candola in posizione rovesciata, ciò non toglie che siano coppe o ciotole e non coperchi. Inoltre, Chierici (1885, 141) scrisse che la tomba 72 (allora indicata come 11) aveva “tre vasetti d’argilla, uno dei quali soltanto raccolto intero”. Nessun recipiente, quindi, di cui la coppa avrebbe potuto essere l’eventuale coperchio. 47 Chierici 1885, 144, tav. VI, 12.48 Cornaggia Castiglioni 1971, tav. XVII, 1.49 Longhi 2010, fig. 4.50 Cfr. Bandieri ms, tav. X, 1; Colini 1898, tav. VII, 8 e 6; fig. 39; Cornaggia Castiglioni 1971, tav. XIII, 2; tav. XIV, 2; tav. XV, 2; Barfield 1979, fig. 23.4,6. L’orlo del vaso della tomba 71 è solo parzialmente conservato, ma è più che probabile che le coppie di fori fossero due in posizione diametral-mente opposta.51 Cornaggia Castiglioni 1971, tav. XIII, 1; Longhi 2010, figg. 4-5.
Fig. 12 - Remedello Sotto, località Campo Dovarese. Vaso della tomba BS IV.
Fig. 13 - Remedello Sotto, località Campo Dovarese. Vaso della tomba 75. Scala: 1/3 della gr. nat. Disegno e lucido di Marta Rapi.
317
Fig. 14 - Remedello Sotto, località Campo Dovarese. Vaso biconico con decorazione metopale della tomba 46.
superiore determinava un motivo a reti-colo52 (fig. 13).Due vasi chiaramente biconici sono quelli delle tt. 46 e BS III53. Il primo lungo la linea di carenatura e massima espansione ha due linguette semicir-colari, rivolte verso il basso con due perforazioni verticali, alle quali corri-spondono lungo l’orlo due fori passanti. Certamente questi fori sono in relazione al passaggio di cordicelle dall’orlo alla linguetta per appendere il vaso oppure
per tenere fermo un coperchio, ad es. di legno. Il biconico della t. 46 presenta lungo la fascia della massima espansione una decorazione metopale eseguita a sottili linee incise (figg. 14-15). Quello della t. BS III ha due presette con doppia perforazione verticale lungo il diametro massimo ed è inornato.Alla t. 65 è assegnato dal Bandieri e dal Colini un grande boccale a corpo biconico-globoso con risega, orlo esoverso, fondo piatto e ansa a gomito, con ponticello superiore obliquo verso l’alto e apice rile-vato, la cui funzione doveva essere quella di una brocca (figg. 16-17). La decorazione consiste in un fascio di linee sottili incise lungo la gola e in una serie di cerchi eseguiti a solcatura lungo la massima espansione del corpo54.A un vaso forse simile sono da assegnare i frammenti di orlo e il frammento di ansa della t. 64. Quest’ul-tima presenta apice rilevato con due protuberanze. Un’ansa ripiegata a gomito era nella t. 45, ma non è possibile dire a quale forma vascolare fosse pertinente, forse una tazza. I frammenti dei vasi delle tt. 36, 37, 105 e della t. del 1898 non sono conservati.
52 La superficie della maggior parte dei frammenti è abrasa e non permette la lettura della decorazione. Inoltre, è possibile che le presette a perforazione verticale fossero due per lato. 53 Colini 1898, tav. VII, 7 e fig. 38; Cornaggia Castiglioni 1971, tav. XIV, 1; tav. XVI, 2; Barfield 1979, fig. 23.7.54 Colini 1898, tav. VII, 5; Cornaggia Castiglioni 1971, tav. XVII, 2; Barfield 1979, fig. 23/5; Longhi 2010, fig. 3.
Fig. 15 -. Remedello Sotto, località Campo Dovarese Vaso biconico con decorazione metopale della tomba 46. Scala: 1/3 della gr. nat. Disegno e lucido di Marta Rapi.
318
La scarsità di complessi ceramici dell’età del Rame pre-campaniforme in area padana, specialmente a nord del Po, è un fatto ben noto, e ha sostanzialmente due cause: la non conoscenza degli abitati e la poco frequente deposizione delle ceramiche nelle tombe. Da ciò deriva una notevole difficoltà nell’in-quadrare la ceramica di Remedello. Al contrario, nell’area subalpina e alpina, caratterizzata da sepolture collettive in caverne e ripari sottoroccia, la ceramica è meglio documentata ed è stato possibile definire da parte di A. Pedrotti (1997) un gruppo Tamins-Isera 5 da correlare con la ceramica a fori non passanti/White Ware definita da L.H. Barfield (1979), il quale nel suo ultimo lavoro ha proposto di abbandonare la sua precedente denominazione a favore di Ceramica Civate Grossolana (Barfield 2007, 196). Alcuni confronti per le ceramiche di Remedello si trovano al Riparo Valtenesi di Manerba. La decora-zione a tre gruppi di fasci orizzontali di linee incise del vaso della t. 71 è presente a Manerba su un vaso tronco-conico poco profondo, con alto orlo introflesso (P77), proveniente dal Burnt Burial Deposit, che ha restituito anche frammenti di vasi decorati nel cd. stile di Manerba con fasce a reticolo incise (P 58 e P 60). In nostri precedenti lavori abbiamo attribuito la t. 71 alla fase Remedello 1 e la posizione topografica all’interno del riparto sud non contrasta con questa datazione, infatti tutta la metà sud-orientale del riparto appare come l’area più antica della necropoli (de Marinis 1992, 1997a, 1997b). Barfield (2007) ha espresso la convinzione che al riparo Valtenesi non sia riconoscibile una differente cronologia da sud verso nord e che tutti i complessi indagati siano contemporanei. Tuttavia, il BBD ha la data radiocarbonica più antica finora disponibile per il riparo, ottenuta da una falange umana, purtroppo con un errore di ± 100, per cui nella calibrazione si produce un range di 750 anni, che per la maggior parte cade nella fase cronologica Remedello 1, ma che inevitabilmente si estende anche nella fase 2 (OxA 4550, Barfield 2007, 419-420). La camera 133, la piattaforma settentrionale e il pozzetto della cremazione hanno date che per quanto parzialmente sovrapponibili a quella del BBD, sono nel complesso più recenti. Inoltre, la dendrocronologia effettuata sui legni della camera 133 indica una data di taglio posteriore al 2947-285955, quindi certamente la camera 133 rientra nell’orizzonte cronologico della fase Remedello 2. Il vaso biconico con decorazione metopale della t. 46 per la particolarità delle coppie di fori subito sotto l’orlo e in corrispondenza delle due linguette a perforazione verticale trova riscontro al riparo Valtenesi nei vasi P63 e P65 della camera 133 e P66 del pozzetto della cremazione
55 Cfr. Barfield, Manning, Valzolgher e Higham 2010. I campioni di legno utilizzati non hanno alburno, quindi potrebbero essere assenti anche anelli di duramen. Il numero calcolato degli anelli mancanti tra duramen e alburno (13) potrebbe essere troppo basso. Negli scavi del Lavagnone sono stati osservati legni di quercia con un numero molto elevato di anelli di alburno, superiore a quanto si riscontra nelle querce attuali in Italia.
Fig. 16 - Remedello Sotto, località Campo Dovarese. Boccale/brocca della tomba 65.
Fig. 17 - Remedello Sotto, località Campo Dovarese. Boccale/brocca della tomba 65. Scala: 1/3 della gr. nat. Disegni e lucidi di Marta Rapi.
319
(Barfield 2007, figg. 107-108). Barfield ha richiamato per questa particolarità un vaso biconico della t. III dell’Uditore (Palermo)56. Da notare che tutti questi vasi hanno piccole dimensioni: a Remedello h 12,8 (t. 46), 11,7 (t. 93), 9,5 (t. 71); a Manerba h 12, 12,2 e 13 cm; Uditore h 10,6 cm. La tomba bisoma 46 di Remedello vede l’associazione tra il biconico a decorazione metopale e un pugnale di selce a codolo distinto, tipico della fase Remedello 2. La camera 133 e il Cremation Pit di Manerba si collocano in questo stesso orizzonte cronologico. La decorazione cd. metopale è ben documentata a Colombare di Negrar57, purtroppo senza dati associa-tivi e stratigrafici, ed è inoltre diffusa in Veneto anche a Grotta Perin e Selva di Stanghella, in Lombardia al riparo Valtenesi, in Trentino al riparo Gaban, in Piemonte al Castello di Annone e a Briona, in Liguria alle Arene Candide, in Val d’Aosta a Vollein e in Emilia alla Tana della Mussina e a Spilamberto58. In tutti questi siti non ci sono possibilità di datazione puntuale, quindi la t. 46 di Remedello è l’unico contesto datante per lo stile decorativo metopale in Italia settentrionale. Le affinità tra la ceramica a decorazione metopale di Remedello e quella della cultura di Fontbouisse in Linguadoca furono eviden-ziate per la prima volta da M.O. Acanfora e L. Bernabò Brea59, da allora sono state in genere ammesse, a volte contestate. A noi sembrano indubbie, anche considerando che l’orizzonte cronologico è in gran parte coincidente60.La t. 65, con il boccale a corpo biconico-globoso e la grande ansa a gomito, a prima vista sembrerebbe potersi datare con sicurezza alla fase Remedello 2 per tutta una serie di motivi: innanzitutto la datazio-ne 14C della tomba (ETH 12188: 4185 ± 70 BP), poi l’associazione con due pugnali di selce a codolo distinto, infine, la collocazione topografica in un’area del riparto Sud ricca di tombe di questa fase (tt. 56, 60, 64, 78, 79, 83). Tuttavia, la t. 65 è di quelle incassate e portate al museo di Reggio, ove fu scavata dal Chierici stesso l’11 novembre 1885. Il boccale non era allo stesso livello dello scheletro, dei pugnali e delle cuspidi di freccia, ma fu rinvenuto poco a nord-ovest del cranio 35 cm più in alto dello stesso, “nel rinterro della fossa”. A mezzo metro verso ovest rispetto alla t. 65, la t. 64 racchiudeva un adulto in posizione supina e vi furono rinvenuti frammenti ceramici di un vaso forse simile a quello della t. 65. La distanza di 50 cm è troppa per pensare a un’eventuale pertinenza del boccale alla t. 64, tuttavia potrebbe trattarsi del corredo di una tomba posta a un livello più elevato rispetto alla 65 e che ne avrebbe intercettato l’estremità nord-occidentale. Altrimenti bisogna ipotizzare il caso di un’offerta collocata quando la fossa era ormai quasi completamente colmata di terra. In conclusione, la datazio-ne non può che essere la fase Remedello 2, anche nel caso in cui il vaso sia appartenuto a una tomba posteriore alla 65. Infatti, possiamo dare per certo che si tratti di un tipo anteriore all’antica età del Bronzo, dal momento che su tonnellate di ceramiche di questo periodo provenienti dagli abitati pala-fitticoli dell’area benacense non è reperibile un solo confronto per questo boccale, né ci sono elementi per attribuirlo al periodo campaniforme.
56 Cfr. Cassano, Manfredini 1975, fig. 19.5.57 Cfr. Fasani, Visentini 2002, fig. 5.58 de Marinis, Pedrotti 1997, carta fig. 10; Fasani, Visentini 2002, fig. 6. Da espungere il sito del Bersaglio dei Mori nel Trentino e quello di Chianocco in Val di Susa, trattandosi di frammenti con fasce a reticolo, da collegare eventualmente allo stile di Manerba.59 Acanfora 1956, 358 e ss., fig. 10; Bernabò Brea L. 1956, 259.60 Recentemente J. Vital (2010 e 2011) ha proposto di invertire l’ordine cronologico delle fasi Remedello 1 e 2, la seconda fase con il vaso a decorazione metopale della tomba 46 sarebbe la più antica e la prima fase la più recente. Vital ha presentato una sorta di tabella di associazione (2011, fig. 3), in cui i siti con ceramica metopale di Remedello, Colombare, Arene Candide, Annone, Briona e riparo Valtenesi sono datati tra 3100 e 2800 a.C. Tra i siti datati Vital pone le Arene Candide e il riparo Valtenesi. Nella grotta ligure i frammenti metopali provengono dagli strati superiori, in cui sono presenti materiali che spaziano dal Neolitico all’età del Ferro (quindi nessun contesto valido né tanto meno associazioni chiuse con materiali datati dal radiocar-bonio), al riparo Valtenesi il frammento metopale P 46 è in posizione stratigrafica incerta. Rimane il solo piccolo frammento della Balme des Sollières, attribuito alla fase Neolitico Finale inferiore 2, per la quale si dispone di due date Ly 7507 4245 ± 55 BP e Ly 7508 4252 ± 90 BP. A parte il fatto che queste date sono state ottenute da carboni non determinati – cosa che Vital non dice – una volta calibrate queste date ci riportano alla prima metà del III millennio a.C., vale a dire alla fase Remedello 2. Non capisco come mai Vital ritenga che la decorazione metopale non sia presente a Fontbouisse, ma solo quella a scacchiera o a fasci di linee orizzontali (quest’ultimo motivo non può avere alcun valore cronologico). In questa sede per motivi di spazio non posso soffermarmi oltre sulla stravagante proposta di J. Vital.
320
La decorazione così caratteristica, con teoria di grandi cerchi lungo il diametro massimo del vaso, eseguiti a leggera solcatura, ha ora un confronto a Monte Covolo. Negli scavi 1998-1999 è stata rinve-nuta una tazza con ansa nastriforme leggermente sopraelevata, recante sul corpo una serie di tre cerchi eseguiti a leggera solcatura. La tazza proviene dal fondo di un pozzetto che sembra connesso con un rito di fondazione. Il pozzetto sarebbe stato scavato a partire da un livello attribuito ad età neolitica61. Il Neolitico di Monte Covolo appartiene alla facies tardo neolitica di tipo Breno62. In assenza della pubblicazione dei dati di scavo in maniera sufficientemente esauriente, è difficile esprimere valutazioni sulla datazione effettiva di questa tazza, anche perché le datazioni radiocarboniche finora edite non sono del tutto coerenti con la sequenza stratigrafica63. In effetti, una differenza di 1000-1400 anni tra il boccale di Remedello e la tazza di Monte Covolo sembra difficile da spiegare. Tuttavia, non si può ignorare il fatto che lo stesso tipo di decorazione compare anche su altri frammenti ceramici degli strati tardo neolitici.Il vaso della t. 75 pone problemi di ricostruzione della sua parte superiore, dal momento che il restauro con larghe integrazioni di gesso effettuato negli anni ’60 del secolo scorso si è rivelato non attendibile64. La t. 75 è stata datata con il 14C e si pone al limite tra le fasi Remedello 1 e Remedello 265. La decora-zione di questo vaso non ha confronti puntuali66.In conclusione, appartengono alla fase Remedello 2 le ceramiche delle tt. 42, 45, 46, BS III, BS IV, 64, 65 e probabilmente 70. A cavallo tra le fasi 1 e 2 è da porre la t. 75, ma considerando la sua posizione topografica appare più probabile la pertinenza alla fase 2, mentre alla fase 1 sono da assegnare le tt. 93 e 71. La piccola coppa tronco-conica con piede a tacco in virtù della posizione topografica della t. 72 è da riferire probabilmente all’ultimo orizzonte cronologico dell’età del Rame, quello campaniforme. Dalle ceramiche della necropoli eneolitica deve essere eliminato il frammento di scodellone con ansa canaliculata per i motivi esposti in preceden-za, anche se la sua attribuzione a “sepolcri incerti” nell’esposizione museale, se non ad-dirittura alla tomba LXI, può creare qualche equivoco67.A Fontanella Mantovana le ceramiche erano presenti in 5 tombe su 20. Ne conosciamo solo tre: tt. 2 e 9 e da una tomba non numerata68. Nessuna ha confronti a Remedello, se non per la qualità scadente della modellazione e dell’impasto, ad es. dei vasi delle tt. 70 e 93. Per quanto riguarda l’attribuzione di genere nelle tt. 46 e 75 di Remedello la ceramica rap-presenta il corredo di deposizioni femminili69,
61 Cfr. Poggiani Keller, Baioni, Lo Vetro e Martini 2002, 318 e fig. 4.1; Poggiani Keller, Baioni 2004, 30-31 e tav. 7.1.62 Per questo aspetto culturale cfr. Odone, Fedele 2002 e Fedele 2000, con bibliografia precedente.63 Cfr. Poggiani Keller, Baioni 2004, 54 e 2008, 182 e fig. 18.64 Cfr. la foto pubblicata da Cornaggia Castiglioni 1971, tav. XIII,1.65 Cfr. de Marinis, Pedrotti 1997, tab. 7; de Marinis 1997b, 45.66 Bagolini e Biagi 1988 considerano le ceramiche delle tombe 71 e 75 come appartenenti allo stile metopale, il che non ci trova consenzienti, poiché per stile metopale non si può intendere qualunque decorazione lineare incisa, ma soltanto una decorazione in cui fasci di linee orizzontali si alternano a fasci verticali o a reticolo, come appunto si verifica nelle ceramiche di Fontbouisse. Cfr. ad es. J. Audibert, La civilisation chalcolithique du Languedoc oriental, Bordighera-Montpellier 1962, fig. 6. 10,11, 12, 15. A Remedello sono presenti soltanto due vasi decorati secondo lo stile metopale. 67 Equivoco in cui sono incorsi vari autori (cfr. ad es. Barfield 1979, fig. 23.8, Longhi 2010, fig. 4).68 Cfr. Cornaggia Castiglioni 1971, tavv. XV, 1; XVI, 1; XIX, 1.69 Il soggetto della tomba 75 è una donna di oltre cinquant’anni (comunicazione della dr.ssa Loretana Salvadei, che ringrazio per la sua cortese disponi-bilità al dialogo e allo scambio di informazioni).
Fig. 18 - Remedello Sotto, località Campo Dovarese. Pugnale di rame e accetta di pietra levigata dalla tomba 106. Scala: ½ della gr. nat. Disegni e lucidi di M. Rapi e R.C. de Marinis.
321
anche la t. BS III fu giudicata femminile dal Ruzzenenti, forse per la posizione supina. A Fontanella appare con maggiore chiarezza la pertinenza femminile della ceramica (tt. 2, 7 e 9). La tomba non numerata conservata al museo Pigorini oltre al vaso tronco-conico con fila di bugnette, aveva anche 7 cuspidi di freccia in selce. Tuttavia, il fatto che si tratti di un “residuo di tomba a inumazione” e sia conservato solo un frammento dell’arto superiore, getta qualche dubbio sulla reale associazione tra frec-ce e ceramica. Abbiamo già discusso la pertinenza o meno del grande boccale con ansa a gomito alla t. 65 di Remedello, tomba di un soggetto maschile di età adulta matura. La t. 45, con ansa fittile e una lama probabilmente di alabarda in rame, fu rinvenuta già parzialmente manomessa e di conseguenza l’associazione permane dubbia70.
B.Manufatti di metalloDodici tombe della necropoli di Remedello avevano nel corredo qualche oggetto di metallo, sempre in rame e in un solo caso in argento: pugnali, asce, lesine, uno spillone, un orecchino di filo avvolto a spirale.
I pugnaliI pugnali di rame sono cinque e appartengono a tipi diversi. Nella t. 106, scoperta da Ruzzenenti nella primavera del 1885, il pugnale è del tipo a base semplice arcuata, larga e leggermente debordante rispet-to alla lama, con cinque fori per i ribattini, di cui uno solo si conserva. La lama ha forma triangolare corta, con lati leggermente inflessi71. La guardia dell’impugnatura in materiale organico, molto proba-bilmente legno, aveva lasciato tracce evidenti sulla base della lama, dove si poteva osservare una linea retta poco sotto i due ribattini laterali. L’attuale stato di conservazione è molto precario, soprattutto
70 Tuttavia, recentemente nella necropoli di Forlì-Celletta dei Passeri una tomba con scheletro giudicato femminile, di età adulta senile, aveva per corre-do una piccola lama di alabarda in rame. Cfr. M. Miari in questo volume.71 Chierici 1885, 142 e tav. VI,1; Bandieri ms, tav. VI, 2; Colini 1898, 46 e tav. IX, 3; Mosso 1910, fig. 166; Cornaggia Castiglioni 1971, tav. X, 2; Bianco Peroni 1994, n. 31. La classificazione come tipo Rinaldone (ibid., 6-7) non è condivisibile per l’evidente differenza di forma tra il pugnale di Remedello e quelli della tomba 3 di Rinaldone e di Poggio Aquilone. La presenza di cinque fori per i ribattini è riconoscibile soltanto nel disegno pubblicato dal Chierici. Nel disegni del Ragguaglio del Bandieri la base del pugnale appare già maggiormente lacunosa, evidentemente per asportazione di qualche parte per l’analisi chimica eseguita dal prof. Spallanzani per incarico di Chierici (1885, 141, nota 2).
Fig. 19 - a. Pugnale in rame dalla tomba 79 di Remedello Sotto, b. pugnale in rame dalla tomba 1 di Volongo, campo Panesella, c. pugnale in rame da Carbonara Ticino, loc. Sabbioni. Scala: ½ della gr. nat. Disegno e lucido di R.C. de Marinis.
a. b. c.
322
per quanto riguarda la base, che ha subito asportazioni per l’analisi del metallo da parte del prof. Spal-lanzani (fig. 18). Il pugnale, analizzato in tempi più recenti dal gruppo di Stuttgart, ha un tenore di As del 4,1 % (SAM I, 641). La t. 106, collocata nel cd. riparto Sud, era di un individuo adulto deposto in posizione anomala rispetto alla norma, inginocchiato o accoccolato, rivolto in direzione Nord. Anche la profondità della tomba era di gran lunga maggiore della media delle tombe della necropoli. Il pugnale si trovava all’altezza della mano destra, con la punta verso l’alto.Nelle tt. 62, 79 e 83 abbiamo pugnali a lama triangolare, base rettilinea e codolo distinto, costituito da una breve linguetta di forma rettangolare fornita di un foro per il ribattino. È questo il pugnale comunemente definito tipo Remedello, ma che come vedremo è diffuso su un areale ben più ampio di quello della cultura di Remedello. Innanzitutto, i tre pugnali in questione sono simili tra loro, ma
presentano anche differenze. Il pugnale della t. 79 ha una lama triangolare corta, in cui la lunghezza oscilla intorno al doppio della larghezza alla base. La lama è molto sottile (spess. max 1,4 mm) ed ha una costolatura mediana poco rilevata, contornata su entrambi i lati da una leggera solcatura, la linguetta del codolo presenta un solo foro72 (fig. 19a). Analizzato dal gruppo di Stuttgart, il metallo ha un tenore di As dell’1,15 % (SAM II, 20297)73. Insieme al pugnale, che era stato deposto all’altezza del petto con la punta rivolta verso il mento – “in guisa quasi da toccare la mascella inferiore” (Bandieri) - sono state rinvenute “sulle costole dello scheletro” (Bandieri) sei piccole borchie di rame con capocchia a calotta e il gambo a sezione circolare. Secondo Colini, che riprende quanto scritto da Bandieri nel Ragguaglio, non potevano far parte del pugnale, ma sarebbero pertinenti a una cintura o a un balteo a cui era appeso il pugnale. In realtà, possono aver fatto parte dell’ornamentazione del pomo, senza svolgere alcuna funzione pratica, oppure, considerando la particolare sottigliezza di questo pugnale, il fissaggio delle due valve dell’impugnatura era stato fatto con queste borchie, per cui da un lato si aveva la capocchia a calotta e dall’altro soltanto la ribattitura del gambo.Pugnali del tutto identici, che nel 1994 abbiamo definito tipo Re-medello A 1 provengono da Volongo-Campo Panesella t. I74 (fig. 19b), Carbonara Ticino (PV)75 (fig. 19c), Cumarola (Maranello, MO) con due esemplari76, Orgon (Bouches-du-Rhône, Provenza)77 e ora anche da Forlì-Celletta dei Passeri (t. 47)78. La lunghezza della lama di questi pugnali, escluso il codolo, è compresa tra 11,2 e 13 cm, con l’eccezione dell’esemplare di Forlì, che è di dimensioni inferiori (9 cm). Una varietà caratterizzata da un codolo con due fori (tipo Remedello
72 Colini 1898, 36 e tav. IX, 1; Cornaggia Castiglioni 1971, tav. IX, 3.73 Il pugnale è stato analizzato anche da E. Slater, ma il dato riportato in Barker, Slater 1971 è certamente errato, probabilmente per un errore di impa-ginazione della tabella.74 Cornaggia Castiglioni 1971, tav. X, 1; Barocelli 1971, 81 ss., fig. 3; Bianco Peroni 1994, n. 7; de Marinis 1994, fig. 30; Odone 1994, figg. 142-143.75 Pearce 1991, 10-11, n. 17; Bianco Peroni 1994, n. 3. 76 Bagolini et Alii 1982, fig. 8 e fig. 21.77 Gallay G. 1981, n. 114. 78 Cfr. M. Miari in questo volume.
Fig. 20 - Remedello Sotto, località Campo Dovarese. Pugnale in rame dalla tomba 62. Scala: ½ della gr. nat. Disegno di R.C. de Marinis, lucido di M. Rapi.
323
A 2) comprende i pugnali da Cumarola tomba dell’anno 186079 e dalla Grotta del Castello di Vecchia-no80. Un frammento di pertinenza incerta proviene dalla grotta del Fontino81.Se i pugnali tipo Remedello A si caratterizzano per la lama triangolare corta, con una lunghezza che è all’incirca il doppio della larghezza della base, i pugnali tipo Remedello B hanno una lama triangolare lunga, con un rapporto lunghezza/larghezza alla base che varia da 2,2 fino a 4,5. In questo gruppo abbiamo pugnali con lama a costolatura mediana (B 1) e pugnali con lama piatta priva di costolatura (B 2). Il pugnale della t. 62 appartiene al tipo Remedello B 182. Tre ribattini con capocchia conica probabilmente erano disposti lungo il margine superiore del pomo semilunato o semicircolare (fig. 20). La tomba, in seguito numerata dal Bandie-ri come n. 62, fu scoperta nel febbraio 1884 al momento dello scasso del terreno per l’impianto del vigneto da Ferdinando Fissardi, della cascina Dossello di Sotto, il quale fornì a Ruzzenenti una serie di notizie sulla cui attendibilità già il Colini esprimeva molte riserve: lo scheletro sarebbe stato in posizione supina con il capo in direzione SW e i piedi verso NE, all’altezza del cranio vi era un fascio di 18-20 cuspidi di freccia, poi diventate 25, il pugnale di rame era all’altezza della mano destra, il corredo era completato da tre borchie, pertinenti evidentemente al pugnale di rame, da un pugnale di selce e da un’ascia di rame. La tomba sarebbe stata rinvenuta a 3 m dall’orlo del terrazzo83, ma nella pianta definitiva redatta da Bandieri la t. 62 è collocata a ca. 20 m dalla strada provinciale e 50 m dall’orlo del terrazzo. Il 10 dicembre 1885 lo stesso Chierici si fece dare dal presunto scopri-tore, Ferdinando Fissardi, la descrizione di questa tomba e sulla scorta delle indicazioni ricevute delineò lo schizzo della sepoltura e della posizione degli oggetti di corredo84: lo scheletro era disteso in posizione supina, con il capo orientato verso ovest, le tre borchie erano intorno al collo, come se si trattasse di una collana, l’ascia di rame era accanto all’omero sinistro con il taglio rivolto verso il basso, sempre sul lato sinistro vi erano due pugnali di selce, uno accanto al radio e l’altro accanto al femore, infine a lato della tibia e del perone si trovava il pugnale di rame, con la punta
79 Bagolini et Alii 1982, fig. 13 e 16; de Marinis 1992, nota 38 (il pugnale di Cumarola si conserva a Monaco di Baviera). Cfr. de Marinis, Faudino, Gambari in questo volume.80 Colini 1898, 218 e fig. 42; Cocchi Genick, Grifoni 1985, 101 ss., fig. 4:2; Cocchi Genick, Grifoni 1989, 29 fig. 11; Bianco Peroni 1994, n. 12.81 Bianco Peroni 1994, n. 74.82 Chierici 1884, 137, tav. VI, 1; Colini 1898, 27-228 e fig. 17; Mosso 1910, fig. 169; Cornaggia Castiglioni 1971, tav. IX, 1; de Marinis 1992, fig. 6:5; Bianco Peroni 1994, n. 2.83 Chierici 1884, 136-137.84 Cfr. R. Macellari in questo volume, fig. 7.
Fig. 21 - Remedello Sotto, località Campo Dovarese. Tomba 83 (foto F. Zaina, Bergamo).
324
verso il basso. Le 25 cuspidi di freccia erano riunite alla destra del cranio. Già da questa descrizione, che in più punti si discosta dalla versione precedente, è evidente la scarsa affidabilità del corredo.Il pugnale della t. 62 fu analizzato da Otto e Witter (O-W 299) e risultò di rame con un alto tasso di As (7,8 %), mentre due dei ribattini a capocchia conica furono analizzati dal gruppo di Stuttgart (SAM I, 639-640) e in entrambi i casi è risultato che erano di rame con un tenore di As molto più basso rispetto alla lama del pugnale, 0,62 e 0,68 %. Questa dif-ferenza sembra indicare che nel caso delle lame di pugnale l’arsenico era aggiunto intenzionalmente per aumentare la durezza del metallo.Pugnali tipo Remedello B 1 sono stati rinvenuti a Monte Bradoni85 e a Mirabella Eclano, tomba del capo-tribù86, mentre due nuovi esemplari sono stati scoperti a Forlì-Celletta dei Passeri87. Un pugnale riconducibile al tipo B 1 proviene da Lüscherz88, in-sediamento lacustre del Bielersee (cantone di Berna). Rientra nel tipo come variante il pugnale della tomba 11 di Fontanella Mantovana89, la cui base è lacunosa, in particolare della linguetta del codolo rimane solo
una piccola parte, inoltre alla base della lama vi sono due ribattini in posizione non simmetrica. La ricostruzione del codolo proposta dal Cornaggia ci sembra verosimile. La t. 83 fu trasportata intatta al museo di Reggio e accuratamente indagata da Pellegrino Strobel nel febbraio 188690 (fig. 21). Del corredo faceva parte un pugnale di rame a lama triangolare lunga e base rettilinea con codolo a linguetta con un foro per il ribattino. La lama è piatta, senza costolatura. Al
85 Cocchi Genick, Grifoni Cremonesi 1989, 32-36 con bibliografia precedente, fig. 14: 10, 11; Bianco Peroni 1994, nn. 10-11.86 G. Onorato, La ricerca archeologica in Irpinia, Avellino 1960; Bianco Peroni 1994, n. 13.87 Cfr. M. Miari in questo volume (tombe 25 e 27).88 Strahm 1971, fig. 29. 4; Strahm 1994, fig. 19.6.89 Colini 1898, tav. XIII, 1; Acanfora 1956, fig. 1 i; Cornaggia Castiglioni 1971, tav. IX, 4; Bianco Peroni 1994, n. 20.90 Bandieri ms, tavv. III, V, 1-4; XII; Colini 1898, 37-42, tavv. III, 1; IX, 2, 4, 5; X, 2, 3, 11; figg. 23-26; Bianco Peroni 1994, n. 15; de Marinis 1994, fig. 31; Longhi 1994, fig. 141.
Fig. 22 - Remedello Sotto, località Campo Dovarese. Il pu-gnale della tomba 83 con i ribattini a capocchia conica che decoravano il pomo, collocati alla stessa distanza in cui furono ritrovati nella tomba. Nel foro del codolo è visibile il ribattino che fissava la parte distale delle due guance dell’impugnatura in materiale organico. Scala 1:2.
Fig. 23 - Remedello Sotto, località Campo Dovarese. I ribattini a capocchia conica che decoravano il pomo del pugnale della tomba 83, ma che avevano anche la funzione di fissare le due guance dell’im-pugnatura in materiale organico.
325
momento della scoperta un ribattino semplice era ancora “infisso nel foro del codolo” (Bandieri, p. 13), mentre altri tre ribattini con capocchia conica laminare da entrambi i lati ornavano il pomo e si trovavano quello centrale a 14 cm dalla base del pugnale e i due laterali a 10,2 cm. Il pomo aveva quindi una forma semicircolare (fig. 22-23). Sulla faccia della lama rivolta verso il basso si osservano le impronte di un tessuto, probabilmente il mantello indossato dal defunto. Il metallo di questo pugnale ha un alto tenore di As, 8 % (O-W 337).Oltre al pugnale della t. 83 il tipo Remedello B 2 comprende anche i pugnali delle tt. 1-2 di Buccino91 e della t. 64 di Forlì92. Un esemplare ascrivibile al tipo proviene da St. Blaise93.La forma del pomo e la lunghezza dell’impugnatura dei pugnali tipo Remedello sono ormai ben de-finibili sulla base di nuovi dati di scavo, a Spilamberto e a Forlì, che confermano le osservazioni fatte a Remedello. Nella necropoli di Spilamberto il pugnale della t. 1 presentava tre borchie a capocchia conica cava disposte a triangolo, quella del vertice alla distanza di 13 cm dal foro del codolo del pu-gnale94. Nella t. 5 era stato deposto un pugnale in osso completo di impugnatura e pomo, in cui la distanza massima del pomo dalla base della lama è di 11 cm95. Ancora più importanti le scoperte fatte recentemente a Forlì-Celletta dei Passeri, dove nelle tt. 25 e 64 è stato possibile osservare la posizione delle borchie che ornavano il pomo e la loro distanza massima rispetto alla base della lama, che era rispettivamente di ca. 11,4 e 13,4 cm96.I pugnali di Forlì t. 64, Remedello t. 62, Buccino tt. 1-2 e Mirabella Eclano t. del capo-tribù sono gli esemplari con la lama di maggiori dimensioni finora scoperti, tra 19 e 23,7 cm di lunghezza e appar-tengono tutti al tipo B. Strettamente imparentati con quelli di Remedello sono i pugnali tipo Spilamberto, che si caratterizzano per la base leggermente concava ai due lati del codolo anziché diritta. Anche in questo caso vi sono pugnali con lama a costolatura mediana – due esemplari da Borgo Rivola (BO) - e pugnali con lama piatta: Spilamberto tt. 1 e 997, Grotta delle Fate (Lucca)98 e grotta della Spinosa (Massa Marittima). Una variante del tipo Spilamberto è il pugnale della t. 15 della Selvicciola, che presenta un foro per il ribattino a ciascun angolo della base. Il pugnale ha un tenore di As del 2,49 %99. Per completare il quadro della necropoli di Remedello dobbiamo ricordare il pugnaletto della t. 45, in condizioni di conservazione molto precarie, per cui è utile rifarsi al disegno del Ragguaglio di G. Bandieri (tav. VI, 1). La base semplice è semiellittica, stretta e non debordante rispetto alla lama, con tre ribattini in posizione asimmetrica, la lama di forma triangolare allungata con punta arrotondata100. La tomba risultò manomessa e lo scheletro era supino, orientato verso est, accompagnato anche da un vaso, di cui fu recuperata l’ansa. Il pugnale sarebbe stato deposto sul petto con la punta verso il capo. Comunque, in base alla posizione del tutto asimmetrica dei ribattini, sembra più probabile che si tratti di un’alabarda anziché di un pugnale101. L’analisi effettuata dal gruppo di Stuttgart (SAM I, 638) indica che il pezzo è in rame con un tenore dello 0,8 % di As e piccole impurità di Ag, Ni, Bi e Fe. Il metallo si
91 Holloway 1973, tavv. XI e XXII.92 Cfr. M. Miari in questo volume.93 Strahm 1971, fig. 29. 3.94 Bagolini 1981, 103-108, fig. 44 (la moneta di riferimento ha diametro di 2 cm), figg. 45-47.95 Bagolini 1981, 112-113, fig. 59.96 Cfr. M. Miari in questo volume.97 Borgo Rivola: Anati 1972, fig. 31; Bianco Peroni 1994, nn. 8-9. Spilamberto: Bagolini 1981, 103 ss., figg. 44-46 e figg. 70-71. 98 Cocchi Genick, Grifoni Cremonesi 1989, 14 con bibliografia precedente e fig. 3 A7; Bianco Peroni 1994, n. 17.99 Petitti, Persiani, Pallecchi 2011, 190-191 e fig. 2.9.100 Colini 1898, tav. IX, 6; Cornaggia Castiglioni 1971, tav. X, 3; Bianco Peroni 1994, n. 205; de Marinis 2003, fig. 31.1. Come credo di avere dimo-strato, la classificazione come tipo Lagazzi proposta da V. Bianco Peroni e seguita da altri autori, è infondata.101 Nella necropoli di recente scoperta di Forlì-Celletta dei Passeri la tomba 75, attribuita a un soggetto femminile di età adulta avanzata, aveva una piccola alabarda in rame, secondo l’interpretazione più probabile del pezzo. Questo dato potrebbe rendere verosimile l’associazione della tomba 45 di Remedello. Cfr. Miari in questo volume.
326
differenzia quindi nettamente da quello dei pugnali delle tt. 106, 62, 79 e 83 di Remedello, di Volongo, di Carbonara Ticino, Fontanella t. 11 e Cumarola, che mostrano tutti tassi elevati di As, fino a 8 %.
Il pugnale tipo Remedello, sopratutto nella variante A, è ripetutamente raffigurato sulle stele antro-pomorfe di Sion e Aosta, sulle statue-stele della Lunigiana, sulle stele e i massi istoriati della Valtellina e Valcamonica e sulle statue-stele del Trentino-Alto Adige102. Spesso sono evidenziate la costolatura mediana e le borchie che decorano il pomo, di forma semilunata, a segmento circolare o semicircolare. Nella Lunigiana solo la statua-stele di Filetto IV, priva della parte superiore, mostra a rilievo un pugnale tipo Remedello con costolatura mediana e il pomo ornato da tre borchie. Le statue-stele di Groppoli III e VIII hanno un pugnale tipo Remedello A, con evidenziazione della costolatura mediana, mentre il pomo non mostra alcuna borchia103. A Sion le stele 2 e 6 hanno la figura di un pugnale tipo Remedello con l’indicazione delle borchie del pomo e dell’impugnatura, nel gruppo atesino le statue-stele di Lagundo C e D e di Arco II mostrano pugnali tipo Remedello con lama con costolatura mediana e pomo decorato da borchie. Passando al gruppo Valcamonica-Valtellina possiamo osservare che nella maggior parte dei casi i pugnali con indicazione delle borchie del pomo sono raf-figurati racchiusi nel fodero e a parte Cemmo 1 e Anvoia M14104 ricorrono solo nei monumenti della Valtellina (Tirano-Lovero, Caven 2 e 4, Cornal 2, 3 e 5). Per completare il quadro della diffusione dei pugnali tipo Remedello verso ovest dobbiamo ricordare
102 Per la documentazione cfr. Le Pietre degli Dei 1994 e 2007, Casini, de Marinis, Pedrotti 1996 e il contributo di Casini e Fossati in questo volume.103 Cfr. Paribeni, Iardella, Tiscornia, Tosatti 2012.104 Per la Valcamonica bisogna sottolineare che il numero dei monumenti inediti supera quello degli editi.
provenienza periodo Sn Pb As Sb Ag Ni Bi Au Zn Co Fepugnali a base semplice
SAM 641 Remedello 106 Rame 1 0.010 4.100 0.110 0.010 0.090 0.030pugnali di tipo Remedello e Spilamberto
SAM 20300 Volongo Rame 2 3.200 0.140 tr. 0.046
SAM 20297 Remedello 79 Rame 2 tr. 1.150 tr. 0.100 0.010 0.032 tr.
O-W 299 Remedello 62 (lama) Rame 2 tr. 7.800 0.200 tr. 0.120
SAM 639 Remedello 62 (ribattino) Rame 2 tr. 0.620 0.080 0.010 0.020 0.030
SAM 640 Remedello 62 (ribattino) Rame 2 tr. 0.680 0.080 0.010 0.030 0.030
O-W 337 Remedello 83 Rame 2 tr. 0.050 8.000 tr. 0.200 tr. 0.120
SAM 642 S.Martino Sicc. Rame 2 4.500 0.110 0.020 0.030 0.040
SAM 338 Cumarola Rame 2 0.060 4.600 0.120 tr. 0.600 tr.
Slater 1971 Fontanella 11 Rame 2 4.880 0.127 0.006 0.011
SAM 577 Borgo Rivola Rame 2 0.010 0.010 1.600 0.005 0.120 0.020 0.020 0.020 0.010
SAM 578 Borgo Rivola Rame 2 tr. 2.100 <0.005 0.080 0.020 0.110 0.080
Lab. Firenze Selvicciola 15 Rame 2 2.49Lab. Rennes Orgon Rame 2 0.001 0.01 4.0 0.08 0.20 0.001
SAM 19793 Monte Bradoni Rame 2 0.01 1.25 tr. 0.03 0.04 0.015 tr.
SAM 19792 Monte Bradoni Rame 2 0.05 4.0 0.008 0.09 0.08 0.098 tr.pugnali di tipo campaniforme
SAM 20389 S. Cristina Rame 3 0.000 0.000 2.000 tr. 0.04 0.000 0.017 tr.
O-W 369 BS-Remedello Rame 3 tr. 0.200 2.000 0.050 0.050 0.010 0.010 tr.
alabarde
AA 3 Olmo t. I Rame 2/3 6.200 tr.
O-W 304 Gambara Rame 3 tr. tr. 4.500 0.020 tr. tr.
Ghislanzoni Villafranca Rame 3 tr. 0.100 4.100 tr. tr. tr.
AA 2 Olmo t. 516bis Rame 3 7.100 tr.
Tab. 1 - Analisi dei pugnali e delle alabarde dell’età del Rame.
327
le incisioni rupestri di Oullas (Saint-Paul-sur-Ubaye, nell’alta valle della Durence)105 e di Les Auberts (Chastel-Arnaud, Drôme)106, che confermano il dato offerto dal dolmen di Orgon. Al Monte Bego sono numerose le raffigurazioni di pugnali a lama triangolare e base rettilinea, ma la maggior parte hanno una presa piuttosto corta, in cui non si distingue bene il pomo dall’impugnatura vera e propria, e solo pochi mostrano un pomo semicircolare e un’impugnatura di lunghezza paragonabile a quella dei pugnali tipo Remedello107.Per quanto riguarda la datazione dei pugnali tipo Remedello e Spilamberto si sono acquisiti recentemen-te nuovi importanti dati. Fin dal 1992 avevamo assegnato i pugnali tipo Remedello alla seconda fase cronologica della necropoli e nel 1994 abbiamo condotto una disamina più ampia in occasione della mostra “Le pietre degli dei”. La datazione al secondo periodo dell’età del Rame, all’incirca tra 2800 e 2400 a.C., era stata proposta soprattutto in base al cross-dating con la Schnurkeramik (spillone con te-sta a T della t. BS II di Remedello) e con la cultura di Auvernier, a cui è riferibile il dolmen a entrata laterale del Petit-Chasseur di Sion (M VI), su una lastra del quale era stato raffigurato un pugnale tipo Remedello. Nel frattempo sono state ottenute le datazioni AMS di una serie di tombe di Remedello, che permettevano di definire meglio la cronologia assoluta delle fasi Remedello 1 (ca. 3400-2900 cal. a.C.) e Remedello 2 (ca. 2900-2500 cal. a.C.) della necropoli108. Oggi disponiamo di ulteriori conferme a questa cronologia. La tomba del capo-tribù di Mirabella Eclano (Avellino), il cui corredo comprende un pugnale tipo Remedello B, è stata datata al 2880-2490 cal. a.C.109. Due tombe con pugnali tipo Remedello della necropoli di Forlì sono state datate rispettivamente al 2930-2690 (93 %) la t. 47, e al 2900-2570 (95,4 %) la t. 64110. La t. 15 della Selvicciola (Ischia di Castro, Viterbo) è una tomba a camera dell’importante necropoli riferibile alla cultura di Rinaldone. Per quanto ospitasse sepolture multiple, vi è stato rinvenuto uno scheletro di adulto maschio in giacitura primaria con corredo costituito da una tazza di tipo Laterza, due cuspidi di freccia in selce, una cuspide sbiecata d’osso e un pugnale in rame classificabile come variante del tipo Spilamberto. Lo scheletro è stato datato al 2900-2630 cal. a.C.111. Infine, ad Aosta le fosse di impianto delle stele 8-9 e 26 hanno due date radiocarboniche, che per quan-to con ampia deviazione standard, una volta calibrate cadono nella prima metà del III millennio una e nell’intero III millennio l’altra: 2900-2300 a.C. (95,4 %) e 2880-2470 (68,2 %) – 3100-2100 a.C. (95,4 %)112. L’ipotesi di rialzare la comparsa dei pugnali tipo Remedello alla seconda metà del IV millennio, prospettata recentemente, si basa su una serie di presupposti errati. Le datazioni ottenute alla Grotta della Spinosa (Massa Marittima, Grosseto) si riferiscono a una tibia e ad altre quattro ossa frammentate, che fanno parte di un consistente strato di ossa frantumate, spesso da 25 a 35 cm e relativo ad almeno 36 individui, in mezzo a cui è stato rinvenuto un pugnale di rame tipo Spilamberto113. Il frammento di tibia e il pugnale fanno parte dello stesso strato (us 8/II), e l’argomento a sostegno della tesi rialzista è che “the sample [was] taken from near the dagger itself ” (Dolfini 2010, 716). Che non si tratti di associazione chiusa è lapalissiano114. Quindi, a differenza della Selvicciola, non vi è alcun resto umano in deposizione primaria né tantomeno è possibile identificare un’associazione tra manufatti e resti umani.
105 Cfr. A. Arcà in questo volume.106 Cfr. Morin, Picavet 2005. 107 Cfr. A. Arcà in questo volume.108 Cfr. de Marinis, Pedrotti 1997; de Marinis 1997b.109 DSH: 547 4104 ± 48 BP, cal. con 2σ 2880-2560 (91,8 %), campione prelevato dallo scheletro del defunto; DSH 588: 4102 ± 30 BP, cal. con 2σ 2870-2800 (22,3 %), 2760-2570 (72%), la data è stata ottenuta da un campione di osso del cane della sepoltura. Cfr. Talamo, Passariello, Lubritto, Terrasi 2011.110 Cfr. Miari in questo volume. LTL-5078A: 4249 ± 50 BP; LTL 5079A: 4158 ± 50 BP.111 Cfr. Petitti, Persiani, Pallecchi 2011, 190, fig. 1 e fig. 2.9. OZC-175: 4194 ± 42 BP. 112 UtC 1685 4070 ± 90 BP e UtC 1684 4090 ± 160 BP.113 Cfr. Aranguren 2006, figg. 1-2; Dolfini 2010; Dolfini, Aranguren, Silvestrini 2011, tab. II e p. 177.114 A questo proposito cfr. anche Valzolgher 2011, 471.
328
Le asceIn quattro tombe della necropoli di Remedello vi erano asce in rame. L’ascia della t. 102 è quella di maggiori dimensioni, ha una forma trapezoidale leggermente allungata, tallone diritto, taglio lieve-mente arcuato, e un lieve accenno di margini rialzati nella parte mediana del corpo, determinato dalla martellatura dei lati (fig. 24). Le asce delle tt. 78, 62 e 4 appaiono tipologicamente più evolute e possono definirsi a margini rialzati, poiché la martellatura ha provocato la formazione di piccoli margini lungo tutto il lato e non solo nella parte centrale. La forma è sempre trapezoidale, con tallone diritto e taglio arcuato (fig. 25). L’ascia della t. 4 ha il tallone e soprattutto il taglio asimmetrici per effetto dell’uso. Tutte le asce di Remedello sono in rame puro, con tracce di As e di Ag. Il taglio è sempre accuratamente martellato a freddo, allo scopo di aumentare la durezza del metallo115.
Dall’Italia settentrionale, compreso il Canton Ticino, abbiamo più di 50 asce di rame databili a un pe-riodo anteriore agli inizi dell’antica età del Bronzo116. Di queste 18 sono quasi certamente anteriori alla stessa età del Rame sia sulla base della tipologia sia per il fatto che nessuno dei tipi a cui appartengono è documentato in contesti riferibili all’età del Rame. Si tratta di asce sempre prive di contesto, a parte forse Bocca Lorenza e S. Canziano. Corrispondono ai tipi I e II della vecchia classificazione del Colini e al tipo Bocca Lorenza. I primi due tipi ripetono in metallo forme che sono caratteristiche delle asce
115 Il tema delle asce della necropoli di Remedello è già stato trattato in un mio precedente lavoro, a cui rimando per l’iconografia e la bibliografia: de Marinis 1992, in particolare figg. 5-6 e tabella alla fig. 8 per le analisi. 116 Per un quadro generale delle asce di rame anteriori all’antica età del Bronzo cfr. de Marinis 1992.
Fig. 24 - Remedello Sotto, località Campo Dovarese. Corredo della tomba 102. Scala: ½ della gr. nat.Disegni e lucidi S. Odone e R.C. de Marinis.
329
di pietra levigata neolitiche. Inoltre, la superficie di queste asce presenta quasi sempre un aspetto fortemente rugoso, vescicolare e bulloso, do-vuto alle difficoltà intervenute nel processo di colata e solidificazione del metallo in stampi aperti, indizio di una metallurgia ancora primiti-va117. Le asce tipo Bocca Lorenza si differenziano nettamente per la forma a tallone stretto e rettilineo, corpo di forte spessore e a lati for-temente divaricati e leggermente concavi, taglio largo ed espanso ad arco di cerchio. Inoltre, la loro composizione chimica appare mol-to omogenea: l’argento è sempre la principale impurità, nel caso di S. Briccio di Lavagno presente con una percentuale piuttosto elevata (1.5 %), mentre tutti gli altri elementi compaiono in minime tracce. La distribuzione geografica mostra una diffusione circoscritta alla parte più orientale dell’Italia settentrionale. Questo fatto rende più credibile una connessione con tipi analoghi di asce diffusi dall’area transalpina orientale fino al bacino carpatico, specialmente nell’area culturale Ba-laton - Lasinja durante la seconda fase dell’età del Rame secondo la
117 Cfr. de Marinis 1992, 389-391 e figg. 1, 2 e 4.
Fig. 25 - Remedello Sotto, località Campo Dovarese. Asce in metallo delle tombe 4, 62 e 78. Scala: ½ della gr. nat. Disegni di R.C. de Marinis, lucidi di M. Rapi.
Fig. 26 - Remedello Sotto, località Campo Dovarese. Corredo della tomba 78.
330
periodizzazione in uso nella regione carpato-danubiana118, fase che corrisponde al nostro Neolitico tardo (VBQ di terza fase - Lagozza). Si possono citare come esempi le asce da Zalavar Basasziget119, Gurnitz e Kanzianiberg in Carinzia120.La datazione dell’ascia di Gurnitz a un orizzonte cronologico Mondsee-Melk-Schnurkeramik121 propo-sta da Mayer e ripresa dalla Pedrotti, si basa sull’interpretazione dei ritrovamenti dello strato inferiore della caverna di Tominz a San Canziano, ma è ben lungi dall’essere sicura. Pur in assenza di dati precisi di scavo, il contesto di Kanzianiberg suggerisce una data più antica, corrispondente alla terza fase del VBQ, la stessa data che è probabile per il ritrovamento di Bocca Lorenza. Secondo il Pellegrini, infatti, una delle tre asce fu rinvenuta insieme alle ceramiche del VBQ122. In seguito, è prevalsa l’opinione che le asce dovessero essere associate a sepolture dell’età del Rame posteriori al VBQ123, ma opportunamente si sta ritornando a considerare valida la testimonianza del Pellegrini e l’associazione tra asce di rame e VBQ dello stile a impressioni e incisioni124.Le asce dei tipi I e II del Colini mostrano una composizione chimica differente. Nell’ascia dai Boschetti di Chiozza la maggiore impurità è lo stagno, seguito dallo zinco; nell’ascia di Valle Fontega le maggiori impurità sono l’argento e lo zinco, mentre Pb, As, Sb, Ni, Bi hanno valori più alti rispetto al gruppo delle asce tipo Bocca Lorenza. Nel complesso le asce tipo Bocca Lorenza mostrano una metallurgia più progredita rispetto alle asce dei tipi I e II del Colini, sia per l’elevata purezza del rame, sia per il grado di rifinitura dei pezzi.L’ascia di Kollmann, in Val d’Isarco, forma insieme a quelle di Nova Levante-Hirzlsteig e di Kastelruth-Gamertinerhof un gruppo a se stante125, forse di carattere non funzionale, ma votivo. Le asce di Kol-lmann e di Nova Levante hanno un tenore di As rispettivamente del 3,2 e del 5 %, a differenza di tutte le altre asce dell’età del Rame126.
È da sottolineare il ritrovamento dell’ascia di Nova Levante, avvenuto nei pressi del sentiero Hirzlsteig, che corre a circa 2000 m di quota lungo il versante occidentale del gruppo del Rosengarten/Catinaccio, una conferma che nell’età del Rame cominciarono a essere nuovamente frequentate le alte quote.Ritornando alle asce piatte o a margini appena rilevati dell’età del Rame, il numero degli esemplari provenienti da un contesto è molto superiore rispetto ai periodi precedenti: le asce del Similaun e della
118 Kalicz 1988, 81 e ss., fig. 5 e tabella alla fig. 11.119 Già proposto da Barfield 1992, fig. a p. 169; cfr. Kalicz 1991.120 Cfr. Mayer 1977, n. 103; Pedrotti 1990, 223 e fig. 5 n. 9.121 Orizzonte cronologico che corrisponderebbe alla nostra fase Remedello 2.122 Pellegrini 1910, 74, 76-77.123 Bagolini 1984, 435; Bianchin Citton 1988, 618-619. A questa opinione mi sono conformato anch’io: cfr. de Marinis 1992, 392 e note 3 e 4.124 Cfr. Barfield 1996, 67.125 Dal Rì, Tecchiati 1994, 26, 34, fig. 14.1-2; Wackernell 1999.126 Per l’ascia di Nova Levante informazione di G. Artioli e I. Angelini.
Provenienza Analisi Sn Pb As Sb Ag Ni Bi Au Zn Co FeBL4393 M/S 0.001 0.001 0.001 0.002 0.500 0.008 0.001 0.010 0.010 0.017
BL7776 M/S 0.001 0.001 0.001 0.003 0.500 0.009 0.001 0.010 0.010 0.003
BL7777 M/S 0.001 0.001 0.001 0.005 0.500 0.011 0.001 0.010 0.010 0.007
S.BriccioLavagno O-W114 tr. tr. tr. 0.050 1.500 tr. 0.020
S.Canziano Vierthaler tr. 0.810 0.050 0.260
Marendole O-W75 tr. tr. 0.030 tr.
LaMandria O-W31 tr. tr. tr.
ValleFontega M/S 0.007 0.045 0.033 0.020 0.500 0.021 0.004 0.500 0.001 0.024
Chiozza Slater 0.790 0.020 0.025 0.014 0.052 0.020
Kollmann O-W279 tr. 3.200 0.120 tr. tr.
Tabella 2 – Analisi delle asce di età medio-tardo Neolitica e dell’ascia di Kollmann. M/S = Matteoli-Storti, O-W = Otto, Witter 1952, Slater = Barker, Slater 1971.
331
t. 102 di Remedello assegnate alla prima fase dell’età del Rame, quelle delle tt. 4 e 78 di Remedello assegnate alla seconda fase, l’ascia della tomba di Cumarola del 1860, associata a un pugnale di rame tipo Remedello caratteristico della fase Remedello 2, l’ascia della tomba di S. Cristina di Fiesse associata al Vaso Campaniforme. Dalla necropoli di Forlì-Celletta dei Passeri abbiamo ora ben sei asce piatte, in due casi da tombe datate con il radiocarbonio127.Nell’ambito delle asce riferibili all’età del Rame si possono individuare alcuni raggruppamenti. Vi sono innanzitutto asce di piccole dimensioni, tra 5,9 e 7,3 cm di lunghezza. Fra queste rientrano le asce delle tt. 4 e 62 di Remedello, la prima con margini rialzati, la seconda con margini leggermente rialzati. Tutte le altre sono asce perfettamente piatte. Nel gruppo si distinguono le asce di Cumarola e del museo di Bergamo di provenienza ignota, molto simili tra loro e che si differenziano per una larghezza del corpo decisamente maggiore in proporzione alla lunghezza128.Un secondo gruppo è costituito da asce di dimensioni maggiori, tra 8,8 e 14 cm di lunghezza e di forma trapezoidale, ma abbastanza slanciata, a lati diritti, tallone diritto, taglio leggermente arcuato, in alcuni casi con un accenno di spalla. L’ascia di Remedello t. 78, la più piccola del gruppo, ha margini rialzati (fig. 26), mentre l’ascia del Similaun e della t. 102 di Remedello, molto simili tra loro, hanno margini appena leggermente rialzati nella parte mediana del corpo. Il frammento di ascia dal Bresciano, già nella collezione Rambotti, per forma e dimensioni sovrapponibile all’ascia del Similaun, ha margini rialzati.
Infine, una delle due asce da Castel Grande di Bellinzona, priva della parte prossimale con il tallone, anch’essa sovrapponibile per forma e dimensioni all’ascia del Similaun, ha margini rialzati (fig. 27)129. Nell’età del Rame fanno quindi la loro comparsa le asce con margini rialzati estesi dal tallone al taglio e prodotti da una regolare martellatura dei fianchi, mentre è ancora assente l’incavo al tallone, che farà la sua comparsa solo agli inizi dell’antica età del Bronzo.Un terzo gruppo di asce dell’età del Rame è riconoscibile nell’ascia della tomba campaniforme di S.
127 Cfr. Miari in questo volume.128 Cfr. de Marinis 1992, 394-397 e fig. 5.10-11.129 Le due asce di Castel Grande provengono da livelli posteriori al Neolitico e anteriori all’età del Bronzo, ma non si sa ancora nulla sul loro effettivo contesto. Dello scavo non esiste una sezione stratigrafica e neppure un diagramma stratigrafico. I reperti sono stati rilevati con la quota, il che rende ardua, se non impossibile, la ricostruzione del reale andamento stratigrafico.
Fig. 27 - Asce a margini rialzati dell’età del Rame. 1. Castel Grande di Bellinzona; 2. Località ignota del territorio bresciano, già nella collezione G. Rambotti di Desenzano del Garda. Scala: ½ della gr. nat. Disegni e lucidi di R.C. de Marinis.
Fig. 28 - Ascia piatta in rame da Castel Grande di Bellinzona. Scala: ½ della gr. nat. Disegno e lucido di R.C. de Marinis.
332
Cristina di Fiesse, in una delle asce di Castel Grande, e nelle asce di Ponte d’Enza di Montecchio130, di Cologna Veneta e della palude Brabbia131. Queste asce si caratterizzano per la forma trapezoidale a lati diritti, ma con corpo di maggiore larghezza rispetto al gruppo precedente e per un taglio espanso ad arco di cerchio con piccole spalle ben delineate. L’ascia di Castel Grande si differenzia per i lati leg-germente concavi (fig. 28).In assenza di contesto, la datazione delle asce eneolitiche a una precisa fase cronologica è molto proble-matica, non essendoci in quest’epoca una produzione fortemente standardizzata e rimanendo il campo di variabilità piuttosto ampio. È però evidente la netta differenza da un lato rispetto ai tipi tardo neoli-tici precedentemente descritti e dall’altro rispetto ai tipi delle primissime fasi dell’antica età del Bronzo, quali sono rappresentati nei ripostigli di Remedello Sopra e di Torbole.Le analisi delle asce di Castelgrande di Bellinzona, fatte eseguire da P.L. Donati, non sono state pub-blicate, ma secondo quanto riferito verbalmente sono risultate di “rame puro con un po’ di arsenico”132. Le asce di Remedello e del Similaun sembrano essere state fabbricate con lo stesso tipo di metallo, con assenza di Sb e presenza di As, lo stesso metallo, quindi, con cui sono stati fabbricati i pugnali tipo Remedello, a parte l’aggiunta intenzionale di As, mentre l’ascia campaniforme di S. Cristina di Fiesse si differenzia per la presenza di Pb e Sb e l’assenza di As.
Lo spillone d’argentoLa t. BS II, scavata, o più probabilmente soltanto recuperata dopo l’occasionale scoperta, da L. Ruzzenenti agli inizi del 1886, ha restituito uno spillone d’argento, lungo 17,3 cm, del tipo con testa a T e sormontato al centro da un piccolo occhiello. Lo spillone era collocato trasversalmente sul torace (fig. 29)133.
130 Già ritenuta di Bibbiano, la provenienza esatta è stata ricostruita da James Tirabassi (1997).131 Cfr. de Marinis 1992, 401 e fig. 7.132 Informazione fornita dal dott. R. Carazzetti, direttore dei musei civici di Locarno, che aveva in corso di studio il materiale degli scavi di Castelgrande.133 Colini 1898, fig. 37; Cornaggia Castiglioni 1971, tav. X, fig. 5.
Provenienza Analisi Sn Pb As Sb Ag Ni Bi Au Zn Co FeRemedello 102 O-W 311 0.400 0.130 tr. tr.
Similaun 0.220 0.090
coll. Rambotti SAM20381 tr. <0.01 0.560 tr.
Slater 0.290 0.038 0.030 0.073 0.150 0.001 0.019
Vetto SAM20280 tr. 0.180
Slater tr.
Rivarolo Fuori SAM20299 tr. 0.070 tr.
Trebbo Sei Vie SAM 661 0.040 0.000 0.010 0.350 tr. 0.050 0.040
Remedello 78 O-W 106 tr. tr. 0.100 tr. tr.
Remedello 4 O-W 354 tr. 0.800 0.050 0.070 tr.
Remedello 62 O-W 310 tr. 0.620 0.080 0.010 0.020 0.030
S.Cristina SAM20390 2.400 0.170 0.340 0.010 0.066
Slater 0.630 0.720 0.076 0.049 0.327 0.057 0.001 0.232
Colombare SAM 591 0.010 0.080 tr.
Montecchio O-W 30 tr. tr. tr. tr. 0.0008
Quinzano d’Oglio SAM 637 0.000 tr. 0.040 0.020 <0.001 0.010
Borgo Panigale O-W 1160 tr. 0.300 tr. 0.030 0.100
S. Leo SAM 646 0.050 0.060 0.040 0.020 0.070
Borgo Rivola SAM 579 0.100 tr. 0.050 0.016 0.100
Bobbio SAM 1336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ist. Breda 0.440 0.170 1.030
Tabella 3 - Analisi delle asce dell’età del Rame dall’Italia settentrionale.
333
In Italia quattro spilloni con testa a T sono stati scoperti nella necropoli del Gaudo134, mentre la testa a T in argento di uno spillone il cui gambo doveva essere in materiale organico proviene dalla t. 1 di Ponte delle Sette Miglia (Roma), necropoli riferibile alla cultura di Rinaldone135. La t. 1 con-teneva due deposizioni, un adulto e un bambino, a cui era associato lo spillone, di dimensioni solo di poco inferiori all’esemplare di Remedello136.Gli spilloni con testa a T o a martello, a seconda delle denominazioni, sono un tipo originario delle steppe tra il Volga e il Dnestr e dell’area del Kuban (Caucaso settentrionale)137. Compaiono per la pri-ma volta nella cultura Yamnaja e persistono fino all’inizio di quella delle Catacombe. Si diffondono nell’area della ceramica decorata a cordicella, come dimostrano la già citata tomba di Bleckendorf e gli esemplari degli insediamenti svizzeri di Vinelz, Corcelettes e St. Blaise138. Una serie di datazioni radiocarboniche effettuate su campioni prelevati dagli spilloni e sulle ossa umane della tomba di provenienza139 ha permesso di stabilire che la pri-ma comparsa del tipo si colloca verso il 3000 a.C.
e il periodo di maggiore diffusione verso il 2800-2600 a.C., mentre dopo il 2600 sembrano uscire di moda, almeno nell’ambiente delle steppe140. Gli spilloni con testa a T sono solitamente in osso o corno, ma non mancano esemplari in rame di grandi dimensioni come quello dalla necropoli di Kabardino Park a Nalčik, nel Caucaso settentrionale141.
C. Manufatti in selceL’industria litica in selce comprende essenzialmente cuspidi di freccia e pugnali. Le cuspidi di freccia sono circa 133, distribuite in 29 tombe, oltre a una decina di esemplari provenienti da tombe distrutte dai lavori agricoli, e appartengono tutte al gruppo dei foliati. A parte due casi, sono del tipo a pedun-colo e spalle142; il peduncolo è a lati convergenti, le spalle sono orizzontali o convergenti verso il basso. La forma della punta è a triangolo equilatero o a triangolo isoscele, frequentemente con altezza più del doppio della base, quindi una cuspide lunga (figg. 30-31). Nella t. 111 vi era una cuspide di freccia a base concava e nella t. 56 una cuspide del tipo peduncolato semplice. I pugnali di selce sono 25, distribuiti in 22 tombe, a cui bisogna aggiungerne altri 9 che provengono da tombe sconvolte dai lavori agricoli e non numerate.I pugnali sono tutti a ritocco piatto coprente bifacciale, a stacchi ampi alla base e sulle due facce, a ri-
134 Cfr. Bailo Modesti, Salerno 1998, 140 e fig. 59, con bibliografia precedente. 135 Anzidei, Carboni, Egidi, Malvone 2007, 466 e ss.; Anzidei, Aurisicchio, Carboni 2007, 553 e ss., fig. 1 A.136 La lunghezza della testa è di 4,6 cm, contro i 4,9 dello spillone della tomba BS II.137 Cfr. una carta di distribuzione (bisognosa di aggiornamenti) in Piggott 1965, 84-85 e fig. 40; Müller-Karpe 1974. Tavv. 688 A, 690 C-F, 138 Strahm 1979, figg. 1 e 5.139 Confronto utilissimo, che ha messo in evidenza l’effetto riserva nella datazione delle ossa umane.140 Shishlina, van der Plicht, Zazovskaya 2011.141 Cfr. Müller-Karpe 1974, tav. 690, B 13 e p. 1031 n. 1102.142 Solo nella tomba 4 vi è una cuspide di freccia del tipo a peduncolo e alette, comunque molto brevi.
Fig. 29 - Remedello Sotto, località Campo Dovarese. Spillone con testa a T in argento dalla tomba BS II. Scala: ½ della gr. nat. Disegno e lucido di R.C. de Marinis.
334
tocco più fine e regolare lungo i bordi. Si possono suddividere in due gruppi: a codolo non distinto e a codolo distinto143. Nel primo gruppo abbiamo pugnali di forma foliata, a con-torno ovale, con base arroton-data (tt. 41, 73, 74, 99, 102, 107)144, triangolare (t. 100) 145 o sbiecata (t. 53, 86)146. Il secondo gruppo si caratteriz-za per un codolo distinto con formazione di una spalla più o meno ampia: il codolo può essere largo e breve con base rettilinea (tt. 13, 62, BS I)147, di forma quasi semicircolare (t. 65)148, oppure a peduncolo a lati convergenti (per es. tt. 4, 46, 56, 60, 78)149. In un solo caso il pugnale pre-senta una base arrotondata ma distinta dalla lama per mezzo di due incavi laterali (t. 97)150.Insieme alle cuspidi di frec-cia i pugnali di selce sono il manufatto più frequente nelle tombe di Remedello provviste di corredo e lo stesso fatto è ri-scontrabile nelle vicine necro-poli di Volongo e di Fontanella Mantovana e in quella di Selva di Stanghella (PD). Nessun pugnale in selce proviene dalla
necropoli di Cumarola (MO), mentre si registra un solo caso nella necropoli di Spilamberto-S. Cesario. Per questo aspetto vi è quindi una netta differenza tra area di Remedello ed Emilia orientale e Romagna e una conferma viene dalla necropoli di Forlì-Celletta dei Passeri, di recente scoperta151. Per quanto non siano assenti pugnali in selce sporadici, tuttavia dalla carta di distribuzione appare evidente una loro
143 Per la classificazione dei pugnali in selce rimando a de Marinis 1997a, 274-286.144 Cfr. nell’ordine Colini 1898, fig. 11; Chierici 1885, tav. VI, 13; Colini 1898, fig. 5 e Cornaggia Castiglioni 1971 tav. V, 4; Colini 1898, fig. a p. 44; Colini 1898 fig. 10 e Cornaggia Castiglioni 1971, tav. VII, 2; Chierici 1885, tav. VI, 5. 145 Cfr. Colini 1898, tav. V, 4; Cornaggia Castiglioni 1971, tav. VI, 4. 146 Cfr. Colini 1898, fig. 74; Chierici 1885, tav. VI, 6; Cornaggia Castiglioni 1971, tav. VII, 4. 147 Cfr. Colini 1898 fig. 12, fig. 78 e tav. IV, 1 e Cornaggia Castiglioni 1971, tav. V, 3, tav. VI, 1 e tav. V, 1. 148 Colini 1898, fig. 3; Cornaggia Castiglioni 1971, tav. VII, 6. 149 Cfr. nell’ordine Colini 1898, tav. V, 3; fig. 8; tav. V, 1 e 2; fig. 4; tav. VI, 1; fig. 28; Cornaggia Castiglioni 1971, tav. VII, 1, 5 e 3; tav. V, 2. 150 Colini 1898, fig. 9; Cornaggia Castiglioni 1971, tav. VI, 6. 151 Cfr. Miari in questo volume.
Fig. 30 - Remedello Sotto, località Campo Dovarese. Corredo della tomba 56.
Fig. 31 - Remedello Sotto, località Campo Dovarese. Corredo della tomba 65.
335
rarefazione a est del Secchia152. Nella Lombardia orientale, nel Veneto e nella valle dell’Adige sono numerosissimi i pugnali di selce, ma per la maggior par-te ritrovamenti sporadici senza più contesto. Molti sicuramen-te provengono da sepolture di-strutte dai lavori agricoli. Il pugnale in selce è quindi il manufatto più rappresentativo della cultura di Remedello. Il pugnale era innanzitutto un’ar-ma, ma nello stesso tempo un oggetto di prestigio, uno status symbol. Sembra che nell’area delle sepolture collettive e se-condarie – il cd. gruppo di Civate – venissero fabbricati per uno specifico uso funerario (Barfield 2007). Il pugnale in selce poteva essere anche uno strumento utilizzato per scopi pratici, dalla macellazione di animali alla lavorazione delle pelli al taglio di vegetali. L’uso o il reimpiego come coltello messorio è documentato negli abitati a nord delle Alpi153 ed è facilmente riconoscibile in base alla patina traslucida (sickle gloss), che si forma lungo il bordo. Recentemente tracce d’uso sono state osservate su due pugnali del Trentino, uno dal riparo sottoroccia con sepolture collettive di Ala Le Corone, l’altro da Malga Riondera in comune di Ala154. I pugnali di Remedello non mostrano tracce di utilizzo ed è chiara la loro funzione di arma, che i maschi avevano diritto di portare raggiunta l’età adulta. In due casi, però, a Remedello il pugnale si trova a corredo della sepoltura di adolescenti (t. 56 e t. di Viadana).In questa sede non vi è lo spazio per trattare esaurientemente i problemi di classificazione tipologica e di cronologia dei pugnali di selce, quindi ne affronteremo solo alcuni aspetti.Nei pugnali di forma foliata a base semplice si possono individuare alcuni tipi principali: a foglia di lau-ro, ovvero con la massima larghezza circa a metà della lunghezza e a base arrotondata oppure a punta155; a foglia di salice o forma lanceolata oblunga, con larghezza massima verso la base, che è arrotondata, una delle forme più caratteristiche e maggiormente diffuse156; a peduncolo semplice triangolare157. De-vono essere separati dai pugnali a codolo distinto quelli a base semplice ma con una tacca su entrambi i lati tra lama e base, come il pugnale dell’uomo del Similaun e quello della tomba 97 di Remedello. Per quanto riguarda la cronologia di questi pugnali, che è stata oggetto di ripetute critiche da parte di Elisabetta Mottes158, vorrei ribadire che dobbiamo esaminare innanzitutto i contesti, siano essi assem-
152 Cfr. Mottes 1996a, carta fig. 3.153 Cfr. Honegger, de Montmollin, Joye 2011, 77 e ss. e fig. 6, con bibliografia precedente. Cfr. anche Guilaine in questo volume.154 Mottes, Ziggiotti 2012, 147 e ss. e figg. 2 e 9.155 Cfr. i tipi 1-a, 1b, 1c e 1d in de Marinis 1997a, fig. 5.156 Cfr. tipo 4-a in de Marinis 1997a, fig. 5.157 Cfr. tipi 5-a e 5b in de Marinis 1997a, fig. 5.158 Cfr. soprattutto Mottes 1996a, 2001.
Fig. 32 - Remedello Sotto, località Campo Dovarese. Pugnale in selce a foglia di salice (tipo 4-a) dalla tomba 107 a sinistra e pugnale in selce con peduncolo semplice triangolare dalla tomba 100 a destra.
336
blages di abitato o closed finds di tombe. I pugnali a foglia di lauro sono i più antichi e precedono l’età del Rame, anche se sono ancora presenti ai suoi inizi. Non è un caso che nella necropoli di Remedello, il sito archeologico che ha restituito il maggior numero di pugnali di selce, il tipo sia assente. C’è solo un esemplare della varietà a base tronca nella tomba 86, che si trova nella parte sud-orientale del riparto Sud, a nostro avviso la parte più antica della necropoli. Pugnali a foglia di lauro provengono da Isera La Torretta fase 4, datata tra 3600 e 3400 a.C.159, dalla tomba di Acquaviva di Besenello, datata con il radiocarbonio al 4410 ± 70 BP, cal. 2 σ 3340-2900 a.C. (95,4 %)160 e in selce dei Lessini da Ergolding-Fischergasse in Baviera, insediamento di ambiente umido della cultura di Altheim, datato tra il 3700 e il 3400 a.C.161. È anche significativo il fatto che un ripostiglio di sette pugnali appartenenti tutti al tipo a foglia di lauro a base appuntita sia stato ritrovato nel 1905 ai piedi del Doss Pipel di Isera da parte di Paolo Orsi (Barfield 1970, Mottes 1996b). Per i pugnali a peduncolo semplice triangolare abbiamo due contesti, la t. 100 di Remedello, nella parte meridionale del riparto Sud (fig. 32), e la tomba di Fontaine-les-Puits, in Savoia, che ha due date radiocarboniche di 4615 ± 35 BP e 4570 ± 45 BP, cal. 2 σ 3520-3190 a.C. (95,4 %) e 3500-3090 a.C. (94,5 %) (fig. 33)162.
159 Pedrotti 1997, fig. 1 e tabella 6.160 Pedrotti 1997, tabella 6; Angelini et Alii 1980.161 Tillmann 1993, 453 e ss., tav. a colori III, 1; Schlichtherle 2003, fig. 14.2.162 Rey, Perrin, Bressy, Linton 2010, 107-108.
Fig. 33 - Pugnali in selce a peduncolo semplice triangolare. A sinistra dalla tomba di Fontaine-les-Puits (Savoia), in mezzo dalla Palude Lunga, a destra da Binanova (Cremona). Scala: 2/3 della gr. nat. (da P.-J. Rey et Alii 2010; La Preistoria del lago di Garda; Le pietre degli Dei 1994).
337
I pugnali di forma lanceolata oblunga, a foglia di salice, sono presenti a Remedello nelle tt. 99, 102, 107, tutte nella parte sud-orientale del riparto Sud, e nella tomba conservata al museo di Viadana, mentre altri due esemplari provengono da tombe distrutte dai lavori agricoli. Nella t. 102 il pugnale è associato a un’ascia in rame che costituisce il miglior confronto per l’ascia dell’uomo del Similaun, che, come è noto, è fermamente datato dal radiocarbonio tra 3370 e 3110 a.C. Un ripostiglio di otto pugnali di selce rinvenuto a Conelle di Arcevia, nelle Marche, comprende sei esemplari del tipo a foglia di salice e due del tipo a base sbiecata (fig. 34). Il gruppo di pugnali è stato rinvenuto in un livello riferibile alla fase C dell’abitato, datata dal radiocarbonio tra il 3350 e il 2750 a.C.163. Infine, un pugnale dello stesso tipo, in selce dei Lessini, è stato rinvenuto a Knöbling, Dobl in Baviera, in un contesto della cultura di Cham, che è datata dal radiocarbonio e dal cross-dating con Horgen tra 3300 e 2800 a.C.164, e un altro esemplare a Schellenberg nel Lichtenstein, in un abitato della cultura di Horgen165. Per il pugnale della t. 97 di Remedello, che ha un confronto con quello dell’uomo del Similaun, vi sono altri paralleli in pugnali in selce sudalpina scoperti a nord delle Alpi e datati dalla dendrocronologia: Pestenacker in Baviera (3546 a.C.) e Arbon-Bleiche 3 in Svizzera (3384-3370 a.C.)166. Da questa rassegna di dati si può concludere che vi sono fondati motivi per sostenere la datazione alta dei pugnali in selce che abbiamo attribuito alla fase Remedello 1. Due siti con sepolture collettive e secondarie, Peri in comune di Dolcè (VR) e Ala Le Corone (TN), hanno restituito pugnali in selce del tipo 4-a, da noi attribuito alla fase Remedello 1. Una datazione effettuata su un osso umano del riparo sottoroccia di Ala Le Corone ha fornito un range compreso tra 2860 e 2470 a.C. (95,4 %)167, corri-spondente alla nostra fase Remedello 2. Per il riparo Peri otto date radiocarboniche hanno dimostrato l’utilizzo del sito per deposizioni secondarie in una fase tarda dell’età del Rame e in due distinte fasi dell’antica età del Bronzo. Il pugnale era associato ai resti inumati deposti nel corso del BA I C/BA II.
163 Cfr. Moscoloni, La Rosa 2003; Calderoni, Cazzella 1999.164 Tillmann 1993, tav. a colori III, 3.165 Borrello, Hoffstadt, Leuzinger, Schlichtherle 2002, fig. 10.3.166 Borrello, Hoffstadt, Leuzinger, Schlichtherle 2002, fig. 20; Schlichtherle 2002, fig. 14.3-4; Pedrotti 1997, 258.167 Cfr. Mottes, Ziggiotti 2012, 147-148.
Fig. 34 - Ripostiglio di pugnali di selce di forma foliata scoperto a
Conelle di Arcevia (Ancona) (da Cazzella e Moscoloni 1999).
338
Una serrata analisi condotta da Erio Valzolgher con molta acribia ha portato a escludere fenomeni di commistione accidentale o di dislocazione in seguito a processi di bioturbazione e a concludere che la lama di pugnale deve essere considerata un heirloom o ancor più probabilmente una “reliquia”, frutto di un rinvenimento fortuito o di un prelievo intenzionale in un’altra zona del riparo168, conclusione che sottoscriviamo pienamente. Infatti, non si può seriamente sostenere che questo tipo di pugnale in selce sia stato prodotto ininterrottamente per 1500 anni! Per quanto riguarda il riparo di Ala Le Corone si tratta di un ritrovamento non chiuso e non vi è dimostrata associazione tra pugnale e osso umano datato radiometricamente. Tuttavia, non ci sentiamo di escludere una possibile prosecuzione del tipo anche nella fase Remedello 2, in ogni caso con un trend di progressivo esaurimento.Nella pianura tra Oglio e Mincio, al cui centro si trova il Chiese, sono numerosi i pugnali di questo tipo rinvenuti in tombe (Volongo, Fontanella Mantovana, Le Fornaci) o sporadici ovvero di cui è an-dato perduto il contesto originario (Remedello Sopra loc. S. Angelo, Casalmoro, Castel Goffredo loc. Perosso, Mariana di Redondesco) (fig. 35)169.I pugnali a codolo distinto, che si possono distinguere in alcune varietà in base alla forma del codolo, sono ampiamente documentati nelle necropoli di Remedello e Fontanella Mantovana, a Volongo e a Selva di Stanghelle. A Remedello si concentrano nella parte nord-occidentale del riparto Sud (tt. 56, 60, 62, 65, 78) e nel riparto Nord (tt. 4, 13, 27, 34, 46) (fig. 36). Le tt. 34, 27 e 65 sono state datate con il radiocarbonio. Mentre le tt. 27 e 65 cadono perfettamente all’interno della fascia cronologica Remedello 2, rispettivamente 2910-2570 (95,4 %) e 2900-2300 (95,4 %) a.C., la t. 34 si dimostra più antica, 3340-2890 (95,4 %) a.C. Ciò può significare che la produzione dei pugnali di selce a codolo distinto è iniziata un po’ prima della fase Remedello 2 oppure che la data è affetta da un “effetto riserva” indotto dalla paleodieta. Un tipico pugnale remedelliano a codolo distinto in selce sudalpina è stato
168 Valzolgher, Quarta 2009. In un’altra zona del riparo nel 1887 furono scoperti due pugnali del tipo a foglia di salice insieme a resti umani in deposizione secondaria: cfr. Salzani 2007, fig. 1.1-2.169 Cfr. de Marinis 1997a, 278 con bibliografia.
Fig. 35 - Pugnali in selce a foglia di salice (tipo 4-a), da Remedello Sopra loc. S. Angelo (a sinistra) e Casalmoro (a destra). Scala: 2/3 della gr. nat. (da Le Pietre degli Dei 1994 e disegni e lucidi di R.C. de Marinis).
339
Fig. 36 - Carta di distribuzione dei pugnali in selce nella necropoli eneolitica di Remedello Sotto. pugnali a foglia di salice e a peduncolo semplice triangolare; pugnali a codolo distinto; pugnali di classificazione incerta o di altro tipo pugnali a peduncolo trapezoidale.
340
rinvenuto nell’insediamento di Allensbach-Strandbad sul lago di Costanza in un contesto tardo Horgen datato dendrocronologicamente al 2900-2820 a.C.170.Nella tarda età del Rame, il periodo del Vaso Campaniforme, la tipologia dei pugnali di selce cambia. A Remedello nella t. 73, a ovest del riparto Sud, vi era un pugnale a peduncolo semplice trapezoidale (fig. 37). La datazione radiocarbonica indica 2460-2120 (88,72 %) e 2100-2040 (6,7 %) a.C. ed è quindi probabile che la tomba risalga al periodo campaniforme. Un pugnale dello stesso tipo è stato recuperato nel corso di raccolte di superficie in Val Listrea, in comune di Nave (BS) insieme a frammenti di vasi campaniformi171. La t. 74, anch’essa in posizione periferica a ovest del riparto Sud e accanto alla t. 73, ha un pugnale in selce di forma lanceolata stretta e lunga, con larghezza massima poco sotto la metà lunghezza, che si distingue quindi sia dal tipo a foglia di lauro sia dal tipo a foglia di salice (fig. 38). Per la sua vicinanza alla t. 73 è stata formulata l’ipotesi di una datazione alla tarda età del Rame172. Nel 1999 alla periferia nord-orientale di Verona, in loc. Bongiovanna, è stato scoperto un insediamento di età campaniforme, da cui proviene un pugnale dello stesso tipo173.Infine, sui pugnali a base espansa e con lama triangolare stretta e acuminata – un tipo non attestato nelle necropoli di Remedello e Fontanella Mantovana – vi è consenso tra gli studiosi per una datazione alla fine dell’età del Rame e agli inizi dell’antica età del Bronzo. Alcuni esemplari del tipo sono stati scoperti negli abitati di età campaniforme de Il Cristo a Gazzo Veronese e di S. Bernardino di Coriano. Il quadro dei pugnali in selce dell’età del Rame è certamente più articolato e complesso di quello qui delineato. Esistono diverse fogge che non si lasciano facilmente incasellare nei tipi più caratterizzati.
170 Schlichtherle 2002, 77 e ss., figg. 2, 7 e 14.7.171 P. Biagi, in Preistoria Alpina, 11, 1975, 348.172 de Marinis 1997a, 278 e fig. 6.173 P. Salzani 2002, 96-97, fig. 13. Il pugnale non è del nostro tipo 4-a, a foglia di salice.
Fig. 37 - Pugnale in selce del tipo a peduncolo trapezoidale dalla tomba 73 di Remedello Sotto.
Fig. 38 - Pugnale in selce di forma foliata lanceolata lunga e cuspide di freccia dalla tomba 74 di Remedello Sotto.
341
Non possiamo, però, concordare con le tesi espresse da E. Mottes (1996a, 2001), secondo la quale le lame di pugnale in selce rappresentano elementi di lunga durata, persistono fino all’antica età del Bron-zo e non si possono inquadrare in una precisa sequenza evolutiva. La sequenza da noi stabilita sarebbe tutt’al più valida solo per la necropoli di Remedello. Per quanto siano indispensabili ulteriori dati – associazioni chiuse e datazioni –, dai dati che abbiamo esposto emerge chiaramente che le grandi linee della tipo-cronologia elaborata a partire dallo studio della necropoli di Remedello sono tutt’ora valide. Esiste un indubbio parallelismo tra l’evoluzione dei pugnali in rame e quella dei pugnali in selce, in particolare tra i pugnali in rame tipo Remedello e quelli in selce a codolo distinto, così come nel periodo campaniforme tra il pugnale tipo Ciempozuelos e il pugnale in selce a peduncolo semplice trapezoidale. D’altra parte il pugnale in selce perde progressivamente il suo ruolo di fronte all’affermarsi di tecno-logie sempre più sofisticate per la produzione di pugnali di bronzo, che diventano il nuovo oggetto di prestigio sociale. Né si possono utilizzare ritrovamenti privi di contesto, di indicazioni stratigrafiche e associative, quali sono i pugnali ritrovati nei siti palafitticoli o nelle terramare per sostenere una lunga durata dei tipi fin entro l’età del Bronzo174. D. Manufatti in pietra levigataLe accette in pietra verde levigata sono attestate in otto tombe, mentre cinque esemplari provengono da tombe distrutte dai lavori agricoli (fig. 39). Sono di piccole dimensioni, tra i 6 e i 10 cm di lunghezza, hanno forma leggermente trapezoidale con tallone largo e quasi rettilineo e taglio appena arcuato. La levigatura è quasi sempre limitata al taglio e raramente investe una superficie più estesa delle due facce. La maggior parte presenta segni di uso, con taglio divenuto asimmetrico ed abrasioni e scheggiature nella parte prossimale destinata all’immanicatura. Le caratteristiche tipologiche delle accette di pietra levigata di Remedello si ritrovano anche nelle necropoli di Fontanella Mantovana e di Volongo, da cui provengono rispettivamente cinque e due esemplari175. Le due accette in giadeite dalle tombe 34 e BS I hanno dimensioni ancora minori.
Dalle necropoli di Remedello, Fontanella e Volongo abbia-mo complessivamente 21 asce di pietra levigata contro 4 di rame. Dalle stesse necropoli provengono 48 pugnali di selce contro 7 di rame. È eviden-te quindi che i manufatti di metallo sono ancora oggetti di grande prestigio e indicatori di rango sociale elevato e che l’in-dustria litica continuava a svol-gere una funzione di primaria importanza nell’ambito della produzione di armi e utensili.
174 A questo proposito cfr. le lucide osservazioni di Erio Valzolgher in Valzolgher, Quarta 2009, 95-96.175 Per una trattazione più ampia delle asce di pietra levigata dell’età del Rame in Italia settentrionale cfr. de Marinis 1996.
Fig. 39 - Remedello Sotto, località Campo Dovarese. Asce di pietra levigata da tombe distrutte dai lavori agricoli.
342
L’articolazione della società attraverso l’analisi dei corrediLa maggior parte delle tombe erano prive di corredo o avevano solo qualche scheggia di selce, sulla cui natura di elemento di corredo intenzionalmente deposto accanto al defunto non è facile pronunciarsi senza una revisione di tutti i materiali della necropoli. Su un totale di 126 tombe per le quali sono state compiute osservazioni di scavo o si hanno comunque notizie, soltanto 59 erano fornite di un corredo e appartenevano tutte a individui adulti, tranne 3 che sono di individui definiti giovani: le tt. 56, 63 e Viadana 1, la prima riferibile a un soggetto forse maschile di 13-14 anni con corredo composto da un pugnale e cinque cuspidi di freccia, l’ultima riferibile a un soggetto maschile di 15-18 anni con corredo composto da un pugnale, un’ascia di pietra levigata e due cuspidi di freccia. Il soggetto della tomba 63 è definito da Colini di “giovane età” – il dato è confermato dalla planimetria sul cartone collocato da Bandieri nella vetrina IX – e aveva per corredo una lesina di rame e un orecchino di filo di rame. Per quanto riguarda la percentuale delle tombe con corredo, poco meno della metà del totale delle sepol-ture, è necessario considerare il fatto che su 66 tombe prive di corredo, 47 apparivano già manomesse o parzialmente manomesse dai lavori agricoli e quindi un eventuale corredo può essere stato disperso. Soltanto per 6 tombe, definite intatte, si può affermare che fossero effettivamente prive di qualunque forma di corredo: 4 sono di adulti, 1 di bambino e 1 di adolescente.Ventun tombe contenevano solo una scheggia di selce, che, quando è indicata la posizione, si trovava all’altezza della spalla destra. Di queste 21 tombe, 2 erano già manomesse, 12 erano di bambini, 5 di giovani e solo 2 sarebbero state di adulti, la 114 e la 118176.Delle tombe con corredo, 41 sono caratterizzate dalla presenza di armi e debbono quindi essere con-siderate maschili. Nella composizione dei corredi maschili si osserva un diverso grado di complessità. Alcune tombe hanno soltanto una o più cuspidi di freccia in selce, oppure solo un pugnale, quasi sempre di selce, oppure solo un’ascia di pietra verde levigata. La maggior parte delle tombe con armi è caratterizzata dall’associazione cuspidi di freccia-pugnale di selce o, in due casi, di rame. Un gruppo più ristretto di tombe presenta il maggiore grado di complessità: frecce, pugnale di selce o di rame, ascia di rame o di giadeite o di pietra verde levigata. Una sola tomba, la 104, ha frecce e ascia di pietra, ma non il pugnale177. In 16 tombe sono stati ritrovati vasi in ceramica o frammenti di vasi. In genere le tombe con ceramica non hanno altri elementi di corredo e sono caratterizzate, secondo Bandieri e Colini, da scheletri in posizione supina. Nella t. 37, da cui proviene un frammento fittile, vi era anche una collana composta da anellini di calcare bianco e di steatite, da un cilindretto di calcare e da una valva di conchiglia marina e ciò depone a favore del genere femminile. Nella t. 75 un vaso è associato a un punteruolo di rame e il defunto era in posizione rannicchiata sul fianco sinistro e orientato verso W, la stessa posizione dell’unica altra tomba con un punteruolo di rame, la t. 63178. La t. 46, che ha restituito un pugnale in selce e un vaso biconico, è bisoma e conteneva due scheletri rannicchiati sul fianco destro. Il vaso era associato allo scheletro deposto per primo, mentre allo scheletro deposto successivamente al di sopra del primo era associato un pugnale di selce. Appare evidente che in questo caso siamo in presenza di una sepoltura di coppia e che la ceramica è un elemento di corredo femminile. Con tutte le limitazioni che derivano da una documentazione di scavo largamente incompleta e insuf-ficiente, probabilmente non sempre attendibile, si può comunque concludere che dall’esame dei cor-redi funerari emerge abbastanza chiaramente l’esistenza di norme rituali che codificavano la posizione
176 Secondo Barfield 1986, fig. 2.A, le tombe con schegge di selce sarebbero 25, di cui 19 bambini, 1 giovane e 5 adulti. I dati non corrispondono a quelli che ho ricavato dall’elenco pubblicato dal Colini. 177 Sulla composizione dei corredi con armi cfr. de Marinis 2010, 125 e ss., tabella I.178 Della tomba 75, trasportata al museo di Reggio Emilia, si conservano solo il cranio e i femori. Il cranio indica un individuo di sesso femminile. Secondo Colini lo scheletro era rannicchiato sul fianco sinistro, ma qualche dubbio in proposito appare lecito, anche a giudicare dall’attuale posizione del cranio nella tomba.
343
del cadavere nella tomba, il suo orientamento, l’assenza o presenza di corredo, le diverse categorie di oggetti di corredo. Sono sufficientemente riconoscibili alcune contrapposizioni: tombe senza corredo – tombe con una scheggia di selce – tombe con ceramica – tombe con armi. Si può quindi proporre, come interpretazione, che il rito funerario prevedesse differenti norme a seconda del sesso e a seconda delle classi di età. Vi sono tombe di bambini o adolescenti con soltanto una scheggia di selce, tombe di donne senza corredo oppure con un vaso in ceramica e questa differenza potrebbe rispecchiare differenti status, ad es. donne nubili e donne coniugate. Abbiamo tombe di maschi adulti con armi, seppelliti in posizione rannicchiata, quasi sempre sul fianco sinistro e orientati verso NW, oppure – e sono forse la maggioranza - seppelliti in decubito dorsale e con le gambe flesse e ripiegate verso sinistra o in un caso (t. 83) verso destra, e con diversi gradi di complessità del corredo. Sono proprio questi diversi gradi di complessità e la diversa giacitura del defunto nella fossa l’aspetto più difficile da interpretare: incipiente stratificazione sociale oppure diversi ranghi dei maschi adulti in una società in cui non vi sono ancora stabili diseguaglianze socio-economiche di classe179 ?Per prima cosa bisogna osservare due fatti che indicano uno stadio di sviluppo della organizzazione sociale certamente anteriore alla società di classe e ai chiefdoms di tipo complesso ed evoluto: l’assenza di corredo nelle tombe dei bambini e delle donne, tranne che ceramica e qualche oggetto di ornamento in un gruppo di tombe femminili, appare come il riflesso, a livello dei riti funerari, di una società in cui mancano chiari segni di stabili diseguaglianze socio-economiche di classe; in secondo luogo tutti gli adulti maschi posseggono le armi e quindi conoscevano le arti del combattimento, fatto che sem-brerebbe indicare l’assenza di una classe superiore, un’aristocrazia guerriera, detentrice del monopolio della forza, quale si osserverà nel corso dell’età del Bronzo.A queste considerazioni fanno da contrappeso altri fatti. Come abbiamo già messo in evidenza, i corredi dei maschi adulti mostrano un diverso grado di complessità. Se escludiamo le tombe già manomesse, che non possiamo ritenere attendibili quanto a completezza, sono poche le tombe che mostrano una panoplia completa, l’associazione frecce - pugnale - ascia. Inoltre compaiono alcuni ornamenti e alcuni materiali che nel contesto dell’epoca debbono essere considerati preziosi: i pugnali e le asce di rame (cfr. supra), un mantello con una ricca decorazione di piastrine di Cardium, conchiglia marina impor-tata, e ancor più lo spillone d’argento, rappresentano certamente simboli di prestigio e di superiorità sociale180. Alla luce di queste osservazioni possiamo ipotizzare una comunità tribale evoluta, basata sui rapporti di parentela, ma nello stesso tempo in corso di trasformazione verso una gerarchizzazione con più accentuate distinzioni di status, oppure una forma arcaica di chiefdom, in cui la gerarchia sociale comincia a strutturarsi in modo piramidale, grazie all’egemonia conquistata da alcuni lignaggi rispetto ad altri. Nel primo modello gli status sono determinati dal sesso, dall’età e dal lignaggio, nel secondo inizia a costituirsi una vera stratificazione sociale poiché alcuni lignaggi diventano egemoni e lo status sociale di rango elevato diventa ereditario. La classificazione delle società pre- e protostoriche elaborata dall’antropologia nordamericana attual-mente vacilla sotto i colpi della critica documentata di Alain Testart (2005). Malgrado tutti gli sforzi interpretativi che si possono fare anche in presenza di una documentazione ampia e sistematica, il che raramente succede, la maggior parte, se non la quasi totalità dei fenomeni sociali rimane archeologi-
179 Uno dei compiti più difficili dell’archeologia preistorica e protostorica è quello di inferire dalla documentazione disponibile, priva di fonti scritte, il tipo di organizzazione sociale e di struttura socio-economica. In genere, si tenta di correlare i dati archeologici a uno dei modelli teorici elaborati dall’an-tropologia socio-culturale in base alle fonti etnografiche. Superato da tempo il vecchio schema di L.H. Morgan (società selvaggia, barbarie, civiltà), i due principali modelli dello sviluppo delle società preistoriche a cui gli studiosi hanno fatto riferimento sono quelli di M.H. Fried (The Evolution of Political Society, New York, 1967) e di E.R. Service (Primitive Social Organization. An Evolutionary Perspective, New York, 1971, trad. italiana Torino 1983), che differiscono per l’accento posto su aspetti diversi dell’organizzazione sociale.180 L’interpretazione di Barfield (1986) secondo cui weapons are more to do with age and sex groupings than with rank è condivisibile solo in parte, poiché, come abbiamo cercato di dimostrare, esistono diversi gradi di complessità dei corredi con armi. Inoltre, alcuni degli oggetti tipici dei corredi dei guerrieri, come i pugnali di rame o lo spillone d’argento, sono certamente simboli di prestigio e di potere e come tali riservati a una ristretta élite.
344
camente invisibile. Nell’analisi delle necropoli l’archeologo può operare con relativa sicurezza a livello delle classi di età e del genere. Nelle società stratificate, anche se pre-urbane e pre-satali, è prassi fre-quente assicurare la coesione sociale attraverso lo strumento ideologico della religione e diffondere la convinzione che i capi dei gruppi egemoni siano discendenti dalla divinità, spesso solare, o comunque in rapporto con essa. A questo proposito l’analisi delle stele antropomorfe e dei massi istoriati della regione alpina e della Lunigiana può recare un contributo utile a comprendere le caratteristiche della società, integrando in modo determinante la documentazione, pur importantissima ma non sufficiente, della necropoli di Remedello.
Cronologia relativa e assolutaLa proposta formulata nel 1992 e 1994 di un’articolazione dell’età del Rame nell’Italia settentrionale in tre periodi, Rame 1 o Eneolitico antico, Rame 2 o Eneolitico medio e Rame 3 o Eneolitico tardo, corri-spondente alla cultura del Vaso Campaniforme, è oggi comunemente accettata sia in Italia che all’estero. Questa proposta si imperniava essenzialmente sull’analisi tipologica e cronologica della necropoli di Remedello, che nonostante le limitazioni imposte da una documentazione insufficiente per gli standard della ricerca attuale, ha continuato a rimanere il complesso più organico e più ricco di materiali. La trama delle associazioni, per quanto limitata, consente di riconoscere alcune correlazioni. L’ascia di rame tipologicamente più antica, quella della t. 102, molto simile all’ascia dell’Uomo del Similaun, è associata a un pugnale di selce di forma foliata, del tipo 4-a della nostra tipologia. Le due asce a mar-gini leggermente rialzati, tipologicamente più recenti (tt. 4 e 78), sono invece associate a pugnali di selce a codolo distinto. Se si considera la distribuzione di questi elementi all’interno della necropoli si può osservare che le tombe con pugnali di selce di forma foliata, a codolo non distinto (tt. 86, 97, 99, 102, 107), si concentrano nella parte sud-orientale del riparto Sud, dove una sola tomba ha un pugnale a codolo distinto (t. 94) e per di più collocata ai margini dell’area. Al contrario, nella parte nord-occidentale del riparto Sud abbiamo solo tombe con pugnali a codolo distinto (tt. 56, 60, 62, 65, 78), mentre mancano del tutto i pugnali foliati a base semplice. Nel riparto Nord tutti i pugnali sono a codolo distinto (tt. 4, 13, 27, 34, 46), tranne il caso della t. 41.A questo fatto si possono aggiungere ulteriori considerazioni: il pugnale in rame della t. 106, che non appartiene al tipo Remedello, si trova nell’area delle tombe con pugnali di selce a codolo non distinto. La tomba è stata datata dal radiocarbonio al 3370-3000 (92,9 %) 2980-2940 (2,5 %) a.C..Una tomba della parte nord-occidentale del riparto Sud, la t. 65, è stata datata dal radiocarbonio al 2910-2570 a.C. (95,4 %). In questa stessa zona si trovano le tt. 62, 79 e 83 con pugnali in rame del tipo Remedello, tipo che ha ormai il conforto di numerose date radiocarboniche ottenute a Forlì-Celletta dei Passeri e a Mirabella Eclano181, che lo collocano tra il 2900 e il 2500 a.C.182.La t. 75, che nei nostri precedenti lavori avevamo assegnato alla fase Remedello 1, è da collocare con ogni probabilità nella fase 2 sia per la posizione topografica sia per il venir meno di una cronologia alta del Riparo Valtenesi183, in particolare per la camera 133, con un vaso della quale era stato messo a confronto il vaso della t. 75. Il riparto Nord si colloca quasi interamente nella fase Remedello 2. Le tt. 27, 34 e 40 sono state datate con il radiocarbonio. Le tt. 27 e 40 cadono interamente nella fase Remedello 2, la t. 34 ha una data un po’ più antica, verso la fine della fase 1.Si può riconoscere, almeno nella parte più meridionale della necropoli, una stratigrafia orizzontale del
181 Cfr. supra.182 Cfr. supra.183 La camera 133 ha ora una data post quem di 2936-2856 a.C.: cfr. Barfield, Manning, Valzolgher, Higham 2010.
345
Fig. 40 - Planimetria della necropoli eneolitica di Remedello Sotto. tombe della fase Remedello 1 (ca. 3400-2900 a.C.); tombe della fase Remedello 2 (ca. 2900-2500 a.C.); tombe della tarda età del Rame (periodo campaniforme, ca. 2500-2200 a.C.); tombe di datazione incerta.
346
tipo a macchia d’olio, con le tombe più antiche concentrate nella parte sud-orientale del riparto Sud e le tombe più recenti che si dispongono a nord-ovest e a sud-ovest (fig. 40). La tomba BS II, nel cui corredo abbiamo lo spillone d’argento con testa a T, tipo che rimanda all’orizzonte cronologico della Ceramica Cordata a nord delle Alpi184, si trova poco più di 50 m a sud del riparto Sud, così come la tomba BS III, con un vaso biconico con presette perforate. A una ventina di metri a SE del riparto Sud è stata scoperta la tomba BS I, comprendente 6 frecce, un pugnale di selce a codolo distinto e un’accetta di giadeite. L’attribuzione della t. BS II alla fase più recente della necropoli è confermata dalla datazione radiocarbonica, 2880-2470 (95,4 %) a.C., che la colloca nell’orizzonte cronologico immediatamente pre-campaniforme. Si può, infine, ricordare a completamento della trama delle associazioni, che nella t. BS II si trova l’ornamento a rotella in marmo, che ha un corrispettivo nell’ornamento cruciforme in marmo, con foro centrale, della t. 83, il cui corredo comprende un pugnale di rame a codolo distinto monoforato (tipo Remedello B 2) e che si trova nella parte nord-occidentale del riparto Sud.
Alla luce di quest’analisi è possibile definire due fasi cronologiche nella necropoli di Remedello. La fase 1 è caratterizzata dai pugnali di selce a codolo non distinto (tt. 86, 97, 99, 100, 102, 107, Viadana I e nel riparto Nord t. 41), dal pugnale di rame della t. 106, che ben si colloca in una fase arcaica dell’età del Rame, dall’ascia di rame della t. 102, che si può confrontare con l’ascia del Similaun. Per quanto riguarda le tombe con ceramica a questa fase si possono assegnare le tt. 93 e 71, soprattutto in base alla loro collocazione topografica.La fase 2 è caratterizzata dai pugnali di selce a codolo distinto (tt. 56, 60, 62, 65, 78 nel riparto Sud, tt. 46, 34, 27, 13, 4 nel riparto Nord, t. BS I a sud del riparto Sud), dalle asce di rame a margini leg-germente rialzati (tt. 4 e 78), dai pugnali di rame tipo Remedello (tt. 83, 79, 62), dalla ceramica a decorazione metopale (tt. 46 e BS IV), dalle tazze e boccali con ansa a gomito (tt. 64, 65, 42), dallo spillone d’argento con testa a T (t. BS II).Frequentazioni successive o meglio una terza fase della necropoli è documentata in maniera solo fram-mentaria. Ceramiche campaniformi, provenienti probabilmente da una tomba distrutta dai lavori agricoli, sono state scoperte a un centinaio di metri a NW della necropoli. La t. 111, subito a sud-est
184 Cfr. supra ed anche Barfield 1971, 57.
Tabella delle datazioni radiocarboniche calibrate della necropoli di Remedello Sotto. A partire dall’alto: tomba 106, 34, 75, 65, 40, BS II, 27, 73.
347
del riparto Sud, ha restituito una cuspide di freccia a base concava, che probabilmente si data al periodo campaniforme. La t. 73, posta a una dozzina di m a ovest del riparto Sud, aveva per corredo un pugnale di selce a peduncolo semplice trapezoidale, un tipo che è senza dubbio più recente rispetto ai tipi di pugnale che caratterizzano le fasi 1 e 2 della necropoli185. Nella t. 73, scavata dal Chierici, l’inumato, un soggetto maschile di circa 30-40 anni186, era in posizione rannicchiata sul fianco sinistro, con orien-tamento N-S187, un costume funerario tipico del Vaso Campaniforme. Il pugnale era posto all’altezza dell’omero con la punta rivolta verso il basso, una posizione quindi del tutto diversa rispetto alla norma vigente nelle fasi 1 e 2 della necropoli, quando il pugnale è all’altezza della cintola a portata della mano destra, e che potrebbe indicare che fosse portato appeso a una bandoliera188. La tomba è stata datata dal radiocarbonio al 2460-2120 a.C. (88,7 %), vale a dire al periodo del Vaso Campaniforme. Una lunga durata della necropoli di Remedello Sotto non è incompatibile con il numero non elevato delle sepolture, come alcuni hanno in passato affermato. Innanzitutto, abbiamo già messo in evidenza come il numero dei corredi recuperati corrisponda solo a una piccola parte delle tombe che formavano originariamente la necropoli. La stima di 300 tombe fatta dal Bandieri è certamente una valutazione minimale.La necropoli di Remedello rappresenta per l’Italia settentrionale la prima grande necropoli comple-tamente separata dall’insediamento. Come è noto, in età neolitica i morti venivano seppelliti spesso sotto i pavimenti delle case o all’interno dell’area del villaggio. È un dato ampiamente osservato nel Vicino Oriente, nell’Europa sud-orientale e nel mondo mediterraneo. La separazione del mondo dei morti da quello dei vivi, con la creazione di un cimitero nettamente distinto dall’area dell’abitato, è un fenomeno che in molte regioni caratterizza il passaggio dal Neolitico all’età del Rame e che viene posto in relazione ai cambiamenti dell’economia, con la diffusione della pastorizia e dell’allevamento nomade o seminomade, o ai cambiamenti sociali e alla formazione di lignaggi che rivendicano la discenden-za da un antenato comune e il diritto all’occupazione di un determinato territorio189. “L’espressione della permanenza e della continuità della comunità, base della vita collettiva, è ora affidata non più all’abitato, ma alla necropoli. I gruppi ritornavano sempre al loro cimitero, che conservava e assicurava a ciascuno il posto che da vivo occupava nell’ambito della comunità. Ciò può sembrare insolito, ma è un fatto che sono le tombe che in quest’epoca simbolizzano l’unità e la stabilità della comunità”190. Ci sembra che queste parole di Nandor Kalicz descrivano molto bene anche il caso della necropoli di Remedello Sotto.
185 Per un elenco di pugnali in selce del tipo a peduncolo semplice trapezoidale cfr. de Marinis 1997a, 285. Sono tutti esemplari ormai senza contesto.186 Comunicazione di L. Salvadei.187 L’orientamento deviava solo di 13° verso est.188 Secondo Elisabetta Mottes non si tratterebbe di un pugnale, ma di un’alabarda (Mottes 1996a, 49, nota 19; 2001, 530-531). Considerata la posizione in cui fu rinvenuta la lama, l’idea sembra improbabile. Infatti, pugnali, asce, alabarde, cuspidi di freccia erano deposte nella tomba insieme al rispettivo manico o nel caso delle frecce all’asta, materiale organico che non si è conservato. L’alabarda sarebbe stata deposta in posizione trasversale rispetto al torace e trattandosi di un rannicchiato sul fianco o sotto il corpo o sopra il fianco destro, posizione che non corrisponde ad alcuna logica. Devo, inoltre, precisare che contrariamente a quanto scrive E. Mottes (2001, 529) nel mio lavoro del 1997 (1997a, 284-285 e fig. 8.6) i pugnali a peduncolo semplice trapezoidale non sono stati attribuiti alla fase Remedello 2, bensì al periodo campaniforme, mentre è vero che in 1997b – scritto prima ma pubblicato dopo 1997a - scrivevo che la t. 73 poteva essere essere assegnata alla fase Remedello 2 “or also later”. La ricerca è costantemente in progress.189 Per una sintetica discussione del problema, ma con riferimenti alla bibliografia cfr. Pessina, Tinè 2008, 303-306.190 N. Kalicz 1970, 57-58.
348
Acanfora M.O. 1956, “Fontanella Man-tovana e la cultura di Remedello”, in BPI, LXV, 321-385.
Anati E. 1972, I pugnali nell’arte rupestre e nelle statue-stele dell’Italia settentrionale, Capo di Ponte, Edizioni del Centro.
Angelini B., B. Bagolini, T. Pasquali 1980, “Acquaviva di Besenello (Trento)”, in Preistoria Alpina, 16, Trento, 67-69.
Anzidei A.P., G. Carboni, Egidi, Mal-vone 2007, “Rinaldone a sud del Tevere: nuove necropoli e materiali da contesti di abitato nel comprensorio della via Tusco-lana nell’area sud-est di Roma”, in Atti XL Riunione Scientifica, strategie di in-sediamento fra Lazio e Campania in età preistorica e protostorica, II, Firenze, 461-476, IIPP.
Anzidei A.P., C. Aurisicchio e G. Car-boni 2007, “Manufatti in argento dalle tombe a grotticella della facies di Rinaldo-ne del territorio di Roma”, in Atti XL Ri-unione Scientifica, strategie di insediamento fra Lazio e Campania in età preistorica e protostorica, II, Firenze, 553-559, IIPP.
Aranguren B. 2006, “Primi dati di cro-nologia assoluta dal livello funerario ene-olitico di Grotta della Spinosa, Massa Marittima (GR)”, in PPE. Atti del Settimo Incontro di Studi, II, Milano, 481-489.
Arcà A. 1995, “I pugnali dell’Ubaye”, in AA.VV., Immagini dalla Preistoria. Inci-sioni e pitture rupestri: nuovi messaggi dalle rocce delle Alpi Occidentali, Catalogo della mostra, Boves, 87-88.
Archeologia e Arte Rupestre 2001, Archeo-logia e Arte Rupestre. L’Europa. Le Alpi. La Valcamonica, Fossati A., P. Frontini (a c. di), Atti del 2° Convegno Internazionale di Archeologia Rupestre, Darfo-Boario Terme 2-5 Ottobre 1997, Milano.
Bagolini B. 1981, a c. di, Il Neolitico e l’età del Rame. Ricerca a Spilamberto e S. Cesario 1977-1980, Vignola.
Bagolini B. 1984, a c. di, Archeologia a Spilamberto. Ricerche nel territorio (Spilam-berto – S.Cesario), Bologna.
Bagolini B. e P. Biagi 1988, “Distribu-tion, Chronology and Cultural Signifi-cance of the “metopal” Wares of Northern Italy”, in Natura Bresciana, 24,1987, 183-187.
Bagolini B., M.G. Ferrari, G. Giacobi-ni e M. Goldoni 1982, “Materiali inedi-
ti dalla necropoli di Cumarola (Maranello di Modena) nel quadro dell’eneolitico italiano”, in Preistoria Alpina 18, 39-78.
Bailo Modesti G. e A. Salerno 1998, Pontecagnano II.5, La necropoli eneolitica. L’età del Rame in Campania nei villaggi dei morti, Napoli, Ist. Univ. Orientale.
Bandieri G. ms, Ragguaglio sulle esplo-razioni e scoperte fatte a Remedello Sotto di Brescia nell’ultimo quadrimestre dell’anno 1885 (prima stesura con correzioni), Ar-chivio Musei Civici di Reggio Emilia.
Barfield L.H. 1970, “L’insediamento neolitico “ai Corsi” presso Isera (Trento)”, in Studi Trentini di Scienze Naturali, XL-VII, 1, 56-77.
Barfield L.H. 1971, Northern Italy before Rome, Thames and Hudson, London.
Barfield L.H. 1975, “Il periodo eneo-litico nella provincia di Reggio Emilia”, in Preistoria e Protostoria del Reggiano. Ricerche e scavi 1940-1975, Reggio Emilia, 27-31.
Barfield L.H. 1979, “Eneolitico”, in Preistoria nel Bresciano. La cultura mate-riale, Brescia, 35-44.
Barfield L.H. 1986, “Chalcolithic Bu-rial in Northern Italy. Problems of Social Interpretation”, in Dialoghi di Archeologia, n.s., 4, 241-248.
Barfield L.H. 1996, “The Chalcolithic in Italy: Consideration of metal typology and cultural interaction”, in The Copper Age in the Near East and Europe, Colloquium XIX, UISPP 1996, Forlì, 65-74.
Barfield L.H. 2007, “Beads and other Necklace Elements”, in Barfield L.H., a c. di, Excavations in the Riparo Valtenesi, Manerba, 1976-1994, Origines, Firenze, 296-331, IIPP.
Barfield L.H., S. Buteaux e G. Boc-chio 1995, Monte Covolo: una montagna e il suo passato. Ricerche archeologiche 1972-1994, Birmingham.
Barfield L.H., S.W. Manning, E. Val-zolgher e T.F.G. Higham 2010, “A wiggle-matched date for the Copper Age cemetery at Manerba del Garda, Northern Italy”, in Proceedings of the 20th Internatio-nal Radiocarbon Conference, ed. by A. J. T. Jull, Radiocarbon, 52, 2-3, 984–1001.
Barocelli P. 1971, “Ostiano e Vologno”, in Oblatio (in onore di A.Calderini),
Como, S.A.C., 81-108.
Bernabò Brea M., M. Maffi, S. Man-tini, P. Mazzieri e L. Salvadei 2010, “Testimonianze funerarie della gente dei Vasi a Bocca Quadrata in Emilia occiden-tale. Archeologia e antropologia”, in RSP, LX, 63-126.
Bernabò Brea M., M. Maffi, S. Man-tini, P. Mazzieri e L. Salvadei 2011, “Le sepolture eneolitiche alle Mose (Pia-cenza)” in L’età del Rame in Italia, Atti della XLIII Riunione Scientifica, Bologna, 26-29 novembre 2008, Firenze, 685-691, IIPP.
Bernabò Brea M., M. Miari e G. Stef-fè cds, “L’Eneolitico dell’Emilia Roma-gna”, Preistoria e Protostoria in Emilia Ro-magna, Atti della XLV Riunione Scientifica, Modena, 26-31ottobre 2010, IIPP.
Bertoldi F., M. Miari, L. Tagliani, M. Costa, A. Rasia e F. Bestetti cds, “La necropoli eneolitica di Forlì, Celletta dei Passeri: dati archeologici ed analisi antropologica preliminare”, in Preistoria e Protostoria in Emilia Romagna, Atti della XLV Riunione Scientifica, Modena, 26-31 ottobre 2010, IIPP.
Biagi P. 1991, “An AMS Radiocarbon Date from Grave BS II of the Copper Age Cemetery of Remedello Sotto”, in Natura Bresciana, 26, 1989, 299-300.
Bianchin Citton E. 2004, “Il sito del Neolitico recente e dell’età del Rame di Sovizzo-località S. Daniele nel suo con-testo geomorfologico, paleoambientale e archeologico”, in L’area funeraria e cultuale dell’età del Rame di Sovizzo nel contesto archeologico dell’Italia settentrionale, a c. di E. Bianchin Citton, Quaderni di Archeologia Vicentina, 1, Vicenza 2004, 13-101.
Bianco Peroni V. 1994, I pugnali nell’Ita-lia continentale, PBF VI, 10, Stuttgart, F. Steiner.
Borrello M.A., J. Hoffstadt, U. Leu-zinger e H. Schlichtherle 2002, “Ma-teriali preistorici di origine meridionale tra i laghi Lemano e Costanza. Identificazione dei contatti transalpini nel Neolitico e nell’età del Rame”, in Il declino del mondo neolitico. Ricerche in Italia centro-setten-trionale fra aspetti peninsulari, occidentali e nord-alpini, a c. di Ferrari A. e P. Vi-
Riferimenti Bibliografici
349
sentini, Atti del Convegno, Pordenone 2001, Quaderni del Museo Archeologico del Friuli occidentale, 4, 25-50.
Calderoni G. e A. Cazzella 1999, “Le datazioni radiocarboniche e i rapporti cronologici con altri contesti italiani e transadriatici”, in Conelle di Arcevia. Un insediamento eneolitico nelle Marche, a c. di A. Cazzella e M. Moscoloni, Roma, 177-185.
Casini S. 2001, “Comparisons between Figures of Axes on Valcamonica and Val-tellina Stele (style III A) and archaeologi-cal Finds”, in Archeologia e Arte Rupestre, 199-210.
Casini S. 2012, “Le figure di armi della roccia 23 di Foppe di Nadro (Valcamo-nica): elementi per la cronologia delle incisioni dell’età del Bronzo”, in Acta Mi-neraria e Metallurgica, Studi in onore di Marco Tizzoni, C. Cucini, a c. di, NAB, 20, 243-253.
Casini S., R.C. de Marinis, A. Pedrotti (a c. di) 1996, Statue-stele e massi inci-si nell’Europa dell’età del Rame, NAB, 3, 1995.
Casini S., A. Fossati 2007a (a c. di), Le Pietre degli Dei. Statue stele dell’età del Rame in Europa. Lo stato della Ricerca, Atti del Convegno Internazionale di Brescia, NAB, 12, 2004.
Casini S., A. Fossati 2007b, “Le figure di armi dell’età del Rame sulla roccia 23 di Foppe di Nadro (Valcamonica)”, in Casini, Fossati 2007a, 313-337.
Cassano S.M., A. Manfredini 1975, “Recenti ricerche nelle necropolis eneoli-tiche della Conca d’Oro”, in Origini, IX, 153-224.
Cavani V. e M. Secondo 2009, “MA 91. San Venanzio, Cumarola”, in Atlante dei Beni Archeologici della Provincia di Mode-na, Collina e Alta Pianura, vol. III, Tomo 1, a c. di A. Cardarelli e L. Malnati, Firenze, 234-235, All’Insegna del Giglio.
Cazzella A. e M. Moscoloni, a c. di, 1999, Conelle di Arcevia. Un insediamento eneolitico nelle Marche, I, Ed. Gangemi, Roma.
Chierici G. 1884, “I sepolcri di Reme-dello nel Bresciano e i Pelasgi in Italia”, in BPI, X, 133-164, tavv.VI-IX.
Chierici G. 1885, “Nuovi scavi nel se-polcreto di Remedello”, in BPI, XI, 138-146, tavv. VI-VII.
Cocchi Genick D. e R. Grifoni 1985,
L’età dei metalli nella Toscana nordocciden-tale, Pisa.
Cocchi Genick D. e R. Grifoni 1989, L’età del Rame in Toscana, Viareggio.
Colini G.A. 1898-1902, “Il sepolcreto di Remedello Sotto nel Bresciano e il periodo eneolitico in Italia”, in BPI, XXIV, 1898, 1-47; 88-110; 206-260; 280-295; tavv. I-XIX bis; BPI, XXV, 1899, 1-27; 218-295; tavv. I-IV, XII-XIV; BPI, XXVI, 1900, 57-101; 202-267; tav. IV; BPI, XXVII, 1901, 73-132, tavv. V-IX; BPI, XXVIII, 1902, 5-43, 66-103.
Cornaggia Castiglioni O. 1971, La cultura di Remedello. Problematica ed er-gologia di una facies dell’eneolitico padano, Milano, Memorie SISN, XX,1.
Corrain C. e P. Gallo 1968, “I resti scheletrici umani della stazione eneolitica di Fontanella di Casalromano (Manto-va)”, in Istituto Lombardo, Rend. Lett., 101, 1967, 293-329.
Courtin J. e G. Sauzade 1975, “Un poignard de type Remedello en Provence”, in BSPF, 72, 184-190.
Dal Ri L., U. Tecchiati 1995, “L’area megalitica e la statua-stele eneolitiche di Velturno-loc. Tanzgasse (BZ). Contribu-to alla storicizzazione delle statue-stele dell’area atesina”, in Contributi allo studio dell’archeologia e dell’arte rupestre in Valca-monica e nell’arco alpino, Fossati A., a c. di, NAB, 2, 1994, 15-35.
Dal Ri L., G. Rizzi e U. Tecchiati 2004, “L’area megalitica dell’età del Rame di Vel-turno-località Tanzgasse (BZ). Aggiorna-menti sullo stato delle ricerche. Significato del sito e storia delle ricerche”, in L’area funeraria e cultuale dell’età del Rame di Sovizzo nel contesto archeologico dell’Italia settentrionale, a c. di E. Bianchin Citton, Quaderni di Archeologia Vicentina, 1, Vicenza 2004, 125-174.
de Marinis R.C. 1990, “Preistoria e Protostoria del territorio di Piacenza”, in Storia di Piacenza, Dalle origini all’anno mille, vol. 1, II, Piacenza, 687-764.
de Marinis R.C. 1992, “La più antica metallurgia nell’Italia settentrionale”, in Der Mann im Eis, Band I, Bericht über das Internationale Symposium 1992 in Inn-sbruck, Innsbruck, 389-409 (consultare la ristampa con correzioni).
de Marinis R.C. 1994, “La datazione dello stile IIIA”, in Le Pietre degli Dei. Menhir e stele dell’età del Rame in Val-camonica e Valtellina, a c. di S. Casini,
Bergamo, 69-87.
de Marinis R.C. 1996, “La pietra leviga-ta nell’età del Rame dell’Italia settentrio-nale. Remedello Sotto tomba del museo di Viadana. Fontanella Mantovana, fondo La Pista, tomba 12”, in Le vie della pietra verde, a c. di M. Venturino Gambari, Torino, 174-177, 180-182.
de Marinis R.C. 1997a, «La cultura di Remedello : nuove proposte di cronologia relativa e assoluta», in de Marinis, Pe-drotti 1997, 260-289.
de Marinis R.C. 1997b, “The Eneolithic Cemetery of Remedello Sotto (BS) and the relative and absolute chronology of the Copper Age in Northern Italy”, in NAB, 5, 33-52.
de Marinis R.C. 2010, “L’immagine del guerriero e i segni del potere nell’età del Rame e del Bronzo dell’Italia setten-trionale alla luce della documentazione funeraria”, in Les manifestations du pouvoir dans les Alpes, de la Préhistoire au Moyen-Age, XIIème colloque international sur les Alpes dans l’Antiquité, Yenne (Savoia), 2-4 octobre 2009, BEPA, XXI, 127-136.
de Marinis R.C. e A. Pedrotti 1997, “L’età del Rame nel versante italiano delle Alpi centro-occidentali”, in La Valle d’Ao-sta nel quadro della preistoria e protostoria dell’arco alpino centro-occidentale, Atti della XXXI Riunione Scientifica, Courmayeur 1994, Firenze, 247-300, IIPP.
de Marinis R.C. e A.E. Fossati 2004, “Armi ed armati nell’arte rupestre del-la Valcamonica e della zona alpina”, in Guerrieri, Principi ed Eroi fra il Danubio ed il Po dalla Preistoria all’Alto Medioevo, Marzatico F., Gleirscher P., a c. di, Trento, 355-365.
Dolfini A. 2010, “The origins of me-tallurgy in central Italy: new radiometric evidence”, in Antiquity, 84, n. 325, 707-723.
Dolfini A., B. Aranguren e M. Sil-vestrini 2011, “La prima metallurgia in Italia centrale alla luce di nuove date radiometriche”, in Atti XLIII Riunione Scientifica L’età del Rame in Italia, Bologna 26-29 novembre 2008, Firenze, 171-179, IIPP.
Fedele F. 2000, a c. di, Ricerche archeo-logiche al Castello di Breno, Valcamonica. I: Notizie generali. Ceramica neolitica e calcolitica, NAB, 8, 1-432.
Fedele F. 2007, “Monoliths and human
350
skeletal remains: ritual manipulation at the Anvòia ceremonial site, Ossimo (Val Camonica, Italy)”, in Casini, Fossati 2007a, Bergamo, 49-66.
Gallay A. 2006. “L’idéologie des stè-les”, in Des Alpes au Léman. Images de la préhistoire, Gallay A., a c. di, Gollion, 158-164.
Gallay G. 1981, Die kupfer- und alt-bronzezeitlichen Dolche und Stabdolche in Frankreich, PBF, VI, 5, München.
Gasparini E. 1957, “Il rito protoslavo della seconda sepoltura”, in Ricerche Slavi-stiche, VI, 3-41.
Grifoni Cremonesi R., a c. di, 2001, La grotta sepolcrale eneolitica di San Giusep-pe all’isola d’Elba, Origines, Firenze, IIPP.
Harrison R. e V. Heyd 2007, “The Tran-sformation of Europe in the Third Millen-nium BC: the example of Le Petit Chas-seur I + III (Sion, Valais, Switzerland)”, in Praehistorische Zeitschrift, 82, 129-214.
Häusler A. 1974, Die Gräber der älteren Ockergrabkultur zwischen Ural und Dnepr, Berlin, Akademie Verlag.
Häusler A. 1976, Die Gräber der älteren Ockergrabkultur zwischen Dnepr und Kar-paten, Berlin, Akademie Verlag.
Heyd V., R. Harrison 2007, “Sion, Ao-sta e le trasformazioni nell’Europa del terzo millennio a.C.”, in Casini, Fossati 2007a, 143-173.
Holloway R.R. 1973, Buccino. The ene-olithic necropolis of S.Antonio and other prehistoric discoveries, Roma, De Luca ed.
Honegger M., P. de Montmollin e C. Joye 2011, “Un essai sur les premières armes de guerre du Néolithique. Flèches, poignards et haches de combat au nord-ouest des Alpes », in L’armement et l’image du guerrieri dans les sociétés anciennes : de l’objet à la tombe, a c. di L. Baray, M. Ho-negger, M.-H. Dias-Meirinho, Dijon, 71-102.
Kalicz N. 1970, L’âge de pierre et du cuivre en Hongrie, Budapest.
Kalicz N. 1988, «The new results of the investigations on the Hungarian Copper Age”, in L’età del Rame in Europa, Rassegna di Archeologia, 7, 75-103.
Kalicz N. 1991, «Beiträge zur Kenntniss der Kupferzeit im ungarischen Transdanu-bien», in J. Lichardus, Die Kupferzeit als historische Epoche. Symposium Saarbrücken und Otzenhausen, 6.-13.11.1988, Saar-
brücker Beiträge zur Altertumskunde 55, Bonn, Habelt, I,
La valle delle incisioni 2009, La valle delle incisioni, a c. di R. Poggiani Keller, Ca-talogo della mostra (Brescia, 21 marzo-10 maggio 2009).
Le grandi vie della civiltà 2011, Marza-tico F., R. Gebhard, P. Gleirscher, Le grandi vie della civiltà, Catalogo della Mostra, Trento.
Le Pietre degli Dei 1994, Le Pietre degli Dei. Menhir e Stele dell’età del Rame in Valcamonica e Valtellina, a c. di S. Casini, Catalogo della mostra, Bergamo.
Longhi C. 1994, “La necropoli di Re-medello Sotto (BS)”, in Le Pietre degli Dei. Menhir e stele dell’età del Rame in Valcamonica e Valtellina, a c. di S. Casini, Bergamo, 203-210.
Longhi C. 2010, «La ceramica della ne-cropoli dell’età del Rame di Remedello Sotto, Brescia”, in RSP, LX, 145-165.
Mayer E.F. 1977, Die Äxte und Beile in Österreich, PBF, IX, 9, München.
Mazzieri P. e L. Giorgio 2011, “Una sequenza stratigrafica da Sant’Ilario, loca-lità Taneto (Reggio Emilia)”, in L’età del Rame in Italia, Atti della XLIII Riunione Scientifica, Bologna, 26-29 novembre 2008, Firenze, 605-611, IIPP.
Mezzena F. 1998, “Funzione e significato delle stele antropomorfe”, in AA.VV., Dei di Pietra. La grande statuaria antropomorfa nell’Europa del III Millennio a.C., Milano, Skira, 84-88.
Miari M., M. Bernabò Brea, G. Steffè, F. Bertoldi e L. Salvadei cds, “Sepol-ture eneolitiche in Emilia Romagna”, in Preistoria e Protostoria dell’Emilia-Roma-gna, Atti della XLV Riunione Scientifica, Modena, 26-31ottobre 2010, IIPP.
Morin A., R. Picavet 2005, “Étude pré-liminaire sur des poignards gravés de type Remedello découverts dans les Préalpes du Sud (Chastel-Arnaud, Drôme, France) et réflexions sur leur insertion dans le Néo-lithique final régional”, in BSPF, 102, 2, 345-359.
Moscoloni M. e E. La Rosa 2003, «Le cuspidi foliate di Conelle di Arcevia», in Conelle di Arcevia II, 1, a c. A. Cazzella, M. Moscoloni e G. Recchia, Roma, 275-307.
Mosso A. 1910, Le origini della civiltà mediterranea, Milano, F.lli Treves.
Mottes E. 1996a, “Considerazioni sulle
lame di pugnale litiche del territorio Vero-nese nel quadro dell’Eneolitico dell’Italia settentrionale”, in Dalla terra al museo, a c. di G. Belluzzo e L. Salzani, Legnago, 35-56.
Mottes E. 1996b, “Lame di pugnale in selce dal Trentino meridionale conservate presso il museo civico di Rovereto”, in Ar-cheologia del Comun Comunale Lagarino, a c. di U. Tecchiati, Rovereto, 97-105.
Mottes E. 2001, “Bell Beakers and beyond: flint daggers of northern Italy between technology and typology”, in F. Nicolis ed., Bell Beakers today. Proceedings of the International Colloquium Riva del Garda, II, Trento, 519-545.
Mottes E. e S. Ziggiotti 2012, “Analisi funzionale su lame di pugnale bifacciali in selce dell’età del Rame dal territorio di Ala (Trento) in Valle dell’Adige”, in Il Baldo nell’Antichità, Atti del secondo incontro di studi e ricerche archeologiche, Verona, 145-163.
Müller-Karpe H. 1974, Handbuch der Vorgeschichte, III, Kupferzeit, 1-3, Mün-chen.
Oberrauch H. 1996, “Die Spätneoliti-sche Siedlung auf dem Pigloner Kopf”, in Der Schlern, 70, 613-630.
Oberrauch H. 2002, “Il passaggio dal neolitico finale all’età del rame nel sito di Pigloner Kopf”, in Il declino del mondo ne-olitico: ricerche in Italia centro-settentriona-le fra aspetti peninsulari, occidentali e nord alpini, Atti del Convegno (Pordenone 5-7 aprile 2001), Quaderni del Museo Archeo-logico del Friuli Occidentale, 4, 257-270.
Odone S. 1994, “Volongo, loc. Panesella (BS)”, in Le Pietre degli Dei. Menhir e stele dell’età del Rame in Valcamonica e Valtelli-na, a c. di S. Casini, Bergamo, 210-212.
Odone S. 2005, Museo Civico Archeologi-co di Remedello, Remedello.
Odone S., F. Fedele 2002, “La ceramic di tipo Breno nera nel quadro del Neolitico tardo della Lonbardia centro-orientale”, in Ferrari A. e P. Visentini 2002, a c. di, Il declino del mondo neolitico. Ricerche in Italia centro-settentrionale fra aspetti peninsulari, occidentali e nord-alpini, Atti del Convegno, Pordenone 2001, Pordenone, Museo delle Scienze, 325-334.
Otto H. e W. Witter 1952, Handbuch der ältesten vorgeschichtlichen Metallurgie in Mitteleuropa, Leipzig.
Paribeni E., R. Iardella, I. Tiscornia, A.M. Tosatti 2012, “Lo scavo delle sta-
351
tue-stele di Groppoli ed altre ricerche nel territorio di Mulazzo (MS)”, in Atti XLII Riunione Scientifica, L’arte preistorica in Italia, Preistoria Alpina, 46, II, 235-244.
Pearce M. 1991, Materiali preistorici (ca-taloghi dei civici musei di Pavia I), Pavia.
Pedrotti A. 1993, Uomini di Pietra. I ri-trovamenti di Arco e il fenomeno delle statue stele nell’arco alpino, Trento.
Pedrotti A. 1997, “La transizione dal tardo Neolitico all’età del Rame”, in de Marinis, Pedrotti 1997, 248-260.
Pellegrini G. 1910, “Stazione eneolitica della Bocca Lorenza presso S. Orso (Vi-cenza)”, in BPI, 36, 71-85.
Pessina A. e V. Tinè 2008, Archeologia del Neolitico. L’Italia tra VI e IV millennio a.C., Roma, Crocci editore.
Petitti P., C. Persiani e P. Pallecchi 2011, “Reperti metallici dalla necropoli della Selvicciola (Ischia di Castro – Vi-terbo)”, in Atti XLIII Riunione Scientifica L’età del Rame in Italia, Bologna 26-29 novembre 2008, Firenze, 187-194, IIPP.
Piggott S. 1965, Ancient Europe, from the beginnings of Agriculture to Classical Antiquity, Edinburgh.
Poggiani Keller R., M. Baioni 2008, “The Bell Beaker at Monte Covolo: struc-tures and decorated pottery”, in Bell Bea-ker in everyday life, Millenni 6, Museo Fio-rentino di Preistoria, Firenze, 171-182.
Poggiani Keller R., M. Baioni, D. Lo Vetro e F. Martini 2002, “Monte Co-volo tra tardo Neolitico ed età del Rame. Strutture e materiali degli scavi 1998-1999”, in Ferrari A. e P. Visentini 2002, a c. di, Il declino del mondo neolitico. Ricer-che in Italia centro-settentrionale fra aspetti peninsulari, occidentali e nord-alpini, Atti del Convegno, Pordenone 2001, Pordenone, Museo delle Scienze, 311-324.
Primas M. 1996, Velika Gruda I. Hügel-gräber des frühen 3. Jahrtausends v. Chr. Im Adriagebiet – Velika Gruda, Mala Gruda und ihr Kontext, UFzPA, 32, Bonn.
Rey P.-J., T. Perrin, C. Bressy e J. Linton 2010, “La tombe de la nécropole de Fon-taine-le-Puits (Savoie), un depot funéraire
exceptionnel de la transition Néolithique Moyen/Final”, in BEPA, XXI, 105-124.
Salzani L. 1998, “Capanna dell’età del Rame a Gazzo Veronese”, in Simbolo ed enigma. Il bicchiere campaniforme e l’Italia nella preistoria europea del III millennio a.C., a c. di F. Nicolis e E. Mottes, Tren-to, 77-79.
Salzani L. 2007, “Sepolture dell’età del Rame nel Veronese”, in Bullettino Museo Civico Storia Naturale Verona, 31, 69-98.
Salzani P. 2002, «Verona – loc. Bongio-vanna. Insediamento della fine dell’età del Rame», in Preistoria Veronese, Contributi e Aggiornamenti, a c. di A. Aspes, Memorie Museo Civico Storia Naturale Verona, IIa serie, sezione scienze dell’uomo, 5, Verona, 96-98.
Schlichtherle H. 2003, “Remedello-dolch in fremden Griff? Ein geschäfteter Feuersteindolch aus der endneolithischen Ufersiedlung Allensbach-Strandband am Untersee/Bodensee”, in Nachrichtenblatt Arbeitskreis Unterwasserarchäologie, 10, 77-85.
Shishlina N.I., J. van der Plicht e E.P. Zazovskaya 2011, “Radiocarbon dating of the Bronze Age bone pins from Eura-sian steppe”, in Geochronometria, 38, 2, 107-115.
Stèles de Provence 2004, Stèles anthropo-morphes néolithiques de Provence, D’Anna A., S. Renault (eds.), Catalogue du Mu-sée Calvet d’Avignon, Avignon.
Strahm C. 1971, Die Gliederung der schnurkeramischen Kultur in der Schweiz, Acta Bernensia VI, Bern.
Strahm C. 1979, „Les épingles des parures en os du Néolithique final“, in Industrie de l’os néolithique et de l’âge des métaux, a c. di H. Camps-Faber, Paris, 47-66, CNRS.
Strahm C. 1994, “Die Anfänge der Me-tallurgie in Mitteleuropa”, in Helvetia Archaeologica, 97, 2-39.
Strobel P. 1886, “Le conchiglie nei se-polcri di Remedello nel Bresciano”, in BPI, XII, 134-140.
Talamo P., I. Passariello, C. Lubritto e F. Terrasi 2011, “Evoluzione culturale in
Campania: indagine cronologica sistema-tica tramite datazioni radiocarboniche”, in Atti XLIII Riunione Scientifica, L’età del Rame in Italia, Firenze, 39-48, IIPP.
Testart A. 2005, Eléments de classification des sociétés, editions Errance, Paris.
Tillmann A. 1993, “Gastgeschenke aus dem Süden ? Zur Frage einer Süd-Nord Verbindung zwischen Südbayern und Oberitalien im späten Jungneolithikum”, in Archäologisches Korrespondenzblatt, 23, 4, 453-460.
Tirabassi J. 1997, “Eneolitico”, in Mon-tecchio Emilia, Catasto Archeologico della Provincia di Reggio Emilia, a c. di R. Ma-cellari e J. Tirabassi, Supplemento 2, Reggio Emilia, 28-39.
Valtellina 1989, Valtellina e mondo alpino nella Preistoria, Poggiani Keller R., a c. di, Cosimo Panini ed., Modena.
Valzolgher E. e G. Quarta 2009, “Date radiocarboniche AMS dal riparo di Peri (Dolcé, Verona)”, in Bullettino Museo Ci-vico Storia Naturale Verona, 33, 85-113.
Valzolgher E. 2011, “Forma di fusione aperta monovalve. Palafitta di Ledro”, in Le grandi vie della civiltà, a c. di F. Mar-zatico, R. Gebhard, P. Gleirscher, Trento, 471.
Vital J. 2010, “Les sequences céramiques de la Balme de Sollières-Sardière (Savoie) et de la grotte de la Chauve-Souris à Donzère (Drôme): implication sur le Néolithique final transalpin, le phasage et le concept de Remedello», in Économie et société à la fin de la préhistoire. Actualité de la recherche, a c. di A. Beeching, È. Thirault, J. Vital, DARA 34, Lyon, 237-253.
Vital J. 2011, “Articulation chrono-cul-turelle et connexions transalpines de la séquence céramique Néolithique Final dans le Sud-Est de la France: questions et hypothèses», in Atti XLIII Riunione Scientifica L’età del Rame in Italia, Bologna 26-29 novembre 2008, Firenze, 145-150, IIPP.
Wackernell N. 1999, “Die Kupfer-beilklinge vom Gamertinerhof (Kastel-ruth)”, in Der Schlern, 73, 5, 272-274.