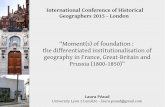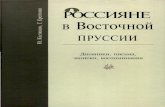Stato e cultura in Prussia sotto Federico II a cura di Edoardo Tortarolo
Transcript of Stato e cultura in Prussia sotto Federico II a cura di Edoardo Tortarolo
Nella stessa collana:
1. Antonello Mattone, Giuseppe Manno magistrato, storico, letteratotra Piemonte della Restaurazione e Italia liberale, 2009
2. Giuseppe Ricuperati, Un laboratorio cosmopolitico. Illuminismo estoria a Torino nel Novecento, 2011
3. Giovanni Bonacina, Eretici e riformatori di Arabia. I wahhâbiti inprospettiva europea 1772-1830, 2011
4. Paolo Desideri e Maria Antonietta Giua, Emilio Gabba fra sto-ria e storiografia sul mondo antico, 2011
Tortarolo, Edoardo (a cura di)Stato e cultura in Prussia sotto Federico IICollana: Quaderni della Rivista Storica Italiana, 5Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2013pp. X+000; 24 cmISBN 978-88-495-2748-3
© 2013 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.80121 Napoli, via Chiatamone 700185 Roma, via dei Taurini 27
Internet: www.edizioniesi.itE-mail: [email protected]
I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo(compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.
Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di cia-scun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla siae del compenso previsto dal-l’art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall’accordo stipulato tra siae,aie, sns e cna, confartigianato, casa, claai, confcommercio, confesercenti il 18 di-cembre 2000.
Volume pubblicato con il contributo dell’Università degli Studi di Firenze,Dipartimento di Scienze dell’Antichità
INDICE
Introduzione di Edoardo Tortarolo VII
Bernd SösemannLo spirito dell’illuminismo e la politica. Contorni e confini del
progetto politico di Federico II 1
Massimo MoriFederico II e la cultura illuministica 23
Eckhart HellmuthFederico il Grande e l’architettura 45
Michele CometaFederico II di Prussia e la letteratura 73
Riccardo MorelloFederico II di Prussia e la cultura musicale della sua epoca 87
Walter Sparn«Ciascuno a modo suo». Religione e teologia nella Prussia di
Federico II 99
Edoardo TortaroloOpinione pubblica e opposizione in Prussia sotto Federico II 137
INTRODUZIONE
Se c’è un paese europeo la cui storia recentissima ha suscitato in-teresse, timore e ammirazione è certamente la Germania. Sono sen-timenti che nella loro contraddittorietà ben riflettono l’atteggiamentopiù radicato che il pubblico italiano in particolare ha nutrito versola cultura, la società e le strutture pubbliche tedesche, sin da quandoil vasto spazio politicamente invertebrato dell’Europa centrale nelCinquecento e nel Seicento è stato lentamente, nel corso di quasi duesecoli, coagulato in entità via via più estese e rassodato con la forzamilitare nel Reich di Bismarck, producendo gli esiti disastrosi nelNovecento che tutti sappiamo. Dalla fine della seconda guerra mon-diale il processo di ricomposizione nello spazio politico dell’Europacentrale si è riproposto nell’arco di mezzo secolo. Caso più unicoche raro, due stati, in competizione per quarant’anni in tutti modi,esclusa solo la guerra aperta, si sono (ri?)unificati nel rapido volgeredi meno di un anno e hanno dato origine a un sistema politico edeconomico, la cui efficienza, produttività, capacità di innovazione esolidità mettono in difficoltà i partner dell’Unione europea. Nella fi-gura del re di Prussia Federico II (1712-1786) si sono condensatemolte delle caratteristiche che si ritrovano nella storia tedesca dei duesecoli successivi: senso dell’identità collettiva, volontà di imporsi, ri-cerca di regole vincolanti per tutti, disponibilità al sacrificio indivi-duale in vista di un guadagno futuro della collettività. O almeno cosìla storiografia ottocentesca e novecentesca ha visto presenti già nelsovrano vere o inventate tendenze di lungo periodo della storia te-desca: nel passaggio dalle presunte ‘virtù prussiane’ alle altrettantopresunte ‘virtù tedesche’ Federico II è stato un perno. Va da sé chequesta ricerca di una genealogia della paradossale ‘tedeschità’ in Fe-derico II (francofilo quanto pochi altri anche nel generalmente fran-cofilo Settecento) si sia prestata a mille fraintendimenti ideologici. Ilpubblico italiano ha avuto la sua parte di interpretazioni nobilmenteo sciaguratamente ideologiche e strumentali di Federico II. A partegli echi di opere classiche come l’ampia biografia eroica di Thomas
Carlyle1, basti ricordare, nella categoria delle interpretazioni sciagu-rate, il libro del generale Emilio Canevari, organizzatore dell’esercitodella Repubblica Sociale Italiana dopo essere stato tra i firmatari delManifesto della razza. Il suo Federico II il Grande uscì strategica-mente nel novembre del 1944 a Milano e si accostava alla mitizza-zione tardo-hitleriana di Federico II come prova che si può salvare ildestino militare di un paese allo stremo facendo ricorso alla forza dellavolontà e allo spirito di sacrificio. La chiave di volta della vita di Fe-derico II era «saper resistere alle avversità, sfidare i colpi del destino,restare diritto nella tempesta come esempio ai sudditi: non vi è altraregola. […] Se il re o i suoi soldati o il suo piccolo popolo non aves-sero dimostrato tanta lunga, incrollabile tenacia, quell’avvenimento fa-vorevole [l’uscita dei russi dalla coalizione nel 1762] si sarebbe pro-dotto troppo tardi inutilmente»2. L’anno dopo, nella traduzione diGiorgio Bassani e con la prefazione di Alberto Savinio, fu pubblicataa Roma, sorta di antidoto al veleno inoculato dal fascismo repubbli-chino attraverso il re di Prussia, la Vita privata di Federico II scrittada Voltaire3. Nel mutato clima del tardo dopoguerra la traduzionedella sintesi di Gerhard Ritter svolse, più sommessamente, un’analogafunzione di contravveleno. Federico II vi era presentato come unostatista razionale, autocratico sì, ma perno di una storia tedesca chenon si poteva esaurire nella bancarotta morale oltre che materiale delnazismo, della guerra e della catastrofe della sconfitta4. E ancora qual-che anno dopo, a conclusione di una carriera prestigiosa e influentedi storico iniziata proprio sotto il nazismo, Theodor Schieder tornòsulla biografia di Federico II per individuarne le contraddizioni e anzicaratterizzandolo proprio come un «regno delle contraddizioni»: am-bivalente, enigmatico e alla fine sfuggente. Anche la biografia di Schie-der è stata opportunamente messa a disposizione del pubblico italianoe rappresenta il testo di riferimento più sicuro per lo studioso italiano
1 T. Carlyle, History of Friedrich II of Prussia, London, Chapman, 1858-1865. 2 E. Canevari, Federico il Grande, Milano, Mondadori, 1944, p. 416. L’analisi
militare della guerra dei sette anni occupava quasi la metà del volume (pp. 209-360). 3 Voltaire, Vita privata di Federico II. Tradotta dal francese da Giorgio Bas-
sani con un saggio di Alberto Savinio, Roma, Atlantica, 1945.4 G. Ritter, Federico il Grande, Bologna, il Mulino, 2000 (edizione, con nuova
introduzione, riveduta rispetto alla prima, uscita nel 1970). Il testo di Ritter, pubbli-cato in prima edizione nel 1936 (Friedrich der Grosse. Ein historisches Profil, Leip-zig, Quelle und Mayer, 1936) si può accostare quanto all’interpretazione generale allabella voce per l’Enciclopedia Treccani di Federico Chabod (Roma, Istituto dell’Enci-clopedia Italiana, 1932, XIV, pp. 952-6).
introduzioneVIII
che intenda documentarsi sul complesso della figura di Federico II5.Nei trent’anni che ci separano dal libro di Schieder la ricerca su Fe-derico II e sul suo regno ha affrontato temi nuovi, aspetti sinora pocoo punto analizzati della società, della cultura e delle istituzioni prus-siane. Il quadro che se ne può ricavare è assai più ricco di sfaccetta-ture e sfumature ed è quindi profondamente diverso da quello cheRitter o anche Schieder avevano ricostruito e descritto nelle loro bio-grafie. I due ampi volumi recenti sul complesso degli aspetti biogra-fici del re e della costellazione sociale, istituzionale, culturale che nedefinì le possibilità di azione rappresentano al momento la miglioristantanea sulle ricerche recenti6. Anche la ricerca italiana ha recepitoda tempo la necessità di rivedere la ricerca sulla Prussia, uscendo dalmodello angustamente biografico: ha ricuperato e sviluppato spuntidella ricerca tedesca di inizio Novecento legati alla storia costituzio-nale, ha guardato ai temi approfonditi soprattutto dalla storiografiadella Germania orientale come la storia agraria, ha ricostruito la retedelle istituzioni culturali e le forme di opinione pubblica politica7.
In occasione del tricentenario della nascita di Federico II (24 gen-naio 1712), approfittando anche del ritorno di interesse in Germaniaper il periodo federiciano un quarto di secolo dopo le celebrazioniper il bicentenario della morte nel 1987, è apparso opportuno racco-gliere saggi di autori tedeschi e italiani che riflettessero i mutamentidella storiografia più recente fuori dalla riproposizione del mito di Fe-derico II despota illuminato che ancora conserva i suoi cultori in Ita-lia, perlopiù di seconda mano. Contribuire alla conoscenza aggiornata,condotta sulle fonti nella lingua originale, di una fase indubbiamentecruciale della storia tedesca appare come un compito nel quale la co-munità degli storici europei deve riconoscersi. In questo spirito di col-laborazione fattiva, l’Accademia delle Scienze di Torino, per energicoimpulso del suo presidente nel 2012, Pietro Rossi, ha raccolto studiosiitaliani, tedeschi e inglesi per discutere di Federico II e la nascita dellaPrussia moderna il 3 e 4 aprile 2012. Una scelta degli interventi, letti
5 T. Schieder, Friedrich der Große: ein Königtum der Widersprüche, Frank-furt/Main, Propyläen, 1984 (trad. it. Federico il Grande, Torino, Einaudi, 1989).
6 Friedrich der Grosse in Europa: Geschichte einer wechselvollen Beziehung, acura di B. Sösemann e G. Vogt-Spira, Stuttgart, Steiner, 2012.
7 Cfr. a titolo di esempio P. Schiera, Dall’arte di governo alle scienze dello stato:il cameralismo e l’assolutismo tedesco, Milano, Giuffré, 1968; G. Corni, Stato asso-luto e società agraria in Prussia nell’età di Federico II, Bologna, il Mulino, 1982; E.Tortarolo, La ragione sulla Sprea. Coscienza storica e cultura politica nell’Illumi-nismo berlinese, Bologna, il Mulino, 1989.
introduzione IX
e discussi in quell’occasione e profondamente rielaborati per la pub-blicazione, è raccolta ora in questo Quaderno della «Rivista StoricaItaliana». La direzione della «Rivista Storica Italiana» ha accolto conliberalità i contributi in questa sede prestigiosa. La dott. Paola Ru-more (Università di Torino) ha tradotto i saggi scritti originariamentein tedesco e ha collaborato alla redazione dei testi.
Freiburg im Breisgau/Torino, giugno 2013Edoardo Tortarolo
introduzioneX
Bernd Sösemann
LO SPIRITO DELL’ILLUMINISMO E LA POLITICA.CONTORNI E CONFINI DEL PROGETTO POLITICO
DI FEDERICO II
Stando all’immagine di sovrano che Federico il Grande aveva disé, la politique rappresentava una delle colonne portanti (points prin-cipaux) del suo governo. Nei Testaments politiques del 1752 e del1768 egli si dilunga sui motivi che hanno ispirato il suo pensiero ele sue imprese. Analoghe considerazioni si incontrano nell’Exposédu Gouvernement Prussien, des Principes sur Lequel[s] il roulle, avecqualques Reflexions Politiques, redatto nel 1776, nonché nelle Con-siderations Sur L’Etat Politique de L’Europe del 17821. Alcune al-tre informazioni si ricavano poi da vari scritti celebrativi, dalle let-tere e dai discorsi. Il sovrano aveva richiesto che si desse letturadelle trascrizioni più ampie su questo argomento nell’AcadémieRoyale des Sciences et des Belles Lettres de Prusse, che egli stessoaveva riformato2. La scelta di questa sede prestigiosa era il fruttodi un calcolo ben ponderato sulla pubblica diffusione delle sue idee.Egli sapeva infatti che alcuni membri dell’Accademia avrebbero ri-ferito di quelle idee nelle loro corrispondenze, contribuendo in talmodo all’accrescimento della sua gloria. Infine, per comprendereadeguatamente la figura del sovrano, occorre prendere in conside-
1 Questi saggi sono disponibili, insieme ai Testaments politiques, in un’edizionebilingue (tedesco-francese) a cura di R. Dietrich, Die politischen Testamente der Hohen-zollern (Veröffentlichungen aus den Archiven preußischer Kulturbesitz 20), Köln,Böhlau, 1986.
2 Riguardo alla storia dell’Accademia e al suo significato complessivo per l’Eu-ropa cfr. ora E. Tortarolo, Internationalität in der Akademie der Wissenschaftenzu Berlin, in Friedrich der Große in Europa. Geschichte einer wechselvollen Beziehung,a cura di B. Sösemann e G. Vogt-Spira, Stuttgart, Steiner, 2013, I, pp. 293-306.
razione i Mémoires pour servir à l’histoire du Brandebourg3 e i Mé-moires de mon temps4.
Già prima di salire al trono Federico aveva redatto L’Antima-chiavel5: egli era infatti persuaso che l’attività di scrittore rientrasse traquelle attività che contribuivano al prestigio del suo ufficio. Il pub-blico, e in specie le casate dei principi, accolsero lo scritto secondol’uso del tempo, vale a dire come un documento a cui il sovrano avevaconsegnato osservazioni e riflessioni circa i suoi progetti futuri. Piùtardi – nelle considerazioni preliminari anteposte ai Mémoires de montemps – Federico rivelerà la duplice immagine che coltivava di sé: l’im-magine di philosophe6 e di poeta7. Alla pari della gran parte dei so-vrani, anch’egli si considerava per mestiere un brillante storiografo –una convinzione che lo accomunava a Pietro il Grande e a Caterinala Grande. Come Federico, anche questi altri sovrani coltivavano iltopos della modestia, fingendo di mettere a disposizione della storio-grafia successiva una grande mole di materiale per quelle che sareb-bero diventate le loro autopresentazioni storiche8. Questo atteggia-mento di apparente modestia non impediva tuttavia loro di esprimersiin maniera risoluta, perentoria e dogmatica.
Da tutti i testi di Federico finora menzionati si possono ricavareinformazioni circa gli aspetti principali del suo governo, le ragioni chelo mossero ad agire in una maniera anziché in un’altra, i suoi piani,le sue intenzioni, i suoi metodi, le sue imprese e le riflessioni scatu-
3 La prima stesura delle Mémoires pour servir à l’histoire du Brandebourg risaleal 1747; Federico ne fece dare lettura all’Accademia nel maggio del 1748.
4 La prima stesura delle Mémoires de mon temps risale al 1742; nel 1746, 1748e 1778 seguì una serie di revisioni. Già nel 1767 si possono contare più di 20 ri-stampe, e tutte presentano modifiche al testo.
5 Nella Potsdamer Ausgabe delle opere di Federico è ora disponibile un’edizionebilingue (tedesco-francese) de L’Antimachiavel ou Réfutation du Prince de Machia-vel, a cura di A. Baillot e B. Wehinger, in Friedrich der Große, Potsdamer Aus -gabe. Philosophische Schriften, VI, Berlin, Akademie Verlag, 2007, pp. 45-259.
6 Secondo il significato del tempo il philosophe era colui il quale si dedicava allostudio delle scienze e della poesia, che intendeva indagare gli effetti a partire dalleloro cause e dai loro principi e che, nella sua natura di «spirito libero», non tenevain conto i doveri e i vincoli consueti della vita civile, e persino cristiana (riguardo altema dei «filosofi occasionali sul trono» cfr. E. Spranger, Der Philosoph von Sans-souci, Heidelberg, Quelle & Meyer, 1962, pp. 10 ss. e passim).
7 B. Wehinger, Der Monarch als Schriftsteller, in Friedrich der Große in Eu-ropa – gefeiert und umstritten, a cura di B. Sösemann, Stuttgart, Steiner, 2012, pp.43-48.
8 C. Clark, «Le roi historien» zu Füßen von Clio, in Friedrich der Große inEuropa, cit., I, pp. 159-77.
bernd sösemann2
rite dal bilancio di quanto aveva di volta in volta conseguito9. I Te-staments politiques si rivelano una fonte particolarmente preziosa percinque ragioni:
1. essi hanno un grande significato in quanto tali: si tratta infattidi testi redatti con grande scrupolo, su cui Federico è tornato a piùriprese e a cui ha affidato il proprio modello di sovranità a uso deisuoi successori;
2. essi contengono riflessioni spontanee, contingenti e occasionateda eventi specifici, che Federico elaborò in circostanze che percepivacome problematiche;
3. essi presentano le esperienze del sovrano – diversamente da quelche accade nello scritto giovanile L’Antimachiavel10 – secondo un or-dine e una sistemazione che egli stesso aveva concepito, rivelandonel’ambizione di offrire un resumé dei suoi propri pensieri;
4. essi si condensano di frequente in moniti chiari e imperiosi, an-corché il sovrano affermi più volte il contrario;
5. insieme ai trattati del 1776 (Exposé) e del 1782 (Considérations),essi consentono un’interpretazione ad ampio raggio. Percorrendo un arcodi quarant’anni, i Testaments mostrano chiaramente che cosa persiste eche cosa muta nelle concezioni di Federico – e ciò sia relativamente aisuoi ripensamenti circa le questioni politiche sia rispetto all’avvicendarsi
9 La concezione politica e giuridica del monarca è stata spesso oggetto di studispecifici. Parimenti le sue concezioni della morale e dell’etica. Le presentazioni piùdatate richiedono sovente un’integrazione, a causa della prospettiva eccessivamente ri-stretta da cui osservano la questione, riducendola alle solite bipolarità, come assolu-tismo/Illuminismo, machiavellismo/antimachiavellismo, potenza/diritto, ragion diStato/umanità, spregiudicatezza/coscienza. Persino le biografie più recenti tentano disvelare la «legge dell’azione» di Federico ricorrendo a concetti quali «natura bifronte»,«dominio delle contraddizioni» (Th. Schieder) o «doppiezza», se non persino a me-tafore che rimandano all’«enigma» del suo personaggio o alla «contraddizione internadi Federico» (T. Schieder, Friedrich der Große. Ein Königtum der Widersprüche,Frankfurt/Main, Propyläen, 1983, pp. 341-64: «Roi-Connétable», Federico il Grande,Torino, Einaudi, 1989).
10 L‘Antimachivel ha influenzato nella maniera più determinante la ricezione del-l’idea politica del sovrano prussiano; la mia discussione si serve dell’elemento specu-lativo-teoretico che domina in quell’opera solo come termine di confronto. JohannesKunisch ha preferito assumere l’atteggiamento opposto nel suo studio sulle afferma-zioni di Federico circa la teoria dello Stato. Kunisch ha rinunciato espressamente aun’analisi dettagliata dei Testaments politiques, poiché quei testi sono eccessivamentediretti all’«orientamento della prassi». A questo proposito cfr. il suo contributo (incui ripropone con qualche modifica un testo più vecchio), Lob der Monarchie. Aspekteder Staats- und Herrschaftsauffassung, in Friedrich der Große in Europa – gefeiertund umstritten, cit., pp. 27-42.
lo spirito dell’illuminismo e la politica 3
delle ragioni che orientarono il suo operato sia, ancora, alla variazionedella funzione della strategia e del posizionamento tattico11.
Già nel primo Testament politique (1752), la politique occupa unposto di primo piano accanto all’amministrazione della giustizia, all’e-conomia finanziaria e all’organizzazione militare. Il sovrano concepivala politique in pieno accordo con l’Illuminismo europeo come un’«arte»,come l’«arte del governo». Se si possiede quest’arte, si dispone di unaconoscenza sicura delle misure e dei mezzi adeguati (moyen convena-ble) per la salvaguardia dei propri interessi: «Pour agir Conformementa Ses Interets il faut Les Conoitres, et pour parvenir a Cette Conois-sance il faut de l’etude, du recoeuillement et de L’aplication»12. Oc-corre pertanto studiare accuratamente gli sviluppi che si realizzano inEuropa, concepirli in una maniera scevra da pregiudizi e tenere sottocontrollo la situazione economica e militare. Il principe deve conoscerela situazione in cui versano le casse dello Stato così come si confà achiunque attenda in maniera avveduta alla propria economia dome-stica. Nei periodi di pace il sovrano agirà pertanto come un ispettoreaccorto, intransigente e illuminato dalla ragione (éclairé par sa raison);in guerra, invece, sarà un comandante capace di pianificare rigorosa-mente la gestione delle finances e del fourrage. Solo in questo modoil principe riesce a garantire la sicurezza dello Stato e ad ampliare isuoi possedimenti. Quando si aspira a realizzare qualcosa di grande,occorre accrescere la propria potenza e innalzare la propria fama: «onne parvient à des grandes choses qu’en affrontant de grands hasards»13.Il sovrano inglese è sì un reggente accorto, ma vede tutto dalla pro-spettiva del suo principato di Hannover. Per questa ragione le sue con-siderazioni sono irrimediabilmente unilaterali: «La haine quil a contrela Prusse vient en partie d’ansienes brouilleries du ministere hanovrienavec celui de Berlin, et en partie de l’envie quil porte a l’accroissementde puissance de son voissin»14.
11 Ovviamente il carattere soggettivo e contingente può indebolire la forza espres-siva di un testo. D’altra parte questo tipo di unidimensionalità, proprio perché evi-dente, non costituisce un vero e proprio impedimento all’interpretazione. La situa-zione delle fonti e lo stato della ricerca sono soddisfacenti, ma sono comunque peg-giori di quel che si pensa. L’edizione storico-critica delle opere continua a rimanereun desideratum.
12 Qui e in seguito si cita da Die politischen Testamente der Hohenzollern, cit.13 In una lettera al principe Augusto Guglielmo del 12 agosto 1756, in Œuvres
de Frédéric le Grand, a cura di J.D. Erdmann Preuß, 30 voll., Berlin, Decker, 1846-56; voll. X-XV: Œuvres poétiques: XIII, n. 7836, p. 205.
14 Die politischen Testamente der Hohenzollern, cit., p. 332.
bernd sösemann4
Federico voleva organizzare la sfera politica sulla scorta della pienaconvinzione di essere l’unico detentore dell’autorità dello Stato. Comesovrano, egli riservava per sé tutte le decisioni – che egli prendeva inassoluta autonomia e di cui si riteneva l’unico responsabile: «Mais silest Necessaire que Le prince gouverne par Lui Meme L’Interieur deSon Etat, combien plus L’est il quil dirige Sa politique Lui Meme,quil face Les alliances qui Lui Convienent, quil forme Lui Meme sesdesseins et prene Son parti dans les Conjonctures Delicates et Sca-breusses»15. Il sovrano rappresentava il punto di convergenza neces-sario di tutti i fili del governo16.
Federico poneva al primo posto il proprio servizio (Dienst)17, vale
15 Ivi, p. 326.16 Analogamente anche nel Testament politique del 1768: «il faut un point Cen-
tral qui Unisse toute[s] Les Lignes du Gouvernement», Die politischen Testamenteder Hohenzollern, cit., p. 614.
17 Nel giorno della sua ascesa al trono (il 12 giugno 1740) Federico scriveva aVoltaire questi versi: «Desormais ce peuple que j’aime / Est l’unique dieu que je sers./ Adieu mes vers et mes concerts, / Tout les plaisirs, Voltaire même; / Mon devoir est
lo spirito dell’illuminismo e la politica 5
Fig. 1 - Axel Groehl, Staatslenker. Ohne Zügel kommen die Sorgen, Acquarello (pro-prietà privata).
a dire il dovere di rendersi utile alla patria e di servirla18. È oppor-tuno fare alcune considerazioni a questo proposito, trattandosi in-dubbiamente della più citata tra le sue dichiarazioni. Il termine su cuisi regge la questione, che in tedesco viene perlopiù reso con Diener(servitore), incontra in francese molteplici sfumature di significato. Ilsovrano si descriveva come il «premiere domestique de l’état» o comeil «premier Serviteur de l’Etat» o, ancora, come il «premier magistrat»o «premier ministre»19. Così facendo, Federico spostava l’accento suidiversi aspetti del suo ruolo, dava voce a esigenze diverse e si riferivaa circostanze differenti. Queste sfumature possono venir colte a par-tire dai differenti contesti in cui veniva descritto il ruolo del sovranoe confermano il sospetto che Federico ne abbia di volta in volta con-sapevolmente accentuato un aspetto o l’altro. Soltanto la formulazione«le premiere domestique de l’état» richiama un concetto assimilabileal tedesco Diener, ancorché nel francese si alluda anche al ruolo dipubblico ufficiale (Amtsträger) o di funzionario (Beamte). Parlandodi sé come del «premiere Serviteur de l’Etat», Federico poneva invecel’accento sulla sua funzione di servizio e sul carattere esemplare dellesue azioni; nell’espressione «premiere magistrat» spostava invece l’at-tenzione sulla sfera della gestione dello Stato e, di conseguenza, sulrapporto tra il sovrano e i suoi sudditi; con «premier ministre» ri-marcava il significato della sovranità rispetto all’organizzazione costi-tuzionale dello Stato. Complessivamente, però, in tutte queste for-mulazioni l’immagine di Federico si pone in netto contrasto sia conla figura del sovrano assoluto («la maître absolue»), sia con quella delreggente ozioso.
Lo spirito di servizio non si rivolgeva, per Federico, esclusiva-mente al suo governo, ma si estendeva anche al tempo a venire, conl’intento di predisporre le condizioni favorevoli per l’azione politicadel suo successore. Al contempo, però, egli aveva ben chiari i limitidelle sue possibilità: Federico non si aspettava affatto che i suoi pro-getti trovassero una realizzazione immediata. La storia non progredi-sce in maniera lineare. Nel mondo tutto sottostà alla legge del muta-
mon dieu suprême», Aus dem Briefwechsel Voltaire – Friedrich der Große, a cura diH. Pleschinski, Zürich, Haffmans Verlag, 1992, p. 177.
18 La patria prese per Federico il posto della trascendenza. Il 18 settembre 1760egli confessava all’amico Jean Baptiste de Boyer, Marquis d’Argens, con sguardo re-trospettivo: «Dovete sapere che non è necessario che io viva, ma che io faccia il miodovere e combatta per la mia patria (que je combatte pour ma patri) per salvarla, sepossibile» (T. Schieder, Friedrich der Große, cit., p. 381).
19 Die politischen Testamente der Hohenzollern, cit., p. 328 e passim.
bernd sösemann6
mento. Ogni situazione mostra le sue irriducibili peculiarità. La morteannienta chi dispensa consigli insieme a tutti i suoi piani20. Nei Te-staments politiques Federico procede come un nocchiero che conoscebene le zone tempestose del mare della politica, e le segnala per tempo.
Ma nella sfera della politique interieure Federico non si acconten-tava di queste misure particolari: egli guardava alle istituzioni politi-che, sociali e giuridiche, e si preoccupava che ogni azione avesse unapropria legittimità. I processi andavano rigorosamente condotti sullabase di un fondamento giuridico. Il sovrano non doveva influenzarela giurisdizione21. Egli aveva il dovere di mantenere in forza la leggee di esaminare le singole sentenze per stabilire se in un caso o in unaltro non sarebbe stato più opportuno giudicare in maniera più omeno severa: «c’est dans Les tribunaux ou les lois doivent parler etou le souverain doit se taire, mais en meme tem[p]s ce Silence ne m’apoint empeché d’avoir Les yeux ouvert pour Veiller sur La Conduitedes juges […]»22. Occorre controllare periodicamente tutte le istitu-zioni, affinché le riforme siano introdotte con tempestività. L’immo-bilità condurrebbe alla rovina; l’imperfezione dell’agire umano ha sem-
20 Federico ha rimarcato ripetutamente nei suoi scritti e nelle sue corrispondenzedi trarre forza, lucidità e libertà interiore dalla certezza di potersi suicidare (cfr. P.Paret, Ein einzigartiges Leben – verschiedentlich reflektiert, in Friedrich der Großein Europa – gefeiert und umstritten, cit., pp. 13-26, e T. Stamm-Kuhlmann, Vomrebellischen Sohn zum Landesvater. Der Herrscher zwischen Familie und Staat, inFriedrich der Große in Europa, cit., I, pp. 4-20).
21 M. Wienfort, Gesetzbücher, Justizreformen und der Müller-Arnold-Fall, inFriedrich der Große in Europa, cit., II, pp. 33-46.
22 Die politischen Testamente der Hohenzollern, cit., p. 256. Nel caso del mu-gnaio Arnold, Federico revocò però in forza della propria autorità le decisioni deigiudici. Egli giustificò il proprio intervento accusando i giudici di aver favorito il no-bile proprietario terriero. Lo ripugnava la violenza del procedimento che aveva con-dotto all’arresto del mugnaio e di sua moglie, e alla confisca del mulino. Il sovranofece quindi arrestare i giudici, restituendo nuovamente al mugnaio il mulino. L’in-tervento di Federico suscitò grandi consensi tra il pubblico. Ma il caso era ben piùcomplicato di quanto non avesse inteso il sovrano. Gli storici della costituzione e deldiritto non si accordarono mai riguardo alla valutazione del caso Arnold. Essi mo-stravano di comprendere sia il sovrano, che propugnava una «giustizia uguale pertutti», sia i giudici, che avevano motivato in maniera assai accurata la condanna delmugnaio. Appare comunque evidente che Federico, facendo arrestare i giudici, agìcontro il principio dell’autonomia della giustizia da lui stesso rivendicato. Egli esi-geva una sentenza chiara, che tutti i sudditi potessero comprendere. La sua sovranitàsarebbe stata incoronata con la fama di «Federicus legislator», cfr. M. Diesselhorst,Die Prozesse des Müllers Arnold und das Eingreifen Friedrichs des Großen, Göttin-gen, Schwartz, 1984, pp. 60 ss.
lo spirito dell’illuminismo e la politica 7
pre bisogno di venir corretta: «Elle est Nessaire et ramener toute Leschoses au but de leur Institution»23.
Altero e determinato Federico proclama di non aver mai convo-cato un consiglio dei ministri. Riteneva infatti che quell’istituzionefosse altamente dannosa; era molto difficile che tante teste mirasseroa un obiettivo comune, operando in maniera ferma e risoluta in vistadel suo conseguimento: «un sistheme ne peur emaner que d’une Tete;donc il faut quil parte De Celle du Souverain»24. Sotto questo rispetto,e in alcuni altri casi, Federico dava parzialmente ragione a Machia-velli. Un principe sovrano poteva nutrire l’ambizione di distinguersiper i suoi successi militari. Ma le ambizioni devono accompagnarsialla saggezza che sola può garantirgli di agire secondo ragione e diessere votato a un’impresa giusta. Un atteggiamento siffatto preser-vava il principe ambizioso dal fascino delle «disputes frivoles» e dalcommettere azioni sconsiderate nei confronti di avversari potenti, ca-dendo in rovina25. La guerra, nel migliore dei casi, doveva rappresen-tare l’extrema ratio: «Les Aquisitions qu’on fait par la plume, sonttoujours preferables a celles que lon fait avec L’epée»26. In questomodo l’uomo politico non era esposto alle peripezie del fato o allacontingenza delle circostanze: agendo in questa maniera avveduta, eglimetteva al riparo sia le sue finanze sia le sue forze militari, senza peròperdere la presa sul futuro, vale a dire sulla gioventù operosa. Fu cosìche la Prussia – che ancora nel 1752 difettava di forza interna (forceintrinseque) – riuscì col tempo a diventare una delle principali po-tenze europee.
Nel Testament politique più tardo, del 1768, si legge che l’uomopolitico non deve soltanto sforzarsi di anticipare gli eventi futuri, madeve altresì conoscere lo spirito del popolo («le Genie des peuples»):«Les prussiens ne manqent pas d’esprit; il y en a qui forment debon[s] sujets»27. Il sovrano deve però preoccuparsi innanzitutto di af-fermare se stesso28. Molti degli ampliamenti sostanziali che si incon-trano in questo scritto rispetto alla versione del 1752, così come l’i-
23 Die politischen Testamente der Hohenzollern, cit., p. 256. 24 Ivi, p. 326.25 L’Antimachiavel ou Réfutation du Prince de Machiavel, cit., p. 204: «C’est
grand, j’en conviens, mais ce n’est louable qu’a proportion que l’entreprise du con-quérant est juste», nonché p. 206.
26 Ivi, p. 174.27 Ivi, p. 588.28 M. Junkelmann, Der Militärstaat in Aktion. Kriegskunst des Ancien Régime,
in Friedrich der Große in Europa, cit., II, pp. 166-91.
bernd sösemann8
nasprimento di alcune idee, furono il risultato delle esperienze vissuteda Federico durante le guerre di successione austriache. Per questa ra-gione non deve affatto stupire che rispetto alla guerra preventiva laposizione di Federico si avvicinasse a quella di Machiavelli. Al di làdi ogni dichiarazione idealistica dei primi decenni del suo governo, inquegli anni Federico aveva imparato a riconoscere chiaramente l’e-goismo e l’invidia, l’ipocrisia e la viltà nelle azioni degli uomini, e per-sino l’astuzia e la crudeltà. Di fronte a queste bassezze occorreva ce-lare la propria ambizione: «et Le Moyein de Cacher son ambition se-crete est d’affecter des sentiments passifiques jusqu’au Moment favo-rable ou lon peut deployer Ses Vues secrettes»29. La questione moralerimaneva tuttavia immutata: un principe aveva il diritto di ingannaregli altri reggenti?30 Ovviamente un posto predominante è occupatodalle riflessioni sulle questioni militari e sulla politica delle alleanze31.
L’ultima tappa delle guerre per la successione sul trono austriacoche avevano coinvolto l’Europa intera, la cosiddetta Guerra dei Setteanni, aveva indebolito straordinariamente la Prussia. Quella guerrarientrava tra le esperienze più significative di Federico, e lo avrebbelegato inscindibilmente, anche in futuro, alla Russia. Da quell’espe-rienza Federico aveva anzi capito che sarebbe stato opportuno strin-gere ulteriormente l’alleanza tra i due paesi; ma occorreva attendereuna circostanza opportuna32. Chi non sa pazientare e non dà mostradi modération non giungerà mai alle vette dell’arte politica. Al tempola situazione era difficile da prevedere, poiché «Je Vois partout desprincipes de changemens»33.
Otto anni più tardi Federico scriveva il suo Exposé du Gouver-nement Prussien, des Principes sur Lequel[s] il roulle, avec quelquesReflextions Politiques (1776). L’alleanza con la Russia, così vi si leg-geva, gli stava a cuore come mai prima. La Zarina avrebbe potutoprocurare i danni peggiori ai territori orientali del suo regno. Ma dinuovo Federico tornava ad affermare che i tempi avrebbero potutocambiare e condurre ad altre alleanze. Occorreva comunque tenereaccuratamente celati i propri progetti ambiziosi: «Un Village sur La
29 Die politischen Testamente der Hohenzollern, cit., p. 652.30 Nel secondo Testament politique Federico formula le sue idee in maniera tal-
mente inequivocabile che la monarchia degli Hohenzollern ne proibì la pubblicazionefino alla fine.
31 B.R. Kroener, «Eine Armee, die sich ihren Staat geschaffen hat?», Militär-monarchie und Militarismus, in Friedrich der Große in Europa, cit., II, pp. 233-49.
32 Die politischen Testamente der Hohenzollern, cit., p. 648.33 Ivi, p. 682.
lo spirito dell’illuminismo e la politica 9
frontiere Vaut mieux qu’une principauté a 60 Lieux. C’est une At-tention necessaire de cacher autant quil est possible Ses Desseins d’am-bition […]. Le Segret est une Vertu Essencielle pour La politique aussibien que pour L’art de la Guerre»34.
Federico non afferma in nessuno dei suo scritti che la politica el’ambito politico in generale si esauriscono in una pura azione di go-verno; essi coinvolgono piuttosto un insieme di questioni che si pos-sono individuare in cinque ambiti principali: la gestione interna («Dela politique intérieure»), il quadro del sistema politico europeo nel suocomplesso («De la politique extérieure»), la giustizia, la finanza e l’e-sercito.
34 Ivi, p. 706.
bernd sösemann10
Fig. 2 - Caricatura di John Lodge (1692-1774): The Polish Plumb-Cake, 1774.
Testament Diritto Finanza Politica interna Politica estera Esercito Quota
1752 1 22 12 42 23 %1768 a stento 1 19 12 35 33 %
Le proporzioni sono inequivocabili: soltanto due pagine del Te-stament politique del 1752 concernono questioni relative all’ordina-mento giuridico appena introdotto. Seguono, quanto allo spazio cheoccupano, le finanze e l’esercito in misura pressoché uguale. La poli-tica estera è tre volte e mezzo più presente della politica interna. Que-sta partizione di massima rivela quale fosse in realtà l’interesse prin-cipale di Federico, e rispecchia al contempo le sue preoccupazioni piùurgenti. Il confronto quantitativo dei due Testaments politiques rivelai seguenti cambiamenti: l’opera cresce, nel 1768, del 17%; l’ordine te-matico muta anche nel senso che le considerazioni militari vengonoespunte dalla parte sulla politica estera e vengono accostate a quellesulle finanze; le considerazioni sul diritto vengono ridotte allo 0,8%,mentre quelle sulle finanze sono limitate al 19%, e la politica internamantiene comunque lo spazio che aveva nel 1752; l’attenzione per lequestioni militari cresce notevolmente dopo l’esperienza delle tre guerredella Slesia fino a occupare un terzo del Testament politique; le con-siderazioni di politica estera si riducono di un terzo.
Il confronto qualitativo tra i due Testaments offre il seguente qua-dro d’insieme: né questi scritti né gli altri trattati di Federico sem-brano fondarsi sul progetto teorico di un illuminista, di un ‘principeilluminato’. Nettamente predominanti sono le considerazioni legate asituazioni concrete, in cui il governo e la responsabilità vengono vi-ste dalla prospettiva di un sovrano assoluto. Federico vedeva una con-nessione diretta tra le azioni e le meditazioni, indipendentemente dalfatto che si trattasse di suggestioni di tipo religioso o filosofico35. Leconcezioni di Federico non rimanevano mai su un piano puramenteformale, ma lo conducevano sempre, grazie a riflessioni pragmatichee finalizzate a uno scopo preciso, a rivendicare il suo senso di re-sponsabilità. Nello scritto De la politique intérieur egli aspirava conla «docile madre tolleranza» a un «bonum Commune», a una felicità
35 M. Kerautret, Religiöse Toleranz oder philosophische Indifferenz, in Friedrichder Große in Europa, cit., II, pp. 47-66; R. Nürnberger, Friedrich der Große alsStaatsmann, Hannover, Niedersächsische Landeszentrale für Politische Bildung, 1986,p. 6 (riveduto con il titolo Friedrich der Große. Réflexiones sur Charles XII, in Spie-gel der Geschichte. Festgabe für Max Braubach, a cura di K. Repgen e S. Skalweit,Münster, Aschendorff, 1964, pp. 590-601).
lo spirito dell’illuminismo e la politica 11
generale. Nel 1752 scriveva, a proposito del cattolicesimo, di auspi-care un’amicizia con il Papa e di collocarsi in una posizione neutraletra Roma e Ginevra. Nel 1768 le sue considerazioni assumevano untono decisamente più superficiale e si infarcivano di frasi fatte: se siaffrontano con rigore le continue ostilità non si perviene a conflitti.In una politica interna «felice» rientrava in massima misura, secondoFederico, tanto la colonizzazione interna quanto l’amministrazione deiterritori, dei domini e dei depositi. Oltre a ciò egli si occupava ab-bondantemente di politica sanitaria, demografica e migratoria, nonchédi politica dei traffici, dei commerci, del lavoro, di politica culturalee delle istituzioni preposte all’insegnamento, del controllo delle noti-zie e di politica della stampa e della censura. Esattamente secondo l’i-dea della letteratura cameralistica, tutte le istituzioni giuridiche, statalie militari dovevano curarsi collettivamente e di comune accordo dellasicurezza del paese. La polizia («Policey») non era dunque innanzi-tutto preposta a combattere i crimini, ma alla promozione di una con-dotta decorosa («das betragen») e di una certa agiatezza («die be-quemlichkeit»). Tutt’al più i cosiddetti Kreisausreiter (guardie a ca-vallo) e gli ispettori di polizia si preoccupavano dell’«ordine», vale adire del rifornimento sufficiente di generi alimentari e del benesserecollettivo36.
Dal momento che Federico destinava una grande parte dell’atti-vità amministrativa alla gestione complessiva delle entrate e delle uscitedello Stato, sembra evidente che egli guardasse alla politique da un’u-nica prospettiva. Incrementando tutte le risorse di cui disponeva il so-vrano, essa era pensata come strumento al servizio delle sue decisioni.La politique non era però concepita in vista di una generica salva-guardia della sovranità; essa doveva invece occuparsi concretamente,all’interno dello Stato, della conservazione del privilegio dell’autono-mia decisionale del sovrano contro le continue richieste di coopera-zione. Federico riteneva che per questo fine vi fossero mezzi eccel-lenti: la forte centralizzazione dei procedimenti amministrativi e laconcentrazione e razionalizzazione della sua propria autorità. In que-sto modo egli contrapponeva un’«autentica» e una «falsa» politica.
A tale scopo nei Testaments politiques Federico passava in rasse-gna l’intero spettro delle attività del sovrano. Nel De la politique inté-rieure analizzava in maniera sistematica alcune parole chiave: nobiltà,
36 Cfr. Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialenSprache in Deutschland, a cura di O. Brunner et al., IV, Stuttgart, Klett-Cotta, 1978,p. 836 e p. 885.
bernd sösemann12
città, cittadino, contadino, ecclesiastico e, d’un tratto, «les princes desang». Seguivano temi più generali, come la munificenza del principe,l’autocrazia e il suo impegno personale nel governo; oppure questioniparticolari relative all’allestimento del cerimoniale di corte. In gene-rale Federico nutriva una concezione ideale del sovrano in netto con-trasto con la visione machiavelliana della politica come «arte del buongoverno tirannico». Nel far ciò si ispirava ai principi fondamentali chegli enciclopedisti francesi avevano dichiarato essere i criteri distintividi un agire politico razionale. Nei suoi scritti politici principali redattidopo il 1742 il sovrano si concedeva riserve non irrilevanti rispetto aquanto aveva sostenuto nell’Antimachiavel37. Dopo le prime due guerredi Slesia Federico aveva trasformato il concetto un tempo astratto dipolitique in un vero e proprio concetto di politica reale38. Esso pre-vedeva due obiettivi: l’ampliamento territoriale e l’incremento della si-curezza complessiva del regno, vale a dire sociale, finanziaria e mili-tare. Quale fosse il grande valore che Federico riconosceva a questidue obiettivi emerge chiaramente dal Testament politique del 1768. Sitratta dell’esigenza irrefrenabile di preservarsi da qualsiasi eventualitàe di predisporsi alla ponderazione oggettiva delle diverse maniere incui potevano evolvere le diverse situazioni; la parola d’ordine era«toujours en vedette».
Al di là di qualsiasi questione morale, la sicurezza e l’affermazioneduratura del potere divennero per Federico le priorità somme. Nellapolitica interna si trattava pertanto di assicurare allo Stato le risorsenecessarie: la ripresa dei commerci, l’ordine delle finanze e la potenzadell’esercito. Per questa ragione la nobiltà meritevole e devota, zelantee compiaciuta (la nobiltà respectable) doveva godere di una protezioneparticolare da parte del sovrano39. E infatti Federico ne rafforzò lospirito di corpo dispensando benefici, privilegi e onorificenze. Agli uf-
37 «Machiavelli corrompit la politique, et entreprenait de détruire les préceptesde la saine morale. […] J’ai toujours regardé le Prince de Machiavel comme un desouvrages les plus dangereux qui se soient répandus dans le monde», L’Antimachia-vel ou Réfutation du Prince de Machiavel, cit., p. 46.
38 Rispetto all’inconciliabilità delle brame di potere con l’immagine di un sovranomoderato e riflessivo, vale a dire rispetto al tentativo compiuto da Federico di con-ciliare su un piano superiore le idee illuministico-umanitarie con gli «istinti agonali»cfr. J. Schumpeter, Zur Soziologie der Imperialismen (1919), in Id., Aufsätze zur So-ziologie, Tübingen, Mohr, 1953, pp. 72-146, nonché T. Schieder, Friedrich der Große,cit., pp. 102-26.
39 G. Birtsch, Zur sozialen und politischen Rolle des deutschen, vornehmlichpreußischen Adels am Ende des 18. Jahrhunderts, in Der Adel vor der Revolution, acura di R. Vierhaus, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1971, pp. 77-95.
lo spirito dell’illuminismo e la politica 13
ficiali nobili – la borghesia otteneva quel grado solo in guerra – do-veva venir inculcato il convincimento che tutti loro erano innanzituttodei prussiani e che dovevano agire di conseguenza, a prescindere dallaloro provenienza effettiva. Come misure di protezione di fronte alleaggressioni esterne Federico prediligeva i mezzi tradizionali, quindi lealleanze e le coalizioni. Al contempo ammoniva continuamente i suoisuccessori affinché non si abbandonassero alla fiducia eccessiva o aforme di confidenza inopportuna. Ogni Stato persegue i suoi propriinteressi, che nel corso del tempo possono anche mutare. Il principiodella rispondenza al fine orienta sia le massime d’azione, sia la sceltadei mezzi politici adeguati. Pur procedendo sulla base di questi pre-supposti, occorre però tener ben presente che nell’ambito della poli-tique vige una legalità sua propria.
L’attore politico che persegua con rigore i propri interessi non puòvenir danneggiato dalla politique in maniera imprevista, e neppure nepuò venir deluso o gettato in disgrazia. In circostanze particolari, eper necessità, si possono rompere patti e alleanze. Qui l’autore del-l’Antimachiavel si accosta a un tipo di sovrano più orientato al mo-dello machiavellico: un sovrano disposto a rompere i patti, favorevolealla guerra privata e conquistatore. Le contraddizioni tra i principi cheFederico professava e la sua azione effettiva emergono nella manierapiù nitida nell’ambito del diritto. Mi limiterò a tre esempi.
Nonostante i suoi principi, nel caso Müller-Arnold il sovrano sioppose al tribunale supremo non soltanto rivendicando fermamentela propria autorità (che pure gli spettava in quanto sovrano), ma vio-lando l’indipendenza dei giudici. Di contro, nel processo contro Katte,suo padre non aveva mai neppure preso in considerazione l’idea dimanipolare il procedimento giudiziario, di mettere in discussione l’in-dipendenza del tribunale o di sanzionare e incarcerare i giudici cheavevano espresso un parere a lui contrario. Federico, invece, rompevapatti, alleanze e coalizioni, e imbrogliava ripetutamente alleati e amici,a cominciare dalla doppia rottura del trattato di Nymphenburg finoallo scioglimento (che non fu certo l’ultimo) dei patti prussiano-fran-cesi.
Federico era poi incoerente anche rispetto al controllo sulla stampae sull’informazione. La prassi della censura mostra nel corso dei de-cenni un quadro assolutamente disomogeneo. La libertà di stampa ela soppressione della censura nella sfera pubblica annunciata al tempodella sua ascesa al trono avevano avuto un valore solo temporaneo.L’«editto per il ripristino della censura» del 1749 risparmiava la Sle-sia. La circolare per la «censura dei libri e degli scritti che verranno
bernd sösemann14
pubblicati» del 1772 non riguardava né la Slesia né la Pomerania. Nelsuo 35esimo anno di governo (1775) un rescritto estese il controllo atutti i territori prussiani. Soltanto l’Accademia e i Collegi dei medicicontinuavano a rimanere esenti da censura. Di fatto però non tuttoquel che era previsto dall’editto veniva poi realmente sottoposto acontrollo. E ciò, per la semplice ragione che l’ufficio superiore pre-posto alla censura pativa una carenza di personale, e in generale mo-strava somma negligenza nell’impiego degli addetti ai controlli40. Leautorità supreme competenti erano del tutto disinteressate a una ri-gida censura, in sintonia con i principi illuministici da tempo ormaiassai popolari. Ai viaggiatori stranieri – come lo scozzese affiliato dellamassoneria, il futuro Generale John Moore – saltava agli occhi la non-curanza con cui i comuni passanti criticavano confronti delle dispo-sizioni del governo e persino le misure disposte dal sovrano. Era per-sino possibile, osservava Moore, acquistare libercoli in cui il sovranoera fatto oggetto delle satire più sprezzanti41.
Parimenti discontinue erano anche le misure riformatrici di Fede-rico. Prediligevano la regione del Brandeburgo e trascuravano vastezone a oriente. Non applicavano il sistema di reclutamento unilate-rale basato sui cantoni in ogni territorio occidentale. La Slesia, go-dendo dello stato di «zona a gestione speciale»42 e di un proprio Mi-nistro provinciale della giustizia assai prominente, possedeva un si-stema giuridico autonomo rispetto a quello del resto del regno. Solodi rado le istituzioni che operavano intralciandosi a vicenda, venneroriorganizzate nelle loro sfere di competenza. Federico non si curòneppure del numero crescente di banche che sorgevano l’una accantoall’altra. L’impressione che si ricava dai suoi Testaments politiques –ossia che egli favorisse uno stile di governo chiaro e trasparente – erasmentita dai fatti. I ministeri cruciali e il direttorio generale perserola loro influenza, mentre le amministrazioni provinciali incrementa-rono le loro competenze. Il monarca prediligeva una forma di co-municazione personale, diretta e segreta. Il sistema collegiale seguitoda suo padre venne abbandonato a favore di un governo con un ga-binetto di segretari composto di assai poche persone fidate. Ancorché
40 Per questa ragione nell’ultimo lustro del regno di Federico molti libri di ar-gomento filosofico e di scienza naturale ed economica rimasero al riparo dalla cen-sura.
41 C. Clark, Preußen. Aufstieg und Niedergang 1600-1947, München, Pantheon,2006, pp. 303 ss.
42 K. Berndl, Ernst Ferdinand Klein (1743-1810). Ein Zeitbild aus der zweitenHälfte des 18. Jahrhunderts, Münster, LIT Verlag, 2004, p. 218.
lo spirito dell’illuminismo e la politica 15
le misure della gestione quotidiana si complicassero enormemente nelcorso degli anni, Federico continuò a riservare per sé la gran partedelle decisioni.
È fuori di dubbio che Federico esercitasse un potere assoluto; piùdubbia risulta invece la possibilità di considerarlo un illuminista toutcourt. Senz’altro le idee dell’Illuminismo ne hanno in larga parte in-fluenzato le riflessioni e l’operato. Egli stesso riconosceva d’altra partela necessità di imporre un limite alla propria volontà organizzatrice eriformatrice. Doveva scendere a compromessi: non intendeva infatti de-molire la base feudale della sovranità assoluta, ovvero l’organizzazionedella società in ceti, la posizione privilegiata della nobiltà e il ruolo diprimo piano rivestito dall’esercito. Una realizzazione ampia, sistema-tica e coerente delle idee illuministiche avrebbe invece condotto, sia inPrussia sia in altri Stati, al sovvertimento dell’Ancien régime43. Lo spa-zio per una realizzazione anche solo accennata dei diritti dell’uomo edegli ideali dell’umanità era quindi angusto. Soltanto nei discorsi in-cauti pronunciati al desco e assolutamente lontani dalle orecchie delpubblico era consentito discutere di principi, di religione, di morale,di fede, del ruolo sociale dell’uomo e della donna, o della libertà delvolere44. Federico proibiva però qualsiasi critica al suo operato poli-tico. Se il discorso si appropinquava alla questione, egli diveniva ta-gliente, ironico e non di rado offensivo. Quando Voltaire diede segnodi non volersi attenere a questa disposizione, il sovrano lo rimproveròduramente nella maniera che si confà a chi detiene il potere assoluto,ricordandogli altresì il suo rango di cortigiano45. In questo senso Fe-derico rimane un rappresentante dell’Ancien régime.
43 Anche dalla corrispondenza letteraria di Melchior Grimm, che circolava intutte le corti europee, emerge questa preoccupazione, così come dallo scambio epi-stolare infarcito di idee illuministiche che Federico intratteneva con Voltaire. Fede-rico riceve la corrispondenza dal 1763, Caterina la Grande dal 1764 (Correspondanceprivée de Frédéric-Melchior Grimm 1723-1807, a cura di J. Schlobach, Genève, Slatkine,2009). La corrispondenza di Federico con Voltaire si protrae, con qualche interru-zione, per tutta la vita del sovrano; dopo il 1763 Caterina la Grande intrattiene percirca quindici anni uno scambio epistolare con Voltaire (Katharina die Große / Vol-taire. Monsieur – Madame. Der Briefwechsel zwischen der Zarin und dem Philo-sophen, a cura di H. Schumann, Zürich, Manesse-Verlag, 1991). Federico rappresen-tava per Caterina il modello del sovrano illuminato e illuminista: ammirava l’attivi-smo, la volontà organizzatrice e lo spirito dinamico del monarca prussiano.
44 Se alcuni interlocutori volevano comunque esprimere le loro riflessioni, la cen-sura glielo impediva. Gli stessi membri dell’Accademia dovevano servirsi dei circuiticlandestini per far circolare le loro pubblicazioni su questi temi.
45 B. Sösemann, Monarchen als Moderatoren aufklärerischer Vorstellungen und
bernd sösemann16
Federico riteneva che il Sacro Romano Impero e la sua costitu-zione fossero obsoleti, stravaganti e bizzarri. Non lo reputava unagrandezza degna di divenire oggetto di attenzione. La sua Prussia sisarebbe mantenuta intatta grazie all’invidia dei principi e delle potenzevicine, ma il numero dei piccoli principati e delle città del regno scemòprogressivamente (1752). Dopo il 1746 – l’anno in cui il sovrano ri-nunciò a imporre il rispetto delle decisioni imperiali nel regno – Fe-derico aveva ritenuto superflui molti interventi nella politica dell’Im-pero da parte della Prussia. La stessa campagna del 1787/88 non avevaassunto la portata di una guerra secondo i vecchi parametri. Il sistemadel regno era ormai per Federico un mulo esanime, incapace ormaidi reggere alcun carico.
Tento ora di presentare una sintesi di quanto detto e di affrontarela questione relativa all’effettiva portata storica e interpretativa che ri-siede nei due concetti centrali di «politica» e di «Illuminismo».
La prassi di governo di Federico si muoveva entro una cornice diidee e di concezioni illuministiche. L’elemento illuministico si espressenella prassi politica in più occasioni: nella ampia soppressione dellatortura, nell’aver richiamato a Halle il filosofo Christian Wolff con-dannato all’esilio da Federico Guglielmo I, nei proclami a favore dellatolleranza, nella codifica e nella garanzia del dibattimento giudiziario,nonché nei tentativi risoluti di coniugare la sovranità e la dimensionespirituale sotto la volta delle idee illuministiche, e promuovendonenuovi ampi sviluppi. Gli effetti delle iniziative intraprese nell’ambitodell’istruzione pubblica si percepirono chiaramente solo nel corso delsecolo successivo46. L’istruzione divenne un compito dello Stato. Daallora la responsabilità dell’istruzione elementare e delle formazionedegli insegnanti prese a ricadere sull’amministrazione pubblica, cosìcome l’educazione musicale in tutto il Paese – il che rispondeva a unparticolare interesse di Federico. Voltaire47, Kant e gli illuministi ber-
Forderungen in Europa. Zum Selbstverständnis von Friedrich II. und Katharina II.als philosophes, in Wo bleibt die Aufklärung? Aufklärerische Diskurse in der Post-moderne. Festschrift für Thomas Stamm-Kuhlmann, a cura di L. Güth, Stuttgart, Stei-ner, 2013, pp. 37-56: p. 47.
46 Christopher Clark rimanda al patrimonio di idee illuministiche che circolavanelle scuole dei magistrati e menziona a titolo di esempio il caso di Neuruppin, cfr.C. Clark, Preußen, cit., p. 189 (manca l’indicazione delle fonti).
47 Voltaire aveva già celebrato il principe reggente come «un principe filosofo,che renderà felici gli uomini […] Non vi è principe che nutra una simile volontà diriportare i propri Stati all’età dell’oro […] un giorno […] sarete osannato dai Vostripopoli e lodato nel mondo intero» (Katharina die Große / Voltaire, cit., pp. 13 ss.
lo spirito dell’illuminismo e la politica 17
linesi48 lo celebrarono per questo suo impegno. E lo fecero con l’o-biettivo, espresso con cautela, di considerare ciò che idealmente spe-ravano di veder realizzato come una conseguenza di quel che già erastato fatto. Ciò rivela – sotto la pressione della censura – una formasottile di costrizione esercitata dagli intellettuali.
Agli occhi del pubblico interessato alle questioni di Stato, l’ope-rato di Federico soddisfaceva appieno l’immagine della «politica». Isudditi concepivano che il loro servizio nei confronti del sovrano sifondeva con quello nei confronti dello Stato. Federico vedeva nelloStato il destinatario del suo operare: considerava un proprio dovere,da quando aveva letto Christian Wolff e Pierre Bayle, lavorare per ilbene di tutti. Si ispirava alla morale illuministica, a un «universalismo»piuttosto «astratto» (Friedrich Meinecke)49. E, infine, anch’egli credevaal progresso del genere umano così come concepito da Voltaire, e al«potenziamento superiore» (Leopold von Ranke) della cultura e dellaciviltà. Dietro a coloro i quali rivestivano uffici pubblici nella città enel Paese si stagliava la figura patriarcale di Federico. Nessun Hohen-zoller prima di allora aveva mai goduto di un’immagine simile a quelladi Federico né mai aveva svolto in maniera tanto risoluta la sua fun-zione esemplare e assunto quindi un atteggiamento altrettanto netto.Al contempo egli limitò drasticamente le convenzioni, il cerimonialee il culto della sua persona50. Non mancava tuttavia l’elemento di rap-presentanza della politica. Ma Federico si sforzava di non ostentarlonel rituale che accompagnava le sue apparizioni pubbliche e la suapersona in generale; esso traspariva invece in maniera piuttosto astrattadalla cultura giuridica e dall’architettura di Berlino e soprattutto diPotsdam51.
(lettera del settembre 1736). Nel febbraio del 1737 Voltaire apostrofava Federico comela sua «terra promessa» (ivi, p. 38) e il 20 dicembre del medesimo anno lo chiamava«il giovane Salomone del Nord» (ivi, p. 80).
48 Cfr. Berliner Aufklärung. Kulturwissenschaftliche Studien, a cura di U. Gol-denbaum e A. Kozenina, II, Hannover-Laatzen, Wehrhahn, 2003.
49 F. Meinecke, Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte, a cura di W.Hofer, München, Oldenbourg, 19602, pp. 345-47; quel che segue è tratto dai discorsidi Ranke per il re Massimiliano II di Baviera (1854), cfr. L. von Ranke, Über dieEpochen der neueren Geschichte. Historisch-kritische Ausgabe, a cura di T. Schiedere H. Berding, München-Leipzig, Duncker & Humblot, 1971, pp. 58-62.
50 Cfr. B. Stollberg-Rilinger, Offenbare Formlosigkeit? Der Stilwandel des di-plomatischen Zeremoniells, in Friedrich der Große in Europa, cit., I, pp. 354-71.
51 «Il sovrano non è innalzato a una condizione superiore e non gli si ricono-sce la somma autorità affinché egli trascini la propria esistenza in maniera negligentee svogliata, affinché parassiti il suo popolo e viva felice mentre tutto intorno si tra-
bernd sösemann18
Il castello di Sanssouci, con la sua tavola rotonda divenuta prestoleggendaria, assunse le forme di una Babele del peccato. La corte eraconsiderata il luogo non cristiano di un libertinismo francofilo. Nonveniva affatto vista come il luogo in cui si discorreva seriamente deifondamenti sociali, giuridici e morali dello Stato assoluto o del suoordine duraturo. Ma proprio qui, tra i salotti letterari e le disquisi-zioni nella cerchia di intimi frequentatori, Federico raggiunse una co-noscenza e una verità che esulava da ogni spiegazione tradizionale insenso teologico e religioso. A Potsdam egli trovò ispirazione per orien-tarsi nelle questioni che gli stavano a cuore: la guerra e la pace, o lalegge, il dominio e la libertà52. Indubbiamente le idee illuministichediscusse a Potsdam si riflettevano sull’agire politico53. Ma molto spessoil monarca scendeva a compromessi, abbandonava le idee illuministi-che, rompeva patti, alleanze e coalizioni, ingannava ripetutamente glialleati e persino gli amici. Per Federico nessun titolo giuridico potevarivendicare un’assoluta legittimità, come si legge nell’Antimachiavel:«J’avoue, d’ailleurs, qu’il y a des nécessités fâcheuses où un prince nesaurait s’empecher de rompre ses traités et ses alliances»54. La preoc-cupazione di garantire «il benessere del proprio popolo» poteva ren-dere doverosa una violazione del diritto55.
Le osservazioni autocritiche del monarca prussiano si devono auna forma di scetticismo che si rafforzò con l’avanzare dell’età. Neilavori sulla vita di Carlo XII di Svezia, che lo occuparono per moltianni, si incontrano di frequente chiari segni di una riflessione auto-critica. Richard Nürnberger osserva che per Federico il confronto traKunersdorf e Poltava era del tutto ovvio56. L’ammirazione per CarloXII, come condottiero militare – una figura di un’audacia temeraria(audace téméraire), di grande valore e determinazione – non poteva
scina in stenti. Il sovrano è il primo servitore (Diener) dello Stato. Viene ben retri-buito affinché preservi la dignità della sua posizione. Ma si pretende che lavori inmaniera attiva per il bene dello stato e che conduca almeno gli affari principali concoscienziosità» (Die politischen Testamente der Hohenzollern, cit., p. 329). Cfr. l’am-pia panoramica presentata da M. Engel, Architektur und Bauherrschaft, in Friedrichder Große in Europa, cit., I, pp. 260-92.
52 U.P. Jauch, Annotationen zu den Asylanten, Querdenkern und Avantgardis -ten in der «Tafelrunde». Die Gemeinschaft der Epikureer zu Sanssouci, in Friedrichder Große in Europa, cit., I, pp. 68-111.
53 B. Wehinger, Der Intellektuelle auf dem Thron und die République des let-tres, in Friedrich der Große in Europa, cit., I, pp. 182-95.
54 L’Antimachiavel ou Réfutation du Prince de Machiavel, cit., p. 178.55 T. Schieder, Friedrich der Große, cit., pp. 182-85.56 R. Nürnberger, Friedrich der Große als Staatsmann, cit., pp. 17 ss.
lo spirito dell’illuminismo e la politica 19
essere incondizionata, ma si accompagnava alla preoccupazione profondache i successi dipendessero esclusivamente da un «capriccio della for-tuna». Le considerazioni conclusive di un osservatore oggettivo – qualesi considerava Federico – dovevano tenere in conto ogni tratto del ca-rattere: «Je vais comparer, pour mon instruction, les règles que lesgrands maîtres de l’art nous ont laissés, avec la conduite que le Roitint durant ces deux campagnes»57. Tra questi rientravano la lungimi-ranza e l’avvedutezza nell’analisi della situazione complessiva – poli-tica e militare – dell’Europa, l’equilibrio nella pianificazione e la so-bria circospezione nell’esecuzione. Moderazione e coraggio («modé-ration et courage») dovevano andare a braccetto58. Così come dove-vano coniugarsi l’aspirazione alla gloria e la retta condotta: «Agisseztoujours vigoureusement et offensivement! Consultez les principes del’honneur et prenez toujours les partis les plus honorables à la na-tion. […] Vous n’êtes point au dessus de la fortune»59.
Le riflessioni di Federico sulla politica e sulla sovranità si fonda-vano in ultima istanza su due convinzioni ottimistiche. Per un verso,sull’idea che ancora alla metà del XVIII secolo potesse essere efficaceuna sovranità esercitata esclusivamente dal gabinetto del monarca. Sinin età avanzata Federico patì l’impossibilità che si faceva man manopiù evidente di tenere sotto controllo, da solo, tutte le ramificazionidella sua complessa struttura di gestione dello Stato. Alla fine deglianni Settanta fu costretto ad avvalersi del supporto di sei segretari pri-vati – il doppio di prima. Tuttavia, nonostante la sua grande capacitàdi lavoro, la sua grande intelligenza e la sua impressionante compe-tenza, era difficile cogliere in tutti i loro dettagli le oltre centomiladecisioni con cui si trovò ad avere a che fare. Ha ragione EckhartHellmuth quando parla di «uno squilibrio tra la pretesa di una so-vranità assoluta e la sua realizzazione effettiva nei singoli ambiti dellarealtà statale e sociale». Sul personale preposto all’amministrazione si
57 Qui e nel prosieguo cito da Friedrich der Große, Réflexions sur les talentsmilitaires et sur le caractère de Charles XII, roi de Suède, in J. Kunisch (a cura di),Aufklärung und Kriegserfahrung. Klassische Zeitzeugen zum Siebenjährigen Krieg,Frankfurt/Main, Deutscher Klassiker Verlag, 1996, pp. 547-86.
58 «La sagesse prépare les voies au courage, l’audace est réservée pour l’exécu-tion, et il faut, pour être applaudi des connoisseurs, plus d’habilité encore que le for-tune», Friedrich der Große, Réflexions sur les talents militaires et sur le caractèrede Charles XII, roi de Suède, cit., p. 552.
59 Indirizzato al Generale Christoph von Dohna il 2 aprile 1758, in Œuvres deFrédéric le Grand, a cura di J.D. Erdmann Preuß, cit., voll. XVI-XXVII: Corre-spondance, XVI, Nr. 9887, p. 347
bernd sösemann20
riversava una marea di carte della burocrazia, e la furia crescente dicontrollo esercitata dal monarca agì alla fin fine come elemento para-lizzante60.
L’altra convinzione ottimistica alla base delle riflessioni di Fede-rico consisteva nel pensare che una monarchia ereditaria potesse perciò stesso assicurare la propria continuità: il dominio di un sovranoconsapevole dei proprio doveri, accorto nel pianificare la vita del suoStato e coerente nelle sue azioni61. Una siffatta potenzialità e un ana-logo spirito di servizio si trovano raramente persino nei governi re-pubblicani. La più ferma convinzione di Federico si condensava inciò: perseveranza, senso della giustizia e coraggio sono le caratteristi-che essenziali di un sovrano assoluto accorto e illuminato62. Tuttavial’idea che Federico nutriva dello Stato, della politica e dell’autorità digoverno non salvò la Prussia dai profondi sconvolgimenti transna-zionali che presero avvio dalla Rivoluzione francese, a una decinad’anni di distanza dalla sua morte. E, tutto questo, malgrado avessepenetrato profondamente le complesse questioni di diritto pubblico edi riorganizzazione amministrativa con la forza del suo intelletto eavesse colto i problemi e le questioni imposte dall’Illuminismo euro-peo.
Gli sforzi compiuti da Federico per creare un ordine pacifico sullungo periodo guardavano prevalentemente alla politica estera, e moltomeno alle condizioni interne della Prussia. Rispetto ai territori prus-siani egli si accontentava di soddisfare ampiamente i bisogni sociali edeconomici, trovando un compromesso tra i privilegi della nobiltà euna moderata accondiscendenza nei confronti delle richieste dei cetia partecipare alla vita politica63. La più chiara espressione di autocri-tica, in cui Federico denuncia un proprio fallimento parziale, si in-contra soltanto un quarto di secolo più tardi, nell’Histoire de montemps. In una considerazione preliminare che sembra andare in cerca
60 E. Hellmuth, Der Staat – Starker Leviathan oder Koloss auf tönernen Füßen,in Friedrich der Große in Europa, cit., II, pp. 20-32.
61 Un’analisi dettagliata in J. Kunisch, Friedrich der Große, Friedrich WilhelmII. und das Problem der dynastischen Kontinuität im Hause Hohenzollern, in Id.,Friedrich der Große in seiner Zeit. Essays, München, Beck, 2008, pp. 135-74.
62 Cfr. B. Preisendörfer, Staatsbildung als Königskunst. Ästhetik und Herrschaftim preußischen Absolutismus, Berlin, Akademie Verlag, 2000, pp. 67-82.
63 J. Garber, Spätabsolutismus und bürgerliche Gesellschaft. Studien zur deut-schen Staats- und Gesellschaftstheorie im Übergang zur Moderne, Frankfurt/Main,Keip, 1992, pp. 119-26, e B. Sösemann, Monarchen als Moderatoren aufklärerischerVorstellungen und Forderungen in Europa, cit., pp. 37-56.
lo spirito dell’illuminismo e la politica 21
di indulgenza da parte del lettore si osserva che quest’ultimo sapràprobabilmente distinguere il filosofo dal sovrano, il filosofo moraledal politico. Nelle riflessioni su Carlo XII Federico chiosava in sensoautocritico: «Avez vous pris pour vous même, grand critique, les leçonsque vous leur prodiguez si libéralement? Hélas! non, j’ai à faire à ceciqu’une reponse: Nous sommes frappés des fautes d’autrui, tandis quenos propre défautes nous échappent»64. Già prima della morte di Fe-derico cominciò la storia dei giudizi e delle leggende sulla sua per-sona65, così come quella delle valutazioni erronee e delle strumenta-lizzazioni66, fino alla mostra allestita a Potsdam nel 2012, l’«anno diFederico»67. Ma questo tema esula dagli obiettivi di questo contributo.
64 Friedrich der Große. Réflexiones sur Charles XII, cit., p. 186.65 Alla formazione di leggende assai pervicaci hanno contribuito le raccolte di
aneddoti pubblicate da Friedrich Nicolai tra il 1788 e il 1792. Nella seconda metàdel XIX secolo, le illustrazioni di Adolph Manzel della biografia di Federico redattada Franz Kugler resero popolare il grande sovrano. Questa biografia comparve al-lora in numerose edizioni economiche e continua a venir stampata ancor oggi (cfr.H. Kohle, Adolph Menzels Inszenierung des Herrschers in Franz Kuglers «Geschich -te Friedrichs des Großen», in Friedrich der Große in Europa – gefeiert und umstrit-ten, cit., pp. 95-111).
66 Cfr. B. Sösemann, «Leitgedanken» und «Instrumentalisierungen» von histori-schen Analogien. Sinnstiftungen in autoritären und diktatorialen Regimen, in Fried -rich der Große in Europa, cit., II, pp. 251-55 e pp. 345-83), nonché i contributi diI. Defflers, A. Pufelska, C. Liermann, A. von Schlachta, P. Bahners, R. Un-fer-Lukoschik e J. Angelow (cap. 6: «Wahrnehmungen und Instrumentalisierun-gen», ivi, pp. 256-344 e pp. 384-407), e C. Kretschmann, «Zerstörer» oder «Schöp-fer»? Österreichische Perspektiven zwischen Erster und Zweiter Republik, in Friedrichder Große in Europa – gefeiert und umstritten, cit., pp. 130-38, J.P. Bled, FriedrichII. und Frankreich, ivi, pp. 77-81, e B. Sösemann, Mit Friedrich siegen – vor Ver-dun! Die Befreiung von einem Trauma mit filmischen Mitteln, ivi, pp. 114-29.
67 Tra le stranezze della mostra spiccava il titolo bizzarro: «Friederisiko» – inqualche modo meraviglioso nella sua sciocca banalità e nel goffo tentativo di mante-nere le distanze. I curatori, Hartmut Dorgerloh e Jürgen Luh, si sforzarono di as-sumere un tono equanime, e tuttavia, nel loro giudizio su Federico, traspariva l’in-clinazione a moralizzarne le scelte e l’operato, ad accanirsi tanto sulle sue tipiche de-bolezze e sulle sue presunte mancanze, quanto sulle sue doti e sulle sue prestazionid’eccellenza, senza riuscire a comprendere il monarca nel contesto della storia euro-pea.
bernd sösemann22
Massimo Mori
FEDERICO II E LA CULTURA ILLUMINISTICA
1. Un Illuminismo del buon senso
Dai primi studi sulla sua figura all’abbondante messe di pubbli-cazioni occasionata dall’approssimarsi del tricentenario della nascita1,nella letteratura critica su Federico II ricorre costantemente il temadella contraddizione. Questa duplicità è talvolta considerata un trattoessenziale del personaggio, in parte espressione caratteriale, in parterisultato di vicende biografiche che, sin da giovane, lo inducono alladissimulazione2. Di qui la frattura tra il Roi-Philosophe e il Roi-Conné-table, tra l’autore dell’Anti-Machiavel e il conquistatore della Slesia,tra l’uomo privato e il principe, tra un esercizio letterario e filosoficocoltivato come divertimento e un’attività politica e militare perseguita
1 Cfr. ad esempio T. Bendikowski, Friedrich der Große, München, Bertelsmann,2010; si veda anche il suo saggio Der ewige König, in H. Kemper (a cura di), MythosFriedrich: Friedrich der Große, Reformer, Schöngeist, Kriegsherr: Leben und Nachle-ben des Preußenkönigs, Hamburg, Zeitverlag Bucerius, 2011, pp. 14-19. Anche J. Ku-nisch, Friedrich der Große, München, Beck, 20112 (2004), pur concentrandosi sugliaspetti politico-militari, riconosce le contraddizioni che essi presentano con le attivitàculturali del re. Un po’ sbrigativamente J. Luh, Der Große. Friedrich II. von Preußen,Berlin, Siedler, 2011, risolve il problema dell’ambivalenza con la tesi che l’unico obiet-tivo di Federico era la ricerca della fama e della grandezza, in qualsiasi attività si spe-rimentasse. Il tema della contraddittorietà ritorna anche in lavori più divulgativi, comeK.-H. Otto, Friedrich II.: Der Philosoph von Sanssouci, Potsdam, Märkische Reise-bilder, 2011. Da un particolare punto di vista la relazione tra l’uomo di cultura e ilsovrano è stata recentemente analizzata da S. Henze-Döhring, Friedrich der Große– Musiker und Monarch, München, Beck, 2012, dove l’amore per la musica e l’atti-vità guerresca vengono tuttavia considerate come «un’unità inseparabile» (p. 14). Unaconsiderazione complessiva della molteplicità della personalità di Federico è offertadal recente volume B. Sösemann (a cura di), Friedrich der Große in Europa – ge-feiert und umstritten, Stuttgart, Steiner, 2012.
2 Cfr. ad esempio T. Schieder, Friedrich der Große, Frankfurt/Main, Propyläen,1983, trad it. Federico il Grande, Torino, Einaudi, 1989, pp. 27-28.
come dovere. In qualunque modo venga declinata questa contraddi-zione, la pietra di paragone per valutarla è il rapporto di Federico conla cultura illuministica. L’Illuminismo sembra infatti esprimere preci-samente ciò che il re celebra a parole e diserta nei fatti. Da un latorazionalità, fiducia nel progresso, pacifismo, cosmopolitismo; dall’al-tro pragmatismo politico, scarsa considerazione dell’umanità, fiera con-duzione della guerra, difesa della ragion di Stato3.
In quest’immagine tradizionale di Federico c’è sicuramente qual-cosa di vero. Le sue declamazioni sulla vanità di tutte le cose sonodi solito espressione più di un esercizio letterario che di una convin-zione personale. In un’epoca in cui il valore delle composizioni poe-tiche non è misurato dalla profondità dell’ispirazione, ma dal rispettoformale delle regole metriche, appariva legittimo proporre contenutiletterari nei quali, nel migliore dei casi, prevaleva l’intellettualismo e,nel peggiore, ritornavano senza originalità motivi convenzionali. Masoprattutto c’è certamente in Federico la consapevolezza del dupliceruolo a cui egli è chiamato, ora come uomo che intende dedicarsi allafilosofia, ora come sovrano che deve difendere gli interessi del suopaese. Già nel 1737, nel ritiro del castello di Rheinsberg, il giovaneprincipe dice che, se non fosse impedito dal suo ruolo, andrebbe aCirey per fare il filosofo accanto a Voltaire4. Nel 1742, verso la finedella prima guerra di Slesia, egli assicura di rimpiangere Rheinsberg eche nulla è cambiato nel suo temperamento: «mais il faut se plier àson état dans le monde, et se faire un plaisir de son devoir»5. Nel1757, durante la guerra dei Sette Anni, a Voltaire che gli rimproveradi non ricercare la pace Federico risponde che se fosse anch’egli unprivato cittadino (particulier) non cercherebbe la gloria del mondo,ma – aggiunge – «notre état fait notre loi», obbligando a fare «cequ’exige notre emploi». Voltaire, nel suo eremo, può dedicarsi alla fi-losofia, ma lui, Federico, minacciato di naufragio per se stesso e peril proprio Stato, deve «penser, vivre et mourir en roi»6.
3 Cfr. ancora T. Schieder, Friedrich der Große, p. 86: «In Federico il sovranodell’Illuminismo e lo schietto propugnatore di una pura politica di potenza si con-trappongono come grandezze del tutto inconciliabili e che non possono in alcunmodo identificarsi tra loro. Questa inconciliabilità e il dilemma che essa propone dicontinuo sono il problema di fondo della personalità di Federico».
4 Lettera a Voltaire del 9.5.1737, XXI, in Œuvres de Frédéric le Grand, Berlin,Decker, 1846-1857, p. 67. D’ora in avanti le Œuvres verranno citate semplicementecon l’indicazione del volume e della pagina di quest’edizione.
5 Lettera a Voltaire del 12.4. 1742, XXII, p. 103.6 Lettera a Voltaire del 9.10.1757, XXIII, p. 16. Cfr. anche l’Epître sur la mé-
massimo mori24
Malgrado queste innegabili tensioni, tuttavia, il contrasto si atte-nua di molto, se si considera che l’Illuminismo di Federico, per quantoriguarda le sue fonti, il suo evolversi, il suo adattarsi alle situazioni,è un Illuminismo sui generis, piuttosto debole nella strutturazione con-cettuale e pensato prevalentemente in funzione dell’attività pratica. Piùvolte Federico protesta di essere un dilettante, e forse occorre pren-dere questa ammissione più sul serio di quanto non la prendesse eglistesso7. Il suo Illuminismo non può essere compreso pienamente senon viene inserito nella cornice di una Weltanschauung più ampia, incui convergono filosofia e buon senso, riflessione concettuale e vitaquotidiana. Anche questa più generica concezione del mondo si nu-tre tuttavia di elementi filosofici, in particolare di quelle tradizionistoica ed epicurea che, non a caso, erano state ampiamente rivalutatedalla cultura illuministica e che facevano parte del bagaglio culturaledi ogni persona istruita. Ma anche su questo punto le fonti di Fede-rico non sono sempre solide. Per quanto riguarda lo stoicismo apparepiuttosto scolastico il frequente riferimento a Zenone di Cizio, da luiperaltro confuso con Zenone di Elea8. Dello stoicismo più tardo diCicerone, Seneca, Epitteto e soprattutto Marcaurelio – che compren-sibilmente Federico considera il suo «eroe» e il suo «modello»9 – egliha invece conoscenza diretta, seppure in traduzione latina: benevol-mente d’Alembert si sentirà in dovere di correggere il suo augustocorrispondente quando questi si riferirà a Epitteto e Marcaurelio comead «autori latini»10. Anche per quanto riguarda l’epicureismo le cose
chanceté des hommes (1761): «Ennemi declaré de leur [dei re] culte idolâtre, / je pa-rus malgré moi sur le même theâtre; / Le hazard, qui nous place ici-bas à son choix,/ Voulu qu’un philosophe eût le sceptre des rois» (XII, p. 199).
7 Cfr. lettera a Voltaire dell’1.5.1960, XXIII, p. 91; lettera a d’Alembert del1.11.1970, XXIV, p. 563; lettera a Voltaire del 4.4.1773, XXIII, p. 277; lettera a d’A-lembert del 24.2.1781, XXV, p. 195.
8 Lettera a d’Alembert del 30.12.1775, XXV, p. 38.9 Épître au Marèchal Keith. Sur les vaines terreurs de la mort et les frayeurs
d’une autre vie (1750), X, p. 237.10 Nella lettera del 9.2.1781, commentando il saggio De la littérature allemande,
che Federico gli aveva inviato, d’Alembert osserva che questa è l’unica piccola mendariscontrata nell’opera. Generosamente egli tenta di giustificare Federico, dicendo che«senza dubbio Vostra Maestà non ha voluto riferirsi che alle opere tradotte, che sonodel resto state scritte a Roma, per cui possono in qualche modo essere consideratecome appartenenti ai Latini; infatti Vostra Maestà non ignora certamente che gli ori-ginali di queste opere sono in greco» (XXV, p. 193). Ma se si considera il testo diFederico, si vede che l’«equivoco», che d’Alembert raccomanda di eliminare dalle suc-cessive edizioni, era sostanziale. Dopo aver sostenuto l’importanza delle traduzioni
federico ii e la cultura illuministica 25
non vanno meglio: l’opera di Epicuro, che è poco più di un vago ri-ferimento, giunge a Federico non certo attraverso i frammenti tra-mandati da Diogene Laerzio, ma con la mediazione dell’amato De re-rum natura lucreziano.In ogni caso Federico ritiene che epicureismo e stoicismo siano tra-dizioni filosofiche da conciliare, più che da contrapporre11. Per spie-gare la qual cosa non occorre fare appello alle tendenze eclettiche delleuniversità tedesche del tempo, e tanto meno a Christian Thomasius,che tale indirizzo aveva giustificato teoricamente (seppure Federico loindichi come il termine di riferimento metodologico per la riformadell’istruzione superiore in Prussia12). Piuttosto la convergenza degliinsegnamenti tramandati dalle due scuole post-aristoteliche esprimequelle che per Federico sono le due esigenze fondamentali dell’uomo,che concorrono a comporre l’atteggiamento insieme teorico e praticoalla base della sua Weltanschauung. Da un lato si deve cercare il mas-simo di felicità possibile, accaparrandosi tutti quei piaceri, anche sen-sibili, che rendono gradevole la vita. In questo Federico si allinea, unpo’ alla buona, con quella tendenza eudemonistica che costituiva unodei caratteri fondamentali della cultura settecentesca. D’altro lato l’uomodeve imparare a sopportare tetragono le avversità di un’esistenza chenon può riservargli solo piaceri, ma che – data la inevitabile mesco-lanza in essa di beni e di mali – lo sottopone prima o poi a dureprove. Naturalmente l’equilibrio tra le due tendenze non è semprecostante. L’accento viene posto da Federico ora sull’una ora sull’altrascuola, a seconda delle fasi della vita: l’epicureismo appare più adattoalla gioventù, lo stoicismo alla maturità e alla vecchiaia. Ma la valu-tazione dello stoicismo varia anche e soprattutto a seconda delle cir-costanze: le dure esperienze della guerra dei Sette Anni – nel 1758,nella stessa giornata, Federico subisce la gravissima sconfitta di Hoch -
dei classici antichi per infondere nuova energia alla letteratura tedesca, Federico esem-plifica: «Prendiamo dai Greci, Tucidide, Senofonte, non dimentichiamo la Poetica diAristotele, ma ci si applichi soprattutto a rendere bene la forza di Demostene. DaiLatini prendiamo il Manuale di Epitteto e i Pensieri dell’imperatore Marco Aurelio,i commentari di Cesare, Sallustio, Tacito e l’Arte poetica di Orazio» (De la littéra-ture allemande, VIII, p. 119).
11 Epître à d’Argens. Sur la faiblesse de l’esprit humain (1749), X, p. 111. NellaEpître à mon esprit (1749) Federico riferisce questa congiunzione alla propria bio-grafia: «Oui, sans haïr Zenon, j’estimai Épicure, Et pratiquai les lois de la simple na-ture» (X, p. 258).
12 Lettre sur l’éducation. Lettre d’un Genevois à M. Bourlamaqui, Professeur àGenève (1769), IX, p. 137.
massimo mori26
kirch e la perdita di due persone per lui fondamentali: l’amata sorellaGuglielmina e l’amico feldmaresciallo Jakob Keith, caduto appunto inquella battaglia – lo inducono da un lato a vedere nello stoicismo lasola forza per superare la prova, dall’altro a sperimentare personal-mente i limiti della sua efficacia. Del resto, l’astrattezza di un indi-rizzo di pensiero che nega la realtà del male si manifesterà anche, epiù semplicemente, di fronte ai dolorosi attacchi di gotta cui il vec-chio re andrà sempre più frequentemente soggetto13.
All’influenza di epicureismo e stoicismo si deve aggiungere quelladella terza scuola post-aristotelica, lo scetticismo. In questo caso tut-tavia il riferimento all’antichità – Federico si proclama discepolo diCarneade14 – è soltanto di maniera. Come del resto è poco più di unoslogan il frequente richiamo al que sais-je di Montaigne. Questa voltal’atteggiamento scettico, che indurrà Federico a definirsi roi pyrrho-nien, è ampiamente filtrato da letture o frequentazioni espressamenteilluministiche, come Bayle e Voltaire. Lo scetticismo di Federico è in-fatti il risultato del progressivo sgretolarsi della sua fiducia nella me-tafisica e, più in generale, delle capacità conoscitive della ragione umana.E ciò malgrado la rigorosa formazione razionalistica che egli ricevedalle sue prime letture filosofiche. Negli anni della giovinezza, a Rheins -berg tra il 1736 e il 1740, il principe è attento lettore di Leibniz e so-prattutto di Christian Wolff, di cui dimostra una conoscenza profondae precisa. Di Wolff si fa anche propugnatore, facendo tradurre le sueopere in francese. La difesa delle dottrine wolffiane degli «esseri sem-plici» e del «principio di ragion sufficiente» lo vedono impegnato inuna discussione epistolare con Voltaire in cui l’acutezza analitica e laforza argomentativa stanno più spesso dalla parte del giovane prin-cipe che del più maturo philosophe. Eppure anche in questi anni diprofessione del wolffismo, Federico, portato ad ammirare nel filosofotedesco più la lucidità del ragionamento che la certezza dell’acquisi-zione teorica, è sempre pienamente consapevole della difficoltà deiproblemi e della problematicità delle soluzioni. Cosa che non sfuggeall’astuto Voltaire, che nel 1738 non perde occasione per lodare nelsuo interlocutore l’onestà di combinare la difesa di Wolff con l’inse-gnamento di Montaigne. Sotto l’abile guida voltairiana, infatti, il prin-cipe ribalta presto la sua posizione. «La metafisica – egli sostiene in
13 Cfr. lettera a d’Alembert del 18.5.1782 e del 5.7.1782, XXV, pp. 253, 258-59.14 Cfr. Épître à d’Argens. Sur la faiblesse de l’esprit humain, X, p. 110. In ogni
caso un apprezzamento della nuova Accademia è già contenuto nella Réfutation duPrince de Machiavel, VIII, p. 247.
federico ii e la cultura illuministica 27
un passaggio che sembra anticipare un gusto kantiano – mi parve untempo come un paese adatto a fare delle scoperte; ora essa mi si pre-senta come un mare immenso e famoso per i suoi naufragi»15. Nel1740 Federico, che tra poco sarebbe diventato re, pur professando an-cora rispetto per il principio di ragion sufficiente, ammette che essosarebbe utile soltanto nel caso disponessimo di conoscenze che nonpossiamo avere. Da questo momento in poi il suo rapporto con Wolffè quello di un rapido, progressivo allontanamento. Una ventina dianni dopo egli considererà la filosofia wolffiana nient’altro che un in-sieme di astruserie alla stessa stregua della filosofia scolastica.
La progressiva critica del wolffismo porta con sé un ridimensio-namento delle possibilità conoscitive della ragione. I limiti dell’attivitàrazionale appaiono duplici. Per un verso essa è condizionata dalla na-tura sensibile dell’uomo («l’homme est plus sensible que raisonna-ble»16), che restringe fortemente l’ambito dei problemi accessibili. Peraltro verso i limiti sono anche intrinseci alla ragione. Quella capacitàargomentativa e dimostrativa, che in maniera diversa Federico apprezzain Bayle e in Wolff, appare sempre più come un gioco formale, utilea creare sistemi filosofici astratti più che a cogliere la realtà. L’uomoè «un être raisonneur plutôt que raisonnable»17. La critica illumini-stica all’esprit de système in Federico assume la forma, un po’ annac-quata, di uno scetticismo fondato più sull’esperienza esistenziale chesu considerazioni gnoseologiche. La conseguenza, in parte sollecitatada Voltaire ma autonomamente sviluppata da Federico, è che l’uomonon è fatto per la conoscenza, ma per l’azione. A partire dal 1738l’affermazione che «l’homme est fait pour agir, et non pas pour con-templer» diventa un tema ricorrente18. La priorità della morale sullaconoscenza teorica è ormai un punto fermo della concezione filoso-fica di Federico, molto più di quanto essa non caratterizzasse, in li-nea di massima, l’intera cultura illuministica e il pensiero di Voltairein particolare.
15 Lettera a Voltaire del 17.6.1738, XXI, p. 233. 16 Lettera a d’Alembert dell’8.9.1782, XXV, p. 264.17 Au Géneral Bredow. Sur la Réputation (1749), X, p. 156. Cfr. lettera a d’A-
lembert dell’8.1.1770: «l’homme est plus raisonneur que raisonnable», XXIV, p. 521.18 Lettera a Voltaire del 17.2.1738, XXI, 184. Cfr. in particolare l’Epître à d’Ar-
gens. Sur la faiblesse de l’esprit humain, dove viene ripresa l’espressione «l’hommeest fait pour agir, non pour philosopher» (X, p. 110). Si veda anche l’ultima letterainviata a d’Alembert il 30.9.1783: «Il me semble que l’homme est plutôt fait pouragir que pour connaître», XXV, p. 288.
massimo mori28
2. Dio, l’anima e la libertà
Unde, ubi, quo? A queste domande fondamentali sulla prove-nienza, natura e destinazione dell’uomo non è possibile rispondere,secondo Federico, se non con una confessione di ignoranza19. Tutta-via, per quanto il re tenti di mettere da parte le grandi questioni me-tafisiche, l’interesse per l’indagine morale gli impedisce di trascuraretre di esse: l’esistenza di Dio, la natura dell’anima e la libertà umana.A queste questioni Federico fornisce soluzioni piuttosto imprecise,talvolta fluttuanti. Ma proprio questa scarsa consistenza concettualemostra la funzione che egli attribuisce a quelle indagini: non risolvereproblemi che stanno molto al di là della portata umana, ma aprireprospettive che consentano di elaborare una filosofia morale fondatasull’autonomia della ragione e libera da ipoteche metafisiche.
Che l’esistenza di Dio sia un’utile premessa per una concezionemorale del mondo è una convinzione che attraversa l’intero arco dellariflessione federiciana. Ad analoghe preoccupazioni può essere ricon-dotta la rabbiosa avversione per l’ateismo sostenuto dal barone d’Hol-bach, del resto pienamente condivisa da Voltaire20. Su come si debbaintendere Dio, Federico ha invece le idee meno chiare. Le prime ma-nifestazioni del suo pensiero in proposito lasciano spazio a qualcheelemento teistico: la bontà e la misericordia sono due attributi essen-ziali di una divinità che ancora oscilla tra la religione naturale e quellapositiva21. Poco alla volta questi residui di un Dio inteso come per-sona lasciano il posto a una più lineare concezione deistica, in baseai più consueti moduli dell’Illuminismo. Dio è «causa prima», «mo-tore sconosciuto», «orologiaio esperto», «natura intelligente che devenecessariamente presiedere al mantenimento dell’universo»22. Ma so-prattutto Federico è preoccupato di mantenere netta la distinzione traDio e mondo. A d’Alembert, il quale gli obietta che l’intelligenza or-dinatrice dell’universo è una proprietà dell’organizzazione, e quindidella materia, egli risponde con una chiara contrapposizione tra Dioe mondo materiale, concepiti come due princìpi coeterni e indipen-
19 Vers sur l’existence de Dieu. Composés par Frédéric quelques années avant samort. Unde, ubi, quo?, XIV, pp. 19-22.
20 Examen critique du Système de la nature (1770), IX, 180. Cfr. lettere di Vol-taire dell’8.6.1770 e 27.7.1770, XXIII, pp. 178, 184.
21 Apologie des bontés de Dieu (1737), XIV, pp. 7-11; Ode sur les Grâces, dontle Créateur nous comble (1737), XIV, pp. 12-15.
22 Épître à Maupertuis: La Providence ne s’intéresse point à l’individu, mais à l’e-spèce (1749), X, pp. 126-27; Examen critique du Système de la nature, IX, p. 180.
federico ii e la cultura illuministica 29
denti. Dio non è né spirito né materia, ma piuttosto «il sensorium del-l’universo, così come l’intelligenza è applicata (attaché) all’organizza-zione eterna dei mondi che esistono»23. Più che riferirsi a Newton, lanozione di sensorium serviva a Federico per garantire l’autonomia di-vina rispetto al mondo e alla materia, in modo da sfuggire non soloallo spinozismo invocato da d’Alembert (che era poi un eufemismoper dire ateismo), ma anche al panteismo del detestato Diderot. Inol-tre, la reciproca indipendenza di Dio e materia, se introduceva certa-mente qualche difficoltà teorica circa l’infinitezza di Dio, serviva an-che per risolvere brillantemente il problema della teodicea. Un Dioche ha in suo potere le eterne leggi del movimento, ma non il domi-nio della materia, non è responsabile di quei mali che scaturisconodalla resistenza della sostanza materiale all’ordine intelligente24.
Al di là di queste oscillazioni, o di queste ingenuità concettuali,un secondo punto, accanto all’idea di un Dio compatibile con l’or-dine morale, preme a Federico. L’uomo deve liberarsi dalla paura, col-tivata dal fanatismo religioso, di un Dio che assilla l’uomo con as-surdi comandi e minacce. Negli anni giovanili, in cui l’idea di Dio haancora riflessi teistici, Federico si accontenta di assicurare che la mi-sericordia divina è incompatibile con la concezione di un Dio tiranno,foscamente tratteggiata da qualche «scolastique atrabilaire»25. Nella piùmatura concezione deistica la paura di Dio si dissolve nella conside-razione del fatto che la provvidenza divina riguarda solo le leggi uni-versali e non si occupa del particolare, ignorando i destini dell’indi-viduo umano. Nella gestione della sua vita l’uomo non deve quindipreoccuparsi di piacere o dispiacere a Dio. Certo questa visione privagli uomini dell’immagine consolante di un Dio sollecito e premuroso.Tanto più che in Federico si rafforza sempre più l’idea che il mondosia retto dal caso (hazard), non nel senso epicureo del termine, chesarebbe incompatibile con l’ordine dell’universo, ma nel senso che lapur necessaria connessione delle cose è impenetrabile alla mente umana.L’uomo conosce a posteriori soltanto le cause più prossime, ma nonriesce mai a cogliere le cause delle cause, che stanno alla base degliavvenimenti. Ogni possibilità di previsione è pertanto esclusa e la suc-cessione dei fatti, pur obbedendo a leggi necessarie, nella sua opacitàha di fatto una valenza casuale. Pertanto la prudenza non serve a pre-
23 Lettera a d’Alembert del 18.12.1770, XXIV, p. 576. La lettera di d’Alembertcui Federico risponde è del 30.11.1770, XXIV, p. 569.
24 Épître à Monsieur Mitchell sur l’origine du mal (1761), XII, pp. 229-30.25 Apologie des bontés de Dieu, XIV, pp. 7-11.
massimo mori30
vedere, ma si limita ad assumere l’aspetto della saggezza e fermezzastoica di fronte a ciò che non si può evitare26. Tuttavia questa conce-zione severa dei rapporti tra uomo e Dio ha anche un aspetto posi-tivo. L’emancipazione dell’uomo dalla tutela di un Dio previdente eprovvidente ha infatti come contropartita la restituzione dell’uomo ase stesso, alla sua etica e alla sua legittima ricerca della felicità mon-dana. Se Dio non si occupa degli esseri umani, se non in quanto essirientrano nel suo generale piano provvidenziale, l’uomo può ripren-dersi la sua porzione di autonomia e tornare ad essere arbitro di quellospazio che gli concedono la misura delle sue forze e la latitudine delcondizionamento naturale. Che la conciliazione tra l’uno e l’altro ele-mento, tra l’autonomia dell’uomo e la necessità delle leggi di natura,fosse difficile non era del tutto estraneo alla consapevolezza filosoficadi Federico, ma neppure presente al punto di giungere alla contrad-dizione conclamata.
Nel respingere l’idea di un Dio tiranno che ostacola i disegni umanie minaccia punizioni tremende a chi non segue la sua legge risuonacertamente, in Federico, l’eco del primo dei quattro farmaci epicurei:liberare gli uomini dalla paura degli dèi. Ancora più evidente è peròla presenza del secondo: liberare gli uomini dalla paura della morte.A questo scopo è costantemente finalizzato l’esame della natura del-l’anima, nella misura in cui è possibile conseguire qualche conoscenzain questa materia. Anche in tal caso si possono trovare nelle opere diFederico affermazioni che lasciano spiragli alla spiritualità e immorta-lità27. Ma, malgrado qualche oscillazione, sin dal 1736 egli sembra ac-cettare l’ipotesi voltairiana della natura materiale dell’anima28, che siva via via rafforzando con riferimenti alla tradizione epicureo-lucre-ziana, a Locke e agli studi della medicina contemporanea. L’uomoviene ridotto a materia, che nasce, vegeta e si distrugge in un’eternametamorfosi29. Nel 1775, in una lettera a Voltaire, Federico riassumein questi termini la questione: «Sono perfettamente sicuro che la mia
26 Épître sur le Hazard. A ma seur Amélie (1758), XII, pp. 64-79. L’esclusionedell’accezione epicurea del caso è contenuta anche in Épître à Monsieur Mitchell surl’origine du mal, XII, p. 225.
27 Nella Épître au Marèchal Keith si parla della possibilità della sopravvivenzadi una «faible étincelle, / Un atome inconnu, qu’on nomme âme immortelle», X, p.228. Un piccolo spazio all’ipotesi dell’immortalità è lasciato anche in Le stoïcien (1761),XII, pp. 217-18.
28 Lettera a Voltaire del 3.12.1736, XXI, p. 23.29 Lettera a Voltaire del 5.3.1749, XI, p. 155. Sulla metamorfosi universale cfr. Le
stoïcien, p. 217.
federico ii e la cultura illuministica 31
natura non è duplice, e mi considero come un essere unitario. So chesono un animale materiale, animato, organizzato e che pensa; da ciòconcludo che la materia animata può pensare, così come ha la pro-prietà di essere elettrica»30. Questa prospettiva toglieva all’uomo ognisperanza di immortalità che non fosse quella della buona reputazionelasciata di sé – alla quale Federico conferiva molto valore, conside-randola la componente migliore di una «gloria» che altrimenti rischiavadi essere una semplice vanità. La considerazione della propria morta-lità richiamava l’uomo, ormai libero dalla paura dell’inferno come dal-l’attesa del paradiso, alla necessità di dare lui stesso un significato allapropria esistenza attraverso l’operosità e la virtù. Anche in questocaso, la concezione naturalistica dell’uomo e della mente, legata alladissoluzione della paura della morte – al pari di quella che conseguivaalla liberazione dalla paura di Dio – doveva avere un significato fon-damentalmente etico.
Incidenza morale aveva tuttavia soprattutto la terza questione me-tafisica che non poteva essere elusa: la libertà umana. Su questo puntol’evoluzione del pensiero di Federico comporta un vero e proprio ri-baltamento. Il giovanile attaccamento alle teorie wolffiane lo obbligaa schierarsi dalla parte di un radicale determinismo. Ancora una voltala disputa con Voltaire mette in luce la sua preparazione e la sua ca-pacità: il costante e preciso riferimento al principio di ragion suffi-ciente gli consente di opporsi validamente al suo interlocutore, la cuiesigenza morale di salvaguardare la libertà dell’uomo si avvale spessodi argomentazioni esili, ancorché formalmente complesse31. Ma le po-sizioni sono destinate a invertirsi. A un vecchio e disilluso Voltaire,che dubita ormai della sua battaglia a favore della libertà umana32, sicontrappone un Federico che, abbandonata da tempo la metafisicawolffiana, si fa paladino della libertà. Le argomentazioni di cui egli siserve sono anche peggiori di quelle di cui si era servito Voltaire, poi-ché, oltreché deboli, sono confuse. Federico non arriva neppure a co-gliere con chiarezza la distinzione tra «libertà di fare» e «libertà divolere» che era stata magistralmente illustrata da Locke, al quale egli
30 Lettera a Voltaire del 4.12.1775, XXIII, p. 404.31 Cfr. la lettera a Voltaire del 26.12.1737, XXI, pp. 144-45 in risposta alla let-
tera di Voltaire dell’ottobre precedente, con estratti del capitolo sulla libertà da Traitéde métaphysique, XXI, pp. 113-24. La polemica continua nelle lettere successive.
32 Cfr. lettera di Voltaire dell’8.10.1771, XXIII, p. 229. La libertà è difesa da Fe-derico nella lettera a Voltaire del 16.9. 117, XXIII, pp. 227-28, ma soprattutto, con-tro la nozione di fatalità di Holbach, nell’Examen critique du Système de la nature,IX, pp. 184-85.
massimo mori32
pure si richiama – ma in maniera inopportuna. La sua argomenta-zione più forte è ora la stessa di cui più frequentemente si era ser-vito Voltaire: l’appello al «sentimento interiore» della libertà. Quelloche il giovane Federico rifiutava come argomento a posteriori, irrice-vibile di fronte alla dimostrazione a priori della connessione tra prov-videnza divina e necessità causale, appare ora fortissimo proprio per-ché rinuncia ad argomentare astrattamente e si affida all’esperienzadell’uomo comune. Questo non significa che Federico si pronunci afavore di una libertà assoluta: in più luoghi egli afferma di attestarsisu una concezione intermedia, in base alla quale l’uomo dispone sìdella capacità di agire liberamente, ma condizionata dalle passioni edai vincoli fisiologici33. In ogni caso, tuttavia, la libertà, ancorché li-mitata, appare un’esigenza irrinunciabile per non vanificare il sensodella virtù e dell’impegno nell’azione. Questo è il fulcro della tardapolemica contro Holbach, in cui Federico, rivendicando all’uomo unacomponente di attività che si contrappone alla passività rispetto aisensi, sostiene che dal sistema della fatalità discenderebbero conse-guenze funeste per la società: non sarebbe più possibile distinguere iprobi dai malvagi e l’applicazione delle pene sarebbe priva di senso34.Del resto già molti anni prima il giovane Federico, quando ancora di-scettava sulla fatalità che incombe su tutte le cose, nel considerare l’a-spetto pratico della vita aveva incitato i suoi Prussiani all’azione ri-cordando loro che «le sort est en nos mains»35.
3. Una morale sociale
La morale è dunque l’interesse filosofico fondamentale di Fede-rico. L’indagine razionale dell’uomo non solo non deve perdersi neimeandri della metafisica, fonte di errori e di astruserie concettuali, maneppure sopravvalutare la matematica e le scienze naturali. Le disci-pline matematiche, alle quali Federico tende ad assimilare anche l’a-stronomia, gli appaiono un elegante, ma vano esercizio intellettuale.Anche sulla fisica e sulle altre scienze naturali egli ha ampie riserve,malgrado il continuo apprezzamento per l’esperienza. Il timore è cheanch’esse si avventurino sugli ardui sentieri della conoscenza pura,
33 Lettera a Voltaire del 13.2.1749, XI, pp. 149-50; Lettera a d’Alembert del7.7.1770, XXIV, p. 543.
34 Examen critique du Système de la nature (1770), IX, pp. 184-85.35 Aux Prussiens (s. d.), X, p. 41
federico ii e la cultura illuministica 33
senza avere una ricaduta effettiva sulla vita pratica: con divertita iro-nia Federico ricorda la fontana fatta costruire nel parco del castellodi Sanssouci in base al progetto di Eulero, i cui complessi ingranagginon riuscirono però a sollevare l’acqua di quei pochi piedi di disli-vello necessari per provocarne la ricaduta36. Il vero ambito di appli-cazione della ricerca filosofica è l’uomo, quale l’esperienza storica equotidiana lo fa conoscere. Ma soprattutto interessa a Federico con-siderare in che modo l’uomo, in base alla conoscenza empirica che sene può ottenere, possa agire per la realizzazione della felicità propriae, ancor più, di quella collettiva37.
Anche se l’attenzione di Federico per la definizione di una mo-rale di natura filosofica, liberata dalle superstizioni religiose, è docu-mentata sin dagli scritti giovanili, a una trattazione organica del temaegli giunge solo all’inizio degli anni Settanta, quando la conclusionedelle guerre gli consente di dedicarsi alla stesura di alcuni brevi saggifilosofici, tra cui l’Essai sur l’amour propre envisagé comme principede la morale (1770). In una lettera a Voltaire egli dichiara di essersiispirato al De l’esprit di Hélvetius e agli Essais di d’Alembert, ancor-ché «l’uno scriva con una metafisica troppo sottile e l’altro si limitiad abbozzare le sue idee»38. Questi due rilievi hanno un elemento incomune: Hélvetius e d’Alembert, seppure in forme diverse, non sonopervenuti alla concretezza dell’esperienza morale, l’uno costruendo si-stemi e l’altro formulando teorie non sperimentate. Il ricorso all’e-sperienza consente invece di giustificare i due princìpi che, secondoFederico, possono fondare il concetto di virtù. Il primo è che, ribal-tando una massima di La Rochefoucauld, l’amor proprio è la mollafondamentale non solo dell’agire umano in generale, ma anche deicomportamenti virtuosi. Ciò richiede ovviamente una comprensionelata dell’amor proprio, il quale «innanzitutto è l’amore della vita edella propria conservazione, e poi la voglia di essere felici, il timoredel rimprovero e della vergogna, il desiderio della conservazione edella gloria»39. Esso non riguarda soltanto benefici fisici, legati al pro-
36 Lettera a Voltaire del 25.1.1778, XXIII, p. 475. Nella lettera precedente, del17.12.1777, Federico aveva criticato, per diverse ragioni la metafisica, la teologia, lageometria (che costruisce in eterno «curve inutili») e la medicina, salvando solo lebelle lettere.
37 Questo vale soprattutto per l’esercizio della politica: cfr. Examen de l’Essai surles préjugés (1770), IX, p.163.
38 Lettera a Voltaire del 17.1.1770.39 Essai sur l’amour propre envisagé comme principe de la morale (1770), IX,
p. 110.
massimo mori34
prio benessere materiale, ma anche, e forse soprattutto, contenuti psi-cologici, come la reputazione e la gloria, che possono provenire sol-tanto dall’approvazione degli altri e dal confronto sociale. L’amor pro-prio non ha quindi soltanto una radice egoistica, ma si traduce, perquanto paradossale la cosa possa sembrare, in una forma di «disinte-resse», che costituisce il secondo principio della virtù. Naturalmentenon si tratta di un disinteresse in senso forte, che non prenda in con-siderazione il proprio tornaconto – in questo senso vedere in Fede-rico un «kantiano prima di Kant» è del tutto fuorviante40 – bensì diun agire per gli altri con la consapevolezza che esso ridonda anche aproprio favore. La morale federiciana è dunque essenzialmente mo-rale sociale. La risposta alla domanda «Che cos’è la virtù?», con cuisi apre il Dialogue de morale – redatto ad uso dei figli dei nobili – èla seguente: «È una felice disposizione dello spirito che ci porta acompiere i doveri sociali per nostro proprio vantaggio»41.
La tesi federiciana della convergenza tra amor proprio e azionemorale disinteressata si fonda su una concezione espressamente orga-nicistica della società, le cui dinamiche vengono talvolta assimilate aquelle della famiglia o del corpo umano. Anche qui non c’è nessunaprefigurazione di un hegeliano spirito oggettivo42. Il modello dell’or-ganicismo socio-politico di Federico è l’apologo classico di MenenioAgrippa, che non era mai scomparso completamente dalle analisi so-ciali del Sei-Settecento, e che viene facilmente fatto convivere con ilmodello meccanicistico – questo sì pienamente illuministico – delloStato-macchina, dello Stato-orologio. Ne consegue una concezione percui ciascuno deve svolgere il proprio ruolo nella società, agendo in-
40 Cfr. ad esempio E. Spranger, Der Philosophe von Sans-Souci, Heidelberg,Quelle & Meyer, 1962, p. 83.
41 Dialogue de morale à l’usage de la jeune noblesse, IX, p. 117. Almeno in nuce,la concezione della morale in termini sociali è già presente sin dagli anni giovanili(Cfr. Réfutation du Prince de Machiavel, VIII, p. 194).
42 Ancora E. Spranger, Der Philosophe von Sans-Souci, cit., p. 85, parla di un«hegeliano prima di Hegel». Su ciò viene proiettato forse lo stesso giudizio di He-gel, il quale vede in Federico il primo riconoscimento della natura universale dellostato (G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, in Werke inzwanzig Bänden, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1969-1979, vol. XII, p. 523, trad. it. diG. Bonacina e L. Sichirollo, Lezioni di filosofia della storia, Roma-Bari, Laterza, 2003,p. 358). Sicuramente Federico rovescia la tradizione giusnaturalistico-illuministica chesubordinava lo stato all’individuo, ma rimane salda la convinzione, propria di quellatradizione, che la finalità dello Stato è la felicità degli individui. Cambia solo il mododi concepire lo strumento per realizzare quel fine: la felicità degli individui non è se-parabile da una certa politica di potenza.
federico ii e la cultura illuministica 35
sieme disinteressatamente, per il bene collettivo, ed egoisticamente, perl’utile proprio. Ma il modo più semplice per svolgere questa funzioneè inserirsi correttamente nel meccanismo dello Stato, o anche sempli-cemente dell’edificio sociale, in modo che tutto funzioni come un oro-logio efficiente. L’organicismo di Federico si sposa quindi assai benecon quella rigida concezione dell’apparato amministrativo dello Statoche egli aveva ereditato dal nonno e, soprattutto, dal padre. In que-sta prospettiva anche il principio dell’assolutismo politico – mai messoin discussione – muta natura. Se per Luigi XIV, incurante della suacollocazione all’interno del corpo della nazione e della macchina dellostato, esso si concretava nel principio «L’état, c’est moi», in Federico,per il quale prima viene il tutto e poi la parte, per quanto importantepossa essere, esso si declina nella nuova formula per cui il re è il«primo servitore dello Stato»43. La strenua difesa del ruolo della no-biltà che Federico non perde occasione di perseguire è insieme tuteladi un privilegio ritenuto indispensabile per l’ordine sociale e richiamoal dovere e alla responsabilità, morali prima che sociali, che da quelprivilegio derivano.
Nello stesso tempo, l’importanza data alla responsabilità delle scelteporta a stabilire tutta una serie di limiti e di cautele, in base a cui leistanze teoriche devono sempre essere commisurate alla loro concretaefficienza. L’attività politica di Federico – in cui si confondono la cri-tica del pregiudizio e della superstizione da parte del filosofo e la vo-lontà concretamente riformatrice da parte del sovrano – è diretta con-seguenza di questo duplice atteggiamento: promozione della tolleranzareligiosa (strettamente limitata però agli aspetti teorici); protezione de-gli intellettuali perseguitati all’estero (purché siano «modérés et paisi-bles»44); contenimento del potere del clero (riconoscendo tuttavia lasua funzione di secondo Stato); limitazione dell’influenza della Chiesacattolica (senza però cacciare i Gesuiti); riforma del sistema giudizia-rio (conservando tuttavia la pena di morte, contro l’insegnamento diBeccaria e il consiglio di Condorcet, entrambi pur ampiamente ap-prezzati); rifiuto dell’«assurdo» principio della prevalenza della nascitasul merito (ma garantendo alla nobiltà il predominio nell’esercito edescludendola dalle professioni borghesi45); miglioramento delle condi-
43 Federico usa espressioni analoghe sin dalla Réfutation du Prince de Machia-vel, VIII, p.190.
44 Lettera a Voltaire del 13.9.1766, XXIII, p. 122.45 Per questo secondo aspetto cfr l’Allgemeines Landrecht, parte II, titolo IX,
§ 76.
massimo mori36
zioni dei contadini e condanna della servitù della gleba quale condi-zione contraria alla dignità dell’uomo (riconoscendo tuttavia che unaabolizione istantanea di quest’istituto produrrebbe la rovina dell’agri-coltura e dell’economia nazionale). Malgrado le considerazioni empi-riche e pragmatiche che spesso le limitano drasticamente, queste di-sposizioni culturali e volontà riformistiche – occorre riconoscerlo –vanno talvolta al di là delle forti idiosincrasie del sovrano. Un soloesempio: l’attenzione per l’educazione femminile, l’intenzione di pre-venire più che punire l’aborto, la creazione di istituti per ragazze ma-dri, l’auspicio che possa essere rimosso il pregiudizio che riteneva in-famante sposare una giovane già madre di figli altrui non sono da sot-tovalutare in un uomo che si vantava del fatto che a Sanssouci nonavesse mai messo piede né un prete né una donna.
La forte connotazione sociale che la morale riceve in Federicogetta luce anche sul rapporto da lui intrattenuto con la religione, inparticolare quella cristiana. Il nucleo del Cristianesimo è ricondottoal principio «non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te»,che è esattamente lo stesso che sta alla base della morale sociale. Haquindi sbagliato chi, come Holbach, ha criticato la religione di per sestessa (o, peggio, ha inventato un’improbabile alleanza tra preti e so-vrani per ingannare i popoli). Cristo era un esseno e la dottrina de-gli esseni era simile a quella degli stoici: il Cristianesimo, nella sua es-senza, non è che pura religione naturale e razionale, secondo gli schemi,qui un po’ semplificati, del razionalismo religioso settecentesco46. Lacolpa dunque non è della religione cristiana, ma dei religiosi, chel’hanno mistificata con contenuti dogmatici e incrostazioni di credu-lità. L’azione critica dell’Illuminismo, e dei sovrani illuminati, deve es-sere esercitata contro questa fonte di superstizione e fanatismo, noncontro la vera religione. Ma in realtà anche la fiducia di Federico inquesta più circoscritta attività di rischiaramento è molto ristretta – edè questo forse il limite maggiore del suo Illuminismo, sebbene essosia almeno in parte condiviso anche da philosophes come Voltaire stesso.La pessimistica antropologia filosofica di Federico lo induce a pen-sare che il numero degli uomini che possono elevarsi alla chiarezzadella ragione sia molto limitato. Per la gran massa l’inclinazione almeraviglioso sarà sempre un ostacolo definitivo ad accogliere una re-ligione puramente razionale47. Anche se i filosofi riuscissero a instau-
46 Lettera a d’Alembert del 18.10.1770, XXIV, p. 560.47 Di questa convinzione Federico è sin dagli anni giovanili. Cfr. Réfutation du
Prince de Machiavel (1739), VIII, p. 204. Ma cfr. anche lettere a Voltaire del 13.8.1766,
federico ii e la cultura illuministica 37
rare il migliore dei governi con la migliore delle religioni, esso sarebbedestinato a corrompersi in breve tempo48. La fiducia nell’educazioneprofessata da Helvétius – per il quale Federico nutre una stima assaiscarsa49 – va contro la testimonianza dell’esperienza, così come è il-lusoria la proposta di d’Alembert di inaugurare una religione naturaleestesa al popolo50. In questa situazione lo stesso comportamento delsovrano deve essere attento a non ferire i sentimenti popolari per noncreare disordini. Nel 1740 un giovane Federico, principe filosofo chepochi mesi dividono ormai dall’ascesa al trono, ha già le idee chiarein proposito. Socrate incensava i Penati, l’incredulo Cicerone rispet-tava la religione pubblica: «facciamo qualche sciocchezza con gli scioc-chi per garantire una situazione tranquilla»51.
4. Il filosofo e la guerra
Al centro delle preoccupazioni etiche e politiche di Federico vi èsempre lo stato, il bene comune. Non è certamente condivisibile l’in-terpretazione un po’ nazionalistica di Dilthey, il quale sopravvaluta lapresa di distanza di Federico dall’Illuminismo francese per sottoli-nearne invece la consonanza, al di là dei mancati riconoscimenti for-mali, con quella Aufklärung che, ponendosi totalmente al «serviziodella società e dello Stato», dimostrava la sua «infinita superiorità» ri-spetto alla cultura francese52. Ma Dilthey coglie nel segno nell’affer-mare che l’Illuminismo di Federico, privo degli intenti critici versol’autorità politica che avevano spesso caratterizzato quello francese, èinvece incentrato sulla convergenza tra patriottismo ed educazione po-
XXIII, p. 117, dell’agosto dello stesso anno, XXIII, pp. 120-25; lettere a d’Alembertdel 25.11.1769, XXIV, p. 514, del 8.1.1770, XXIV, pp. 521-23 e del 7.7.1770, XXIV,p. 544.
48 Lettera a Voltaire del 29.9.1775, XXIII, p. 339.49 Cfr. lettera a d’Alembert del 24.3.1765, in cui Federico scrive che il De l’e-
sprit, «per quanto pieno di spirito, non mi ha né persuaso né convinto» (XXIV,p. 436).
50 Lettera a Voltaire del 12.8.1773, XXIII, pp. 282-83; lettera a d’Alembert del18.12.1770, XXIV, p. 579 e risposta del 13.3.1771 alla lettera dell’1.2.1771 in cui d’A-lembert gli proponeva di costruire a Berlino un tempio in cui si venerasse solo la re-ligione naturale (XXIV, pp. 585-86, 590).
51 Lettera a Voltaire del 6.1.1740, XXI, p. 384.52 W. Dilthey, Friedrich der Grosse und die deutsche Aufklärung, in Gesam-
melte Schriften, B.G. Teubner Verlagsgesellschaft-Vandenhoeck & Ruprecht, Stutt-gart-Göttingen, 1959, vol. III, pp. 83-205: p. 133.
massimo mori38
polare. Il che tuttavia non dipende tanto dalla presa di distanza di Fe-derico dalla cultura francese, che – fatta eccezione per i pochi aspettidi cui si dirà – egli continua ad assumere a modello, né da un suoriavvicinamento a quella tedesca, che continua a sottovalutare. La veraragione sta ancora una volta nella concezione affatto concreta, fino aconfondere idealità ed empiria, che muove il suo ideale patriottico.Nelle Lettres sur l’amour de la patrie – sentimento, quello dell’amorper la patria, che si colloca al vertice delle virtù – il richiamo a que-sta concretezza non potrebbe essere più esplicito. «Non sono questecase, queste mura, questi boschi, questi campi che io chiamo la vo-stra patria, ma i vostri genitori, vostra moglie, i vostri amici e coloroche lavorano per il vostro bene nelle diverse branche dell’ammini-strazione, e che vi rendono servizi ogni giorno, senza che voi vi diateneppure la pena di informarvi sul loro lavoro»53. Di qui il rifiuto diun astratto cosmopolitismo e l’aspra critica agli Enciclopedisti, che loavevano propagandato. Imbarazzata e poco convincente appare la di-fesa di d’Alembert, che cerca di mostrare come lo spirito cosmopo-litico dell’Enciclopedia non sia mai andato a detrimento dell’amor dipatria54. Questo è sicuramente il punto di maggior frizione tra il par-tito dei philosophes e Federico, il quale si avvicina invece, probabil-mente senza averne coscienza, a quel Rousseau che disprezza comecolui che ha corrotto il rigore razionale con la moda dei paradossi55.
La concezione della morale sociale che culmina nell’amor di pa-tria e nel riconoscimento dell’organicità statale, da un lato, e l’appelloa una razionalità concreta, radicata nell’esperienza, dall’altro, possonospiegare la posizione di Federico nei confronti della guerra. Non ne-cessariamente a questo proposito si produce una frattura tra l’intel-
53 Lettres sur l’amour de la patrie ou Correspondence d’Anapistémon et de Phi-lopatros (1779), IX, p. 252.
54 Lettres sur l’amour de la patrie, IX, pp. 272-74. Lettera di d’Alembert del19.11.1779 e risposta di Federico del 3.12.1779, XXV, pp. 148-50.
55 Per i giudizi sul metodo paradossale di Rousseau cfr. le lettere a Voltaire deldicembre 1766, XIII, p. 131, e del 29.9.1775, XXIII, p. 399, nonché la lettera a d’A-lembert del 4.6.1768, XXIV, p. 486. Per la critica del Discours sur les sciences et lesarts cfr. il Discours sur l’utilité des sciences et des arts dans un État (1772), IX, pp.197-99. Un quadro complessivo del giudizio di Federico su Rousseau è contenutonella lettera a Mylord Marischal del 1.9.1962, dove da un lato emerge l’insofferenzadel re per i «paradossi» dei «filosofi moderni», dall’altro la sua totale incomprensionedel tema rousseauiano del ritorno alla natura: «non sarò mai persuaso a brucare l’erbae camminare a quattro zampe» (XX, pp. 322-23). Malgrado questo Federico offre aRousseau la sua protezione a Neuchâtel tramite George Keith e gli fa avere degliaiuti in beni di natura, per non offenderlo.
federico ii e la cultura illuministica 39
lettuale e il sovrano. L’immagine di un Federico scisso tra due per-sonalità, inaugurata da un Voltaire che lo accusa di scrivere bei versicontro la guerra e nello stesso tempo di prendersi gioco del mondo,è in realtà un po’ stereotipata56. Certo nel 1734, quando il ventiduenneFederico ha il suo battesimo del fuoco durante la guerra di Succes-sione polacca, le due prospettive appaiono inconciliabili, e la sola so-luzione gli sembra essere quella di assolvere gli obblighi militari senzalasciarsi coinvolgere emotivamente, così come «on peut aller au bor-del,/ sans y prendre la chaude-pisse»57. Ma già nella Réfutation duPrince de Machiavel, spesso a torto considerata come un documentodella frattura tra filosofo e principe, è documentata l’adesione ancheintellettuale di Federico a una guerra che risponda agli interessi delloStato. Da un lato la guerra viene più volte condannata a causa dellesue atrocità e conseguenze nefaste: questa critica, che risponde piena-mente alle ricorrenti proteste del pacifismo illuministico, rimarrà unacostante nelle opere di Federico, non solo in quelle in cui si può so-spettare un condizionamento letterario, ma anche laddove è più evi-dente la sincerità della valutazione filosofica. Ma, d’altro lato, altret-tanto costante, dalla Réfutation alla tarda critica a Holbach, è la con-vinzione di Federico che la guerra diventi un dovere quando sia resanecessaria dall’interesse dello Stato.
In primo luogo questa difesa è condotta sul piano giuridico, uti-lizzando gli strumenti classici del giusnaturalismo seicentesco, UgoGrozio e Samuel Pufendorf in primis. La guerra è innanzitutto giu-stificata come procedura giuridica per risolvere le vertenze sul pianointernazionale, dove non esiste un arbitro superiore. In particolare,viene ampiamente ricuperata la dottrina della guerra giusta. Due mo-dalità di conduzione bellica, richiamate da Federico nell’ultimo capi-tolo della Réfutation, venivano unanimemente considerate giuste dallatradizione del diritto naturale: la guerra di difesa contro un aggres-sore esterno, e la guerra di ripetizione del dovuto, per reclamare undiritto sostenibile per ragioni dinastiche, contrattuali o di altro genere.Nell’elenco delle guerre giuste il principe Federico inserisce tuttaviaanche una terza forma di conflitto, sulla quale in realtà i giusnatura-listi erano molto divisi: la guerra offensiva a carattere preventivo, inbase a cui un sovrano può aggredire una potenza vicina che lo mi-nacci anche solo con il suo ingrandimento territoriale58. Certo Fede-
56 Lettera di Voltaire del 26.1.1749, XXII, p. 202.57 Vers faits dans la campagne du Rhin en 1734 (1736), XI, p. 79.58 Réfutation, cap. XXVI, VIII, pp. 33233.
massimo mori40
rico in questo modo si allontana molto dal pacifismo illuministico,che solitamente limitava la guerra giusta all’autodifesa in senso stretto.Ma di vera contrapposizione non si può parlare se, andando al di làdella vulgata illuministica, si considera che, tra coloro i quali asso-ciano la normatività della ragione al realismo dell’analisi filosofica,non mancherà chi, come Montesquieu, si pronuncerà a favore dellaguerra preventiva59. Anticipando in ciò la posizione di un altro illu-stre «illuminista», che sarà grande ammiratore di Federico: ImmanuelKant60.
La posizione di Federico è però meglio compresa se, più che alleragioni giuridiche, si fa appello alle considerazioni etico-politiche (idue aspetti sono indisgiungibili) con cui egli giustifica la necessità dellaguerra. Il ricorso alle armi è doveroso quando si tratta di difenderele condizioni per promuovere la prosperità anche economica delloStato. Non bisogna dimenticare che Federico scrive e opera in untempo in cui esisteva ancora una netta separazione tra le operazionibelliche e la normale conduzione delle attività civili: per questo egliindividua, sempre alla luce del suo organicismo politico, una separa-zione dei compiti, una sorta di divisione del lavoro, nella quale i mi-litari detengono l’irrinunciabile funzione di difendere il tranquillo eser-cizio delle attività produttive e commerciali della popolazione civile.Gli eserciti permanenti, tanto avversati dalla cultura illuministica (maanche da Machiavelli e dalla tradizione repubblicana) svolgono di fattol’essenziale ruolo di polizia armata contro i pericoli esterni. Ma c’è dipiù. In vista della promozione della prosperità dello Stato lo stru-mento della guerra può anche essere concepito in funzione della con-quista, se essa appare necessaria per il conseguimento della sicurezzanazionale. Sotto questo aspetto è illuminante la revisione, o per me-glio dire la censura, che Voltaire compie nella correzione della Réfu-tation du Prince de Machiavel ai fini della pubblicazione come Anti-Machiavel ou Essai de Critique sur le Prince de Machiavel. Nel terzocapitolo egli amplifica le parole di dura condanna usate da Federicocontro i conquistatori, ma sopprime i passi da cui si evince che il giu-
59 C.-L. Secondat de Montesquieu, Esprit des lois, X, II, in Oeuvres complè-tes, Paris, Flammarion, 1941-51, II, pp. 377-78 (trad. it. di S. Cotta, Lo spirito delleleggi, Torino, Utet, 2005, pp. 247-48).
60 I. Kant, Die Metaphysik der Sitten, § 56, in Kant’s gesammelte Schriften, acura della Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften (e prosecutori), Ber-lin-Leipzig, de Gruyter, 1900 e ss., Reimer, Berlin 1910 e ss., vol. VI, p. 346 (trad.it. di G. Vidari in Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto, Torino, Utet,1965, pp. 537-38).
federico ii e la cultura illuministica 41
dizio severo riguarda soltanto la conquista fatta per pura ambizione,mentre si riconosce che il sovrano acquisisce una giusta gloria quando«diviene conquistatore per necessità e non per temperamento»61. Daquesto punto di vista, la guerra di conquista della Slesia, non riduci-bile a nessun caso di guerra giusta, è già giustificata nell’animo delgiovane principe, pur deferente allievo di Voltaire. Analogamente, nelsedicesimo capitolo, Voltaire enfatizza l’apprezzamento di Federicoper le conseguenze positive del lusso sull’economia nazionale, ma cassale parti in cui il principe – che non a caso sarà partecipe lettore del-l’Esprit des lois di Montesquieu sin dalla sua pubblicazione – limitaqueste considerazioni agli Stati di grande estensione. Per gli Stati pic-coli e ancora poveri – com’era la Prussia – il lusso avrebbe conse-guenze catastrofiche: nella Réfutation non c’è affatto l’esaltazione dellacircolazione del denaro, che nell’Anti-Machiavel Voltaire, seguace diMelon, attribuisce anche al suo augusto allievo. C’è invece l’invito aun’oculata tesaurizzazione che consenta di preparare durante la pacele condizioni per sostenere la guerra futura62.
Non sorprende dunque che la lettura della voce Guerre del Dic-tionnaire philosophique di Voltaire abbia irritato assai Federico. Il cau-stico sarcasmo voltairiano aveva immaginato un sovrano il quale, sol-lecitato da un genealogista che gli prospetta la possibilità di giustifi-care una guerra con ragioni dinastiche, «trova immediatamente un grannumero d’uomini che non hanno nulla da fare, né da perdere; li ve-ste di un pesante panno blu a centodieci soldi l’oncia, borda i lorocappelli di un grosso filo bianco, li fa girare a destra e a sinistra emarcia alla gloria». Federico, che pure non fece mai nulla per atte-nuare il barbaro sistema di reclutamento dell’esercito prussiano, nonsi riconosce in questa caricatura: quelli descritti da Voltaire non sonosovrani che hanno a cuore il bene del loro paese, ma ladroni che de-vono essere mandati al patibolo63. Con il loro astratto pacifismo ideo-logico e irrealistico Voltaire e il parti philosophique stanno soggio-gando l’Europa, non diversamente da come in altri tempi fecero i papicon i loro dogmi. Essi non hanno infatti compreso la dimensione ri-gorosamente deontologica della guerra, che è un dovere gravoso peri re e un métier de gens d’honneur per coloro che la praticano per
61 Réfutation, VIII, p. 194.62 Réfutation, VIII, pp. 265-65, 268 (sulla forzatura voltairiana relativamente alla
circolazione del denaro cfr. Anti-Machiavel, VIII, p. 127).63 Lettera a Voltaire del 9.10.1773, XXII, pp. 290-91.
massimo mori42
amor di patria, senza interesse privato64. Certo si tratta di un pro-gramma filosofico che non ha nulla a che vedere con le fantasie fe-deralistiche di un abate di Saint-Pierre65, ma che al contrario presup-pone una stretta connessione tra la normatività del progetto filosoficoe il realismo della considerazione storica. Non è un caso che, di tuttala sua attività letteraria, la ricerca storica sia senz’altro il settore in cuiFederico ha conseguito i risultati più elevati. Ispirandosi alla storio-grafia voltairiana, essa ha spesso superato il suo modello: laddove lapur lucida ricostruzione di Voltaire era spesso piegata alla dimostra-zione di una tesi precostruita, legata alla sua filosofia della storia,quando non semplicemente funzionale alla ricerca dell’effetto lettera-rio, l’analisi di Federico è sempre finalizzata alla scoperta di costantistoriche che, sia pur in mezzo all’inestricabile intreccio delle cause ge-nerali, consentano all’agente politico il massimo di prevedibilità e diresponsabilità66.
Non c’è dunque necessariamente frattura tra Federico II, sovranoe condottiero, e la cultura illuministica. Certo il modello giovanile delTélemaque di Fénelon (letto a nove anni), in cui alla filosofia si as-segna il compito dell’educazione del futuro sovrano, richiede delle me-diazioni per valere anche per il vecchio Federico. Ma in nessuna fasedel suo percorso di sovrano e di intellettuale viene meno l’apprezza-mento per quello che era per lui il nocciolo dell’Illuminismo: lo scet-ticismo rispetto alle questioni metafisiche, la costante adesione all’e-sperienza, la lotta contro il fanatismo e la superstizione, la priorità deiproblemi pratici su quelli teorici, l’importanza di una morale effetti-vamente operativa, la centralità del problema della società e dello Stato,ma soprattutto il senso della concretezza della razionalità umana. Nelprogramma illuministico di Federico non manca la dimensione dell’i-dealità: ma egli ritiene che i valori in cui crede, e continua a crederefino alla fine, non siano realizzabili se non parzialmente e a poco apoco, scendendo continuamente a compromessi con i limiti imposti
64 Dialogue de morale à l’usage de la jeune noblesse (1770), IV, pp. 122-23.65 «L’abate di Saint-Pierre, che ha la cortesia di onorarmi della sua corrispon-
denza, mi ha inviato una bella opera sul modo di ristabilire la pace in Europa e diconsolidarla per sempre. La cosa è del tutto praticabile; per realizzarla non man-cano che il consenso dell’Europa e qualche altra sciocchezzuola del genere» (XXII,p. 90).
66 Cfr. Considérations sur l’état présent du corps politique de l’Europe (1738),VIII, pp. 3-4, 21-27. Che l’attività di storico sia quella in cui Federico è massima-mente eccelso lo aveva già osservato W. Dilthey, Friedrich der Grosse, cit., pp. 104-105.
federico ii e la cultura illuministica 43
da una considerazione realistica del mondo67. La celebre chiusa delCandide di Voltaire, in cui il protagonista rinuncia alle magnificheidealità del suo interlocutore leibniziano per concludere che «bisognache lavoriamo il nostro orto», può valere anche per Federico. E il suoorto era la Prussia.
67 Cfr. la lettera a d’Alembert del 7.7.1770, XXIV, p. 544: è bene che gli uominiabbiano «un archétype, un modèle de perfection en vue», senza il quale le loro azionimancherebbero di una guida, ma «ils ne parviendront jamais à cette perfection».
massimo mori44
Eckhart Hellmuth
FEDERICO IL GRANDE E L’ARCHITETTURA
Calce e mattoni furono una vera e propria ossessione per moltiprincipi del tardo Seicento e del Settecento. Con le loro opere di ri-strutturazione e costruzione delle residenze e degli edifici sacri, o conla riorganizzazione di interi paesaggi urbani e la progettazione di par-chi e giardini, i principi cercavano di esprimere la maestosità del lorostatus e il loro gusto artistico. Ancorché si trattasse di un fenomenodiffuso in tutt’Europa, esso trovò un’espressione particolarmente si-gnificativa entro i confini del Sacro Romano Impero. Ciò perché l’Im-pero, data la molteplicità dei suoi possedimenti, rappresentava un am-bito particolarmente propizio per l’attività edificatrice dei sovrani. Il«tarlo del mattone» (Bauwurm) – secondo l’espressione canzonatoriadei contemporanei – imperversava da Dresda a Stoccarda, da Viennaa Mannheim. Neppure i re prussiani ne furono immuni, seppur condiversa intensità. Il Grande Elettore, Federico Guglielmo di Brande-burgo, ad esempio, ordinò la costruzione di un’intera serie di castellia Potsdam, a Berlino e nelle zone circostanti. Il regno del Principeelettore Federico III – che diverrà il primo Re di Prussia con il nomedi Federico I – si connette immediatamente al nome di Andreas Schlü-ter, che con la costruzione dell’Arsenale e della Corte (il cosiddetto«Schlüterhof») del Castello di Berlino («Berliner Stadtschloss») creò leicone della storia dell’architettura prussiana. Persino Federico GuglielmoI, che pare si curasse ben poco delle arti in generale, esibì un’attivitàedificatoria intensa e raffinata dal punto di vista architettonico. Tra lealtre cose, egli fece progettare a Berlino, ove risiedeva, una serie dipiazze molto ampie e decorate da maestosi palazzi nobiliari.
Tra i committenti delle opere architettoniche nel casato degli Hohen-zollern un posto d’eccezione spetta a Federico il Grande1. Nessun
1 Cfr. innanzitutto H.-J. Giersberg, Friedrich als Bauherr. Studien zur Archi-tektur des 18. Jahrhunderts in Berlin und Potsdam, Berlin, Siedler, 1986. Un’ottima
monarca prussiano, né prima né dopo di lui, ha mai esercitato un’at-tività edificatoria tanto intensa2. Ciò concerne innanzitutto le due re-sidenze di Berlino e Potsdam: per un verso, egli conferì un voltonuovo al paesaggio urbanistico berlinese; per l’altro, la sua Potsdam– che venne distrutta dall’ultimo grande attacco aereo appena pochigiorni prima della fine della Seconda Guerra Mondiale3 – è stata giu-stamente ritenuta, accanto a Dresda e a Würzburg, la più bella cittàtedesca del XVIII secolo.
Nella Storia dell’architettura di Potsdam del 1790, Heinrich LudwigManger, consigliere supremo per l’edilizia e ispettore dei giardini dellaCorte prussiana, scriveva che «il sovrano, per sua natura, era un am-miratore delle arti belle e delle scienze, ed era parimenti per convin-zione e orgoglio amante degli edifici utili e sontuosi»4. L’amore di Fe-derico per l’architettura, a cui fa riferimento questo passo di Manger,era incominciato molto presto. Tant’è che Georg Wenzeslaus von Kno-belsdorff, il futuro Sovraintendente ai castelli e giardini reali e Diret-tore generale dell’edilizia nelle province reali, rientrava negli anni Trentadel ’700 tra i membri dell’entourage del Principe ereditario5. Federico
presentazione dell’attività edificatoria di Federico è poi quella di M. Engel, Archi-tektur und Bauherrschaft, in Friedrich der Grosse in Europa. Geschichte einer wech-selvollen Beziehung, a cura di B. Sösemann – G. Vogt-Spira, Stuttgart, Steiner, 2012,I, pp. 260-92.
2 Opportunamente Johannes Kunisch osserva che «guardando a tutto ciò che fucostruito, ampliato e trasformato in Prussia nei 46 anni dell’era di Federico, ci si trovadinanzi a un’opera che non soltanto getta nell’ombra l’attività edificatoria di suononno, il primo re di Prussia sovente disprezzato per le sue dissipazioni, ma che perla sua varietà e originalità potrebbe legittimamente occupare un posto unico nel suogenere all’interno del paesaggio delle residenze dell’ancien régime», J. Kunisch, Frie-drich der Grosse. Der König und seine Zeit, München, Beck, 2004, p. 252.
3 Sulla distruzione di Potsdam nel periodo bellico e postbellico cfr. H. Oster-tag, Vom Strategischen Bombenkrieg zum sozialistischen Bildersturm. Die ZerstörungPotsdams 1945 und das Schicksal seiner historischen Gebäude nach dem Krieg, inPots dam. Staat, Armee, Residenz, a cura di B.R. Kroener, Berlin, Propyläen, 1993,pp. 487-99.
4 H.L. Manger, Baugeschichte von Potsdam, besonders unter der Regierung Kö-nig Friedrichs des Zweiten, Berlin–Stettin, Nicolai, 1789-90, III, p. 542.
5 Sul rapporto tra Federico il Grande e Knobelsdorff cfr. tra gli altri: H.-J. Ka-datz, Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff. Baumeister Friedrichs II., München, Beck,19852; A. Streichhan, Knobelsdorff und das Friderizianische Rokoko, Burg b. Mag-deburg, Hopfer, 1932; T. Eggeling, Knobelsdorffs malerischer Geschmack – «goûtpittoresque», in «Zum Maler und zum grossen Architekten geboren». Georg Wenzes -laus von Knobelsdorff 1699-1753, Ausstellung zum 300.Geburtstag 1699-1753, a curadi T. Eggeling e U.-G. Weickardt, Berlin, Stiftung Preußische Schlösser und GärtenBerlin-Brandenburg, 1999, pp. 21-52.
eckhart hellmuth46
considerava Knobelsdorff uno dei migliori architetti tedeschi: nel 1738lo mandò in Italia e nel 1740 in Francia affinché egli – e il sovranoper suo tramite – acquisisse una certa dimestichezza con la cultura ar-chitettonica di quei Paesi. D’altra parte, già dai tempi in cui era Prin-cipe ereditario Federico il Grande amava collezionare trattati di ar-chitettura e incisioni di edifici celebri6. Per procurarsi queste opereegli ricorreva di frequente all’aiuto di Francesco Algarotti, che avevaconosciuto e incominciato ad apprezzare nel 1739, fino a eleggerloproprio consigliere per le questioni di gusto, di arte e di letteratura.Non stupisce, pertanto, che Federico non si limitasse a commissio-nare opere architettoniche, ma che intervenisse direttamente nella loroprogettazione. Prova eloquente di questa sua attività è rappresentata,tra l’altro, dall’esistenza di suoi numerosi schizzi autografi7. Mangerdescrive in questo modo la ferma volontà del monarca prussiano diintervenire direttamente nella fase di progettazione: «Durante i primiquarant’anni del suo regno, Federico ideava e preparava da sé i primiabbozzi delle facciate esterne dei castelli, degli edifici pubblici, privatie istituzionali di una certa importanza che andavano costruiti, e si oc-cupava personalmente degli ornamenti e degli arredamenti dei suoi al-loggi privati»8. L’ambizione di Federico nelle questioni architettonichesi manifestò innanzitutto – come è già stato osservato – nella ristrut-turazione delle residenze reali di Berlino e Potsdam. Nelle pagine se-guenti verranno delineate le linee portanti di questo processo (§§ 1-2), concludendo con alcune osservazioni generali su Federico qualecommittente di opere architettoniche (§ 3).
1. Una nuova monumentalità a Berlino
Federico il Grande diede inizio alla propria attività edificatoria aBerlino con un progetto effettivamente notevole: la costruzione di unteatro d’opera9. Si tratta della costruzione in Unter den Linden, in cui
6 Cfr. V. Thiele, Architectura Fridericiana – Der König und das Bauwesen, inFriederisiko. Friedrich der Grosse. Die Essays, a cura della Stiftung Preußischer Schlös-ser und Gärten Berlin-Brandenburg, München, Hirmer, 2012, pp. 186-91: p. 187.
7 Un catalogo dei disegni architettonici di Federico il Grande si trova in H.-J.Giersberg, Friedrich als Bauherr, cit., pp. 316-19.
8 H.L. Manger, Baugeschichte von Potsdam, cit., III, p. 542.9 Sulla storia dell’edificazione dell’Opera cfr.: H.-J. Kadatz, Georg Wenzeslaus
von Knobelsdorff, cit., pp. 125-34; A. Streichhan, Knobelsdorff und das Friderizia-nische Rokoko, cit., pp. 37-45; M. Engel, Das Forum Fridericianum und die monu-
federico il grande e l’architettura 47
oggi si trova l’Opera di Berlino («Deutsche Staatsoper»). L’edificio at-tuale, però, è profondamente diverso da quello del XVIII secolo: letrasformazioni edilizie occorse nei primi tre decenni del XX secolo ele misure adottate per rimediare ai danni provocati dalla SecondaGuerra Mondiale ne hanno pregiudicato in maniera persistente l’a-spetto interno ed esterno. Dell’edificio originario rimane oggi benpoco.
Per lungo tempo il progetto di questo teatro d’opera, iniziato nel1741 e inaugurato appena due anni dopo, venne attribuito a Knobels -dorff. Nel frattempo si sono però trovate ottime ragioni per credereche Federico – secondo un uso a lui consono – fosse intervenuto di-rettamente nella progettazione, in particolare per quel che concerne
mentalen Residenzplätze des 18. Jahrhunderts, dissertazione presentata alla Freie Uni-versität di Berlino nel 2001, p. 114 (URL = http://www.diss.fu-berlin.de/diss/serv-lets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate_000000004525/diss_engel.pdf?hosts, ul-tima consultazione 04.9.2013); E. Fürstenau, Das Opernhaus im Laufe der Zeiten,in 185 Jahre Staatsoper. Festschrift zur Wiedereröffnung des Opernhauses Unter denLinden (1928), a cura di J. Kapp, Berlin, Atlantic, 1937, pp. 119-68: p. 121-29; E.Meffert, Das Haus der Staatsoper und seine Baumeister, Leipzig, Beck, 1942, pp.22-43; H. Mackowsky, Das Opernhaus Friedrichs des Grossen und sein Erbauer G.W.von Knobelsdorff, in «Kunst und Künstler: illustrierte Monatsschrift für bildendeKunst und Kunstgewerbe», 4, 1906, pp. 308-13 e pp. 337-46; L. Schneider, Ge-schichte der Oper und des königlichen Opernhauses in Berlin, Berlin, Duncker undHumblot, 1852, pp. 55-85. Sul carattere innovativo dell’Opera come teatro cfr. H.Lange, Vom Tribunal zum Tempel. Zur Architektur und Geschichte Deutscher Hofthea-ter zwischen Vormärz und Restauration, Marburg, Jonas, 1985, pp. 102-104.
eckhart hellmuth48
Fig. 1
l’aspetto esteriore dell’edificio10. Fra i trattati di architettura in pos-sesso del monarca prussiano si trovava infatti il Vitruvius Britannicus,un’opera in tre volumi pubblicata tra il 1715 e il 1725 dall’architettoscozzese Colen Campbell, che documentava i lavori di celebri archi-tetti del tempo ed era destinata a diventare l’opera di riferimento delneopalladianesimo britannico. Nel primo volume del Vitruvius si trovail progetto dello stesso Campbell relativo al Wansted (Wanstead) House,palazzo che gli era stato commissionato da Sir John Child, futuro vi-sconte di Castelemaine.
Evidentemente Federico doveva essere rimasto così colpito da quelprogetto da spingere Knobelsdorff a recuperare alcuni elementi es-senziali del palazzo di Campbell per l’Opera berlinese11. Ciò significache il monarca prussiano si fece costruire nel centro di Berlino unteatro che, per sua espressa volontà, esibisse una facciata ornata se-condo un progetto originariamente concepito per un palazzo nobi-liare inglese. Federico il Grande aveva un’indubbia predilezione perla citazione architettonica e per la copia, come mostrerà chiaramenteil corso della sua attività edificatoria12. Nel caso della costruzione del-l’Opera di Berlino, questa sua predilezione determinò l’impossibilità
10 Cfr. M. Engel, Das Forum Fridericianum, cit., pp. 100-101.11 Cfr. tra gli altri: R. Wegner, Nach Albions Stränden. Die Bedeutung Englands
für die Architektur des Klassizismus und der Romantik in Preußen, München, Sca-neg, 1994, pp. 26-29; Id., Friedrich der Grosse und die englische Kunst, in «Zeit schriftdes Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft», 42, 1988, pp. 49-59, in particolare pp.52-53.
12 Cfr. innanzitutto A.P. Hagemann, Zitat und Kopie bei Friedrich II., in Frie-derisiko, cit., pp. 176-85.
federico il grande e l’architettura 49
Fig. 2
di capire, guardando all’aspetto esteriore dell’edificio, per quale fineesso fosse stato realmente concepito. La sua funzione era invece ri-velata dalle iscrizioni e dagli ornamenti scultorei della facciata: le co-lonne del porticato che si affaccia su Unter den Linden, ad esempio,riportano l’iscrizione «Fridericus Rex Apollini et Musis», mentre ilfrontone presenta una raffigurazione di Apollo, il dio dell’armonia edella musica. Nella visione di Federico, il palazzo non doveva venirimpiegato esclusivamente per le manifestazioni operistiche e musicali;esso doveva ospitare anche danze e balli in maschera. Le stravaganzedi corte e l’opulenza non erano affatto estranee al regime fridericiano13.
Già nel 1743, quindi nell’anno dell’inaugurazione dell’Opera di Ber-lino, J.G. Fünck, Controllore per l’edilizia al servizio di Knobelsdorff,eseguì e presentò un’incisione che mostrava al pubblico colmo di in-teresse il nuovo tempio delle muse di Federico. L’incisione ritraeva l’e-dificio sul limitare di un campo incolto in città – viene naturale do-mandarsi come mai il monarca prussiano abbia scelto proprio una sedecome quella per il suo primo grande progetto architettonico.
13 Cfr. innanzitutto T. Biskup, Eines «Grossen» würdig? Hof und Zeremoniellbei Friedrich II., in Friederisiko, cit., pp. 98-115. Cfr. inoltre le parti dedicate alla me-desima questione in Id., Friedrichs Grösse. Inszenierung des Preussenkönigs in Festund Zeremoniell 1740-1815, Frankfurt/Main, Campus, 2012.
eckhart hellmuth50
Fig. 3
La ragione di questa scelta apparentemente curiosa era questa: ilmonarca voleva costruire una Residenza monumentale nel centro diBerlino, su un terreno fino ad allora mai edificato, e circondarla ditutti gli edifici del caso. L’Opera non era dunque concepita come unacostruzione isolata e solitaria, ma come il primo edificio del cosid-detto Forum Fridericianum14. Il piano di questo enorme progetto ri-saliva a Knobelsdorff: egli voleva costruire a nord di Unter den Lin-den un Palais du Roy, lungo 300 metri e profondo 150, che avrebbesostituito il vecchio castello reale sito nella parte orientale della città.Era prevista una costruzione tripartita con due corti interne e un am-pio cortile d’onore, il quale avrebbe dovuto essere delimitato nellaparte meridionale prospiciente il palazzo reale da un colonnato a quat-tro file. L’Opera e il «Ballhaus» (Sala da ballo), all’incirca delle me-desime dimensioni, avrebbero dovuto affacciarsi sull’altro lato di Un-ter den Linden, di fronte al Palais du Roy. Il progetto di Knobels -dorff, che come molti altri progetti architettonici del tempo era pen-sato secondo le regole della simmetria, non venne però realizzato, nonda ultimo perché il casato Brandeburg-Schwedt si rifiutò di lasciar de-molire un palazzo di sua proprietà.
Federico il Grande non abbandonò comunque il progetto di unaresidenza monumentale. Intervenne personalmente nel progetto diKnobelsdorff, modificando la collocazione dei due edifici accessori.L’Opera venne ruotata di 90° e l’altro edificio, originariamente con-cepito per il ballo, venne sostituito con la costruzione decisamente piùdispendiosa di un nuovo palazzo per l’Accademia. In questa manieravenne abbandonata anche la disposizione simmetrica dei due edifici.Tuttavia, per diverse ragioni, questo progetto rimase sulla carta. Il Fo-rum Fridericianum venne sì costruito, ma non sulla base del progettooriginario di Knobelsdorff, ben concepito e ispirato alle regole di un’e-stetica coerente. Al suo posto, nel corso dei tre decenni successivi,comparvero una serie di edifici con stili estremamente differenti, lacui costruzione non rispondeva affatto a un piano di lungo respiro,ma piuttosto a interventi rapsodici e contingenti del monarca.
Ciò emerge in maniera particolarmente evidente dalla vicenda cheha accompagnato la costruzione della Chiesa di Sant’Edvige («Hedwigs -kirche»)15. L’annessione della Slesia, sancita nel 1745 dalla Pace di Dre-
14 Per quel che segue cfr. l’eccellente presentazione di M. Engel, Das Forum Fri-dericianum, cit., pp. 61-71.
15 Per la storia dell’architettura cfr. innanzitutto: T. Meijknecht – M. Schnee-mann, Der Bau der St. Hedwigskirche in Berlin 1746-1773, in «Mededelingen van
federico il grande e l’architettura 51
sda, aumentò in maniera esorbitante il numero dei sudditi cattolicidella corona prussiana. Stando così le cose, Federico il Grande decisedi far costruire all’interno del Forum Fridericianum una chiesa catto-lica dedicata a Sant’Edvige, protettrice della Slesia. Il 13 luglio del 1747ci fu la posa della prima pietra, compiuta con un dispendio notevolealla presenza della nobiltà cattolica e dell’emissario degli Stati catto-lici in Prussia. Si era deciso di erigere la chiesa su un terreno postosul confine sudorientale del Forum Fridericianum, in prossimità del-l’Opera. Questa soluzione angolare impediva la costruzione di un edi-ficio a pianta rettangolare; pertanto si optò per una costruzione a cu-pola, ispirata al modello romano del Pantheon, la cui curva obliquadoveva risultare particolarmente impressionante per chi scendeva Un-ter den Linden arrivando da occidente – un effetto di cui si può be-neficiare ancor oggi. Nelle incisioni del tempo si riconosce un’archi-tettura ispirata al modello romano del Pantheon, il cui aspetto impo-nente è determinato innanzitutto dal portico con i suoi rilievi.
het Nederlands historisch instituut te Rome», 35, 1971, pp. 113-93; M. Hasak, DieSt. Hedwigskirche zu Berlin und ihr Erbauer Friedrich der Große, Berlin, Heymanns,1932; H.-J. Giersberg, Friedrich als Bauherr, cit., pp. 250-84; S. Badstübner-Grö-ger, Die St.-Hedwigs-Kathedrale zu Berlin, Regensburg, Schnell & Steiner, 20002,pp. 2-19; T. Eggeling, Friderizianische Antikenrezeption am Beispiel der Hedwigskir-che und der Oper, in Katalog Berlin und die Antike. Architektur, Kunstgewerbe, Ma-lerei, Skulptur, Theater und Wissenschaft vom 16. Jahrhundert bis heute, a cura di W.Arenhövel, Berlin, Hellmich, 1979, pp. 113-19; M. Engel, Das Forum Fridericianum,cit., pp. 123-56.
eckhart hellmuth52
Fig. 4
Anche in questo caso l’idea originaria dell’edificio sacro risaliva aFederico il Grande, mentre la progettazione successiva e l’esecuzionevenne nuovamente affidata a Knobelsdorff.
La costruzione della Hedwigskirche rappresentò indiscutibilmenteuna questione politica di primo piano. Occorreva dimostrare al mondoche nella Prussia di Federico il Grande era iniziata l’era della tolle-ranza illuminata. Sebbene il monarca avesse fatto partire lui stesso ilprogetto di costruzione, i lavori si protrassero per oltre un ventenniopoiché le donazioni dell’Europa cattolica – la principale fonte di fi-nanziamento dell’opera – divennero estremamente esigue a partire da-gli anni Cinquanta del secolo. La consacrazione avvenne pertanto ap-pena nel novembre del 1773. Ma ancora a quel tempo – come mo-stra un’incisione del 1777 – si aveva l’impressione di trovarsi di frontea un’opera incompiuta: continuava a mancare la lanterna sulla cupola,prevista dal progetto originario, e la sacrestia annessa alla costruzionecircolare aveva l’aspetto di una rovina. Ciononostante, accanto allaHofkirche di Dresda, la Hedwigskirche rappresentava la più grandechiesa cattolica del nord protestante della Germania.
Quasi in contemporanea con la Hedwigskirche venne eretto unaltro edificio centrale del Forum Fridericianum, il palazzo del Prin-cipe Enrico16, che all’inizio del 1800 divenne la sede della neofondata
16 Cfr. innanzitutto K.-D. Gandert, Vom Prinzenpalais zur Humboldt-Univer-sität, Berlin, Henschel, 19853, pp. 17-44, nonché M. Engel, Das Forum Fridericia-num, cit., pp. 157-65.
federico il grande e l’architettura 53
Fig. 5
Università di Berlino e che oggi, dopo la ricostruzione (1945-1961),ospita la Humboldt-Universität. Il palazzo del Principe Enrico erastato concepito come un regalo di Federico il Grande al fratello mi-nore, che si era distinto come condottiero militare nelle due campa-gne contro la Slesia. I lavori per la costruzione del palazzo iniziarononel 1748, vennero interrotti durante la Guerra dei Sette anni e si con-clusero nel 1766. Il palazzo venne costruito nella zona settentrionaledel Forum Fridericianum, quindi nell’area in cui secondo il piano ori-ginario di Knobelsdorff era previsto il Palais du Roy. Come nel casodel Palais du Roy, anche qui si trattava di un edificio a tre ali, la cuifacciata anteriore, insieme alla cancellata che circondava il cortile d’o-nore, si affacciava su Unter den Linden. La struttura fondamentale diquesto palazzo assomiglia in maniera sorprendente al Palais du Roydi Knobelsdorff, seppur con dimensioni molto ridotte. Mentre nelprogetto di Knobelsdorff la facciata anteriore era lunga 300 metri, nelcaso del palazzo del Principe Enrico non si superavano i 150 metri.Ciò aveva come conseguenza, tra l’altro, che i cortili laterali non eranocompletamente recintati, ma rimanevano aperti su uno o su due lati.E tuttavia – come mostrano gli schizzi relativi alla facciata anterioree a quella prospiciente il giardino – il palazzo del Principe Enrico eraun edificio molto imponente.
eckhart hellmuth54
Fig. 6
Non è chiaro chi fosse l’autore del progetto. Solitamente viene at-tribuito al più vecchio dei Boumann, che di lì a poco sarebbe dive-nuto Direttore generale dell’edilizia prussiana. Senz’altro Boumann,esperto riconosciuto nelle questioni architettoniche, rivestì un ruolodi primo piano nella costruzione di questo edificio, come in quelladella Hedwigskirche; tuttavia non è certo che egli abbia esercitatoun’influenza significativa sulla progettazione dell’edificio. C’è chi hasostenuto con buoni argomenti che anche in questo caso ci sia statol’intervento di Knobelsdorff (Martin Engel). Quel che però importaè che anche qui, come nel caso della Hedwigskirche e dell’Opera, ledirettive principali provenivano direttamente da Federico il Grande:si è conservato un suo abbozzo autografo del progetto della facciataprincipale del palazzo del Principe Enrico.
L’Opera, la Hedwigskirche e il palazzo del Principe Enrico mo-strano una certa uniformità di stile. Ciò può dipendere dal fatto cheKnobelsdorff aveva assai verosimilmente partecipato a tutti e tre i pro-getti17. Il quarto grande edificio introdotto nel Forum Fridericianumall’epoca di Federico il Grande, invece, è di tutt’altro genere. Si trattadella Biblioteca reale, costruita tra il 1774 e il 1786 su progetto diGeorg Christoph Unger e sotto la direzione di Georg Friedrich Bou-man18.
17 Ivi, p. 160.18 Sulla storia dell’architettura della biblioteca reale cfr.: A. Hortzschansky, Die
Königliche Bibliothek zu Berlin: ihre Geschichte und ihre Organisation, Berlin, Beh-
federico il grande e l’architettura 55
Fig. 7
Il progetto di Unger per la facciata esterna della Biblioteca nonera altro che la copia della facciata di San Michele («Michaelerfront»)che Joseph Emanuel Fischer von Erlach aveva progettato per la corteviennese nel 1726. Ciò rispondeva alla volontà esplicita del sovranoprussiano. Per la Biblioteca reale Unger doveva quindi prendere amodello la forma di un edificio originariamente concepito per tutt’al-tro contesto urbanistico e per tutt’altra funzione. Non mancaronole difficoltà: l’interno e l’esterno non si armonizzavano affatto. È si-gnificativo il fatto che la sala lettura venne distaccata: la bibliotecadi Unger era quindi più un deposito di libri che una vera e propriabiblioteca. Come per l’Opera, anche in questo caso occorreva guar-dare agli ornamenti scultorei per capire quale fosse la funzione del-l’edificio: la sola forma architettonica non forniva nessun indizio ariguardo. Inoltre, la linea concava della facciata venne ridotta dellametà rispetto all’originale, il che ne compromise significativamentela resa estetica della profondità della parte anteriore. Solo in questomodo fu però possibile introdurre la Biblioteca nel complesso delForum Fridericianum; e tuttavia l’opera nel suo complesso non sem-brò mai particolarmente riuscita. Engel osservò giustamente che «ilnuovo edificio della Biblioteca venne inserito in quello spazio comeun corpo estraneo che non aveva nulla a che vedere con gli edificigià presenti, né quanto alla forma originaria, né quanto ai singolidettagli. Il progetto della piazza, ormai concluso da vent’anni, vennerimaneggiato, rinunciando completamente alla simmetria e all’armo-nia»19. Tra i contemporanei non mancarono le critiche a quest’operadi Unger20.
Si è ampiamente dibattuto sulle ragioni che indussero Federico ilGrande a far costruire nel cuore di Berlino un’opera architettonicadell’epoca di Carlo VI d’Asburgo, il padre di Maria Teresa. Questasua scelta è stata interpretata come un gesto trionfale, come l’atto concui il monarca prussiano aveva voluto dimostrare la superiorità della
rend, 1908, pp. 49-53; E. Paunel, Die Staatsbibliothek zu Berlin. Ihre Geschichteund Organisation während der ersten zwei Jahrhunderte seit ihrer Eröffnung 1661-1871, Berlin, de Gruyter, 1965, pp. 55-64; F. Wilken, Geschichte der königlichen Bi-bliothek zu Berlin, Berlin, Duncker und Humblot, 1828, pp. 95-97; M. Engel, DasForum Fridericianum, cit., pp. 184-96.
19 Ivi, p. 184. Sul carattere anacronistico di questo edificio cfr. anche W. Rü-digkeit, Bauten und Entwürfe für eine Königliche und Staatsbibliothek in Berlin, in325 Jahre Staatsbibliothek zu Berlin, a cura di W. Schochow, Wiesbaden, Reichert,1986, pp. 15-35: p. 20.
20 Cfr. E. Paunel, Die Staatsbibliothek zu Berlin, pp. 60-61.
eckhart hellmuth56
sua Prussia21. Fino ad allora, infatti, gli Asburgo non erano stati ca-paci di realizzare il progetto che Fischer von Erlach aveva presentatogià nel 1726 – cosa, questa, che sarebbe avvenuta soltanto verso lafine dell’Ottocento. Quest’interpretazione non ha però nessun fonda-mento: Federico il Grande non si espresse mai in questo senso, e nep-pure i contemporanei concepirono mai l’architettura della Bibliotecareale in polemica con la Casa d’Austria22. Sembra invece assai più sen-sato pensarla in un’altra maniera: come si è visto nel caso dell’Opera,e come dimostrano numerosi altri esempi della storia dell’architetturadi Potsdam, Federico amava le citazioni architettoniche, le copie. Eglicollezionava copie degli edifici che riteneva modelli di una cultura ar-chitettonica straordinaria. Per quanto questa passione fosse di certoanimata da un interesse genuino per quest’arte, egli non voleva sa-perne delle nuove correnti architettoniche che incominciavano a cir-colare in Europa alla fine del secolo XVIII. Al contrario, come sievince dalla costruzione della Biblioteca reale nel complesso del Fo-rum Fridericianum, egli coltivava un proprio gusto intriso di motiviarcaici23. In un’epoca in cui gli architetti si apprestavano a scoprire unnuovo vocabolario architettonico ispirato alla Grecia classica, la ri-presa di un progetto dell’alto barocco doveva apparire quanto menoassurda24.
Nonostante il carattere estremamente bizzarro della Biblioteca reale,i contemporanei furono profondamente impressionati dalla piazza mo-numentale che era sorta nel corso di quattro decenni nel centro dellacittà.
Nel 1786 Friedrich Nicolai celebrava la conclusione dei lavoridel Forum Fridericianum con queste parole: «La piazza dell’Operasi estende dai ponti della città nuova fino ai Tigli (Linden). È unadelle più belle piazze del mondo, su cui si ergono edifici e palazziassolutamente magnifici»25. Il Forum Fridericianum era però solo una
21 In questo senso si esprime di recente A.P. Hagemann, Zitat und Kopie beiFriedrich II., pp. 182-83.
22 Cfr. M. Engel, Das Forum Fridericianum, cit., pp. 184-85.23 Sull’arretratezza delle concezioni architettoniche di Federico II cfr. F.E. Kel-
ler, Probleme der spätfriderizianischen Architektur, in «Zeitschrift des deutschen Ve-reins für Kunstwissenschaft», 42, 1988, pp. 61-77.
24 Cfr. D. Watkin-T. Wellinghoff, German Architecture and the Classical Ideal1740-1840, London, Thames and Hudson, 1987, in particolare pp. 59-84.
25 F. Nicolai, Beschreibung der Königlichen Residenzstädte Berlin und Potsdam,aller daselbst befindlicher Merkwürdigkeiten, und der umliegenden Gegend, Berlin-Stettin, Nicolai, 17863, p. 168.
federico il grande e l’architettura 57
parte di un progetto ben più ampio, vale a dire quello della valo-rizzazione di Berlino, capitale del regno e residenza reale. Tra gli in-terventi architettonici intrapresi da Federico rientravano la realizza-zione del Duomo, la ricostruzione dell’Accademia che era stata di-strutta da un incendio, l’ampliamento del castello di Monbijou e diCharlottenburg, l’ammodernamento dei ponti e delle porte cittadine,e l’esecuzione di opere ornamentali come i due colonnati noti comeSpittelkolonnaden e Königskolonnaden. Venne inoltre radicalmentetrasformata la piazza nota come Gendarmenmarkt: al centro si co-struì un teatro francese, ed entrambe le chiese – quella luterana equella francese-riformata – vennero dotate di due cupole voluminosee identiche. Infine, Federico il Grande fece realizzare numerosi Im-mediatbauten in zone celebri della città: si trattava di edifici privati,completamente o parzialmente finanziati dal monarca, le cui facciatesontuose dovevano suscitare una grande ammirazione. Tutto ciò erapensato allo scopo di conferire a Berlino l’aspetto di una metropolieuropea.
2. Potsdam: la corte e la città
Il progetto dell’abbellimento e della valorizzazione di Berlino oc-cupò Federico fino alla fine del suo regno; nondimeno il fulcro dellasua attività edificatoria era Potsdam. Soprattutto qui gli riuscì infattidi realizzare le sue intuizioni architettoniche; probabilmente perché
eckhart hellmuth58
Fig. 8
proprio Potsdam divenne la sua residenza effettiva26. Già nel 1743 Fe-derico trasferì i suoi appartamenti nel castello di Potsdam. L’edificio,che non era in condizioni ottimali, venne successivamente ristruttu-rato27. Inizialmente il monarca si limitò a interventi di risanamento edi manutenzione; ma, come narra Mager nella Storia dell’architetturadi Potsdam, «già all’inizio del 1745 il sovrano decise di non occuparsiesclusivamente del risanamento esteriore e della tinteggiatura della re-sidenza reale, ma di impreziosirne ulteriormente gli ornamenti sia al-l’esterno sia all’interno. Il sovrano ordinò dunque al Barone von Kno-belsdorff di preparare dei progetti per le facciate esterne»28. In que-sto racconto Mangel menzionava, tra l’altro, la costruzione di unanuova ala, la realizzazione di colonnati e soprattutto il riassetto dellafacciata principale. In particolar modo a partire dal 1747 Federico in-cominciò a dedicarsi in maniera molto intensa alle opere architettoni-che di Potsdam. Il progetto dello straordinario risalto centrale che im-
26 Cfr. tra gli altri: Friedrich und Potsdam. Die Erfindung seiner Stadt, a cura diJ. Götzmann, München, Hirmer, 2012; F. Mielke, Potsdamer Baukunst. Das klassi-sche Potsdam, Frankfurt, Propyläen, 19912, pp. 36-83; H. Kania, Die Architektur derStadt Potsdam im 18. Jahrhundert, Potsdam, Jaeckel, 1909.
27 Cfr. per quel che segue H.-J. Giersberg, Friedrich als Bauherr, cit., pp. 50-77.28 H.L. Manger, Baugeschichte von Potsdam, cit., vol. 1, p. 39.
federico il grande e l’architettura 59
Fig. 9
preziosisce il giardino prospiciente la facciata principale del castello,ad esempio, si basa proprio su un abbozzo di Federico.
Analogamente al caso della costruzione dell’Opera berlinese, fonted’ispirazione per il sovrano e per Knobelsdorff fu il neopalladianesimoinglese nella versione del Vitruvius Britannicus di Campbell. Gli in-terventi massicci operati sulla parte esteriore del castello di Potsdam siprolungarono all’interno, dove il sovrano intraprese sontuose opere didecorazione. Quando nel 1752, dopo otto anni di lavori, l’opera giunsea conclusione, «il castello di Potsdam, che dall’esterno non aveva maiavuto un aspetto particolarmente gradevole, si era ormai trasformatoin un edificio di rappresentanza che, grazie all’armonia della strutturaarchitettonica, ai ricchi ornamenti plastici e, non da ultimo, alla sua vi-vace policromia, offriva una visione assolutamente magnifica»29.
29 H.-J. Giersberg, Friedrich als Bauherr, cit., p. 72.
eckhart hellmuth60
Fig. 10
Il castello di Potsdam era concepito come residenza invernale delmonarca, il quale d’estate si trasferiva nel castello di Sanssouci, dovedi norma viveva e lavorava dalla fine di aprile all’inizio di ottobre30.Questa residenza estiva è stata di frequente ritenuta la quintessenzadella cultura architettonica fridericiana. Senza dubbio Sanssouci – comedimostrano tra l’altro schizzi autografi di Federico il Grande, relativial palazzo e al giardino – rappresenta il progetto architettonico in cuitraspare in maniera più evidente la personalità del monarca prussiano.
Il fascino particolare di questo castello deriva dall’insolita combi-nazione di elementi architettonici e naturali: Sanssouci sorgeva infattisull’estremità superiore di un vigneto.
Diversamente da quanto si crede, nella marca del Brandeburgo sierano iniziati a coltivare vitigni sin dal XIII secolo, e per questa ra-gione non dovette sembrare affatto bizzarro che, il 10 agosto 1744,Federico il Grande ordinasse di coltivare con vigneti a terrazze il co-
30 Sul castello di Sanssouci cfr.: W. Kurth, Sanssouci. Ein Beitrag zur Kunst desdeutschen Rokoko, Berlin, Henschelverlag, 1962; H.-J. Giersberg, Schloss Sanssouci.Die Sommerresidenz Friedrichs des Grossen, Berlin, Nicolaische Verlagsbuchhandlung,2005, pp. 32-79; Id., Friedrich als Bauherr, cit., pp. 78-143; F. Mielke, PotsdamerBaukunst, cit., pp. 36-83.
federico il grande e l’architettura 61
Fig. 11
siddetto «Wüstenberg». Sotto la direzione dell’architetto FriedrichWilhelm Diterich, il versante meridionale venne diviso in sei largheterrazze da una serie di muretti arcuati e piegati verso l’interno, in ma-niera da sfruttare quanto più possibile i raggi del sole. Nel 1746 i la-vori relativi ai vigneti terrazzati erano pressoché conclusi. Già il 13gennaio 1745 Federico aveva disposto la costruzione di un padiglionea Potsdam, il cosiddetto Lust-Haus, e il 14 aprile dello stesso annovenne posata la prima pietra. Il Lust-Haus era Sanssouci, dove Fede-rico si insediò dopo appena due anni di lavori di ristrutturazione, no-nostante la residenza non fosse ancora pronta. Il palazzo in stile ro-cocò e disposto su un solo livello, da cui si apriva il passaggio direttoal giardino circostante, era pensato appositamente per rispondere alleesigenze private del monarca. Il suo carattere intimo lo rendeva qual-cosa di decisamente diverso da una comune residenza signorile. Evi-dentemente Federico il Grande non voleva un edificio di rappresen-tanza, ed è significativo il fatto che egli si rifiutò di dar seguito allaproposta di Knobelsdorff di innalzare Sanssouci su un piano semi-in-terrato e avvicinarlo al margine della terrazza superiore affinché otte-nesse maggior visibilità se guardato dai piedi del vigneto31. Nel corsodegli anni, poi, il parco circostante venne impreziosito con una seriedi costruzioni, tra cui la Sala cinese per il tè, il Tempio dell’amicizia edegli antichi, il Belvedere e la Casa dei draghi. Quanto il monarca sisentisse intimamente legato a Sanssouci e al suo parco risulta peraltroevidente dal fatto che egli desiderava venir sepolto proprio lì. Nel te-stamento del 1752 Federico aveva infatti disposto quanto segue: «misi porti a Sanssouci al lume di una lanterna e senza seguito alcuno, emi si seppellisca in quel luogo, semplicemente, sulla cima della ter-razza, sul lato destro salendo, nella cripta che mi sarò fatto prepa-rare»32. Ma questo desiderio di Federico si avverò soltanto nel 199133.
Nelle immediate vicinanze della residenza estiva di Federico ilGrande, nella parte occidentale del parco di Sanssouci, tra il 1763 eil 1769 venne costruito il Palazzo Nuovo (Neues Palais)34. Il maestoso
31 S. Hüneke (a cura di), Bauten und Bildwerke im Park Sanssouci. AmtlicherFührer der Stiftung Preussischer Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Potsdam,Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, 2002.
32 Testamento dell’11 gennaio 1752, in Die Werke Friedrichs des Großen, VII, acura di G. Berthold Volz, Berlin, Hobbing, 1913, pp. 276-80: p. 276.
33 Cfr. H. Bentzien, Die Heimkehr der Preussenkönige, Berlin, Volk und Welt,1991, nonché H.-J. Giersberg-R-H. Krüger, Die Ruhestätte Friedrichs des Grossenzu Sanssouci, Berlin, Nicolaische Verlagsbuchhandlung, 1991.
34 Sul Neues Palais cfr. tra gli altri: H. Drescher-S. Badstübner-Gröger, Das
eckhart hellmuth62
edificio a tre ali – l’ultimo grande castello tedesco in stile rococò –aveva una facciata frontale lunga 220 metri; al suo centro si ergevaun’enorme cupola che raggiungeva i 55 metri d’altezza.
Il castello principale venne completato con due Communs, colle-gati da un colonnato semicircolare.
In un certo senso si trattava della realizzazione di un sogno finoad allora rimasto incompiuto, vale a dire la costruzione di un palazzomonumentale che Federico aveva progettato insieme a Knobelsdorffgià all’inizio del suo regno per il Forum Fridericianum e che non eramai riuscito a realizzare. Già tra il 1755 e il 1756 il monarca prus-siano aveva accarezzato l’idea di costruire un enorme castello che fun-gesse da pendant di Sanssouci sulla riva della Havel. Con il soprag-giungere della Guerra dei Sette anni questi piani vennero necessaria-mente abbandonati e soltanto dopo la Pace di Hubertusburg fu nuo-
Neue Palais in Potsdam. Beiträge zum Spätstil der friderizianischen Architektur undBauplastik, Berlin, Akademie Verlag, 1991; K. Dorst, Das Neue Palais von Sans-souci. Architektonischer Schlussakkord des friderizianischen Zeitalters, in Friederisiko,cit., pp. 280-85; S. Hüneke, «Nec soli cedit» – Dekoration und Bauskulptur am NeuenPalais, in ivi, pp. 286-93.
federico il grande e l’architettura 63
Fig. 12
vamente possibile riconsiderare seriamente il progetto, ancorché nonpiù situandolo sulla riva della Havel, ma – come detto – nella parteoccidentale del parco di Sanssouci, nel cosiddetto Giardino dei caprioli(«Rehgarten»). Il posto era stato scelto da Federico in persona. Egliintervenne in maniera particolarmente vigorosa nel progetto e nellacostruzione del Neues Palais; spesso, anzi, il monarca non teneva innessun conto il parere degli architetti impegnati nel progetto (JohannGottfried Büring, Heinrich Ludwig Manger e Carl von Gontard).Così sorse un castello che, tanto nel suo aspetto esteriore quanto alsuo interno, rispondeva perfettamente al gusto di Federico il Grande,ispirato a modelli risalenti ai primi del Settecento. Ma, a differenza diquanto si può pensare, il castello con le sue 200 stanze, i quattro sa-loni per le feste e il teatro in stile rococò non era affatto concepitocome una residenza reale. Federico se ne servì peraltro in maniera sol-tanto sporadica. Il palazzo fungeva innanzitutto da dimora per gliospiti della corte prussiana, in particolare per i membri della dina-stia35, ancorché per un tal fine fosse assolutamente sovradimensio-
35 K. Zielosko, Verwandtenbesuch. Das Neue Palais als Bühne dynastischer
eckhart hellmuth64
Fig. 13
nato36. Il Neues Palais era più di una foresteria di corte; nella sua mo-numentalità esso rappresentava piuttosto un gesto trionfale, un segnodell’affermazione della Prussia tra le grandi potenze europee all’indo-mani della Guerra dei Sette anni. Occorreva mostrare al mondo in-tero la grandezza della monarchia prussiana. Lo stesso Federico conuna qualche autoironia definiva il Neues Palais una «fanfaronata».
Sanssouci e il Neues Palais furono indubbiamente le opere archi-tettoniche più spettacolari che Federico mise in scena a Potsdam. Maesse erano, per così dire, solo le punte di un iceberg. A Potsdam, inmaniera assai più radicale che a Berlino, l’attività edificatoria di Fe-derico rivoluzionò l’intero paesaggio urbanistico. Egli non si ispirava,qui, all’ideale della regolarità, come aveva fatto per le altre residenze,ad esempio a Karlsruhe o a Mannheim. Nel caso di Potsdam fecepiuttosto sorgere spettacolari edifici solitari; tra l’altro, costruì nuovechiese e ne restaurò di vecchie, realizzò maestose porte cittadine e in-tere zone urbane cambiarono radicalmente volto grazie alla costru-zione di numerosi Immediatbauten. Federico creò a Potsdam unasorta di museo dell’architettura, non da ultimo grazie al fatto che com-missionava ai propri architetti la costruzione di copie di edifici cele-bri e importanti, che egli conosceva unicamente attraverso le incisioniin suo possesso. La citazione architettonica e la copia, che a Berlinoavevano rappresentato un’eccezione (come nel caso dell’Opera e dellaBiblioteca reale), a Potsdam divennero la norma. Qui si rifletteva lapredilezione del monarca per l’architettura barocca e rinascimentaleitaliana. Di conseguenza, il Mercato Vecchio (der Alte Markt) vennetrasformata in una sorta di piazza italiana37.
Tra il 1752 e il 1755, su progetti di Knobelsdorff, il lato dellachiesa di San Nicola (Nicolaikirche) che si affacciava sul Mercato Vec-chio venne ornato con una facciata in perfetto stile barocco tardoro-mano. Non era altro che la copia, in dimensioni ridotte, della facciatadi Santa Maria Maggiore a Roma. Quasi contemporaneamente Fede-
Selbst inszenierung, in Friedrich der Grosse und die Dynastie der Hohenzollern. Bei-träge des fünften Colloquiums in der Reihe «Friedrich300» vom 30. September/1.Ok-tober 2011, a cura di M. Kaiser – J. Luh, URL = http://www.perspectivia.net/con-tent/publikationen/friedrich300-colloquien/friedrich-dynastie/zielosko_verwandtenbe-such (ultima consultazione 04.9.2013).
36 Cfr. H. Graf, Das Neue Palais – Funktion und Disposition der Appartements,in ivi, pp. 294-303.
37 Cfr. il lavoro recente di J. Götzmann, Veduta ideata. Der alte Markt in Pots -dam als Auftakt und Höhepunkt der friderizianischen Stadtgestaltung, in Id., Fried -rich und Potsdam. Die Erfindung seiner Stadt, München, Hirmer, 2012, pp. 22-29.
federico il grande e l’architettura 65
rico commissionò a Boumann e a Carl Ludwig Hildebrandt di ri-progettare il vecchio municipio. La scelta del monarca cadde su unprogetto mai eseguito che Andrea Palladio aveva preparato per Pa-lazzo Angarano a Vicenza. La cupola con la raffigurazione di Atlanteche sovrastava il vecchio municipio si ispirava al palazzo del munici-pio di Amsterdam. Il Direttore generale dell’edilizia Carl von Gon-tard fece la felicità di Federico il Grande facendo costruire tra il 1771e il 1772 una copia di Palazzo Barberini a Roma38, che era stato rea-lizzato a partire dal 1625 sui progetti di Carlo Maderno, GianlorenzoBernini e Francesco Borromini.
Anche dall’altro lato del Mercato Vecchio si trovavano parecchiesempi di architettura italiana: ad esempio un edificio borghese cheriprendeva il progetto che Michele Sanmicheli aveva preparato intornoal 1530 per Palazzo Pompei a Verona39.
Federico non imponeva ai suoi architetti e costruttori di ispirarsisoltanto all’architettura italiana; egli prendeva a modello anche le operedi architetti francesi e inglesi. In particolare egli dava mostra di una
38 Cfr. F. Mielke, Das Bürgerhaus in Potsdam, Tübingen, Wasmuth, I, pp. 324-26.
39 Ivi, pp. 322-26.
eckhart hellmuth66
Fig. 14
mancata passione per il neopalladianesimo inglese40. In questa scia erasorto, ad esempio, il cosiddetto «Knobelsdorffhaus», a imitazione delMarble Hill House costruito tra il 1724 e il 1729 sul progetto degliarchitetti inglesi Roger Morris e Colen Campbell41. Un esempio par-ticolarmente felice del recupero del neopalladianesimo inglese da partedi Federico il Grande è la Casa del carpentiere Craatz («Haus desZimmermanns Craatz»), costruita tra il 1771 e il 177242.
Il monarca prussiano aveva scoperto nel Vitruvius Britannicus lacasa del Generale Wade di Burlington Street a Londra (costruita sulprogetto di Lord Burlington). Con l’aiuto del suo fidato consigliereAlgarotti, Federico era riuscito a ottenere le piante dell’edificio; do-podiché aveva ordinato ai suoi architetti Bürig e Krüger di realizzareuna parafrasi della casa londinese del Generale Wade. Una serie dischizzi autografi fanno capire in maniera inequivocabile quante ener-gie Federico avesse impiegato nell’opera di ripensamento dell’archi-tettura di Potsdam secondo il suo gusto personale; egli non si limitò
40 Cfr. R. Wegner, Nach Albions Stränden, cit., pp. 35-43.41 Cfr. H.-J. Kadatz, Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff, cit., p. 215. R. Weg -
ner, Nach Albions Stränden, cit., pp. 37-38, si riferisce a un altro progetto inglesedel «Knobelsdorffhaus».
42 Cfr. F. Mielke, Das Bürgerhaus in Potsdam, cit., I, pp. 316-317.
federico il grande e l’architettura 67
Fig. 15
infatti a far costruire edifici sulla base di progetti che egli stesso avevaselezionato, ma fornì ai suoi architetti persino una serie di progettiabbozzati di suo pugno che dovevano venir realizzati. Il suo voca-bolario architettonico gli veniva prevalentemente dalle opere di Vi-truvio e Palladio.
Tutti questi edifici erano Immediatbauten, costruzioni di rappre-sentanza finanziate per intero o in parte dal sovrano. Egli stabiliva diconseguenza anche i destinatari di questi suoi doni. Di norma si trat-tava di commercianti e professionisti. Per questa clientela borghese,tuttavia, siffatti regali avevano un valore discutibile, poiché il loro man-tenimento richiedeva mezzi ingenti. E come se ciò non bastasse, que-gli edifici erano assolutamente poco funzionali43. Federico non si cu-rava affatto delle esigenze dei loro futuri occupanti; lui badava alla
43 Cfr. innanzitutto F. Mielke, Potsdamer Baukunst, cit., pp. 46-50.
eckhart hellmuth68
Fig. 16
facciata sontuosa, le cui colonne e pilastri dovevano suscitare l’im-pressione di un’architettura signorile44. Ciò valeva, ad esempio, perPalazzo Barberini, il cui aspetto esteriore faceva pensare che si trat-tasse della residenza di un grande magnate locale. Di fatto, però, eraabitato da un oste e da un carpentiere, i quali si sarebbero di certoimmaginati di abitare in un edificio con un’architettura diversa, datele loro professioni. Nel caso della copia già menzionata della casa lon-dinese del Generale Wade, dietro la magnifica facciata in stile neo-palladiano si celava una modesta abitazione su quattro piani. Ecco chela facciata londinese originale aveva dovuto adattarsi alle condizioniurbane di Potsdam.
Talvolta la fissazione di Federico il Grande per le facciate ornatedi colonne e pilastri comportava una serie di conseguenze che susci-tavano le critiche dei suoi contemporanei. Così, ad esempio, nella Sto-ria dell’architettura di Potsdam, Manger riferisce di un complesso edi-lizio commissionato dal sovrano, per cui non si era tenuto in nessunconto il principio form follows function, per nulla estraneo alla teoriaarchitettonica del tardo Settecento. «Anche nel caso di questi tre edi-fici, come era accaduto diverse volte in precedenza (in specie negliedifici copiati da Palladio), – osserva Manger – successe che la co-modità interna venne sacrificata a vantaggio della fissazione regale perl’esteriorità. Poiché i piani dovevano rispettare dall’interno l’altezza ri-chiesta dalla facciata esterna, la loro luce toccava i 19-20 piedi di al-tezza [circa 6 metri]; dal momento, però, che per le abitazioni ciò nonera assolutamente pratico e, quindi, ogni piano con soffitti così altidoveva venir suddiviso mediante speciali traverse in appartamenti daisoffitti più bassi, non poteva accadere altrimenti che le finestre deipiani inferiori arrivassero fino ai soffitti dei piani superiori, e che ri-cominciassero poi dal pavimento senza nessuna balaustra. Nel primocaso occorreva pertanto apporre dei palchi alle finestre per poter go-dere della luce del giorno; nell’altro, gli abitanti dovevano adattarsi al-l’idea di doversi sdraiare sul pavimento, come potevano, per riuscirea leggere, a scrivere e a svolgere tutte le altre attività quotidiane cherichiedevano la luce del giorno»45. Soltanto verso la fine degli anniSettanta e negli anni Ottanta del Settecento, quando gli interventi edi-lizi di Federico incominciarono a diradarsi, i suoi architetti poterono
44 Cfr. le giuste osservazioni di F. Mielke, Das Bürgerhaus in Potsdam, cit., I,p. 306.
45 H.L. Manger, Baugeschichte von Potsdam, cit., I, pp. 172-73.
federico il grande e l’architettura 69
costruire edifici adibiti ad abitazioni in cui veniva tenuta in debitoconto l’effettiva fruibilità.
3. Autocrazia e architettura
Se si considerano i quattro decenni in cui Federico il Grande eser-citò la propria attività edificatoria appare evidente che, con la sua vo-lontà di ferro, egli costringeva i suoi architetti a realizzare le sue ideee a eseguire i suoi progetti. In questo modo imponeva confini moltostretti alla loro creatività. Peraltro, l’ambizione architettonica di Fe-derico non era sempre commisurata alle sue competenze; il che eraperfettamente chiaro già ai suoi contemporanei. Nella Storia dell’ar-chitettura di Potsdam Manger non esita a criticare in questo senso ilmonarca prussiano. Riguardo al rapporto di Federico con l’architet-tura e con i suoi architetti Manger scrive: «Nel suo carattere c’era unanobile fermezza. […] Ma questa virtù genera di frequente una sortadi caparbietà e di ostinazione che non tollera nessuna critica; e ciò ac-cadeva anche in questo caso. Quel che il sovrano aveva disposto e or-dinato nelle questioni architettoniche doveva assolutamente rimaneretale, persino qualora egli stesso ne avesse poi scoperta l’erroneità. Kno-belsdorff, Le Geai e Gontard sarebbero forse rimasti più a lungo nellesue grazie se non avessero osato fargli notare che, talvolta, persino unsovrano può sbagliare in un’arte che non costituisce la sua occupa-zione principale»46. La «caparbietà» e l’«ostinazione» cui fa riferimentoManger possono riguardare la personalità del sovrano; ma possonoaltresì riferirsi a un contesto più ampio, quello del regime autocraticoche venne coltivato nella Prussia di Federico il Grande. Federico go-vernava dal suo gabinetto. Otto Hintze l’ha definito «la forma piùgrave di autocrazia, in cui il sovrano, lontano dai suoi ministri e nellasolitudine del suo gabinetto, prende decisioni la cui esecuzione toc-cherà poi alle autorità»47. Era un sistema in cui il monarca tentava disottrarsi al controllo della propria amministrazione, al fine di ottenerela massima libertà d’azione possibile. La volontà del monarca – comesi manifestava in innumerevoli ordini di gabinetto dettagliati fino al-l’ossessione – doveva avere una validità illimitata. E ciò valeva, allafin fine, anche per la politica edificatoria di Federico il Grande. Con
46 Ivi, III, p. 546.47 O. Hintze, Die Hohenzollern und ihr Werk 1415-1915, Berlin, Parey, 1915,
p. 295.
eckhart hellmuth70
buone ragioni si sono definiti i suoi abbozzi architettonici ordini digabinetto in forma di disegno48.
Sembra che l’intensa attività edificatoria di Federico sia stata de-terminata da due ragioni di fondo. Per un verso, Federico si preoc-cupava evidentemente di presentarsi al mondo come un monarca do-tato di un proprio senso artistico, come un uomo di gusto. Facendocopiare ai suoi architetti edifici che riteneva esemplari intendeva ren-dere manifesta la propria conoscenza profonda dell’architettura anticae moderna. Per altro verso, la sua politica edificatoria era interamenterivolta a esprimere la grandezza della nuova Prussia, una delle cinquepotenze europee, anche con per mezzo della calce e del mattone. Fe-derico si concentrò soprattutto sulle esibizioni esteriori, e nulla lo di-mostra meglio dell’architettura assolutamente poco funzionale dellefacciate ornamentali che egli mise in scena a Potsdam e a Berlino.Un’architettura che si adattava perfettamente a un parvenu tra le grandipotenze europee.
48 H.-J. Giersberg, Friedrich als Bauherr, cit., p. 145.
federico il grande e l’architettura 71
Michele Cometa
FEDERICO II DI PRUSSIA E LA LETTERATURA
1. È ormai proverbiale il sostanziale disinteresse di Federico II perla letteratura e per la scena letteraria tedesca a lui contemporanea. Unascena, com’è noto, in costante fermento e che nel giro di pochi de-cenni s’impone in Europa con una forza e una capacità di penetra-zione mai registrata prima. Proprio sul fronte dell’esplicito confrontocon la letteratura francese – quella che il monarca aveva frequentatoe costantemente osannato nei suoi scritti – erano stati fatti passi dagigante. Basti pensare alla figura di Lessing, di cui Federico II sem-bra non avere nemmeno registrato l’esistenza.
All’indomani della stesura e della stampa del celeberrimo e con-troverso scritto sulla «letteratura tedesca», Lessing muore (15 febbraio1781), suscitando un’ondata di commozione che il monarca neppureavverte. È significativo che il più grande scrittore di lingua tedesca,Goethe, in quei giorni totalmente sprofondato nel tentativo di scri-vere un dialogo in difesa della letteratura tedesca, contro Federico II,non possa fare a meno di notare la profonda ingiustizia di una morteche lascia l’intera cultura tedesca del tempo priva di uno dei suoi pa-dri spirituali.
Non mi poteva capitare nulla di più fatale del fatto che Lessing è morto.Neanche un quarto d’ora prima che mi giungesse la notizia avevo pro-grammato di fargli visita. Con lui perdiamo tantissimo, molto di più di quelloche possiamo immaginare1.
L’ultima ingiustizia in realtà l’aveva perpetrata proprio FedericoII, non citando neppure Lessing nello scritto in cui, com’è noto, sisoffermava relativamente a lungo sul teatro tedesco. Sicché lo scritto
1 Goethes Werke. Weimarer Ausgabe oder Sophien-Ausgabe (1887-1919), Mün-chen, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1987, IV/5, p. 60.
sulla Letteratura tedesca. Sui difetti che le si possono imputare, le causedi questi e i mezzi per il suo miglioramento2 – che il re completa al-l’età di 68 anni nel giro di poche settimane e pubblica senza nem-meno ascoltare le proposte di miglioramento del fido Ewald Friedrichvon Hertzberg – potrebbe a prima vista essere liquidato come un pro-dotto senile di un monarca con pretese letterarie.
Eppure, già all’atto di nascita della filologia della deutsche Klassik,sul finire del secolo XIX, apparve chiaro che lo scritto del re andavasalvato e contestualizzato. Non a caso Ludwig Geiger, uno dei pro-tagonisti della filologia goethiana, lo ripubblicò nel 1883 addiritturanell’originale edizione francese tra i Deutsche Litteraturdenkmale des18. und 19. Jahrhunderts3 diretti da Bernhard Seuffert e BernhardSuphan. L’editore dell’edizione critica di Herder e di innumerevoli al-tri scritti della Klassik e della Romantik riteneva necessario riconte-stualizzarlo in uno studio monografico che ne indagava tutte le rela-zioni con Weimar ancora nel 18884.
In questi e in altri casi risulta evidente che lo scritto tardo del reassume un’importanza straordinaria per la storia della cultura tedescaproprio per quello che non dice, che trascura o dice in modo incom-pleto o naïf. Le reazioni allo scritto – certo per lo più ‘contenute’,per via del rispetto e della soggezione che l’autore incuteva: Nicolaisi trovò a consigliare al «mago del nord», Hamann, di evitare pole-miche dirette con il sovrano per non ritrovarsi nella prigione di Span-dau! – furono però molteplici, e finirono perlopiù per sviluppare letesi di Federico II, prendendo sul serio lo sprone e l’utopia che l’o-pera consegnava agli scrittori tedeschi ormai convinti di aver risolle-vato le sorti della letteratura «nazionale».
Non è un caso che Wieland colga le «migliori intenzioni» del so-vrano e si auguri – in una recensione sul Teutscher Merkur che è unvero capolavoro di diplomazia – che adesso quello che proprio negliambienti di Weimar veniva affettuosamente chiamato il «tiranno», tro-
2 Federico II, Über die deutsche Literatur, Die Mängel, die man ihr vorwerfenkann, deren Ursachen und die Mittel zu ihrer Verbesserung (De la littérature alle-mande, des défauts que’on peut lui reprocher, quelles en sont les causes, et par quelsmoyens on peut les corriger), Berlin, Decker, 1780. Citeremo dall’edizione Die WerkeFriedrich des Großen, a cura di G.B. Volz, ed. tedesca di F. von Oppeln-Bronikow-ski, VIII, Berlin, Hobbing, 1913 (Philosophischen Schriften), pp. 74-99.
3 Da la Littérature allemande von Friedrich dem Grossen, Stuttgart, Göschen’-sche Verlagsbuchhandlung, 1883.
4 B. Suphan, Friedrich des Grossen Schrift über die deutsche Litteratur, Berlin,Hertz, 1888.
michele cometa74
vasse davvero il tempo di occuparsi direttamente dei destini della cul-tura tedesca, da lui stesso fin troppo trascurati per via delle guerre edella politica. Guerre e politica su cui però veniva dato un giudiziotutto sommato positivo e che non aveva per nulla intaccato la famadel re filosofo.
Anche Goethe, in un mai ritrovato testo, oggetto di appassionatiricerche sul finire dell’Ottocento, aveva progettato un dialogo tra unfrancese e un tedesco – probabilmente letto al cospetto di Herder, chece ne dà testimonianza, di Charlotte von Stein, che fu la prima ad in-coraggiarlo su questa strada, e di Anna Amalia5 – nel quale i due siconfrontavano proprio sullo scritto del re da due diverse prospettivenazionali:
Non se se le ho già detto che Goethe ha scritto in una locanda di Fran-coforte […] un dialogo in cui un tedesco e un francese si intrattengono sulloscritto del re sulla «littérature allemande»? Me lo ha dato perché lo leggessie vi sono dei pensieri molto belli; il tutto però non mi ha soddisfatto e latesi generale non mi è piaciuta6.
Goethe aveva infatti colto l’oggetto vero del contendere e leprofonde motivazioni personali che avevano indotto il monarca a pre-ferire – per tutta la vita – la letteratura francese a quella tedesca. Inuna lettera all’amico Merck, in cui gli annuncia il suo scritto pole-mico, quasi lo giustifica:
Nessuno si è meraviglierebbe dello scritto del vecchio re se lo si riconoscesseper quello che è. Quando il pubblico sente di un eroe che ha compiutograndi imprese, se lo raffigura secondo quello che fa comodo a un’idea ge-nerale, sottilissimo e coltissimo: così pure si fa con un uomo che ha fattomoltissimo, attribuendogli purezza, chiarezza e correttezza intellettuale. Si èsoliti ipotizzare mancanza di pregiudizi, cultura e giustizia. È quello che siè fatto con il re, il quale, nella sua sbiadita uniforme blu e con la sua figuraingobbita, ha fatto grandi imprese così come ha costretto con il suo mododi vedere ostinato, prevenuto e immodificabile tutto il mondo a propria im-magine e somiglianza7.
5 Avevano letto il dialogo tra gli altri anche il principe Augusto di Gotha, KarlLudwig von Knebel, Johann Heinrich Merk, il duca Ernesto di Gotha, Georg Chris -toph Tobler.
6 J.G. Herder, Briefe. Gesamtausgabe. Nachträge und Ergänzungen, 1763-1803,a cura di G. Arnold, IX, Weimar, Böhlaus Nachfolger, 1988, p. 308.
7 Goethes Werke. Weimarer Ausgabe oder Sophien-Ausgabe (1887-1919), cit.,IV/5, pp. 221-22.
federico ii di prussia e la letteratura 75
Già nel 1796, quando Friedrich von Blankenburg scrive le cele-berrime aggiunte al dizionario estetico di Sulzer, Federico II viene de-finito «un giudice così poco attendibile […] anche se il suo scrittoaveva suscitato attenzione e […] stimolato un bel po’ di scrittori aprendere posizione contro di esso»8.
Del resto è noto che immediatamente a ridosso dell’edizione te-desca – anzi delle edizioni tedesche se si contano quelle di Vienna,Monaco e Zurigo, sempre nel 1781, e quella più tarda di Zurigo nel1787 – sullo scritto di Federico II, erano apparsi numerosi saggi inparticolare quelli di Justus Möser e di Johann Friedrich Wilhelm Je-rusalem9.
Il testo di Jerusalem, commissionato dalla sorella di Federico II,la duchessa di Braunschweig, polemizzava cautamente con il monarcatanto che Goethe si vide costretto a liquidarlo in una lettera alla vonStein con parole durissime: «La letteratura tedesca di Jerusalem è ap-parso. Benevola, modesta, corretta, distaccata e povera»10. Nel testoJerusalem finiva infatti per accettare i ‘suggerimenti’ del re sulla ne-cessità del tradurre e sul modello neogreco, ma non manca di sotto-lineare l’esistenza di alcuni grandi protagonisti della traduzione comeFriedrich Leopold Graf zu Stolberg e Johann Jakob Engel e, ovvia-mente, del padre della grecofilia tedesca, Johann Joachim Winckel-mann, certamente il grande assente, insieme a Lessing, nello scritto diFederico II.
A questi due testi andrebbero senz’altro aggiunti quelli di JohannKarl Wetzel (1781), l’anonima recensione sulla Berliner Haude- undSpenersche Zeitung del 2 dicembre 1780, i testi di Balthasar LudwigTralles11 e del commerciante ebreo A. M. Lion Gomperz12, cui peral-tro il monarca in persona rispose il 6 settembre 1781.
È dunque del tutto evidente che lo scritto del re ha non pococontribuito a far uscire allo scoperto alcuni autori già consapevoli del
8 J.G. Sulzer, Allgemeine Theorie der schönen Künste, Leipzig, Weidmann, 17922
(riprod. Hildesheim, Olms, 1970, con un’introduzione di G. Tonelli), I, p. 371.9 Tra i quali vanno almeno ricordati: J. Moser, Ueber die deutsche Litteratur.
An einen Freund, Hamburg, Hoffmann, 1781; J.F.W. Jerusalem, Über die deutscheSprache und Literatur. An Ihro Königliche Hoheit, die verwitwete Frau Herzoginvon Braunschweig und Lüneburg, Berlin, s.e., 1781.
10 Goethes Werke. Weimarer Ausgabe oder Sophien-Ausgabe (1887-1919), cit.,IV/5, p. 60.
11 B.L. Tralles, Schreiben von der deutschen Litteratur, Breslau, Löwe, 1781.12 A.M. Lion Gomperz, Lettre sur la langue et sur la littérature allemande, Dan-
zig, Floerke, 1781.
michele cometa76
grande sviluppo avuto dalla letteratura tedesca, ha irritato alcuni grandi– soprattutto Goethe, Herder e Wieland che nelle loro lettere private,e certamente nei loro incontri, hanno usato toni meno accondiscen-denti nei confronti del monarca, colpevole peraltro agli occhi di Wei-mar di trascurare un alleato importante – e soprattutto costretto moltia ‘storicizzare’ ex novo la letteratura tedesca, a fare, per così dire, ilpunto della situazione e a rivendicare una centralità riconosciuta – comenel caso di Winckelmann – dall’Europa intera.
Ma ancora più significative delle risposte esplicite sono quelle im-plicite, se tra queste si contano l’intenzione di Herder di riprenderee ampliare i celeberrimi Fragmente über die deutsche Literatur (1766),un testo fondamentale di cui il re non tiene affatto conto, e che siconcretizza nella settima e ottava Sammlung (1796) dei Briefe zurBeförderung der Humanität, che costituisce una risposta diretta al mo-narca insieme agli Andenken an einige ältere deutsche Dichter (1793),pubblicati nei Zerstreute Blätter, e ai Briefe, den Charakter der deut-schen Sprache betreffend (1803). Nell’anno di pubblicazione del sag-gio del re Herder peraltro implicitamente risponde anche con un ne-crologio di Winckelmann pubblicato anonimo e, per così dire, ‘a caldo’sul Teutscher Merkur dell’autunno del 1781. Herder fu del resto il piùcolpito dall’indifferenza e forse dalla deliberata damnatio memoriaedel monarca perché era stato premiato per ben tre volte dall’Accade-mia di Berlino e l’ultima volta per il fondamentale scritto Vom Ein-fluß der Regierung auf die Wissenschaften und der Wissenschaften aufdie Regierung, un testo apparso nel 1780, che difficilmente può es-sere sfuggito al re e che per certi versi costituisce semmai il presup-posto del suo saggio.
Katharina Mommsen13 ha inoltre dimostrato in modo convincenteche tutta l’attività del Journal von Thiefurth – una rivista diffusa incopie manoscritte a Weimar a partire dal 1781 – promossa da AnnaAmalia, nipote di Federico II, costituisce una virulenta reazione alletesi dello zio. Anche il Principe Augusto di Gotha si sentiva, come i
13 K. Mommsen, Herzogin Anna Amalias «Journal von Tiefurth» als Erwide-rung auf Friedrichs II. «De la littérature allemande», URL = http://www.goethe-zeitportal.de/fileadmin/PDF/db/wiss/epoche/mommsen_journal-von-tiefurth.pdf. Si vedaanche Id., Potsdam und Weimar um 1780. Gedanken zur Kanonbildung anlässlichvon Friedrichs II. «De la littérature allemande», in Kanonbildung. Protagonisten undProzesse der Herstellung kultureller Identität, a cura di R. Charlier e G. Lottes, Han-nover, Wehrhahn, 2009, pp. 13-33.
federico ii di prussia e la letteratura 77
weimariani, profondamente messo in discussione dal testo del mo-narca. In una lettera a Herder si legge:
Che cosa penseranno di noi tedeschi gli inglesi, i francesi, gli italiani etc. seil grande re sulla Sprea scrive così del nostro stato attuale, e […] giudicacome se avesse vissuto tutto questo tempo a Londra, a Parigi o a Roma?14
2. Molto dunque è stato detto sulla ricezione dell’opera e moltoci sarebbe ancora da dire sulla sua ricezione indiretta della stessa. So-prattutto se si guarda a piccoli capolavori della cultura tedesca che sipossono comprendere innanzitutto come risposte indirette allo scrittodel re.
Ma la storia del saggio sulla letteratura tedesca può ridursi a unamera storia della ricezione? Il fatto che lo scritto rispecchi una visioneche il monarca si era fatto alcuni decenni prima, almeno a partire dal1737, toglie all’opera qualsivoglia attualità e significato nel 1781?
Forse può essere utile rileggere la genesi di quest’opera non soloper accertarne i significati nascosti e rivederne certe asperità con mag-giore serenità di giudizio, ma soprattutto per individuare altri percorsiinterpretativi, coglierne alcune tensioni, politiche e letterarie a un tempo,che certamente fanno di questo scritto pubblicato tardivamente untassello di una storia più grande e di un progetto che anche il vec-chio re non solo non riteneva concluso, ma lasciava in qualche modoin eredità alla sua ‘nazione’.
Le frasi finali del saggio, infatti, non avevano mancato di infiam-mare i cuori anche dei più critici ed erano ampiamente condivise per-sino da Herder o da Goethe:
Avremo i nostri classici. Ognuno potrà leggerli per imparare da loro. Lecorti parleranno tedesco con soddisfazione e potrà accadere che la nostralingua raffinata e perfezionata si diffonderà da un capo all’altro dell’Europagrazie ai nostri migliori scrittori. I giorni felici della nostra letteratura nonsono ancora arrivati, ma si avvicinano. Io li annuncio, sono imminenti. Io
14 Lettera del principe August von Sachsen-Gotha-Altenburg a J.G. Herder del25.12.1780 (Staatsbibliothek Berlin Preußischer Kulturbesitz, Ms. Germ. Qu. 1336,Bl. 53r-53v.), cit. in K. Mommsen, Herzogin Anna Amalias «Journal von Tiefurth»,cit., p. 9. Al principe si deve l’attacco più esplicito al sovrano in una lettera a Her-der: «Bisogna dunque farsi avanti e urlare: ‘Grand’uomo, taci! Non sai di cosa parli;ti rendi ridicolo agli occhi dei tuoi concittadini e coetanei; ripulisciti la tua armaturadi guerriero in modo che non arrugginisca e lascia che la polvere si accumuli sui li-bri che avresti dovuto leggere; lascia perdere e vergognati!’», Lettera del principe Au-gust von Sachsen-Gotha-Altenburg a Herder del 21.3.1781 (Staatsbibliothek BerlinPreußischer Kulturbesitz), ivi, p. 17.
michele cometa78
non li vedrò più. La mia età mi priva di questa speranza. Sono come Mosè:vedo la Terra promessa da lontano, ma non la calpesterò15.
Per cogliere però questi percorsi alternativi è necessario sgombrareil campo da alcuni fraintendimenti e da alcune semplificazioni.
Innanzitutto va ricordato che l’opera non è, se non in minimaparte, un saggio sulla situazione della «letteratura tedesca», intesa comeproduzione letteraria nel campo della prosa, del teatro e della poesia.La dizione «letteratura» riguarda tutta la produzione scientifica, sulfronte delle cosiddette schöne Wissenschaften, come su quello dellescienze della natura e della tecnica. Il saggio va considerato nei limitidella visione settecentesca sulla produzione intellettuale come una bi-bliografia generale delle opere scientifiche di un’intera nazione. Qui«letteratura» comprende sia le «belle lettere, come la Bered-samkeit/Rhetorik (eloquenza/retorica), la Dichtung (poesia) propria-mente detta, ma anche il teatro, la grammatica, la logica, oltre che lamedicina, la teologia, la matematica, la storiografia (genealogia), la fi-losofia, il diritto e persino la tecnologia. Non deve meravigliarci dun-que che le parti dedicate alla letteratura nel senso moderno del ter-mine siano limitate a pochi nomi, effettivamente lontani dalla scenaletteraria del 1780 – come Christian Fürchtegott Gellert, Friedrich vonCanitz, Salomon Gessner e Johann Gottlob von Quandt – e che siesprimano termini durissimi soprattutto sul teatro tedesco con la fa-mosa scomunica del Götz von Berlichingen di Goethe e il reiteratosilenzio su Lessing:
Per convincersi della mancanza di gusto che domina oggi in Germania ba-sta andare a teatro […]. Come può piacere e commuovere questa strana me-scolanza di alto e basso, di pagliacciate e tragedia? Si può perdonare a Shakes -peare queste strane aberrazioni, perché la nascita delle arti non è mai comeal tempo della maturità. Ma adesso appare sulla scena pure un Götz vonBerlichingen, un’orribile imitazione delle peggiori opere inglesi e il pubblicoapplaude a scena aperta e pretende con entusiasmo il bis di queste idiozieprive di gusto16.
È stato giustamente notato che ogni parola di queste argomenta-zioni offendeva non solo Goethe, ma tutta la corte di Weimar impe-gnata in uno sforzo teatrale senza precedenti, i traduttori di Shakes -peare e, insieme, tutta l’estetica tedesca del tempo. Ma questi passaggi
15 Die Werke Friedrich des Großen, cit., p. 99.16 Ivi, 88.
federico ii di prussia e la letteratura 79
sulla letteratura costituiscono solo una parte, e certo non la più rile-vante, della produzione intellettuale dei tedeschi che, sia pure all’in-terno di una retorica della Beförderung vedeva per lo meno messe incampo figure come Leibniz, Wolff, Copernico, Thomasius, Adelung,e persino gli inventori tedeschi della polvere da sparo, della stampa edella pompa ad aria. Questo ovviamente non giustifica la mancanzadi Lutero – posto al centro della storia tedesca solo da Herder – o ilsilenzio sui berlinesi, Moses Mendelssohn innanzitutto, particolarmenteinviso al monarca per ragioni personali.
Tuttavia questa trascuratezza del testo – ma Katharina Mommsenconsidera con buoni argomenti che questa damnatio memoriae di Wei-mar rappresenta la dura risposta del monarca proprio a Goethe e al-l’intera corte che, su consiglio del poeta, non si lasciò trascinare nel-l’ennesimo conflitto prussiano – va letta nel contesto di una visionemolto più ampia della littérature allemande. Non è un caso che Fe-derico II di fatto risponda a un testo di cui si era occupato molti de-cenni prima, nel 1767, allorché il barone Jakob Friedrich Bielfeld avevapubblicato uno scritto dal titolo Progrès des Allemands, dans les Scien-ces, les Belles-Lettres et les Arts, particuliérement dans la Poésie, l’E-loquence et le Théâtre17, indirizzato proprio all’Accademia di Berlino.
È certamente significativo che Bielfeld insista, soprattutto nellaterza edizione, sulla Miss Sara Sampson di Lessing e si mostri infor-mato sulle ultime novità, mentre il re tace caparbiamente. Ma è chiarogià a una lettura superficiale che il testo del sovrano si presenta comeun confronto e a volte una confutazione delle principali osservazionidi Bielfeld pur nel contesto di una rassegna esaustiva di tutte le di-scipline praticate in Germania.
La parte polemica del pamphlet si concentra su quelli che Biel-feld considera nell’Avertissement i principali «scogli» (écueils) che lelettere tedesche devono superare: 1) l’eccesso di traduzioni dal fran-cese in tedesco che finisce per violentare la stessa lingua tedesca18, unatesi che il re capovolge integralmente, sostenendo semmai la necessitàdelle traduzioni e il loro valore nello sviluppo della lingua stessa; 2)l’eccesso di «pedanteria» nella scelta degli argomenti studiati, un trattoche Federico II stigmatizza nel suo saggio; e, infine, 3) l’uso ecces-
17 J.F. Bielfeld, Progrès des Allemands, dans les Sciences, les Belles-Lettres et lesArts, particuliérement dans la Poésie, l’Eloquence et le Théâtre, Leide, Samuel et JeanLuchtmans, 1767, e Liège, J.F. Bassompierre Fils, 1768.
18 Ivi, p. X.
michele cometa80
sivo nella poesia dell’esametro che rende lo stile tedesco «oscuro, enig-matico» e sostanzialmente noioso19.
Il testo di Federico II è dunque certamente scritto in risposta aquello di Bielefeld. Molti nomi ritornano e soprattutto l’impianto dellediscipline, presentate quasi nella stessa sequenza: filosofia, giurispru-denza, medicina, storia, matematica e fisica. Uguale attenzione Fede-rico II dedica alle invenzioni, soprattutto la polvere da sparo, la stampae la pompa pneumatica20.
Certo la prolissa parte sui poeti deve aver irritato non poco il so-vrano che pure vi attinge per ricordare Canitz, Gellert, Albrecht vonHaller (ricordato tra gli scienziati!). Non una parola invece su Mar-tin Opitz, Friedrich von Hagedorn, Johann Wilhelm Ludwig Gleim,Anna Louisa Karschin, cui giustamente Bielfeld dedica pagine e pa-gine, stracolme di esempi poetici. Ancor meno si spiega l’assenza diLessing e della Miss Sara Sampson diffusamente commentata e am-piamente tradotta in francese.
3. Se quanto abbiamo via via ricostruito è plausibile, apparirà dun-que naturale incominciare a interpretare il testo dalle due prospettivetemporali: quella del 1767, data in cui il re concepisce il testo alla finedi un trentennio di riflessione sui limiti e le prospettive della culturatedesca, e quella di pubblicazione finale del saggio nel 1780, quandoormai la parabola del monarca si avvia alla conclusione.
Lo scritto di Bielfeld è solo lo sprone a mettere insieme conside-razioni che risalgono almeno al 1737, quando in una lettera a Vol-taire, il monarca aveva già individuato i due grandi limiti della cul-tura tedesca: la mancanza di una lingua nazionale normata e norma-tiva e il «disprezzo» che i principi tedeschi mostrano nei confrontidei Gelehrten21. Ancora nel 1775, sempre in una lettera a Voltaire, ilre individua nella «mancanza di gusto», un altro ostacolo allo svi-luppo cultura:
Il gusto manca del tutto ai tedeschi […]. Il loro gusto è un miscuglio diquello romano, inglese, francese e tedesco. Manca loro il giudizio critico chesignifica cogliere il bello là dove si trova, e imparare a distinguere tra il me-diocre e il perfetto, tra il nobile e il sublime […]22.
19 Ivi, p. XII.20 Ivi, pp. 46 ss.21 Die Werke Friedrich des Großen, cit., VIII, p. 306; si veda anche la lettera a
d’Alembert, ivi, p. 307.22 Ivi, p. 309.
federico ii di prussia e la letteratura 81
Una considerazione che quanto meno testimonia del fatto che ilre si è comunque impadronito del lessico tecnico dell’estetica tedescadi quegli anni. Il pessimismo di questa precoce discussione si stem-pera invero in una lettera a Voltaire dell’8 settembre dello stesso annodove si legge:
Avete ragione: i nostri bravi germani stanno solo all’alba della cultura (Bil-dung). La Germania è oggi allo stesso livello in cui si trovavano le arti aitempi di Francesco I23.
Il che lascia intravvedere un’evoluzione possibile che nel saggiodel 1780 viene definitivamente conclamata. Un ottimismo che ormaiappare chiaro in una lettera a d’Alembert scritta all’indomani dellapubblicazione:
Vi prenderete gioco di me visto che mi sono sforzato di insegnare ad unpopolo che fino ad oggi non ha inteso null’altro che del mangiare, bere,amarsi e combattere, alcuni concetti del gusto e del sale attico. Tuttavia ci sisforza di rendersi utili. Spesso una parola che cade su un terreno fertile fio-risce e porta frutti insperati24.
E, in effetti, il testo, composto in un arco di tempo che va dal1737 al 1767, è a quell’altezza temporale un testo non soltanto otti-mista e pieno di futuro, ma rappresenta uno sprone in positivo afronte delle dure critiche25, ed è anche ricco di intuizioni e di prefi-gurazioni di come la cultura tedesca si sarebbe potuta rinnovare nelgiro di pochi decenni. A quell’altezza temporale, infatti, le considera-zioni di Federico II sono tutt’altro che arretrate o inopportune. Inquesta sede ci limiteremo a pochi accenni che però andrebbero sup-portati da un confronto costante con le fonti, prima di tutto quelleche sorreggono le argomentazioni dello stesso Bielfeld.
Significativo è senz’altro il riferimento all’antica Grecia come Wiegeder schönen Künste (culla delle belle arti) e in particolare lo sviluppostorico delle stesse attraverso Roma e la loro rinascita, dapprima inItalia, poi in Francia e Inghilterra, quasi Federico avesse letto il suoWinckelmann, più o meno direttamente. Frasi come «i loro primi teo-
23 Ivi, p. 310.24 Ivi, p. 311.25 Nell’incipit del saggio infatti si legge: «Io amo la nostra comune patria quanto
Voi e per questo mi guardo bene dal lodarla prima che meriti questa lode. Signifi-cherebbe celebrare il vincitore prima che conquisti la vittoria. Aspetto che raggiungala meta. Allora il mio plauso sarà leale quanto vero» (ivi, p. 74).
michele cometa82
logi e i loro primi storici furono i poeti» sono patrimonio comunedei tedeschi, e certamente di Wincklemann, Herder o Lessing.
Lo stesso va detto della metaforica organicistica (Saat, Keim, Blühe)che informa il modello storiografico del monarca, un paradigma cheprevede vertici assoluti, ma anche lente e inevitabili decadenze (chepossono coinvolgere anche gli italiani, i francesi e gli inglesi26), se-condo uno schema che Winckelmann aveva importato proprio dallafilosofia francese contemporanea.
Ma è sul piano metodologico che lo scritto si dimostra all’altezzadelle sperimentazioni che in quel trentennio avrebbero rappresentatole punte più avanzate della riflessione teorica tedesca. I concetti di«comparazione» (Vergleich), di «critica» (Kritik) e l’idea di un «ca-none» (Vorbilder) da imitare e diffondere, stavano alla base dell’este-tica e della scienza della cultura tedesca da Wincklemann a Lessing,appunto. È particolarmente significativo l’accento che Federico II ponesu un concetto di critica che non risparmi neppure i modelli cano-nici, Grecia compresa:
A questi grandi esempi si sono attenuti quanto più possibile e hanno impa-rato da essi a pensare. Ma nonostante l’ammirazione per le grandi bellezzedi cui pullulano le opere degli antichi, essi non hanno sorvolato sui loro di-fetti. Nonostante la grande considerazione la critica va esercitata e mai sideve scadere nella cieca adulazione27.
Inutile insistere in questa sede sulla già ben nota diffidenza delmonarca rispetto alle strutture ecclesiastiche e sulla necessità di unagraduale ma decisa Volksaufklärung.
È del resto fin troppo evidente che il saggio di Federico II aspiraad essere innanzitutto un trattato sul metodo con cui bisogna affron-tare gli studi, ed è dunque importante seguire il ductus argomentativodel saggio che si muove sul discrimine sottile della ricostruzione sto-rica, ma la integra con i ‘rimedi’ che è possibile mettere in campo: in-nanzitutto la questione delle traduzioni, da cui il monarca lascia di-pendere ogni miglioramento della lingua; del resto in sintonia conquelle humanistische Studien, lo studio dei classici, cui aveva attribuito
26 Ivi, p. 79: «I bei tempi che gli italiani, i francesi e gli inglesi si sono godutiprima di noi cominciano adesso a svanire sensibilmente. Il pubblico è sazio dei ca-polavori che sono già apparsi. Le conoscenze da quando sono diffuse cominciano adessere meno considerate. In breve questi popoli si credo in possesso della fama chei loro scrittori hanno procurato loro e dormono sugli allori».
27 Ivi, p. 79.
federico ii di prussia e la letteratura 83
– in una lettera a d’Alembert del 28 gennaio 177328 – il successo del-l’Umanesimo italiano e del Classicismo francese.
Il problema del metodo è per Federico però prima che un pro-blema filosofico un problema politico. È la mancanza di metodo nellascuola e nell’università che rende impossibile un miglioramento deicostumi e della cultura. E qui si innesta la seconda prospettiva da cuiè opportuno leggere il testo, un punto di vista costantemente presentenella politica culturale del sovrano, ma che nel 1780 sembra cristal-lizzarsi in un testamento spirituale. La riforma della scuola e dell’i-struzione è innanzitutto una riforma del metodo pedagogico altrimentitroppo affidato all’improvvisazione e all’illogicità della prassi:
Passiamo adesso dalle scuole alle università e giudichiamole spassionatamente.L’errore che salta per lo più agli occhi è la mancanza di un metodo gene-rale per l’insegnamento. Ogni professore ne ha uno. Dal mio punto di vi-sta vi è solo un metodo a cui attenersi29.
La questione per il re è tutt’altro che teorica. Attiene invece allapolitica culturale che egli intende sviluppare. E su questo sono in moltia dargli ragione. Weimariani compresi:
Io propongo innanzitutto di scegliere accuratamente i docenti e prescrivereloro un metodo d’insegnamento ragionevole (verständig) e sensato (sinnreich)[…]. Io credo che il migliore e più chiaro trattato di logica sia quello diWolff. Si dovrebbe dunque indurre tutti i docenti ad imparare da esso […].Per la retorica si faccia riferimento a Quintiliano. Chi non impara già nellascuola l’eloquenza non la acquisirà mai più. Lo stile di quest’opera è chiaro;contiene tutte le regole e tutte le prescrizioni della retorica […]. Seguendoil metodo che propongo i docenti svilupperanno le predisposizioni naturali,il giudizio dei loro discenti, li abitueranno a non prendere decisioni senzaconoscere i motivi e a trarre le giuste conclusioni dalle regole della retorica.La retorica renderà metodico il loro spirito30.
Se si guarda allo scritto sulla «letteratura tedesca» dalla prospet-tiva del suo impianto di politica pedagogica31 ci si renderà presto contoche l’argomentazione è, da questo punto di vista, tutt’altro che da-
28 Ivi, p. 307.29 Ivi, pp. 80 ss.30 Ivi, p. 86.31 Concretizzatosi per altro già nel 1772 con lo scritto Über den Nutzen der
Künste und Wissenschaften im Staate, letto all’Accademia il 27 gennaio, e prima an-cora con il saggio Über die Erziehung (1769), in Die Werke Friedrich des Großen,cit., VIII, pp. 54 ss., e pp. 257 ss.).
michele cometa84
tata. Proprio nel 1779 il re aveva infatti diffuso un Kabinettserlass überdas Unterrichtswesen an den Minister Freiherrn von Zedlitz, che co-stituisce il diretto pendant operativo del saggio sulla letteratura. An-che in quella sede ribadisce, sotto forma di prescrizione, la necessitàdi insegnare in tutte le scuole «retorica e logica»32, insistendo su Quin-tiliano e sulla necessità che venga direttamente tradotto nelle scuole.
La disposizione è una sorta di epitome del testo del 1780: vi siribadisce la centralità del latino e del greco, la necessità di una riformadel metodo, l’importanza delle traduzioni degli auctores33, la completaemancipazione dell’insegnamento della filosofia dai religiosi34.
Non stupisce che all’indomani della pubblicazione del saggio l’in-vio da parte di Karl Philipp Moritz – certo il più grande tra gli scrit-tori tedeschi che gli era capitato di conoscere personalmente – di al-cune poesie e dei due saggi pedagogici Vom Unterschiede des Akku-sativ’s und Dativ’s oder des mich und mir, sie und ihnen, usw. (1780)e delle Kleine Schriften, die deutsche Sprache betreffend (1781), appaiaa Federico II la realizzazione dei suoi desideri più intimi:
Se tutti i tedeschi descrivessero pittoricamente come Voi nelle poesie che miavete voluto inviare, con tanto gusto e dominasse nei loro scritti altrettantointelletto e spirito come quello che riluce dalle due piccole raccolte di epi-stole, allora vedrei precocemente realizzati tutti i miei desideri di padre dellapatria (landesväterlichen) e gli scrittori tedeschi contendersi per dignità esplendore il rango con gli stranieri35.
Da lì a poco l’oscuro ‘maestro’ Moritz sarebbe diventato uno deiprotagonisti del classicismo tedesco ed europeo proprio grazie a unarinnovata nozione di Bildung, che il monarca avrebbe certamente con-diviso e che aveva contribuito a progettare per alcuni decenni.
32 Ivi, p. 313.33 Ivi, p. 314.34 Ivi, p. 315: «E per ciò che riguarda la filosofia non deve essere insegnata dai
religiosi ma dai laici».35 Briefe Friedrich des Großen, a cura di M. Hein, ed. tedesca di F. von Oppeln-
Bronikowski e E. König, Berlin, Hobbing, 1914, p. 244.
federico ii di prussia e la letteratura 85
Riccardo Morello
FEDERICO II DI PRUSSIAE LA CULTURA MUSICALE DELLA SUA EPOCA
Il 7 maggio 1747 – come ci racconta dettagliatamente la primabiografia di Bach, pubblicata nel 1802 da Johann Nikolaus Forkel1 –Johann Sebastian Bach, Thomaskantor a Lipsia dal 1723 e cursächsi-scher Hofkompositeur a Dresda dal 1736, fu invitato dal re di Prus-sia Federico II a Potsdam, al castello di Sanssouci. Non sappiamo conesattezza le circostanze che avevano portato a quell’incontro di cuiparlarono diffusamente le gazzette dell’epoca. È molto probabile cheil tramite della visita fosse il figlio di Bach, Carl Philipp Emanuel(1714-1788), che ricopriva dal 1740 la carica di cembalista di corte aPotsdam, ma è anche possibile che l’invito fosse dovuto alla media-zione del conte Hermann Carl von Keyserlingk (1696-1764), amba-sciatore russo a Dresda e poi dal 1745 al 1749 a Berlino. Grande esti-matore della musica di Bach, costui aveva alle proprie dipendenzecome segretario un cugino del musicista – Johann Elias Bach – edinoltre gli aveva fatto ottenere l’incarico di compositore di corte aDresda. Alle dipendenze di Keyserlingk era anche quel Johann Got-tlieb Goldberg, allievo di Bach e di suo figlio Wilhelm Friedemann,passato alla storia per le celebri Variazioni. All’epoca della visita aPotsdam nel 1747 operavano nella cappella reale Johann JoachimQuantz, flautista e compositore, Georg Benda, Gottlieb e Karl Hein-rich Graun e Christoph Nichelmann. Secondo il racconto di Forkel– basato sulla testimonianza di Wilhelm Friedemann, il figlio mag-giore di Bach che lo accompagnava in quell’occasione – sembra cheil re avesse chiesto a Bach di improvvisare al pianoforte:
1 J.N. Forkel, Über Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke. Fürpatriotische Verehrer echter musikalischer Kunst, Leipzig, Hoffmeister und Kühmel,1802.
Dopo aver provato e improvvisato per un po’, chiese al re un tema per unafuga da eseguire subito senza preparazione. Il re ammirò la sapienza con cuiil suo tema fu sviluppato così sul momento e quindi, probabilmente per ve-dere sino a che punto una tale maestria potesse spingersi, espresse il desi-derio di ascoltare anche una fuga a sei voci. Poiché tuttavia non ogni temasi presta a un tale trattamento, Bach se ne scelse uno per conto suo e, congrande meraviglia di tutti i presenti, subito lo eseguì in modo altrettantosplendido e perfetto di quanto aveva fatto col tema del re2.
Come sappiamo il celebre tema – noto come thema regium – co-stituirà il punto di partenza dell’Offerta Musicale (Musikalisches Op-fer BWV 1079), la composizione pubblicata già nel settembre dellostesso anno con dedica al sovrano, nella quale Bach ritorna sulle cir-costanze della composizione: «Mi resi conto immediatamente che,mancando la necessaria preparazione, l’esecuzione non sembrava al-l’altezza di un tema così eccellente»3. Il tema scelto da Federico nonsi prestava a quel tipo di improvvisazione e Bach dovette adattarloalle sue esigenze compositive, e quest’ultimo «recht königliches Thema»è appunto il thema regium dell’Offerta Musicale. La rapidità nellacomposizione e pubblicazione si spiega con la necessità di sfruttare lanotorietà suscitata dall’incontro col re e di rendere omaggio al grandemecenate e musicista dilettante che sino a quel momento non avevamostrato un particolare interesse nei confronti della musica bachiana.È probabile che Federico considerasse Bach un genio musicale ap-partenente al passato, il cui stile contrappuntistico non era più ri-spondente alle esigenze della musica contemporanea, quello «stile ga-lante» che era la cifra dominante della produzione dei compositori at-tivi a Sanssouci compreso Carl Philipp Emanuel Bach. Prova ne siala pressoché totale assenza di musiche di Bach dai programmi eseguitia corte e dominati dalla produzione strumentale di stile eclettico al-lora in voga. Federico non amava particolarmente la tradizione anticaincarnata da Bach – lo stesso fugato era per lui indicativo di uno stile«severo» vale a dire riservato alla musica religiosa e alla sfera litur-gica. Probabilmente era incline ad apprezzare invece le qualità ba-chiane come improvvisatore e virtuoso della tastiera, cembalo e or-gano, nonché la fama di profondo conoscitore di strumenti musicali.
Il re di Prussia possedeva alcuni allora modernissimi pianoforti(Hammerflügel) fabbricati da Silbermann con una meccanica analogaa quella del Cristofori, ed è probabile che Bach abbia concepito al-
2 Ivi, p. 27.3 Ivi, p. 28.
riccardo morello88
cuni brani, come il ricercare a tre voci dell’Offerta Musicale o il trio-sonata per flauto, violino e pianoforte, proprio per questo nuovo tipodi strumento che aveva avuto modo di provare a Naumburg e poidurante la visita a corte.
Forkel ci racconta che l’arrivo del «vecchio Bach» interruppe laserata musicale, il compositore non ebbe nemmeno il tempo di in-dossare l’abito scuro da Kantor e dovette presentarsi a corte ancoracon gli abiti da viaggio e venne trascinato di sala in sala per pro-vare i pianoforti acquistati dal sovrano (ben quindici) ai quali egliteneva molto. Su tutti gli fu chiesto di suonare e improvvisare. Nonfu dunque Federico II il promotore dello studio e del culto dellamusica di Bach a Berlino – visto che non sono conservate reazionio commenti alla dedica dell’Offerta Musicale – bensì, come è noto,la sorella Anna Amalia (1723-1787), grande appassionata di musicae ottima musicista. La principessa tenne per anni un celebre salottonel palazzo invernale Unter den Linden e in estate nella residenzadella Wilhelmstrasse 102, che era luogo di incontro degli appassio-nati di musica antica. Tra essi il famoso barone Van Swieten, amba-sciatore austriaco a Berlino dal 1770 al 1777, che porterà a Viennala sua passione per Bach. Il maestro della principessa Johann Phi-lipp Kirnberger (1721-1783) aveva trasmesso a tutto il gruppo l’a-more per la tradizione contrappuntistica. Egli fece dono ad AnnaAmalia del manoscritto dei concerti brandeburghesi (BWV 1046-51)e la biblioteca di Amalia, confluita poi nella Biblioteca di Stato prus-siana, costituirà nell’Ottocento la fonte primaria della rinascita delculto della musica di Bach4.
Pur tenendo conto di tutti questi elementi, c’è tuttavia almeno unaspetto che collega direttamente Federico II all’Offerta Musicale e me-rita di essere sottolineato: la comune concezione del ruolo che la mu-sica riveste nella società, la sua centralità nel processo culturale del-l’Aufklärung. Negli anni Ottanta del Novecento una celebre analisidella composizione bachiana fatta da Ursula Kirkendale5 ha dimo-strato il legame strettissimo tra l’Offerta Musicale – la sua articola-zione e costruzione complessiva nonché nei particolari – e l’Institu-tio Oratoria di Quintiliano. Alla base della composizione di Bach c’èquella che Nikolaus Harnoncourt, in un suo saggio sulla prassi ese-
4 Cfr. Bach Handbuch, a cura di A. Küster, Kassel, Bärenreiter-Metzler, 1999.5 U. Kirkendale, The source for Bach’s «Musical Offering»: The «Institutio Ora-
toria» of Quintilian, in «Journal of the American Musicology Society», 33, 1980, pp.88-141.
federico ii di prussia e la cultura musicale della sua epoca 89
cutiva barocca, definisce «Musik als Klangrede»6, ossia la capacità diesprimersi attraverso la musica come mediante un linguaggio univer-salmente condiviso, una condizione propria di epoche in cui essa nonera relegata nell’ambito dei saperi specialistici o peggio declassata arumore di fondo indistinto, come quello che ci accompagna nella con-temporaneità, ma faceva parte della vita quotidiana e della formazioneculturale di base. Federico II non è stato semplicemente un mecenatecome tanti e un cultore in privato del piacere tipicamente tedesco delMusizieren – così come sembra suggerire l’iconografia e la ricca aned-dotica in proposito, sintetizzata dal celebre dipinto di Adolph Men-zel Das Flötenkonzert in Sanssouci (1852), dove il re, illuminato daun fascio di luce dall’alto, suona il flauto attorniato dagli amici, in pri-mis il maestro Quantz che lo guarda con premurosa attenzione. Que-st’immagine risente evidentemente di un addomesticamento in sensoborghese della realtà federiciana; Federico era un grande monarca con-vinto dell’importanza sociale ed educativa della musica. Certo, comes’è detto, il suo orientamento era eminentemente legato alla prassi mu-sicale del tempo e la sua concezione era quella propria dell’Empfind-samkeit: musica come «allgemeine Empfindungssprache», strumentodi comunicazione universale, capace di superare le differenze di lin-gua e cultura. La musica si fondava su un sistema consolidato di re-gole universalmente accettate, una sorta di sensus communis, la dot-trina degli affetti (Affektenlehre) che permetteva appunto di esprimerein modo efficace e immediatamente percepibile le più sottili sfuma-ture del proprio sentimento. È facile ricavare un parallelismo tra ilconservatorismo del re in campo letterario, la sua condanna della let-teratura moderna insofferente nei confronti delle regole classiche det-tate dall’ideale dell’equilibrio e della bienséance tipico dell’ancien ré-gime, e un analogo conservatorismo in campo musicale, che si mani-festa particolarmente nell’ultima parte della sua vita, quando Federicoappare sordo, se non ostile, di fronte alle grandi innovazioni della mu-sica contemporanea tedesca che oramai ha spostato il proprio bari-centro da Berlino a Vienna.
Nel celebre metodo per flauto di Quantz Versuch einer Einwei-sung die Flöte Traversiere zu spielen (1752) – il più importante me-todo moderno dopo quello di Hotteterre (1707) e prima della tra-sformazione operata sullo strumento nell’Ottocento da Böhm, un trat-
6 N. Harnoncourt, Musik als Klangrede. Wege zu einem neuen Musikver-ständnis, Salzburg, Residenz, 1982.
riccardo morello90
tato che costituisce il corrispettivo per il flauto di quello di Carl Phi-lipp Emanuel Bach per il cembalo o di Leopold Mozart per il vio-lino – si legge una frase che rispecchia assai bene tale concezione mu-sicale:
Dal momento che non intendo soltanto formare un bravo suonatore di flauto,ma un vero intenditore di musica non dovrò soltanto insegnargli la posi-zione delle labbra, della lingua e delle dita ma plasmare il suo gusto musi-cale e affinare la sua capacità di giudizio7.
Il trattato di J.J. Quantz si propone infatti come una enciclope-dia della musica della propria epoca, un tentativo di plasmare il gu-sto e fondare una scuola berlinese in grado di competere coi tradi-zionali centri europei di irradiazione della cultura musicale. Non solotecnica strumentale – diteggiatura, labbra, modalità di emissione delfiato e di esecuzione di una nota – ma anche e soprattutto analisi ecomposizione, dunque riflessione, per formare non semplici esecutoriprofessionisti o dilettanti ma veri «conoscitori» della musica. Quantzmostra di discostarsi dagli enciclopedisti francesi per quel che con-cerne il giudizio relativo alla musica strumentale. Mentre costoro nonerano riusciti a liberarsi dal pregiudizio razionalistico che bandiva lamusica non vocale, per cui d’Alembert poteva affermare nella prefa-zione all’Enciclopédie che la musica «occupa l’ultimo posto nell’or-dine dell’imitazione», egli sostiene la piena autonomia del discorsostrumentale. Il lieve disprezzo con cui i francesi alludevano sempreall’ambito puramente strumentale, parlando di «symphonies» e «so-nates», lascia il posto all’apprezzamento tipicamente tedesco per que-sto genere musicale, che si era andata sviluppando nel corso del Set-tecento e si fondava sul dosaggio degli effetti. Quantz naturalmenteè un sostenitore dell’ideale equilibrio che si attua attraverso i contra-sti dinamici, il variare dei timbri degli strumenti, l’alternanza di adagie allegri, piani e forti, temi patetici e temi vivaci, tutto ciò che costi-tuirà la base dell’elaborazione dello stile classico e, pur riconoscendoi pregi della musica vocale e del melodramma italiano, si fa sosteni-tore di uno stile musicale tedesco che nasce appunto dall’utilizzazionedei migliori raggiungimenti delle due tradizioni francese e italiana8.
Nel Versuch über die wahre Art das Klavier zu spielen (1753) diCarl Philipp Emanuel Bach, accanto ai suggerimenti tecnici per l’ese-
7 J.J. Quantz, Versuch einer Einweisung die Flöte Traversiere zu spielen, Berlin,Voß, 1752, pp. 58.
8 Cfr. E. Fubini, L’estetica musicale dal settecento ad oggi, Torino, Einaudi, 1976.
federico ii di prussia e la cultura musicale della sua epoca 91
cutore, troviamo analogamente interessanti annotazioni: la condannadella pura abilità tecnica e del virtuosismo fine a se stesso e la ne-cessità, per il buon interprete, di porsi al servizio della musica e delcompositore. Il fine ultimo dell’interprete, sostiene Bach, è rivelare al-l’ascoltatore «il vero contenuto e il sentimento della composizione»,cosa che può realizzarsi unicamente attraverso un atto di Einfühlung,di immedesimazione emotiva. L’esecutore coglie emotivamente il sensodi una composizione e, attraverso la perfetta padronanza tecnica deimezzi espressivi, lo trasmette al pubblico. Il musicista vero sa perce-pire e trasmettere quel quid che non è scritto nello spartito ma checostituisce stilisticamente ed emotivamente la vera cifra di una com-posizione. Non bisogna ridursi al rango di quegli esecutori che si li-mitano a suonare le note. Questo discorso sull’interpretazione è instretta correlazione con gli abbellimenti. Verso la metà del Settecento,infatti, si cerca di disciplinare l’impiego di quest’elemento così essen-ziale nello stile galante. Bach in particolare sottolinea come i cosid-detti abbellimenti non sono elementi aggiuntivi e superflui, ma es-senziali, della composizione: occorre che il compositore specifichi ine-quivocabilmente il loro impiego, non lasciandone la scelta al capric-cio dell’interprete, riportando quindi gli abbellimenti dalla sfera del-l’arbitrio a quella dell’espressione. Un discorso analogo è svolto daBach per gli accompagnamenti, non considerati più come un semplicesupporto alla melodia, ma come parti integranti del discorso musicale.Tutto questo discorso, unitamente alla difesa appassionata dello spes-sore e della qualità della musica del padre contro i suoi detrattori,come Scheibe, che l’aveva tacciata di astrusità e artificio, preludonoanche a una nuova consapevolezza del ruolo creativo del compositoree della necessità di una maggiore indipendenza della sua funzione.Sono temi che – come vediamo dagli studi di Norbert Elias su Mo-zart9 – emergeranno in maniera drammatica nel periodo del classici-smo viennese, quando gli ideali critici ed estetici della società illumi-nistica finiranno per entrare in conflitto con la realtà sociale, il tradi-zionale mecenatismo delle corti europee. Per ora Bach discretamenterivendica al compositore il diritto a non comporre musica «a co-mando», ma di avere la libertà di seguire la propria ispirazione, fa-cendo appello alla competenza del proprio mecenate, il quale ben co-nosce le ragioni dell’orecchio e del cuore.
Federico era un vero e profondo conoscitore della musica soprat-tutto nella sfera intima e privata. Le testimonianze dei contemporanei
9 N. Elias, Mozart, Bologna, il Mulino, 1991.
riccardo morello92
– ad esempio il viaggiatore musicale inglese Charles Burney o JohannFriedrich Reichardt – ci trasmettono un’immagine abbastanza fedeledelle serate musicali a Charlottenburg o a Sanssouci, in cui non solo ilre suonava il flauto accompagnato al cembalo da Bach o dall’orchestra,ma si eseguivano anche brani vocali, cantate e arie. Certo il repertoriostrumentale – sonate, trii e concerti per flauto – era predominante, per-ché preferito dal sovrano e adatto a metterne in luce le capacità esecu-tive che erano quelle proprie di un virtuoso di buon livello. La pas-sione di Federico per la musica sembra travalicare i limiti del mecena-tismo settecentesco, ha in sé un elemento di rivalsa nei confronti degliostacoli opposti dalla società e dal proprio status sociale, anche nei con-fronti dell’autoritarismo incarnato dall’odiata figura paterna, aspetti tra-mandati da una ricca aneddotica in proposito che trova vasta risonanzatra i contemporanei e i posteri. Un esempio per tutti è Beethoven – delquale tra l’altro circolava la diceria, ovviamente del tutto destituita diogni fondamento, che fosse un figlio naturale del re. Come ha scrittoLuigi Magnani, la nota ammirazione del compositore di Bonn per Fe-derico non era certo dovuta a ragioni politiche o sentimentali, bensì alriconoscimento della sua grandezza umana che aveva saputo tener te-sta ai colpi del destino. Era questa tenacia nel riaffermare la propria li-bertà, che accomunava per Beethoven tutti i grandi spiriti, anzi tuttal’umanità, a rendere simpatico ai suoi occhi il vecchio re ipocondriacoe misogino che aveva voluto farsi seppellire con i suoi cani. Per lui va-leva quello che in uno dei Quaderni di conversazione si dice di Rous-seau: «egli era un poco ipocondriaco, ma chi non lo diventerebbe quandosi vive in un’epoca che non può comprendervi?»10. Certo l’immaginedel sovrano che, anche negli anni peggiori della guerra dei Sette anni,quando, minacciato dalla Grande Coalizione rischia di perdere il Re-gno, nei rari momenti di pausa, nell’accampamento, suona il flauto oscrive versi, appare circonfusa da un alone mitico e celebrativo: tutta-via doveva avere anche per i contemporanei una particolare allure co-raggiosamente eroica. Un singolare connubio di pedanteria – l’atten-zione per il particolare apparentemente insignificante, dal bottone delladivisa dell’ultimo ussaro alla qualità della musica eseguita dalle sue bandemilitari – e spirito paternalistico tipico del dispotismo illuminato.
Il re aveva avuto un’ottima educazione musicale, in linea con ilproprio status sociale. La musica faceva parte del corredo culturale dibase di un principe e le prime lezioni gli furono impartite da Gott -
10 L. Magnani, Beethoven nei suoi quaderni di conversazione, Torino, Einaudi,1975.
federico ii di prussia e la cultura musicale della sua epoca 93
lieb Hayne organista del duomo di Berlino. Successivamente vista lapredisposizione musicale del giovane Federico, il padre, Federico Gu-glielmo I di Prussia, piuttosto avaro e restio a spese in campo arti-stico, e sotto la cui scomoda tutela Berlino aveva perso l’opera e l’or-chestra di corte, gli concederà di prendere lezioni di flauto dal mae-stro Quantz che diverrà il suo più fedele amico e consigliere musi-cale, e, successivamente, anche lezioni di composizione da Graun. Du-rante un viaggio ufficiale a Dresda nel 1728 in compagnia del padreFederico era rimasto affascinato dall’eccellente qualità della cappelladi corte sassone, anche se allora non più diretta dal celebre Hasse, edall’opera italiana che si eseguiva in quel teatro. In effetti tutti i mu-sicisti che poi Federico ingaggerà prima a Rheinsberg nella sua cap-pella privata e poi a Berlino dopo l’incoronazione a re di Prussia nel1740 provenivano da Dresda (Quantz, i fratelli Graun e Benda), percui si può davvero affermare che Dresda rappresentasse in quegli anniun modello esemplare di gestione della vita musicale. Johann JoachimQuantz (1697-1773) aveva iniziato la sua carriera di strumentista comeStadtpfeifer a Pirna, entrando come oboista e flautista nella cappelladi Augusto il Forte di Sassonia a Dresda. Aveva poi molto viaggiato,era stato a Vienna in Italia a Napoli e infine in Inghilterra dove avevaincontrato Händel, conosceva la musica strumentale italiana (Vivaldi)e anche l’opera italiana. Nel 1728 divenne maestro di flauto del prin-cipe e poi suo consigliere musicale sino agli ultimi anni. Fu autore dioltre trecento concerti e sonate che ne fanno uno dei principali rap-presentanti dello stile galante. I due fratelli Graun, Johann GottliebGraun (1702-1771) e Carl Heinrich Graun (1703-1759), entrambi mu-sicisti, violinista allievo di Tartini l’uno, rappresentavano il trait d’u-nion tra stile concertistico italiano e tradizione tedesca. Insieme a Bendaquando nel 1740 Federico ascese al trono di Prussia le sorti della mu-sica subirono veramente una svolta epocale.
La mirabile cura con cui la Maestà attualmente regnante in Prussia, a par-tire dal suo insediamento nel glorioso governo, si è degnata di dedicare allacrescita e all’acquisizione delle arti e delle scienze in tutti i Suoi Stati, si èestesa in particolare anche al ripristino dell’arte musicale, in precedenza quasidel tutto caduta in discredito (Marpurg, 1754)11.
Non soltanto Federico attuò una riorganizzazione della vita mu-
11 Cit. in Friedrich der Große in Europa. Geschichte einer wechselvollen Be-ziehung, a cura di B. Sösemann e G. Vogt-Spira, I, Stuttgart, Steiner, 2012, p. 112.
riccardo morello94
sicale di corte ma sostenne e promosse la diffusione della musica comecapitale sociale, fondamentale base di emancipazione ed educazioneetica e culturale della nazione, favorendo la creazione di concerti pub-blici, associazioni musicali, biblioteche e raccolte di musica, lo svi-luppo della pubblicistica e della trattatistica musicale, in particolare sulterreno dell’estetica (si pensi al saggio di Algarotti, Sull’opera in mu-sica, del 1755).
La cappella reale, che a Rheinsberg a partire dal 1736 contava già17 membri, fu ampliata ulteriormente a una ventina di componentipiù le aggiunte per le occasioni solenni. Federico si occupò immedia-tamente anche della rifondazione del teatro musicale a Berlino. Duemesi dopo la sua incoronazione già inviò Graun in Italia per trattarel’ingaggio di cantanti per il nuovo teatro d’opera che si sarebbe inau-gurato nel 1742. L’interesse di Federico non era rivolto unicamentealla musica strumentale ma anche agli sviluppi di quella vocale divisaallora tra le due scuole rivali, quella francese e quella italiana. In ef-fetti il legame della musica col teatro in genere era molto stretto: nonc’era rappresentazione teatrale che non prevedesse l’impiego di un ac-compagnamento strumentale e vocale. Mentre l’opera di corte avevaun carattere eminentemente rappresentativo e veniva allestita solo incerte occasioni (carnevale, genetliaci, feste di matrimonio ecc.), i con-certi di corte rappresentavano una prassi consolidata, anche qui conla distinzione molto netta tra la sfera pubblica – i concerti per la re-gina madre al castello di Montbijou o per la regina Elisabeth Chris -tine a Schönhausen – e quella strettamente privata, a inviti, a Potsdam.Federico compose per queste occasioni non solo pezzi per flauto maanche numerose arie operistiche. Autore di alcuni libretti in francese– Silla (1753) da Corneille, Montezuma (1755) e Merope (1756) daVoltaire e altri – Federico, in questo assecondato da un consigliered’eccezione quale il conte Algarotti, fu protagonista di primo pianodella rinascita operistica di Berlino come piazza di importanza euro-pea nel panorama del melodramma della metà del Settecento. I mo-delli erano principalmente quelli francesi, caratterizzati dal gusto peril meraviglioso, la presenza dei balletti, la concentrazione su conflittidi natura etica piuttosto che erotica e la mescolanza al dialogo di ariee pezzi di insieme. Agli ottimi strumentisti e compositori furono af-fiancati celebri cantanti di livello internazionale quali i castrati F. Sa-limbeni (1743-50) e G. Carestini (1750-1754), la primadonna G. Astrua(1747-1757) – di origine piemontese (era nata a Graglia nel biellese),aveva iniziato la carriera al Regio di Torino per proseguire al SanCarlo di Napoli – il maestro di ballo Denis (1749-1766) e come sce-
federico ii di prussia e la cultura musicale della sua epoca 95
nografo del teatro di corte, a partire dal 1753, una star del firmamentointernazionale, Galli Bibiena, che era stato convinto ad abbandonareDresda. Federico fu anche un sostenitore dell’intermezzo comico, del-l’opera buffa italiana, alla quale riconobbe sempre un’oggettiva supe-riorità sul terreno della pura efficacia teatrale. Egli ingaggiò per Ber-lino la compagnia di Maria Angela e Carlo Paganini, Filippo Sidoti eGiovanni Croce, che avevano iniziato la loro carriera al teatro SanMoisè di Venezia e poi portato in tournée in tutta Europa i loro suc-cessi, tra cui alcuni lavori su libretto di Carlo Goldoni. Il successointernazionale dell’opera buffa italiana era legato al dibattito esteticointorno alle differenze tra le varie tradizioni nazionali che si era svi-luppato soprattutto in Francia e del quale è tributario il saggio di Al-garotti sull’opera in musica. L’apprezzamento del genere buffo si fondasempre sulla contrapposizione tra artificio e naturalezza. I soggettidell’opera comica, tratti dalla vita contemporanea, anziché dalla mito-logia come quelli dell’opera seria, producono un’impressione di fre-schezza e una musicalità semplice e naturale.
Uno dei motivi che troviamo nelle considerazioni di Federico sullamusica accanto all’apprezzamento dell’espressione è la critica dellapompa, dell’esibizione puramente fine a se stessa, quale si manifestaad esempio nelle grandi rappresentazioni allora in voga nelle corti eu-ropee. Certo con una punta d’invidia polemica per la sensazione su-scitata dalla rappresentazione di Ezio (1755) di Hasse a Dresda, conl’impiego di oltre quattrocento comparse, cinque vetture tra cui uncarro trionfale tirato da quattro cavalli, Federico scrive alla sorellaWilhelmine:
Costoro [intende la corte sassone] vogliono che si parli ai loro occhi anzi-ché al loro cuore; un’unica scena commovente è preferibile alle bizzarrie deiloro cortei trionfali. Guai a coloro che non hanno mai conosciuto il piaceredi versare delle lacrime12.
E con ciò torniamo al cuore, al motivo centrale della concezionefedericiana della musica come «Sprache der Gefühle». La capacità dipadroneggiare la tecnica per trasmettere emozioni, con la voce o conlo strumento, e riuscire a commuovere gli ascoltatori, il pubblico. Èprobabile che Federico fosse sommamente felice quando al flauto nonsi sentiva più monarca, ma appunto un uomo capace di provare e tra-smettere semplicemente sentimenti. Schiller, il poeta che confessava di
12 Cit. in S. Heine-Döhring, Die Musik, ivi, p. 240.
riccardo morello96
non amare la figura di Federico e si dichiarava incapace di intrapren-dere il processo di idealizzazione necessario a suo dire per fare di luiun grande personaggio drammatico, ha scritto che la poesia commuoveil cuore perché sgorga dal cuore. E Beethoven nella partitura dellaMissa Solemnis annotò: «Von Herzen, möge es wieder zu Herzengehen». Sotto la patina dissimulatrice del misogino odiatore di sé edell’umanità si nasconde forse un cuore sensibile.
A margine vorrei infine ricordare il legame anche musicale di Fe-derico con il popolo e con l’esercito. L’attribuzione a lui del Hohen-friedner Marsch – una delle marce militari tradizionali prussiane, com-posta prima del 1750 e caratterizzata dalla struttura semplice, ancorasenza trio – anche se probabilmente non è autentica rappresenta co-munque un fatto significativo. Quell’andamento misurato, più solenneche marziale, esprime assai bene l’ethos della vecchia Prussia e mi sem-bra correggere se non contraddire il rutilante militarismo del Preus-sens Gloria di Piefke, frutto del nazionalismo sciovinistico di fine Ot-tocento: evoca un sentimento misto di serietà e tenacia, virtù eroiche,purtroppo infangate da quel che è seguito nella storia tedesca, ma cheprobabilmente, così amiamo pensare, costituisce l’autentica eredità la-sciata da Federico II, un re che ha amato la lira di Apollo più dellaspada.
federico ii di prussia e la cultura musicale della sua epoca 97
Walter Sparn
«CIASCUNO A MODO SUO».RELIGIONE E TEOLOGIA NELLA PRUSSIA
DI FEDERICO IL GRANDE
Il filosofo piemontese Carlo Denina, che nel 1782 era giunto allacorte di Berlino su invito di Federico II, pubblicò nel 1788, dopo lamorte del suo mecenate, un ampio lavoro sulla vita e sul regno delsovrano. Successivamente, tra il 1791 e il 1792, diede alle stampe trevolumi sulla Prussia dei letterati e dei dotti, in cui prendeva in esame,tra l’altro, il giudizio notoriamente negativo di Federico sulla lettera-tura tedesca del suo tempo1. Sarebbe molto interessante analizzare lavalutazione di Denina, che oggi appare tanto garbato quanto ambi-guo. Lascio questo compito agli studiosi di Denina.
1. Federico II: critica del cristianesimo, governo ecclesiastico e politicareligiosa
L’analisi che intendo affrontare non concerne soltanto la naturapiù o meno religiosa della persona del sovrano, ma si estende al pro-filo religioso, ecclesiastico e teologico del suo Stato, del Brandeburgo-Prussia dell’epoca fridericiana, e, più in generale, alla politica che Fe-
1 C. Denina, Essai sur la vie et le règne de Frédéric II, Berlin, Decker, 1788;Id., La Prusse littéraire sous Frédéric II, 3 voll., Berlin, Rottmann, 1790-91 (riprod.Genève, Slatkine, 1968). Cfr. A. Costazza, Carlo Deninas ambivalente Position inBerlin, in Europäische Ansichten, a cura di I.-M. D’Aprile, Berlin, Berliner Wissen-schaftsverlag, 2004, pp. 141-68; E. Tortarolo, Das historische Wissen in den deut-schen Akademien und Carlo Denina, in Id., Diesseits und jenseits der Alpen, Leip-zig, Leipziger Universitätsverlag, 2011, pp. 97-116; W. Rother, Piemontesische Au-toren, in Grundriss der Geschichte der Philosophie. Die Philosophie des 18. Jahrhun-derts, vol. 3, Basel, Schwabe, 2011, pp. 318-31 e p. 353; cfr. anche il saggio di M.Cometa in questo volume.
derico adottò nei confronti delle istituzioni ecclesiastiche e universi-tarie. La politica religiosa ed ecclesiastica di Federico non dipende di-rettamente – e neppure esclusivamente – dalle sue convinzioni perso-nali; essa è ispirata innanzitutto ad altre questioni, come quella dellalegittimità politica di ciò che è utile o inevitabile. Ovviamente le di-chiarazioni personali di Federico sul fenomeno religioso rivestono uninteresse storico; già i suoi contemporanei ne avevano colto l’impor-tanza2. Esse contenevano infatti una violenta critica nei confronti dellareligione, che assumeva toni che nell’Europa del XVIII secolo si in-contravano soltanto in alcuni rari ‘spiriti liberi’ – laddove invece inGermania l’Illuminismo lasciava grande spazio al rapporto persino co-struttivo con la religione, mettendo talvolta capo a uno scambio pro-ficuo3. Per questa ragione occorre anteporre alla trattazione del no-stro tema alcune considerazioni preliminari sulla persona di Federico.
Federico II non era un uomo pio – né nel senso di allora, né inquello odierno. Per tutta la vita aderì com’è ovvio alla Chiesa cristianadi confessione riformata (calvinista), a cui nel 1613 si erano conver-titi gli Hohenzollern del Brandeburgo una volta abbandonato il lute-ranesimo. I suoi rapporti con il cristianesimo non erano buoni: lo ri-teneva infatti, per un verso, una superstizione sciocca e spregevole e,per l’altro, una disciplina sociale utile dal punto di vista politico. Que-sta sua opinione derivava in massima parte dall’educazione severa erigorosa che gli era stata impartita dal padre, Federico Guglielmo I,il Re Soldato, promotore del pietismo hallense. La pedagogia dei pie-tisti si caratterizzava per l’esplicita ossessione nei confronti della di-sciplina sociale, concepita come mezzo per contrastare la (peccami-nosa) ostinazione dei fanciulli. Come molte altre vittime di questomodello educativo, anche Federico era stato abituato a tacitare qual-siasi bisogno interiore, emotivo e morale, che il pietismo associava os-
2 Cfr. ad esempio [Anonimo], Gedanken über die Religion, von Friedrich demZweiten, König von Preußen. Aus dem Französischen, Halle, [s.e.], 1789.
3 Ancor oggi occorre richiamare lo studio di Emanuel Hirsch, in cui l’Illumini-smo del XVIII secolo viene presentato come un’evoluzione necessaria anche dal puntodi vista teologico: E. Hirsch, Geschichte der neuern evangelischen Theologie im Zu-sammenhang mit den allgemeinen Bewegungen des europäischen Denkens, 4 voll.,Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus, 1952, 20005. Un lavoro concepito in maniera ana-loga a quello di Hirsch, ma aggiornato sulla base della letteratura più recente, è quellodi A. Beutel, Kirchengeschichte im Zeitalter der Aufklärung, Göttingen, Vandenhoeck& Ruprecht, 2009. Il testo di riferimento della storiografia teologica rimane K. Aner,Theologie der Lessingzeit, Halle, Niemeyer, 1929 (riprod. Hildesheim, Olms, 1964),che però, seppur ricco di materiale, risulta oggi eccessivamente datato.
walter sparn100
sessivamente ai temi del «peccato», della «penitenza», dell’«umiltà» edella «santificazione». Un’alternativa a questo sistema educativo si pro-filava, negli anni Trenta del Settecento, grazie a Christian Wolff, lanuova figura dominante dell’Illuminismo tedesco che incarnava consuccesso una morale e una religione «razionali», fondamentalmentecompatibili con il cristianesimo. Nel 1736 il padre di Federico avevafinalmente ceduto a questa concezione dietro consiglio di alcuni giu-risti e teologi seguaci di Wolff. Costoro riponevano tutte le loro spe-ranze nel giovane Federico, in cui vedevano un futuro Re Filosofo diorientamento wolffiano4.
Il Principe ereditario si interessava in maniera solo cursoria e su-perficiale di tali questioni, accontentandosi piuttosto di professare quellavaga forma di deismo che gli era stata mediata da Voltaire, con cuiintratteneva uno scambio epistolare dal 1736. Federico ammetteva l’e-sistenza di un «essere superiore» – indipendentemente dalla rivela-zione positiva e storicamente contingente del Cristo – e venerava Diocome garante dell’ordine morale del mondo (se si vuole usare questaformulazione per le considerazioni fredde e distaccate su Dio tipichedi Voltaire e del deismo inglese in generale)5.
Tuttavia l’amara esperienza dell’imposizione religiosa cui vennesottoposto Federico non ebbe come sola conseguenza il cinismo; egline ricavò altresì l’importanza fondamentale del richiamo morale dellacoscienza. Molto significativo a questo proposito è il Sermon sur lejour de judgement, che Federico compose a uso esclusivamente pri-vato nel 1759, durante i giorni più bui della Guerra dei Sette anni6.Ma sul cristianesimo prevalse innegabilmente la sua presa di distanzaironica e satirica dal fenomeno religioso in generale, la quale assunsetalvolta toni talmente blasfemi da impedire per lungo tempo la circo-lazione delle sue opere letterarie, come il Dialogue des morts entreMadame de Pompadour et la Vierge Marie, composto nel 1772-737.
4 Cfr. J. Bronisch, Der Mäzen der Aufklärung. Ernst Christoph von Manteuf-fel und das Netzwerk des Wolffianismus, Berlin, de Gruyter, 2010, in particolare pp.67 ss.
5 Soltanto negli ultimi anni la ricezione del deismo inglese è diventata oggettodi studi approfonditi: cfr. C. Voigt, Der englische Deismus in Deutschland, Tübin-gen, Mohr Siebeck, 2003.
6 Frédéric le Grand, Sermon sur le jour de jugement, in Œuvres de Frédéricle Grand, a cura di J.D.E. Preuss, 30 voll., Berlin, Decker, 1846-56, XV, pp. 1-10.
7 Friedrich II. König von Preußen, Totengespräch zwischen Madame de Pom-padour und der Jungfrau Maria, a cura di G. Knoll, Berlin, Berlin-Verlag Spitz, 1999.
8 Frédéric le Grand, Bref de S.S. le Pape a M. le Maréchal Daun (1759), inŒuvres de Frédéric le Grand, cit., XV, pp. 122-23.
«ciascuno a modo suo» 101
Federico condivideva con Voltaire anche l’atteggiamento aspra-mente critico nei confronti delle Chiese cristiane che a quel tempofungevano da supporto allo Stato o che – come nel caso delle Chieseevangeliche – rappresentavano vere e proprie Chiese di Stato. Obiet-tivo della sua furiosa polemica era però innanzitutto la Chiesa diRoma, dove Papa Clemente XIII sosteneva con ogni mezzo l’ImperoAsburgico contro la Prussia «eretica». Tra il 1759 e il 1774 Federicodiede alle stampe una serie di perfide satire che avevano per oggettole ingerenze del Papa e dei suoi gesuiti nelle questioni politiche, e lefece circolare tra le Corti europee. Già nel 1759 aveva intrapreso l’o-pera di messa in ridicolo della religione con un Breve fasullo di PapaClemente XIII per il Feldmaresciallo austriaco Daun8. Nella scia diPierre Bayle – del cui Dictionnaire historique et critique Federico avevaredatto un estratto – si dedicò anche seriamente alla critica storica delcristianesimo, in particolare delle sue manifestazioni superstiziose, set-tarie, di fanatismo spiritualistico e misticheggiante. Così fece, ad esem-pio, nella prefazione all’edizione compendiata della storia ecclesiasticadi Claude Fleury (1691 e seguenti), che egli aveva studiato integral-mente nonostante fosse composta da numerosi volumi (Avant-Proposde l’Abrégé de L’histoire ecclésiastique de Fleury, 1766). Successiva-mente compose anche alcune satire, come la Jérusalème céleste (1770)e il Rêve (1777), a sostegno del verdetto voltairiano dell’Infâme, incui venivano messi in ridicolo i profittatori di ogni religione. I Com-mentaires apostoliques et théologiques sur les saintes prophéties de l’au-teur sacré de Barbe-bleu (1779) rivestivano di amaro sarcasmo l’in-terpretazione mistica, vale a dire arbitrariamente allegorica, di testi pre-sunti sacri9. Come si avrà modo di vedere, gli stessi teologi protestantidi quell’epoca, richiamando il principio della sola Scriptura, sostene-vano un’ermeneutica contraria all’interpretazione allegorica della Bib-bia.
La polemica di Federico contro il cristianesimo ecclesiastico èsoltanto uno degli aspetti della sua attività in campo religioso. Unaltro aspetto, ben distinto da questo, concerne la sovranità ecclesia-stica che competeva al monarca in quanto Principe di uno Stato delSacro Romano Impero della Nazione Germanica. Questa forma di
9 Alcuni testi di Federico II dedicati alla critica della religione sono stati tradottiin tedesco da Rudolf Neuwinger: Friedrich der Grosse, Theologische Streitschrif-ten, Berlin, Nordland, 1939, 19412 (poi ristampati nel 2004 con il titolo TheologischeStreitschriften und Satiren). Rudolf Neuwinger ha curato anche l’edizione dei Briefeüber die Religion, Berlin, Nordland, 1941.
walter sparn102
sovranità sulla Chiesa vigeva in tutti i territori secolari e in tutte lecittà imperiali della Germania dal 1555, quando, con la Pace reli-giosa di Augusta, era stata stabilita per diritto imperiale. Il monarcaaveva il diritto di determinare la confessione del proprio Paese e ildovere di guidare la Chiesa di Stato in ogni questione esteriore, so-ciale ed economica. Pensata originariamente come una misura diemergenza, questa forma di governo ecclesiastico da parte dei prin-cipi si trasformò presto in una sorta di assolutismo dei sovrani chesi estendeva anche agli affari interni. Nel Brandeburgo-Prussia di Fe-derico II ciò si traduceva nel fatto che il Principe, in forza della so-vranità di cui godeva per diritto naturale, governava la Chiesa cri-stiana attraverso concistori di giuristi e teologi come una qualsiasicomponente dell’ordine pubblico, quindi in base al criterio del be-nessere generale che egli ovviamente intendeva in un senso conve-niente per lo Stato10. Questo rappresentava l’unico criterio in baseal quale Federico II valutava l’ammissibilità delle pratiche di culto estabiliva i confini della tolleranza del governo di fronte alle «sette»religiose: «[esse] possono essere tutte uguali per lo Stato, che lasciaa ognuno la libertà di guadagnarsi il paradiso nel modo che gli èpiù congeniale. Lo Stato gli chiede soltanto di essere un buon cit-tadino»; e ancora, in maniera decisamente più autoritaria, «tutte lereligioni sono ugualmente buone nella misura in cui educano gli uo-mini all’obbedienza»11.
Tanto era conforme ai principi illuministici l’atteggiamento per cuiFederico aveva rinunciato alla legittimazione della sua sovranità Deigratia, quanto era invece affine al modello assolutistico il modo in cuiegli si riservava il diritto di governare le Chiese del suo regno – siaquella luterana, sia quella riformata calvinista – nel senso di una «re-ligione pubblica». Nel Testament politique del 1752 egli scriveva: «Inqualche maniera io sono il Papa dei luterani e dei riformati, il capodella Chiesa; faccio il prete…»12. Istituendo a Berlino un concistorosuperiore, comune ai concistori luterani e al direttorio ecclesiastico
10 Cfr. H.-W. Krumwiede, Kirchenregiment, Landesherrliches, in TheologischeRealenzyklopädie (TRE), vol. 19, Berlin-New York, de Gruyter, 1990, pp. 59-68; H.de Wall, Kirchenregiment, in Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG4), IV,Tübingen, Mohr Siebeck, 20014, pp. 1292-94; A. Schindling, Kirchenregiment, inEnzyklopädie der Neuzeit (EDN), VI, Stuttgart-Weimar, Metzler, 2007, pp. 685-93.
11 Frédéric le Grand, De la superstition et de la religion (1751), in Œuvres deFrédéric le Grand, cit., I, pp. 241-42.
12 Frédéric le Grand, Testament Politique, in Die politischen Testamente Fried -richs des Großen, a cura di G.B. Volz, Berlin, Hobbing 1920, pp. 149.
«ciascuno a modo suo» 103
riformato, Federico piegava i rapporti giuridici ormai consolidati traStato e Chiesa alle esigenze del proprio governo. A quest’organo ap-parteneva dal 1750 anche August Wilhelm Friedrich Sack, predicatoredi corte (riformato) e membro dell’Accademia delle Scienze di Ber-lino. Già il predecessore di Sack, Daniel Ernst Jablonski – interlocu-tore di Leibniz per le questioni di politica religiosa e scientifica – erastato membro del governo ecclesiastico luterano e riformato (e, finoal 1741, presidente dell’Accademia delle Scienze). Sack, celebre predi-catore, lavorava all’Unione delle Chiese protestanti13. Seppur realiz-zata solo nel 1817, l’Unione rappresentava un auspicio importante ditutti i sostenitori delle posizioni illuministiche in fatto di teologia nelBrandeburgo-Prussia. Questi erano ben consapevoli di godere dellaprotezione del sovrano, una protezione non soltanto verbale (egli par-lava perlopiù di «religione protestante»), ma valida anche nell’ambitodella politica ecclesiastica e personale.
I pastori preposti al culto pubblico o all’ispezione scolastica ri-masero comunque vincolati alle loro rispettive confessioni, sebbenegià dal 1713 non fosse più obbligatorio prestare giuramento. Verso lafine del regno di Federico II il vincolo personale nei confronti delleconfessioni tramandate si allentò ulteriormente. Ciononostante conti-nuava a valere il legame confessionale «statutario»: il teologo di HalleJohann Salomo Semler, fondatore dell’esegesi storico-critica della Bib-bia e uno dei principali sostenitori del diritto – anche da parte dei pa-stori – a una religione privata di natura morale, riteneva fosse asso-lutamente opportuno mantenere il vincolo statutario, dal momentoche costituiva un elemento cruciale della stabilità dello Stato. La me-desima convinzione fu espressa anche in Die Religion innerhalb derGrenzen der bloßen Vernunft (La religione nei limiti della sempliceragione, 1793) del suddito di Königsberg Immanuel Kant, il qualeavrebbe incontrato proprio a causa di questo suo scritto notevoli dif-ficoltà con la censura reintrodotta dopo la morte di Federico II. InDer Streit der Fakultäten (Il conflitto delle facoltà, 1798) Kant chiarìin linea di principio la natura del rapporto che ogni ecclesiastico deveintrattenere, per un verso, con la Chiesa a cui è vincolato in manierastatutaria (e quindi con la dottrina che egli deve professare) e, per l’al-tro, con il mondo, ossia con il pubblico in generale14.
13 Cfr. A. Beutel, Kirchengeschichte im Zeitalter der Aufklärung, cit., pp. 116 ss.14 Cfr. I. Kant, La religione nei limiti della semplice ragione (1793), in Id., Scritti
di filosofia della religione, a cura di G. Riconda, Milano, Mursia 1989, pp. 65-216,pt. III, pp. 133-75; Id., Il conflitto delle facoltà (1798), in Scritti di filosofia della re-
walter sparn104
La tolleranza di Federico nelle questioni di politica religiosa ri-guardava quindi gli spazi d’azione previsti dal sistema del diritto ec-clesiastico statale. La massima della «tolleranza» che egli formulò nel1740 in una nota a margine apposta sulla relazione inviatogli dal Di-partimento ecclesiastico – «che ciascuno si salvi l’anima a modo suo»15
– non incoraggiava una sorta di fai-da-te individuale, ma consentivala libera scelta tra una delle confessioni giuridicamente legittime nelsuo regno o tra le «sette» tollerabili da un punto di vista morale epolitico, come ad esempio l’Unitas fratrum. Federico preferiva net-tamente la «religione protestante» – come amava dire – alla Chiesacattolica. Nello scritto De la superstition et de la religion (1751) enell’Avant-propos all’opera di Fleury (1766) vi sono notevoli espres-sioni di apprezzamento nei confronti della Riforma e di Lutero, il«nuovo Bellerofonte», per l’impegno profuso nella formazione dellecoscienze e per l’introduzione del principio di tolleranza. Federicoguardava alla Riforma come a una benedizione per il mondo e peril progresso dello spirito umano, ma era anche profondamente con-sapevole dei mali che essa aveva in qualche maniera comportato: leguerre di religione. Se, come usava dire, «la storia della Chiesa è operadella politica, delle brame e degli interessi personali dei preti», nondeve meravigliare che «nella prospettiva dell’interesse statale» egli ri-tenesse il protestantesimo la religione «ugualmente più adatta alle re-pubbliche e alle monarchie». Il protestantesimo era indicato per lerepubbliche, in virtù dello spirito libero che ne costituiva il tratto es-senziale, ma anche per le monarchie, perché qui «la religione prote-stante, non dipendendo da nessuno, poteva essere completamente sot-tomessa al governo»16. Libertà di coscienza e soggezione nei fatti sonoi tratti che caratterizzano il doppio ruolo del protestantesimo nellaPrussia di Federico II.
Bene o male, con la conquista della Slesia del 1740 e con la spar-tizione della Polonia del 1772, Federico si trovò costretto a tollerareil cattolicesimo, questo «Stato nello Stato, colmo di intrighi e cospi-razioni». Benché esaltasse Federico I – il grande Principe elettore chedal 1648 tollerava i sudditi cattolici delle province occidentali – non
ligione, cit., pp. 229-308. Cfr. W. Sparn, Die öffentliche Aufgabe der Theologie – imSinne Immanuel Kants, in Luthers Erben, a cura di N. Slenczka e W. Sparn, Tübin-gen, Mohr Siebeck, 2005, pp. 169-92.
15 Citato da M. Lehmann, Preußen und die katholische Kirche nach 1640. Zwei-ter Teil: Von 1740-1747, Leipzig, Hirzel, 1881, p. 4.
16 Frédéric le Grand, De la superstition et de la religion, cit., p. 237.
«ciascuno a modo suo» 105
poteva negare che questi aveva agito in senso anche repressivo17. Fe-derico II aveva a cuore la lealtà dei suoi sudditi romano-cattolici nonsoltanto per questioni di politica ecclesiastica, ma soprattutto a finistrategici. Egli aveva persino messo a disposizione un terreno per lacostruzione di un sontuoso edificio sacro, la Chiesa di Sant’Edvige aBerlino (ancorché per la costruzione di chiese protestanti in Slesiaavesse concesso ben di più), dove peraltro fece recitare un Requiemall’indomani della morte di Voltaire (1778) – cosa che a Parigi si eranorifiutati di fare18. Il tono canzonatorio che traspare da una lettera in-dirizzata a d’Alembert rivela l’atteggiamento derisorio che Federicoaveva assunto fin da principio nei confronti della Chiesa cattolica.Quando, ad esempio, si era trattato di scegliere una determinata per-sona per il posto di coadiuvante vescovile a Breslavia nel 1743, egliaveva presentato la propria decisione in questo modo: «Lo SpiritoSanto ed io, insieme, abbiamo deciso che…»19. Gli inizi di quel cheoggi si è soliti chiamare «Illuminismo cattolico» furono recepiti daFederico II solo alla luce della soppressione dell’Ordine dei Gesuiti(1773) e della chiusura dei monasteri ordinata da Giuseppe II20.
Ancora meno equanime e quasi integralmente condizionato da opi-nioni preconcette era l’atteggiamento di Federico nei confronti dell’e-braismo, che egli riteneva culturalmente inferiore e politicamente dan-noso, nonostante alcuni teologi della sua Accademia fossero attiva-mente impegnati nel tentativo di superare il tradizionale antigiudai-smo, investendo, per un verso, su una migliore educazione degli ebreie, per l’altro, sull’agevolazione del processo di conversione. Così, nel1763 il predicatore di corte Sack propose di aprire una scuola ebraicaa Francoforte sull’Oder; nel 1778 David Friedländer, allievo di Mo-ses Mendelssohn, fondò a Berlino una scuola gratuita per gli indigenti(Freischule) di orientamento ebraico riformato. Mendelssohn incorag-giò la redazione dello scritto Über die bürgerliche Verbesserung derJuden (Sul miglioramento civile degli ebrei, 1781-83) del giurista Chris -tian Wilhelm Dohm (assai esperto, peraltro, in questioni teologiche)e intervenne nel vivace dibattito con la sua Jerusalem, oder über re-ligiöse Macht und Judentum (Gerusalemme, o sul potere religioso e
17 Friedrich der Grosse, Theologische Streitschriften, cit., pp. 107-109.18 Lettera a d’Alembert del 22 giugno 1780, in Œuvres de Frédéric le Grand,
cit., XXV, pp. 171-74.19 M. Lehmann, Preußen und die katholische Kirche nach 1640. Zweiter Teil:
Von 1740-1747, cit., p. 399.20 Cfr. A. Beutel, Kirchengeschichte im Zeitalter der Aufklärung, cit., pp. 170 ss.
walter sparn106
sul giudaismo, 1783). Ma nemmeno ciò sortì effetti sulla politica diFederico II nei confronti degli ebrei, che dal 1750 era sì regolamentadal punto di vista giuridico, ma si traduceva di fatto in un inaspri-mento dei controlli e della pressione fiscale (questa forma di tolle-ranza fondata sulla corresponsione di denaro si sarebbe protratta finoal 1812). Federico II ostacolò inoltre l’ingresso di Mendelssohn – ilcelebre filosofo, intimo amico di Gotthold Ephraim Lessing e di Fried -rich Nicolai – tra i membri dell’Accademia delle Scienze di Berlino21.
Lessing, che fin dai tempi del suo soggiorno a Berlino era statoun severo critico di Federico, scrisse con scherno che la «libertà ber-linese» non era altro che «la libertà di mettere in circolazione qual-siasi sciocchezza saltasse in mente contro la religione»22. Fortunata-mente questa non era tutta la verità. Tant’è che oltre agli aspetti piùpersonali e a quelli attinenti la politica ecclesiastica, le attività di Fe-derico rivelavano un interesse ulteriore: la politica religiosa. Qui emergeil suo rapporto attivo e passivo con l’Illuminismo nella sua portatateologica e nelle sue conseguenze religiose, spirituali e persino filoso-fiche. La politica religiosa di Federico era strettamente connessa aglialtri due aspetti menzionati, soprattutto alla politica universitaria e alrapporto personale che egli intratteneva con il mondo religioso – valea dire con gli esponenti del clero, da un lato, e con i musicisti per-lopiù occupati a comporre musica sacra, dall’altro. I maestri di corte– ad esempio, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Joachim Quantze Carl Heinrich Graun – componevano anche musica di chiesa e mu-sicavano i testi di poeti illuministi e devoti, come Christian Fürchte-gott Gellert. Questi personaggi costituiscono di per sé un tema digrande interesse, dal momento che si fecero promotori di un rinno-vamento dello stile e della passione musicali che, dopo la metà del se-colo, si estese anche alla scena letteraria, al dibattito pubblico e alla
21 Moses Mendelssohn im Spannungsfeld der Aufklärung, a cura di M. Albrechte E.J. Engel, Stuttgart-Bad Cannstatt, frommann-holzboog, 2001; G. Heinrich, «…man sollte itzt beständig das Publikum über diese Materie en haleine halten»: DieDebatte um die «bürgerliche Verbesserung der Juden» 1781-1786, in Appell an dasPublikum. Die öffentliche Debatte in der deutschen Aufklärung 1687-1796, a cura diU. Goldenbaum, Berlin, Akademie-Verlag, 2004, pp. 813-96; D. Bourel, Moses Men-delssohn, Zürich, Ammann, 2007.
22 G.E. Lessing, Lettera a Friedrich Nicolai del 28 agosto 1769, in Id., Werkeund Briefe in zwölf Bänden, a cura di W. Barner, XI/1, Frankfurt, Insel, 1987, pp.622 seg. Cfr. K. Bohnen, Grenzsetzungen, in Zensur im Jahrhundert der Aufklä-rung, a cura di W. Haefs e Y.-G. Mix, Göttingen, Wallstein, 2006, pp. 133-44; H.B.Nisbet, Lessing. Eine Biographie, München, Beck, 2008, passim.
«ciascuno a modo suo» 107
pubblicistica teologica, e che si esprimeva innanzitutto nella centralitàdella «sensibilità» (Empfindsamkeit) estetico-morale23. Tra gli illumi-nisti del regno di Federico II la nuova «cultura del sentimento» fupromossa in maniera molto vigorosa proprio dai teologi e dai peda-gogisti.
Ma, muovendo ben al di là dell’aspetto strettamente personale,l’atteggiamento di Federico nelle questioni di politica religiosa e teo-logica determinò – in parte grazie a un impegno attivo, in parte conun atteggiamento indulgente – cambiamenti profondi e duraturi nellasituazione della Chiesa e della teologia nella Germania del tempo. NelBrandeburgo-Prussia si realizzò la principale trasformazione del cri-stianesimo riformato dopo la Riforma, nello spirito di un Illumini-smo devoto24. A questo proposito si può certo parlare di una «spintaverso la modernità», ma non (o perlomeno non senza le opportuneprecisazioni) di «secolarizzazione»25. Anche se non si apprezzano leinterpretazioni teleologiche della storia, non si può non constatare expost che questa trasformazione ha rivestito un ruolo di primo pianonel processo che ha condotto il cristianesimo protestante ad assumereuna parte attiva nei processi di sviluppo della modernità: essa contri-buì infatti alla realizzazione del pluralismo religioso, della particola-rizzazione ecclesiastica e della differenziazione culturale. I principali
23 Cfr. H.-G. Kemper, Deutsche Lyrik der frühen Neuzeit, VI/1: Empfindsamkeit,Tübingen, Niemeyer, 1997; M. Luserke, Empfindsamkeit / Sturm und Drang, inRGG4, II (1999), pp. 1262-67; M. Huber, Empfindsamkeit, in EDN, III (2006), pp.264-68; A. Beutel, Kirchengeschichte im Zeitalter der Aufklärung, cit., pp. 56 ss.
24 Beutel offre una spiegazione di questo concetto nell’ambito dell’epoca storicain questione, Kirchengeschichte im Zeitalter der Aufklärung, cit., pp. 35-66, in parti-colare pp. 61 ss.; una prospettiva piuttosto critica si trova in G. Walther et al.,Aufklärung, in EDN, I (2005), pp. 791-830, in particolare pp. 791 ss., pp. 805 ss. epp. 826 ss.
25 Così questo concetto è stato connesso al ruolo prominente dei figli dei pa-stori nella letteratura tedesca che fioriva in quegli anni, cfr. ad esempio A. Schöne,Säkularisation als sprachbildende Kraft. Studien zur Dichtung deutscher Pfarrerssöhne,Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1968; parimenti si può ritenere la nascita dellapsicologia empirica che si rifaceva alla cultura pietistica dell’osservazione di sé un pro-cesso di secolarizzazione (K.P. Moritz, Gnothi seauton oder Magazin für Erfah-rungsseelenkunde, Berlin, Mylius, 1783-93). Ma già questo è problematico, poiché sipuò parlare di «secolarizzazione» solo in riferimento al diritto ecclesiastico, dove sus-siste una relazione di causa-effetto lineare (l’appropriazione dei beni della Chiesa daparte dello Stato). Relativamente ad altri tipi di sviluppi, determinati da una molte-plicità di fattori e percorsi da disincronie e disteleologie, il concetto non risulta op-portuno, o perlomeno veicola in maniera latente messaggi ideologicamente orientati.Cfr. F.W. Graf, Säkularisierung, in EDN, vol. XI (2010), pp. 525-42.
walter sparn108
cambiamenti che ciò comportò in ambito teologico furono l’indivi-duazione di una religiosità autentica e la critica storica delle tradizionicanoniche. Tutto ciò accadeva nella Prussia di Federico II.
2. La convergenza di Illuminismo e protestantesimo nella Prussia diFederico
Quando, nel 1740, Federico salì al trono, la questione delle orto-dossie rigide dell’epoca confessionale non era più attuale. Il Brande-burgo era lo Stato del Sacro Romano Impero che già nel XVII se-colo aveva mosso il primo passo in vista di un’epoca post-confessio-nale. Dal 1613 il casato dei sovrani aveva un orientamento «rifor-mato», moderatamente calvinista; non esercitando più lo jus refor-mandi, i monarchi non obbligavano i sudditi luterani a convertirsi allaconfessione riformata. Una volta che con la Pace di Westfalia (1648)anche il calvinismo aveva ottenuto la sua legittimazione giuridica, ilGrande Elettore Federico Guglielmo cercò di porre fine alla disputaconfessionale. Persino lo stesso Federico II si adoperò attivamente pergarantire la convivenza pacifica delle diverse confessioni. Al tempo ilnumero dei riformati era notevolmente cresciuto in seguito alle on-date migratorie verso la corte berlinese, tra le file dell’esercito e nel-l’Università di Francoforte sull’Oder, dove dal 1685 si trovavano al-tresì ugonotti francesi (presenti anche nel margraviato del Brande-burgo-Bayreuth degli Hohenzollern). Ancorché alcune comunità ter-ritoriali luterane avessero dovuto accogliere un pastore riformato, nellecittà si riuscì a realizzare una convivenza produttiva tra le diverse con-fessioni, tant’è che nell’espressione «protestantesimo» trovava voceun’(auto)coscienza rinvigorita, comune tanto ai riformati quanto ai lu-terani26.
Federico II si era inizialmente trovato a governare una situazioneprofondamente segnata dall’alleanza che suo padre aveva stretto coni teologi pietisti di Halle: un’alleanza che, sebbene già prima della suaascesa al trono avesse rivestito un’importanza assolutamente margi-nale, aveva tuttavia inculcato precise convinzioni nella mentalità prus-siana, non da ultimo l’habitus del dovere morale, quella sorta di au-todisciplina caratteristica della «religione prussiana». Poiché il pieti-smo di Halle intendeva promuovere il miglioramento sociale attra-
26 Per la preistoria di tale questione cfr. C.V. Witt, Protestanten. Das Werdeneines Integrationsbegriffes in der Frühen Neuzeit, Tübingen, Mohr Siebeck, 2011.
«ciascuno a modo suo» 109
verso l’educazione dei giovani alla pietas, ma anche all’‘abilità profes-sionale’, all’operosità sociale ed economica in vista della realizzazionedei propri doveri, e alla moderazione, ecco che i pietisti occupavanotutti posti di primo piano sulla scena pedagogica ed economica. Lariforma dell’Università di Halle (1693), che presto sarebbe divenutal’Università più importante della Germania, si deve proprio a teologipietisti e a giuristi riformati – in primo luogo, rispettivamente, a Au-gust Herrmann Francke e a Christian Thomasius, che condividevanol’avversione per l’erudizione libresca della scolastica aristotelica e l’e-sigenza di rivolgersi al «mondo», ossia alla dimensione della prassi so-ciale. Halle divenne un centro vivace, animato da idee teologiche, giu-ridiche e mediche, fonte di ispirazione per le nuove imprese pedago-giche che si realizzarono in Prussia (e non solo) e di cui beneficia-rono quasi tutti gli intellettuali di spicco del Paese, compresi Imma-nuel Kant e Johann Georg Hamann27.
Cionondimeno Federico II nutriva una netta avversione per il pie-tismo, sia perché esso costituiva una rete politica, di protezione e pro-paganda molto attiva, sia perché, ove necessario, anteponeva gli inte-ressi religiosi a quelli scientifici. Questo atteggiamento pietista potevarappresentare una minaccia per gli esponenti dell’Illuminismo che, col-tivando l’ideale di una razionalità universale, erano propensi a subor-dinare ad essa le questioni religiose. Il conflitto assunse toni spetta-colari quando coinvolse Christian Wolff, a cui venennero contestati ilricorso al metodo matematico, la teologia metafisica e la filosofia pra-tica fondata sul diritto naturale. La responsabilità delle trame dei teo-logi pietisti nell’allontanamento di Wolff da Halle rappresentava perFederico II una ragione più che sufficiente per prendere le distanzedalla politica del padre e per adoperarsi attivamente affinché Wolff fa-cesse ritorno in quella città, come trionfalmente accadde proprio nel1740. Tra i consiglieri principali di Federico Guglielmo I, oltre a Man-teuffel, c’era il predicatore di corte Johann Gustav Reinbeck, rappre-sentante della schiera dei «teologi wolffiani». Questo gruppo avevasostituito la vecchia scolastica con il metodo razionale di Wolff e avevaintrodotto nella dogmatica tradizionale – secondo un modello co-munque conservatore – l’utilizzo del procedimento razionale in vistadi una concordia rationis cum fide. In questa direzione muoveva an-
27 Cfr. Geschichte des Pietismus, a cura di M. Brecht et al., vol. 2: Der Pietismusdes 18. Jahrhunderts, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1995; per la «spinta dimodernizzazione» dell’Università di Halle dagli anni Trenta del Settecento cfr. A.Beutel, Kirchengeschichte im Zeitalter der Aufklärung, cit., pp. 129 ss.
walter sparn110
che l’ordine di gabinetto con cui Reinbeck invitava i candidati rifor-mati (nel 1739) e quelli luterani (nel 1740) a servirsi nelle loro predi-che sempre di «concetti chiari» e di «argomentazioni razionali»28. Fuun personaggio del calibro di Johann Christoph Gottsched a com-porre l’omiletica che Reinbeck diede successivamente alle stampe comemanuale di riferimento per tutto il territorio del Brandeburgo-Prus-sia29.
Una svolta epocale ebbe inizio quando, all’incirca dal 1740, il con-tra rationem maturato negli ambienti ortodossi e pietistici incominciòa perdere plausibilità nella Germania protestante, sia in ambito pub-blico, sia in ambito teologico. Negli anni a venire il pietismo subì unaprofonda trasformazione – e, con esso, anche il wolffismo. Tutto muo-veva nuovamente da Halle. I due fratelli Baumgarten – Siegmund Ja-cob e Alexander Gottlieb – riuscirono a coniugare in un’ottima con-vergenza teologico-filosofica la razionalità astratta del wolffismo e ilmisticismo dell’ermeneutica pietista. L’interesse specifico di SiegmundJacob per la storia, rivolto in particolare alla ricezione della storio-grafia inglese, lo condusse a elaborare un metodo d’esegesi storico-critico che andava ben oltre i progressi filologici di Ugo Grozio, diRichard Simon o di August Hermann Francke30. Con l’Aesthetica(1750) il più giovane dei Baumgarten, Alexander Gottlieb, integrò –in vista di una critica del sapere mossa dall’interesse per la chiarezzaestensiva delle conoscenze – la facoltà conoscitiva intellettuale conquella sensibile31. La rivalutazione della facoltà conoscitiva inferiorecome organo estetico ha costituito un tema essenziale anche per l’Il-luminismo teologico.
28 A. Straßberger, Johann Gustav Reinbeck. Pietismus und Aufklärung, in Pro-testantismus in Preußen, a cura di A. Beutel, Frankfurt, Hansisches Druck- und Ver-lagshaus, 2009, pp. 163-83; W. Sparn et al., Protestantische wolffianische Theologie,in Grundriss der Geschichte der Philosophie. Die Philosophie des 18. Jahrhunderts, IV,Basel, Schwabe, 2013 (in corso di stampa).
29 Cfr. A. Beutel, Kirchengeschichte im Zeitalter der Aufklärung, cit., pp. 107ss.; A. Straßberger, Johann Christoph Gottsched und die «philosophische» Predigt,Tübingen, Mohr Siebeck, 2010.
30 S.J. Baumgarten, Unterricht von Auslegung der heiligen Schrift, Halle, Bauer,1742 (riprod. con un’introduzione di W. Sparn, Hildesheim, Olms, 2012). Cfr. U.Barth, Hallesche Hermeneutik im 18. Jahrhundert, in Die Hermeneutik im Zeital-ter der Aufklärung, a cura di M. Beetz e G. Cacciatore, Köln, Böhlau, 2000, pp. 69-98; W. Sparn, Siegmund Jacob Baumgarten, in Grundriss der Geschichte der Philo-sophie. Die Philosophie des 18. Jahrhunderts, IV, cit.
31 Cfr. A.G. Baumgarten, L’estetica, a cura di S. Tedesco, Palermo, Aesthetica,2000.
«ciascuno a modo suo» 111
In questa sede si può soltanto constatare l’enorme importanza diqueste innovazioni dal punto di vista scientifico e letterario. Occorretuttavia perlomeno ricordare che per molti anni Siegmund Jacob Baum-garten rese note al pubblico attraverso la sua rivista molte opere teo-logiche pubblicate all’estero – e ciò proprio quando incominciava avenir meno il carattere internazionale del latino. Non va neppure di-menticato che la generazione dei teologi attivi a partire dal 1770 siera formata quasi tutta sotto la guida del vecchio Baumgarten; tra que-sti teologi non vi erano soltanto illuministi dichiarati – come JohannSalomo Semler, il successore dello stesso Baumgarten, e molti altrineologi – ma anche teologi che nutrivano un atteggiamento scetticonei confronti dell’Illuminismo, come Johann Melchior Goeze, l’av-versario di Lessing a Hamburg, o Johann Christoph Woellner, l’au-tore degli editti conservatori sulla censura e sulla religione promulgatinel 1788 sotto il regno di Federico Guglielmo II. Per correttezza sideve ricordare che l’opera di storicizzazione della teologia praticata aHalle fu promossa anche altrove: nell’Università di Helmstedt e inquella di Göttingen, fondata nel 1734, Johann Lorenz von Mosheimdiede vita alla storiografia pragmatica32. Nell’Università di Erlangen,fondata nel 1743 dalla margravia Guglielmina, la sorella prediletta diFederico II, lo storico ecclesiastico Johann Martin Chladenius rivelòil carattere intrinsecamente prospettico di ogni discorso e di ogni com-prensione (che egli mostrava richiamando il caso esemplare delle mol-teplici differenti descrizioni di una medesima battaglia)33. In questomodo l’ermeneutica generale – già concepita dai teologi del XVII se-colo – compì un passo ulteriore in direzione di quella scienza cheavrebbe conosciuto con Friedrich Schleiermacher un primo momentodi spicco.
Uno degli elementi principali nella convergenza tra religione e Il-luminismo nell’epoca di Federico II va infine riscontrato in un’altrainnovazione fondamentale: la trasformazione illuministica della pietas
32 Johann Lorenz Mosheim (1693-1755). Theologie im Spannungsfeld von Philo-sophie, Philologie und Geschichte, a cura di M. Mulsow, R. Häfner et al., Wiesba-den, Harrassowitz, 1997; A. Beutel, Kirchengeschichte im Zeitalter der Aufklärung,cit., pp. 102 ss.
33 J.M. Chladenius, Einleitung zur richtigen Auslegung vernünfftiger Reden undSchriften, Leipzig, 1742 (riprod. Düsseldorf, Stern, 1966). Cfr. W. Alexander, Her-meneutica Generalis, Stuttgart, M & P Verlag für Wissenschaft und Forschung, 1993,pp. 244 ss.; W. Sparn, Kirchenleitung und Theologie in Brandenburg-Bayreuth, inMarkgraf Friedrich von Brandenburg-Bayreuth 1711-1763, a cura di G. Seiderer eC. Wachter, Erlangen, FAU, 2012, pp. 125-40: pp. 136 ss.
walter sparn112
e la forma di riflessione filosofico-religiosa e critica nei confronti deidogmi promossa dalla «neologia». I neologi costituivano un movi-mento teologico che si sviluppò in Prussia all’indomani della Guerradei Sette anni. L’inizio di questo movimento è segnato dall’appari-zione di un trattato agile e brillante che il giovane pastore Johann Joa-chim Spalding pubblicò nel 1748 con il titolo Die Bestimmung desMenschen (La destinazione dell’uomo). Esso comparve dapprima ano-nimo, poi in più edizioni ampliate e con il nome dell’autore. L’operadivenne oggetto di accese discussioni, ad esempio tra Thomas Abbte Moses Mendelssohn, e nel 1794 arrivò all’undicesima edizione. Fusubito tradotta in sei lingue (non però in italiano) e una delle sei tra-duzioni francesi risale alla consorte di Federico II, Elisabetta Cristina(di cui Spalding era padrino di battesimo – il che gli consentì verosi-milmente di divenire nel 1764 uno degli esponenti più in vista delclero berlinese e di rimanerlo fino all’editto sulla religione di Woell-ner del 1788). Non è chiaro (quanto alle mie conoscenze) se Fede-rico II avesse letto perlomeno la versione francese del testo di Spal-ding. La versione tedesca esercitò una grande influenza anche su Fried -rich Schiller e su Schleiermacher, laddove Johann Gottlieb Fichte neriprese intenzionalmente il titolo per il ‘breviario filosofico’ che pub-blicò nel 180034.
Il progetto di Spalding costituiva una delle prime espressioni delcambiamento di mentalità vissuto dalla Germania a partire dalla metàdel Settecento. Spalding prendeva le distanze dal razionalismo wolf-fiano, assai poco interessato alle passioni dell’animo umano, e dallaforma coercitiva della religione moralistica dei pietisti. Egli rappre-sentava al contempo una valida alternativa alle idee deistiche – checircolavano negli ambienti vicini a Federico II, soprattutto grazie allapresenza di Voltaire che fu a Potsdam dal 1750 – e materialistiche diLa Mettrie che, protetto del sovrano e membro dell’Accademia, avevapubblicato – anch’egli come Spalding nel 1748 e in forma anonima –il trattato filosofico L’homme machine. In Spalding si rifletteva altresìlo spostamento dell’interesse del mondo culturale tedesco dalla Fran-cia anticlericale all’empirismo scozzese e all’ottimismo platonizzante
34 J.J. Spalding, Die Bestimmung des Menschen, a cura di A. Beutel et al., inId., Kritische Studienausgabe, vol. I/1, Tübingen, Mohr Siebeck, 2006, «Einleitung»,pp. XXI-XLIX (il testo di Spalding è stato di recente tradotto in italiano con il ti-tolo La vocazione dell’uomo, Milano, Bompiani, 2011). Cfr. W. Sparn, Spalding,Johann Joachim, in Encyclopedia of the Enlightenment, a cura di C.A. Kors, NewYork, Oxford University Press, 2002.
«ciascuno a modo suo» 113
venato da un interesse estetico proprio della filosofia morale inglese.Spalding leggeva e traduceva anche autori francesi, ma, dietro sugge-rimento del vecchio Baumgarten, si adoperò alacremente per la tra-duzione di Shaftesbury, Francis Hutcheson, Joseph Butler e JamesFos ter. L’influenza dell’attività di Spalding non concerneva esclusiva-mente le questioni filosofiche e teologiche, ma si estendeva anche allebelle lettere, dove si esprimeva in una presa di distanza serena, ana-creontica, dall’Illuminismo smodatamente virtuoso e nel culto dell’a-micizia, come quella con Johann Wilhelm Ludwig Gleim di Halber-stadt. Punto di riferimento divenne anche la «poesia sacra» di Frie-drich Gottlieb Klopstock, il cui poema eroico Der Messias (Il Mes-sia, 1747-73) rientrava tra i testi prediletti dei neologi35. La neologiaè stata opportunamente definita una «teologia della sensibilità d’a-nimo» (Theologie der Empfindsamkeit)36.
La destinazione dell’uomo di Spalding determina anche l’inizio diuna nuova epoca nella storia del concetto di pietas: con essa si giungead affermare la piena libertà dell’individuo da ogni condizionamentoesteriore in vista di un agire determinato esclusivamente dalla propriainteriorità. Questo processo era stato avviato dalla spiritualità tardo-medioevale e, successivamente, dalla preminenza del concetto rifor-mato della certezza del credere. All’osservanza religiosa subentrava oral’autenticità religiosa. Non è un caso che la teologia empirica dei neo-logi – che vedeva nella semplicità non artificiosa un criterio impor-tante della comunicazione autentica – fosse strettamente congiunta allaprassi ecclesiastica, e venisse sostenuta innanzitutto da rappresentantidi primo piano del clero, specialmente in Prussia e nella vicina Braun-schweig. La stessa neologia accademica si conformava a questa prassi,non soltanto affermandola pubblicamente, ma anche sostituendo nellaformulazione delle sue teorie le categorie relative al rapporto perso-nale con se stessi a quelle della metafisica tradizionale della sostanza.Il saggio di Spalding risulta esemplare anche sotto questo rispetto:esso inscena un monologo interiore che riconosce una dimensione di
35 Per il contesto letterario cfr. H.-G. Kemper, Deutsche Lyrik der frühen Neu-zeit, V/2, Tübingen, Niemeyer, 1991, pp. 173 ss., nonché VI/1: Empfindsamkeit, cit.,pp. 417 ss.; W. Sparn, «Der Messias». Klopstocks protestantische Ilias, in Protestantis -mus und deutsche Literatur, a cura di J. Rohls e G. Wenz, Göttingen, Vandenhoeck& Ruprecht, 2004, pp. 55-80; A. Beutel, Kirchengeschichte im Zeitalter der Aufklä-rung, cit., pp. 56 ss.
36 H.-G. Kemper, Deutsche Lyrik der frühen Neuzeit, VI/1: Empfindsamkeit,cit., pp. 151 ss.
walter sparn114
trascendenza negli stati esistenziali di volta in volta determinati dallasensibilità, dai piaceri dell’animo, dalla virtù e dalla religione, e chetrova piena soddisfazione soltanto nella certezza dell’immortalità del-l’anima37 e, in definitiva, in Dio. Questo percorso attraverso l’espe-rienza interiore, attraverso il sentire (l’Empfindung, allora ritenuta ilprincipale strumento della certezza), è accessibile a ogni uomo, in que-sta vita terrena e al di là di qualsiasi Rivelazione. Chi si apre ad essae alla sua portata divina riconoscerà, nell’immagine toccante del Cri-sto, il proprio naturale cammino, purificato, compiuto e profondo38.
Nel suo trattato – che si può considerare una forma di «filosofiadella religione» ante litteram (quest’espressione sarebbe infatti com-parsa di lì a poco) – Spalding introduce «Dio» e l’«immortalità» comepostulati antropologici, senza nessun rimando alle vecchie teologie ealle psicologie metafisiche. In questo contesto non si può però par-lare di «idee regolative», perché Spalding si trova ancora al di quadella svolta epistemologica kantiana, essendo persuaso che la realtà diquei concetti potesse venir stabilita con sufficiente certezza sulla basedella loro fenomenologia interna. Mentre Kant avrebbe concentratol’attenzione sull’aspetto epistemologico, Spalding (che pure era in con-tatto epistolare con Kant) insisteva sulla centralità dell’interesse an-tropologico – un tema che con l’Essay on Man di Alexander Pope(edito nel 1733-34, e apparso in traduzione tedesca nel 1740) era en-trato nell’agenda dell’Illuminismo europeo – e dell’interesse peculiareper l’uomo nel suo complesso. L’antropologia religiosa di Spalding nonconiugava soltanto la morale e la religione, ma anche la razionalità ela sfera delle emozioni, «il cuore e il cervello»: il «valore dei senti-menti» costituisce un tema su cui il cristianesimo del tempo si inter-rogava apertamente39. Ritenendo la religione una «questione che con-cerne l’uomo»40, Spalding esprimeva in maniera esemplare la conver-
37 Per l’analisi di Spalding cfr. il saggio introduttivo in Id., Die Bestimmung desMenschen, cit., nonché U. Dreesman, Aufklärung der Religion. Die Religionstheolo-gie Johann Joachim Spaldings, Stuttgart, Kreuz, 2008. Una presentazione estrema-mente chiara della concezione della «religione» in Spalding e nella neologia in gene-rale si trova – oltre che nel saggio introduttivo appena citato – in A. Beutel, Kir-chengeschichte im Zeitalter der Aufklärung, cit., pp. 240-46.
38 W. Jaeschke, Religionsphilosophie, in Historisches Wörterbuch der Philosophie(HWPh), VIII, Basel, Schwabe, 1992, pp. 748-63: pp. 748 ss.; H.-P. Großhans, Re-ligionsphilosophie, in EDN, X (2009), pp. 1121-26.
39 J.J. Spalding, Gedanken über den Werth der Gefühle in dem Christenthum,Leipzig, Weidmann, 1761, 17845 (in Id., Kritische Ausgabe, I/2, a cura di A. Beutele T. Jersak, Tübingen, Mohr Siebeck, 2005).
40 J.J. Spalding, Religion, eine Angelegenheit des Menschen, Leipzig, Voss, 1797,
«ciascuno a modo suo» 115
genza di religione e Illuminismo nella Prussia di Federico II. Tutta-via per Spalding questa convergenza non dipendeva esclusivamentedalla sensibilità dell’animo: essa derivava in misura altrettanto decisivadal processo di decanonizzazione delle tradizioni dogmatiche attra-verso l’opera storico-critica della neologia accademica.
Occorre spendere due parole sul fenomeno della «neologia», unmovimento che ha rivestito un ruolo di primo piano nella storia dellateologia41. Essa non costituì una scuola accademica, ispirata da un pre-ciso programma e raccolta sotto la guida di una figura di riferimento.Il termine «neologo» venne utilizzato per molto tempo in senso de-teriore, per indicare i cosiddetti ‘illuministi devoti’, vale a dire coloroi quali ritenevano praticamente possibile e teoricamente necessaria lacorrelazione tra cristianesimo e Illuminismo. A quel tempo era dif-fusa la convinzione di una perfettibilità del cristianesimo, tanto comedottrina, quanto come pietas individuale e morale, nonché come orien-tamento collettivo. Quest’opinione si radicava nell’idea, condivisa dallagran parte degli illuministi, di doversi adoperare attivamente per ilperfezionamento dell’umanità, ossia per un progresso a venire – unarappresentazione «chiliastica» che si discostava dalla tradizione cri-stiana più antica42. Sostenitori di una siffatta trasformazione del cri-stianesimo in direzione illuministica, ovvero di questa ‘rifinitura’ cri-stiana dell’Illuminismo, si incontravano nelle Facoltà teologiche e fi-losofiche (dove si trovavano a fare i conti con la censura), legati dauna fitta rete di corrispondenze e azioni coordinate. Del tutto nuovoera anche che questi personaggi intervenissero nel dibattito letterariopubblico che incominciava ad affermarsi proprio a quel tempo in untedesco accessibile a tutti, uomini e donne43. Le prospettive dei neo-logi si modificarono progressivamente durante l’opera di rischiara-mento (anche) della stessa religione, e i singoli autori interpretaronoe realizzarono ognuno a suo modo la dinamica asimmetrica in cui si
18065 (in Id., Kritische Ausgabe, I/5, a cura di T. Jersak e G.F. Wagner, Tübingen,Mohr Siebeck, 2001).
41 Cfr. G. Hornig, Neologie, in HWPh, VI (1984), pp. 718-20. La migliore pre-sentazione della neologia accademica ed ecclesiastica è A. Beutel, Kirchengeschichteim Zeitalter der Aufklärung, cit., cap. V, pp. 112-51; sul significato filosofico-religiosocfr. W. Sparn – A.U. Sommer: Die Neologie, in Grundriss der Geschichte der Phi-losophie. Die Philosophie des 18. Jahrhunderts, IV, cit.
42 Cfr. R. Baum – G. Hornig, Perfektibilität, in HWPh, VII (1989), pp. 238-44; W. Sparn – G. Walther, Fortschritt, in EDN, III (2006), pp. 1079-84; H.-P.Großhans, Chiliasmus, in EDN, II (2005), pp. 681-87.
43 W. Schmale, Öffentlichkeit 1, in EDN, IX (2009), pp. 358-62.
walter sparn116
esprimeva la correlazione tra cristianesimo e Illuminismo. Nel corsodel tempo divenne assai controversa la questione del limite da im-porre a una soluzione dell’asimmetria pensata in senso unilateralmenterazionalistico44.
La presenza pubblica e consapevole dei neologi si intensificò al-l’incirca a partire dal 1750; dopo la Guerra dei Sette anni essi diven-nero il gruppo dominante nell’accademia e nella politica ecclesiasticadel Brandeburgo-Prussia. Gli esponenti principali della neologia eranoattivi nei concistori berlinesi, tra i predicatori di corte, nel Diparti-mento ecclesiastico, nelle università di Halle e di Francoforte sull’O-der45, ma anche nei luoghi della discussione pubblica che incomincia-vano a costituirsi. Il più attivo tra questi – che raccoglieva i membridell’ambiente religioso e intellettuale che si era formato a Berlino ne-gli ultimi anni del regno di Federico II – era la Mittwochsgesellschaft:fondata nel 1783, aveva il proprio organo di stampa nella BerlinischeMonatsschrift46. Nonostante la vivacità dei neologi locali, al di fuoridella Prussia – a Braunschweig, Lipsia, Jena, Gottinga, e persino adAltsdorf e a Erlangen – questo movimento s’impose (a eccezione diBraunschweig) con un decennio di ritardo, senza mostrare un parti-colare radicamento negli ambienti dell’Illuminismo progressista47.
In Prussia la situazione appariva invece più favorevole, non da ul-timo grazie al fatto che Federico II aveva adottato molto presto e conferma convinzione una politica di reclutamento ispirata ai principi dellaneologia. Vicino alle posizioni neologiche era anche il ministro KarlAbraham von Zedlitz. Federico cercò persino di attirare in Prussia al-cuni neologi particolarmente brillanti: in questa prospettiva, nel 1770,assegnò la guida delle chiese del Magdeburgo e del celebre Pedago-gium di Kloster Berge, sempre nei pressi di Magdeburgo, al sovrain-tendente generale di Braunschweig, Johann Friedrich Wilhelm Jerusa-
44 Non è però corretto affermare – come accadeva regolarmente nella prima sto-riografia e come talvolta accade ancor oggi – che la neologia debba sfociare in ma-niera più o meno necessaria nel razionalismo, ossia nella negazione di una «Rivela-zione» specificamente cristiana. Cfr. quanto osserva correttamente A. Beutel, Kir-chengeschichte im Zeitalter der Aufklärung, cit., pp. 151-52.
45 Riguardo a Halle e Francoforte sull’Oder cfr. A. Beutel, Kirchengeschichteim Zeitalter der Aufklärung, cit., pp. 129 ss.
46 Berlinische Monatsschrift, Berlin, Haude & Spener, 1783 e ss. W. Schmale,Mittwochgesellschaft, in EDN, VIII (2008), pp. 622-24; sul significato filosofico dell’«Il-luminismo berlinese» e di Federico II, cfr. S. Lorenz, Berliner Aufklärung, in Grun-driss der Geschichte der Philosophie. Die Philosophie des 18. Jahrhunderts, IV, cit.
47 Riguardo a Lipsia, Jena e Göttingen cfr. A. Beutel, Kirchengeschichte im Zeit -alter der Aufklärung, cit., pp. 134 ss.
«ciascuno a modo suo» 117
lem (tra l’altro protettore del direttore della biblioteca di Wolfenbüt-tel, Lessing). Jerusalem s’era imposto sulla scena culturale, oltre cheper una serie di prediche che avevano riscosso un grande successo,per le sue Betrachtungen über die vornehmsten Wahrheiten der Reli-gion (Osservazioni sulle principali verità della religione, 1768, e tra-dotto in francese già nel 1770) e come simpatizzante dell’unione ec-clesiastica48. L’iniziativa di Federico fu tuttavia poco felice. Fu propriolo scrittore Jerusalem, celebre per il suo stile tagliente, che non esitòa mettere in ridicolo lo scritto di Federico De la littérature allemande(1780) con una rassegna della letteratura tedesca contemporanea daltitolo Ueber die Teutsche Sprache und Litteratur (Sulla lingua e sullaletteratura tedesche), pubblicata nel 1781 e tradotta in francese per bendue volte nel medesimo anno49.
Più duraturo fu invece il successo della politica di reclutamentodi Federico II nel caso di Johann August Eberhard, il pastore berli-nese che per la prima volta offrì una presentazione esemplare dellacritica neologica alla tradizione e ai dogmi. A differenza della quasitotalità della tradizione, nella Neue Apologie des Sokrates (Nuova apo-logia di Socrate, 1772-78) Eberhard aveva infatti sostenuto la tesi se-condo cui anche i pagani, qualora moralmente retti, sfuggono alle peneeterne dell’inferno, possono conseguire la santità e non vengono dan-nati a causa del loro cosiddetto ‘peccato originale’50. Già Leibniz avevaaffermato l’eternità delle pene dell’inferno per i peccatori, e questaconvinzione era stata difesa nel 1773 nientemeno che da Lessing, an-corché questi si trovasse d’accordo con molti aspetti dell’argomenta-zione della Neue Apologie. Nonostante la protezione del sovrano, lacarriera di Eberhard subì un brusco arresto da parte di alcuni suoicolleghi, i quali si accorsero immediatamente che questi – da una po-sizione caldeggiata dal pubblico illuminista – smantellava l’intera ere-dità agostiniana (probabilmente, però, non era vista di buon grado
48 J.F.W. Jerusalem, Betrachtungen über die vornehmsten Wahrheiten der Reli-gion, Braunschweig, Waisenhaus-Buchhandlung, 1768, 17765; Fortgesetzte Betrach-tungen… 1772-1779. 1792 (riprod. con un’Introduzione di U.A. Sommer, in Id., Sch-riften, I-II, Hildesheim, Olms, 2007).
49 J.F.W. Jerusalem, Ueber die Teutsche Sprache und Litteratur, Berlin, [s.e.],1781; insieme alla traduzione tedesca dello scritto di Federico II in Id., Nachgelas-sene Schriften, II, Braunschweig, Schulbuchhandlung, 1793, pp. 295-364 e pp. 365-94, riprod. in Id., Schriften, cit., V (con la paginazione originale).
50 J.A. Eberhard, Neue Apologie des Sokrates oder Untersuchung der Lehre vonder Seligkeit der Heiden, 2 voll., Berlin-Stettin, Nicolai, 1772-1778, riprod. con un’In-troduzione di W. Sparn, Hildesheim, Olms, 2010.
walter sparn118
neppure l’amicizia di Eberhard con Mendelssohn). Tuttavia nel 1776la Allgemeine Theorie des Denkens und Empfindens (Teoria generaledel pensare e del sentire) di Eberhard fu premiata dall’Accademia delleScienze berlinese. Si tratta di un’opera che ha segnato la particolarericezione dei Nouveaux essais sur l’entendement humain di Leibniz(pubblicati solo nel 1765) in ambiente neologico. Poiché non era piùpossibile trovare per Eberhard una sistemazione in una Facoltà teo-logica – non da ultimo perché aveva smesso di produrre lavori scien-tifici di argomento teologico – nel 1778 il ministro von Zedlitz lochiamò a Halle sulla cattedra di Filosofia che era stata di Wolff e cheKant aveva appena rifiutato. A Halle Eberhard si occupò fino al 1804con un certo successo di estetica, di politica, di storia della filosofiae di critica del linguaggio, e non da ultimo fu maestro di Schleier-macher. Come antikantiano, invece, ebbe decisamente meno fortuna51.
Gli insuccessi o, perlomeno, i successi soltanto parziali della po-litica religiosa di Federico non impedirono affatto che i teologi e i fi-losofi di orientamento neologico coltivassero a partire dagli anni ’60una sorta di convergenza tra Illuminismo e protestantesimo che te-neva in considerazione tanto il criterio della natura personale dell’e-sperienza religiosa, quanto quello della critica storica. Anche in que-sto caso si distinsero gli esponenti del clero berlinese: Friedrich Ger-manus Lüdke e Anton Friedrich Büsching (entrambi allievi del teo-logo Baumgarten) si adoperarono, ad esempio, per la soppressione delvincolo formale dei testi confessionali riformati, della ‘coercizione delsimbolo’, a favore della tolleranza e della libertà di coscienza52. Ov-viamente la critica si dirigeva contro varie forme di superstizione cheerano sopravvissute, come la credenza nei demoni e nelle streghe, non-ché contro alcuni capisaldi della dogmatica, come la satisfactio vica-ria attraverso la passione e la morte di Cristo, il duplice esito del giu-dizio universale e la dottrina trinitaria – che erano ritenute allora con-cessioni alla concezione del mondo ebraica ed ellenistica. Accanto aiberlinesi, grande centralità avevano i neologi di Halle e di Francoforte
51 W. Sparn, Introduzione a J.A. Eberhard, Neue Apologie des Sokrates oderUntersuchung der Lehre von der Seligkeit der Heiden, cit., pp. V-XXXIII.
52 F.G. Lüdke, Vom falschen Religionseifer, Berlin, Mylius, 1767; Id., Über To-leranz und Gewissensfreiheit, sofern die rechtmäßige Religion sie befördert und dieunrechtmäßige sie verhindert, Berlin, Mylius, 1774; A.F. Büsching, Allgemeine An-merkungen über die symbolischen Schriften der evangelisch-lutherischen Kirche undbesondere Erläuterungen der augsburgischen Confeßion (1770), Hamburg, Buchenröder& Ritter, 1771. Cfr. A. Beutel, Kirchengeschichte im Zeitalter der Aufklärung, cit.,pp. 123 ss. e pp. 134 ss.
«ciascuno a modo suo» 119
sull’Oder, come l’allievo di Baumgarten Johann Gottlieb Toellner el’allievo di quest’ultimo, Gotthilf Samuel Steinbart. Il titolo di un’o-pera di Steinbart esprime pienamente l’impeto neologico nella sua ma-turità: System der reinen Philosophie oder Glückseligkeitslehre desChris tentums für die Bedürfnisse seiner aufgeklärten Landesleute undanderer, die nach Weisheit fragen, eingerichtet (Sistema di filosofia purao dottrina della felicità del Cristianesimo, pensata per soddisfare i bi-sogni dei suoi sostenitori illuminati e per gli altri che domandano dellasaggezza, 1778)53.
La critica neologica alla tradizione concerneva – e in ciò era dav-vero rivoluzionaria – anche la Bibbia. In alcuni scritti – che, seppurredatti in uno stile poco elegante, sono riconosciuti ancor oggi comemomenti di svolta all’interno della critica teologica – il teologo diHalle, Semler, applicava con piena coerenza i metodi della critica sto-rica alla Sacra Scrittura, che poteva ora venir letta anche come un do-cumento storico. Si pensi, a questo riguardo, alla sua Abhandlung vonfreier Untersuchung des Canons (Trattato sul libero esame del canone,1771). Poiché i testi tramandati erano assai difformi e potevano essereinterpretati come il risultato di un accomodamento di Dio rispetto aprecedenti forme religiose più immature, la teologia neologica «libe-rale» – entro cui la riflessività del soggetto religioso rivestiva un ruolocostitutivo (e quindi anche critico) – vi poteva trovare la legittima-zione della propria cristianità. Questo era il tema di un altro scrittodi Semler: Versuch einer freiern theologischen Lehrart (Saggio di unmetodo teologico più libero, 1777)54. Le distinzioni in senso neologico
53 G.S. Steinbart, System der reinen Philosophie oder Glückseligkeitslehre desChristentums für die Bedürfnisse seiner aufgeklärten Landesleute und anderer, dienach Weisheit fragen, eingerichtet, Züllichau, Frommannische Buchhandlung, 1778,17944. Cfr. A. Beutel, Kirchengeschichte im Zeitalter der Aufklärung, cit., pp. 258ss. Relativamente ai neologi e agli «scontri» con i neologi tra il 1760 e il 1780 è an-cor sempre utile K. Aner, Theologie der Lessingzeit, cit., pp. 61 ss. e pp. 234 ss. (maAner credeva erroneamente che Semler non fosse un neologo, cfr. ivi, pp. 98 ss.).
54 J.S. Semler, Abhandlung von freier Untersuchung des Canon, 4 voll., Halle,Hemmerde, 1771-75, riprod. parziale Gütersloh, Mohn, 1980_; Id., Institutio ad doc-trinam christianam liberaliter discendam, Halle, Hemmerde, 1774; Id., Versuch einefreiern theologischen Lehrart, zur Bestätigung und Erläuterung seines lateinischen Buchs, Halle, Hemmerde, 1777. Cfr. H.H.R. Schulz, Johann Salomo Semlers Wesensbestimmung des Christentums, Würzburg, Königshausen & Neumann, 1988;Historische Kritik und biblischer Kanon in der deutschen Aufklärung, a cura di H.Graf Reventlow, W. Sparn e J. Woodbridge, Wiesbaden, Harrassowitz, 1988; A. Chris -tophersen, Bibelkritik, in EDN, II, (2005), pp. 142-47; A. Beutel, Kirchengeschich -te im Zeitalter der Aufklärung, cit., pp. 129 ss.; M. Schröter, Aufklärung durch Hi-
walter sparn120
tra la Bibbia e la parola di Dio, tra la religione e la teologia scienti-fica, tra la storia e il dogma affrontate da Semler facevano della teo-logia protestante il veicolo della coscienza moderna storico-ermeneu-tica, seppur affidando proprio a quella teologia il compito di gettareun ponte sull’«ampio e brutto fossato» – come diceva Lessing – chesepara l’Ora e il Prima, il presente che ha perso il proprio Dio e iltempo dei segni e dei miracoli55.
3. La pratica dell’Illuminismo religioso nella Prussia di Federico II
Sotto il regno di Federico II la neologia ebbe occasione di var-care i confini del mondo dotto e di estendere la propria influenzasulla vita quotidiana. Questa era la sua vera aspirazione. L’atteggia-mento emancipatorio e pedagogico nei confronti della borghesia cit-tadina la poneva in piena consonanza con la filosofia illuministica, chea torto viene spesso ritenuta in tono spregiativo una «filosofia popo-lare». Al di là della «teologia popolare», la neologia assumeva altresìun impegno concreto nei confronti degli esponenti del clero e dellapopolazione, dell’«Illuminismo per il popolo». Essa si estendeva, ol-treché alla pratica religiosa, a tutti gli aspetti della vita, ivi compresiquelli relativi all’agronomia (il che le procurò anche qualche dileg-gio)56. Mi soffermerò brevemente sugli ambiti principali della praticaneologica nella Prussia fridericiana, non soltanto per rimarcarne gliesiti positivi, ma anche per sottolinearne le ambiguità e i limiti.
Tutti i neologi, persino quelli che rivestivano ruoli accademici, si
storisierung. Johann Salomo Semlers Hermeneutik des Christentums, Berlin, de Gruy-ter, 2012.
55 G.E. Lessing, Der Beweis des Geistes und der Kraft (1777), in Id., Werke, acura di H.G. Göpfert, VIII, München, Hanser, 1979, pp. 9-14: p. 13; trad. it. a curadi G. Ghia, Sulla prova dello spirito e della forza, in Id., Opere filosofiche, Torino,Utet, 2008, pp. 541-47: p. 546. Cfr. H.B. Nisbet, Lessing. Eine Biographie, cit., pp.701 ss., in particolare pp. 714 ss.; W. Sparn, Lessing, in Grundriss der Geschichte derPhilosophie. Die Philosophie des 18. Jahrhunderts, IV, cit.
56 Il concetto risale al 1782, ma la letteratura relativa incomincia a comparire giànegli anni Cinquanta; cfr. Volksaufklärung. Eine praktische Reformbewegung des 18.und 19. Jahrhunderts, a cura di H. Böning et al., Bremen, Edition Lumière, 2007;A. Beutel, Kirchengeschichte im Zeitalter der Aufklärung, cit., pp. 146-51. Partico-larmente fortunato fu il Lesebuch für alle Stände. Zur Beförderung edler Grundsätze,ächten Geschmacks und nützlicher Kenntnisse, 10 Teile, Berlin, Maurer, 1781-1804 (2°ed. 1782 ss., 3° ed. 1790 ss.), a cura del pastore berlinese di orientamento neologicoJohann Friedrich Zöllner.
«ciascuno a modo suo» 121
adoperavano con grande vivacità per stabilire una comunicazione at-tiva con un pubblico che si stava progressivamente ampliando e cherivendicava una propria competenza nelle questioni religiose. Di con-seguenza i neologi ricorrevano, nelle loro numerose pubblicazioni inlingua tedesco, a uno stile accattivante e brillante, ma al contempo ac-cessibile e semplice, spesso concepito come veicolo di un dialogo idealecon il lettore, e pienamente conforme al principio neologico fonda-mentale della «semplicità autentica». I molti ebdomadari (Wochen -schriften) di argomento morale rappresentavano per i neologi auten-tiche occasioni per divulgare le loro tesi e i loro argomenti; per laparte di pubblico più colta, invece, si pubblicavano numerose rivistein cui veniva discussa la produzione letteraria più recente. Il princi-pale organo d’informazione (non solo per la Prussia) per le novità let-terarie tedesche ed estere era la Allgemeine deutsche Bibliothek (ADB,Biblioteca universale tedesca), pubblicata tra il 1765 e il 1805 da Frie-drich Nicolai, autore ed editore berlinese, amico di Lessing e Men-delssohn, e membro della Mittwochsgesellschaft. Il pessimo giudizioche a lungo ha pesato su questo personaggio molto prolifico, maspesso incline ad assumere toni polemici troppo bruschi – che fu pe-raltro il traduttore tedesco delle opere di Carlo Goldoni – ha cono-sciuto di recente, e a ragione, revisioni radicali. L’Allgemeine deutscheBibliothek rappresentava uno strumento decisamente efficace per laformazione dell’opinione pubblica: in quegli anni oltre 400 recensori,perlopiù di orientamento neologico, vi discussero all’incirca 80.000nuove pubblicazioni57.
Sotto la protezione di Federico II i neologi lavoravano alla riformadella pratica ecclesiastica. Essi fondavano riviste specializzate su cui di-scutere le loro opinioni circa la riforma liturgica, omiletica e pasto-rale. Considerando che la messa domenicale non rappresentava piùl’unico centro della comunicazione locale e della coesione sociale58, ineologi ponevano al centro delle loro riflessioni anche letterarie la pie-
57 U. Schneider, Friedrich Nicolais Allgemeine Deutsche Bibliothek als Integra-tionsmedium der Gelehrtenrepublik, Wiesbaden, Harrassowitz, 1995 (sulla BerlinerMittwochgesellschaft cfr. in particolare pp. 66 ss.); S. Habersaat, Verteidigung derAufklärung. Friedrich Nicolai in religiösen und politischen Debatten, 2 voll., Würz-burg, Königshausen & Neumann, 2000-2001; Friedrich Nicolai und die Berliner Aufklä-rung, a cura di H.E. Bödecker et al., Hannover, Wehrhahn, 2008.
58 Il processo di «de-ecclesiasticizzazione» (insieme alle polemiche che ne sonoseguite) si impone già all’inizio del XVIII secolo, cfr. F.W. Graf, Entkirchlichung, inEDN, III (2006), pp. 338-40; M. Burckhardt, Die Diskussion über die Unkirchlich -keit […] im ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert, Frankfurt, Lang, 1999.
walter sparn122
tas ‘solitaria’: i loro libri di preghiere e i loro scritti di edificazione(tra questi si contavano pure giornali e almanacchi) conoscevano difrequente un gran numero di edizioni59. Quanto alla celebrazione delservizio divino non tutte le proposte dei neologi ebbero successo, manel complesso le cerimonie della chiesa mutarono in maniera dura-tura.
In Prussia il Gesangbuch (libro dei canti), di orientamento pieti-stico, fu integrato nel 1765 con istanze illuministiche e nel 1780 so-stituito con un nuovo libro dei canti (il responsabile dell’operazioneera l’Oberkonsistorialrat J.S. Dietrich, ma della commissione facevanoparte anche i teologi Spalding e Teller). La gran parte dei canti rien-trava nella poesia contemporanea, ‘sentimentale’, orientata sulle virtù;i canti precedenti furono riformulati con una poetica più conforme algusto del tempo e alle direttive neologiche – ottimismo morale e ele-vazione religiosa degli animi – e cantati con ritmi e melodie più pa-cati. A Berlino e altrove vi furono vivaci discussioni, ma il libro deicanti fu introdotto con un regolare ordine del sovrano60. Alla «sem-plicità» neologica si connetteva la semplificazione della liturgia dellefunzioni, la sostituzione delle preghiere canoniche con forme libere dipreghiera, un allestimento più personale dei sacramenti del battesimoe del matrimonio, e del rito funebre. Poiché era considerata ancheuno strumento per il disciplinamento sociale in stile ‘gesuitico’, si sop-presse la confessione individuale, e si espunse dal rito del battesimola rinuncia a Satana e al peccato. I locali in cui si tenevano le fun-zioni religiose furono riprogettati, per assicurare una maggiore lumi-nosità e semplicità: si ampliarono le finestre, si eseguirono affreschi incui dominava il bianco e in cui comparivano soltanto pochi simboliastratti; si eliminarono i paramenti sacri, ancora in parte utilizzati, ei confessionali61.
Più centrale di prima divenne ora la predica (e il pulpito all’in-terno della chiesa), tuttavia con un’altra finalità e un altro stile: essaveniva ora concepita come una sorta di ‘discorso pronunciato dal pul-
59 Sulla vita ecclesiastica cfr. la ricostruzione complessiva di A. Beutel, Kir-chengeschichte im Zeitalter der Aufklärung, cit., pp. 237 ss.
60 Cfr. P. Weber, Der Berliner Gesangbuchstreit 1781. Aporien der Aufklärung«von oben», in Berliner Aufklärung. Kulturwissenschaftliche Studien, I, a cura di U.Goldenbaum e A. Košenina, Hannover, Wehrhahn, 1999, pp. 101-19.
61 P. Cornehl, Gottesdienst VIII.2 Aufklärung, in TRE, XIV (1993), pp. 61-64;G. Strohmeier-Wiederanders, Kirchenausstattung, in EDN, VI (2007), pp. 607-15;sul servizio divino in generale cfr. A. Beutel, Kirchengeschichte im Zeitalter derAufklärung, cit., pp. 225-30.
«ciascuno a modo suo» 123
pito’. Il pastore continuava a presentarsi come esperto attendibile nellequestioni teologiche, ma non come dispensatore di imposizioni dog-matiche; era il consigliere fidato della sua comunità, capace di appli-care con un linguaggio adeguato e in maniera convincente le ‘veritàfondamentali’ della Bibbia ai bisogni più intimi e concreti dei suoiuditori, alla vita quotidiana e all’orientamento della società. Più tardisi pensò che questo «tipo di discorsi fatti al popolo da un maestro inabiti talari» avesse degradato il cristianesimo a utilitarismo sociale. Ildiscorso pronunciato dal pulpito era effettivamente rivolto a pro-muovere un perfezionamento religioso e morale sia in senso indivi-duale, come intima presa di coscienza, sia in senso collettivo, comeincremento del benessere generale. Questa nuova forma di predicanon intendeva limitarsi, tuttavia, a risvegliare la ragione pratica, mavoleva arrivare al cuore senziente dell’uomo ed ‘elevarne’ il sentimentoverso Dio. Solo in questa duplice accezione il pulpito dei neologi puòvenir considerato la «cattedra dell’Illuminismo»; ciò vale in specialmodo per i predicatori di corte di Federico II, che – come nel casodi Spalding – si trovarono sovente a dover giustificare presso il pub-blico l’immagine neologica del pastore. Sebbene Spalding ritenesse som-mamente importante la questione «se per nostro tramite e per mezzodella religione di Gesù Cristo i nostri uditori conoscano un miglio-ramento interiore e divengano degni del paradiso»62, la sua posizionesuscitò le critiche e le opposizioni di teologi orientati verso un’altraforma di Illuminismo, ad esempio Johann Gottfried Herder. Questidistingueva più nettamente il ruolo dei pastori in quanto maestri diverità e di virtù dalla loro professione (Beruf) che li rendeva «depo-sitari di un tesoro della Rivelazione, preposti a questo compito pro-prio dalla società civile…»63. La trasformazione in corso dell’ufficiopastorale fu discussa sovente nella letteratura epistolare e nei romanziquando si trattava di introdurre figure di pastori, a partire da Goethe
62 J.J. Spalding, Ueber die Nutzbarkeit des Predigtamtes und deren Beförde-rung, Berlin, Voss, 1772, 17912, in Id., Kritische Ausgabe, I/3, a cura di T. Jersak, Tü-bingen, Mohr Siebeck, 2002, p. 227. Le prediche dei predicatori di corte vennerostampate a partire da A.F.W. Sack; le prediche di Spalding sono oggi nuovamente di-sponibili grazie al lavoro di A. Beutel, cfr. J.J. Spalding, Kritische Ausgabe, sez. II:Predigten, Tübingen, Mohr Siebeck, 2009. Sulla condizione dei pastori cfr. A. Beu-tel, Kirchengeschichte im Zeitalter der Aufklärung, cit., pp. 233-37.
63 J.G. Herder, An Prediger. Funfzehn Provinzialblätter (1774), in Id., Werkein zehn Bänden, IX/1, Frankfurt/Main, Deutscher Klassiker Verlag, 1994, pp. 67-138:p. 80. Cfr. A. Beutel, Kirchengeschichte im Zeitalter der Aufklärung, cit., pp. 194-98.
walter sparn124
e Nicolai, passando per Lenz e Voß, fino a Jean Paul. Riscosse ungrande successo il Sebaldus Nothanker (1773-76), l’opera che Nicolaipubblicò in tre volumi illustrati da Daniel Chodowiecki, in cui trac-ciava in toni satirici una diagnosi efficace del suo tempo64.
All’orientamento neologico della predica, che si rivolgeva diretta-mente alle capacità intellettive di un uditorio che aspirava alla felicità,corrispondeva un nuovo orientamento della pedagogia. Sulla scortadelle concezioni di John Locke e di Jean-Jacques Rousseau (e anchedei passi evangelici sui bambini), l’indottrinamento del catechismo lu-terano o heidelberghese venne trasformato in un insegnamento piùadatto allo sviluppo del fanciullo, che mirava complessivamente a faremergere in maniera maieutica e socratica un orientamento autonomofondato su una conoscenza delle questioni religiose effettivamente ade-guata e compresa entro il contesto più ampio di una profonda cul-tura generale. A ciò contribuirono le nuove traduzioni della Bibbia,le nuove esposizioni del catechismo o i nuovi catechismi in generale,ma soprattutto la preparazione e il perfezionamento degli insegnantinelle scuole e nei ginnasi, così come l’introduzione di nuovi manualicommisurati all’età degli scolari. Un membro del concistoro superioredi Berlino, Wilhelm Abraham Teller, scrisse – ancor prima di dedi-carsi alla riforma del Gesangbuch (e alla fondazione della Mittwochs -gesellschaft) – una Instruction für die Landschulmeister (Insegnamentoper i maestri delle scuole di campagna, 1773). Animati dall’impegnodi sorvegliare da un punto di vista spirituale gli ambienti scolastici,molti neologi dirigevano personalmente alcuni ginnasi, come FriedrichGedicke a Berlino, uno dei fondatori della Berlinische Monatsschrifte dal 1787 membro del collegio superiore dell’istruzione appena isti-tuito. Erano neologi anche gli iniziatori della nuova forma scolasticadel Philantropinum, che però fu realizzata soltanto fuori dalla Prus-sia65.
64 Ch.F. Nicolai, Das Leben und die Meinungen des Herrn Magister SebaldusNothanker, 3 voll., Berlin-Stettin, Nicolai, 1773-1776, riprod. Berlin, Rütten und Löh-ning, 1960. Cfr. A. Beutel, Aufklärung und Pietismus auf dem Weg nach Berlin. DieFigur des «Frömmlings» in Friedrich Nicolais Roman «Sebaldus Nothanker», in «Zeit-schrift für Theologie und Kirche», 49, 2002, pp. 262-77; K. Kiesant, SebaldusNothanker als Manifest der Aufklärung, relazione tenuta al convegno «Friedrich Ni-colai im Kontext der kritischen Kultur der Aufklärung» (Potsdam, 2011).
65 Cfr. W. Sparn, Religiöse und theologische Aspekte der Bildungsgeschichte imZeitalter der Aufklärung, in Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte, vol. II: 18.Jahrhundert, a cura di N. Hammerstein e U. Herrmann, München, Beck, 2005, pp.134-68, in particolare pp. 153 ss.
«ciascuno a modo suo» 125
Stando alla Mittwochsgesellschaft, ai suoi sostenitori, alle sue atti-vità e alla sua ricaduta pubblica per mezzo della Berlinische Monats-schrift (la cui pubblicazione non pregiudicava affatto il carattere di se-gretezza della società), si potrebbe pensare che sotto il regno di Fe-derico II la convergenza tra religione e Illuminismo fosse una que-stione risolta. Ciò sembra trovare conferma nei membri di questa «Ge-sellschaft von Freunden der Aufklärung» (Società degli amici dell’Il-luminismo), tra cui si trovavano celebri teologi, pedagogisti e giuristiberlinesi (come Christian Wilhelm von Dohm e Carl Gottlieb Sua-rez). Essi erano accomunati dalla volontà di affermare una riflessioneautonoma, critica nei confronti dei pregiudizi e imparziale nelle que-stioni religiose, morali, pedagogiche e politiche che concernevano la«destinazione dell’uomo». Questo centro di discussione consentiva al-tresì la convivenza di opinioni divergenti, talvolta di vere e propriediscrepanze. Non soltanto Kant e il ministro von Zedlitz, ma ancheEberhard e Wöllner pubblicavano sulla Berlinische Monatsschrift66. Lapresa di distanza dei neologi dal concetto tradizionale, essenzialistico,di «religione autentica» consentiva di distinguere tra prassi religiosa eteologia, tra scienza discorsiva e dimensione esistenziale della fede. Fucosì che all’interno del cristianesimo si aprì uno spazio possibile peril pluralismo teologico e si riconobbe la specificità della teologia comeuna tra le molte forme di riflessione. Di conseguenza, sotto FedericoII i neologi non definivano più in maniera dogmatica il rapporto trail cristianesimo e l’Illuminismo, ma cercavano di portarlo concreta-mente al centro della discussione con altri illuministi – la qual cosaimplicò la considerazione di una grande varietà di vedute.
Non bisogna tuttavia dimenticare che allinearsi a Federico II im-poneva ai neologi limiti ben precisi. Mi sia qui consentito un excur-sus: ovviamente la possibilità di azione e di sviluppo della neologianon era limitata esclusivamente dalle contingenze della politica di Fe-derico II, ma anche da altre forze culturali e dalla loro intima strut-tura concettuale. Neppure in Prussia i neologi divennero i soli attoricapaci di determinare la politica ecclesiastica. Ancora verso la fine delregno di Federico II in Prussia c’erano parroci e membri delle par-rocchie ortodossi e tradizionalisti. Il pietismo riguadagnava un certovigore nei «risvegli» biblici che incominciarono ad avere una notevolerisonanza anche all’interno delle élite sociali e culturali nel momentoin cui, dopo la Rivoluzione francese, l’Illuminismo entrò profonda-
66 Cfr. Was ist Aufklärung? Beiträge aus der Berlinischen Monatsschrift, a curadi N. Hinske, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 19812, pp. XII ss.
walter sparn126
mente in crisi. Il presunto razionalismo della neologia si contrappo-neva ai nuovi orientamenti sovrannaturalistici e alla Glaubensphilo-sophie (filosofia della fede) promossa da Jacobi, la quale ebbe peral-tro un grande successo letterario soprattutto in epoca romantica. Siincontrano, in quegli anni, tentativi curiosi di combinare alla meglioistanze illuministiche, pietistiche e teosofiche. Né la critica dei neo-logi contro ogni forma di misticismo né la svalutazione della teoso-fia nello scritto (assolutamente razionalistico) di Kant contro il visio-nario Emanuel Schwedenborg (1766) impedì il profilarsi di concezionie di pratiche esoteriche. Così, ad esempio, Woellner entrò nel 1776nell’ordine segreto mistico-teosofico dei Rosacroce, introducendovi nel1781 anche il Principe ereditario, di cui egli era mentore – il che, nel1786, avrebbe comportato una serie di conseguenze importanti. Il teo-logo Semler – tanto razionale quanto arido, e polemico nei confrontidell’ordine dei Rosacroce – comunicava in quegli stessi anni al Prin-cipe Ferdinando (il fratello minore di Federico II) i risultati dei pro-pri esperimenti alchimistici – esperimenti che egli stesso poneva nelpunto di convergenza tra la religione e la cultura illuministica67. Maai neologi – genericamente ossessionati dall’idea di estirpare ogni «su-perstizione» – mancava del tutto la sensibilità per cogliere quello cheoggi si è soliti chiamare «il lato oscuro» dell’Illuminismo68.
È comprensibile che la neologia, impostata nel suo slancio eman-cipatorio secondo una logica binaria del razionale opposto all’irra-zionale, avesse esitato a differenziare il proprio concetto di ragione.Ma ciò comportava una serie di limiti interni alla sua capacità di svi-luppo. In particolare i limiti riguardavano due questioni introdotteproprio dalle stesse innovazioni che la neologia aveva inizialmentecomportato.
67 «Teosofia, mistica, spiritualis intelligentia, era da sempre la religione privata diogni cristiano libero, che esercitava autonomamente la propria ragione», citato daH.H.R. Schulz, Johann Salomo Semler als er dreizehn Grane Luftgold untertänigsteinschickte, in Theologie und Aufklärung. Festschrift für Gottfried Hornig, a cura diW.E. Müller e H.H.R. Schulz, Würzburg, Königshausen & Neumann, 1992, pp. 179-204.
68 Cfr. H.-P. Reill, Religion, Theology, and the Hermetic Imagination in theLate German Enlightenment: The Case of Johann Salomo Semler, in Antike Weisheitund kulturelle Praxis. Hermetismus in der Frühen Neuzeit, a cura di A.-C. Trepp etal., Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2001, pp. 219-43; Ch. Soboth, Die Al-chimie auf dem Abtritt – Johann Salomo Semler und die hermetische Kehrseite derNeologie, in Hermetik, a cura di N. Kaminski et al., Tübingen, Niemeyer, 2002, pp.69-99; M. Neugebauer-Wölk, Aufklärung und Esoterik. Rezeption – Integration –Konfrontation, Tübingen, Niemeyer, 2008.
«ciascuno a modo suo» 127
La prima questione derivava dalla storicizzazione delle tradizioninormative: lo sviluppo metodico di una coscienza storica della diffe-renza non poteva prescindere a lungo da una riflessione categorialesulla «storia». La fede neologica in un progrès perpétuel della storia –secondo la formula già usata da Leibniz – e nella perfettibilità del ge-nere umano non venne dal canto suo sottoposta alla critica storica,ma mantenne lo status di «verità eterna» garantita dalla provvidenzadivina. Alla luce di questa fede, il passato rimase subordinato all’«ora»,di cui diveniva una sorta di preistoria, e alcuni fenomeni eterogeneidel presente vennero incorporati come momenti contingenti entro ilquadro teleologico di un progresso inarrestabile. Entro la prospettivaantropologica della neologia non c’era però posto per la coerenza dellastoria, e per il nesso tra l’individuo (che aveva la massima importanza)e il genere umano che doveva trovare nella storia la propria realizza-zione. Soltanto Jerusalem pose al centro della riflessione il tema della«storia del mondo» – ma non gli riuscì di andar oltre l’ingenuità delchiliasmo neologico69. Possibili soluzioni alternative si elaborarono aldi fuori della Prussia, ad esempio, nelle teorie della palingenesi del-l’individuo in «mondi superiori» – opzione caldeggiata da Herder –e nel recupero dell’idea della reincarnazione – come fece Lessing nellaErziehung des Menschengeschlechts (Educazione del genere umano,1777-80)70.
L’altra questione deriva invece dalla volontà di privilegiare l’au-tenticità religiosa: l’ipotesi che le sensazioni interiori e il sentimentodelle proprie esperienze si esprimano immediatamente nel linguaggio,se assunta in maniera non ingenua, doveva venir fondata e consoli-data attraverso una teoria del linguaggio. Nonostante gli sforzi im-pressionanti con cui si cercò di dar vita a una cultura della lingua edello stile linguistico, la neologia non riuscì mai ad andare oltre ilconcetto strumentale del linguaggio – il che risultava particolarmenteevidente nella riformulazione della vecchia poetica nei nuovi libri deicanti neologici. Probabilmente il razionalismo che veniva sovente rim-proverato ai neologi consisteva proprio in questa riduzione della forza
69 La teologia della storia di Jerusalem viene analizzata e contestualizzata in ma-niera esauriente da A.U. Sommer, Sinnstiftung durch Geschichte? Zur Entstehungspekulativ-universalistischer Geschichtsphilosophie zwischen Bayle und Kant, Basel,Schwabe, 2006, pp. 133 ss.; E. Tortarolo, Flögel, Ridolfi und die Geschichtsphilo-sophie, in Id., Diesseits und jenseits der Alpen, cit., pp. 55-73.
70 Cfr. W. Sparn, «Aussichten in die Ewigkeit». Jenseitsvorstellung in der neu-zeitlichen protestantischen Theologie, in Das Jenseits. Facetten eines religiösen Begriffsin der Neuzeit, a cura di L. Hölscher, Göttingen, Wallstein, 2007, pp. 12-39.
walter sparn128
del linguaggio a mezzo di comunicazione. Comunque sia, è per que-sta ragione che alcuni filosofi del tempo – che pure avevano a cuorela convergenza tra la pietas cristiana e il libero pensiero – non vol-lero mai prendere parte alla neologia di tipo berlinese: tra questi, Her-der (che insisteva sull’autenticità poetica del linguaggio religioso), Ha-mann (che rimarcava l’irriducibile natura linguistica della ragione) epersino Lessing (che concepiva il linguaggio come strumento della«Rivelazione»)71. L’ingenuità teologico-linguistica impedì ai neologi diBerlino, di Halle e di Francoforte sull’Oder di stringere amicizia conalcuni loro compatrioti, come Kant e Hamann. Ovviamente il nettorifiuto della filosofia trascendentale kantiana costituì un ostacolo ul-teriore per lo sviluppo potenziale della neologia72.
Tornando ai limiti imposti alla neologia nell’epoca di Federico II,occorre osservare che uno di essi derivava, seppur non esclusivamente,dalla stessa politica confessionale seguita da Federico. Si tratta dell’o-rientamento anticattolico dei neologi. Tanto era intenso il loro impe-gno a favore dell’unione protestante e della tolleranza verso la culturaebraica, quanto era defilato il loro atteggiamento nei confronti dellaChiesa cattolica: essi si sottraevano risolutamente a ogni iniziativa afavore della riunificazione. In particolare Nicolai, che pur dava mo-stra di avere in grande considerazione Mendelssohn e la comunitàebraica berlinese, nei suoi resoconti di viaggio aveva parole ben pocogentili per gli ambienti cattolici, per non parlare della sua aperta av-versione verso il Papa e i gesuiti. Agli occhi di Nicolai la soppres-sione dell’ordine dei gesuiti (1773) e l’Illuminismo cattolico che avevapreso piede in Austria non rappresentavano ragioni sufficienti per ri-vedere il proprio giudizio sul cattolicesimo. Una posizione analogaaveva anche Johann Erich Biester, anch’egli membro della Mittwochs -gesellschaft: sulla Berlinische Monatsschrift del 1784, in occasione del-
71 La loro posizione nell’ambito della storia ecclesiastica e teologica dell’Illumi-nismo è descritta in maniera sempre interessante da E. Hirsch, Geschichte der neuernevangelischen Theologie im Zusammenhang mit den allgemeinen Bewegungen des eu-ropäischen Denkens, cit., capp. 39-42, pp. 120-329; sullo stato attuale della ricerca cfr.A. Beutel, Kirchengeschichte im Zeitalter der Aufklärung, cit., §§ 30-34, pp. 181-201.
72 Davvero tragico appare il destino di Eberhard che, dalle pagine di una rivistache aveva egli stesso fondato, scaglia un attacco contro Kant; la polemica è oggi ri-costruita in I. Kant, Der Streit mit Johann August Eberhard, a cura di M. Lauschkee M. Zahn, Hamburg, Meiner, 1998; in italiano cfr. I. Kant, Contro Eberhard: la po-lemica sulla Critica della ragion pura, a cura di C. La Rocca, Pisa, Giardini, 1994.Cfr. W. Sparn, «Einleitung», in J.A. Eberhard, Neue Apologie des Sokrates oderUntersuchung der Lehre von der Seligkeit der Heiden, cit., pp. XVII ss.
«ciascuno a modo suo» 129
l’apertura delle chiese evangeliche per le funzioni cattoliche in alcunecittà vicino a Berlino, Biester esprimeva i propri timori di fronte al-l’espansione dei cattolici e ai loro tentativi di impadronirsi dei patri-moni ecclesiastici. Sempre sulla Berlinische Monatsschrift gli rispon-deva polemicamente Christian Garve, che a Breslau aveva avuto tutt’al-tra esperienza con la religione cattolica. Cionondimeno anche Garveriteneva che andasse assolutamente esclusa una riunificazione del cri-stianesimo illuminato con il dogma cattolico e con la gerarchia pa-pale73.
Persino Jerusalem – che pur si muoveva nel solco della tradizioneirenica dell’Università di Helmstedt e dei programmi di riunificazioneimmaginati da Leibniz – espresse un’opinione analoga. Non inten-dendo ignorare l’invito che gli era giunto dal cardinale torinese Carlodelle Lanze di prendere parte alla discussione sui temi religiosi, nel1772 Jerusalem redasse un testo che non era stato però pensato perla pubblicazione. Qui egli definiva la Chiesa cattolica una «società ve-nerabile», si diceva in pieno accordo con le posizioni di condanna cheessa aveva nei confronti del deismo, ma riteneva che le misure eccle-siologiche stabilite dal Concilio di Trento – pur nella versione mode-rata di Febronio – fossero insostenibili per una Chiesa vincolata alla«semplicità» del cristianesimo originario e quindi ben disposta versola «libertà di pensiero»74. In maniera ancora più dura di Jerusalem –cui pure si riferiva – reagì Semler un decennio più tardi di fronte alleattività che cercavano di riunire in un’unica società gli illuministi pro-testanti e cattolici. Dalla prospettiva neologica del cristianesimo illu-minato e perciò ineludibile nella sua autenticità personale (veniva in-fatti qualificato come «religione morale» o «religione interiore»), Sem-ler rifiutava risolutamente ogni unione istituzionale con la Chiesa ro-mano-cattolica75.
73 Akatholikus Tolerans [J.E. Biester], Von falscher Toleranz…, in «Berlini-sche Monatsschrift», 3, 1783, pp. 180-92; Ch. Garve, Ueber die Besorgnisse der Pro-testanten in Ansehung der Verbreitung des Katholicismus, in «Berlinische Monats-schrift», 6, 1785, pp. 19-67; entrambi gli articoli e le repliche, così come i voti sle-siani, sono ristampati in Was ist Aufklärung?, cit., pp. 145-369. Cfr. Ch. Speer, Aufklä-rung und Ökumene. Reunionsversuche zwischen Katholiken und Protestanten im deut-schsprachigen Raum des späten 18. Jahrhunderts, Tübingen, Mohr Siebeck, 2005, pp.374-408.
74 [Anonymus], Des Herrn Abts Jerusalems Gedanken zur Wiedervereinigungder christlichen Religionen, Frankfurt-Leipzig, [s.e.], 1772; ed. emendata a cura diJ.F.W. Jerusalem, [s.l., ma Nürnberg], 1772, riprod. in Id., Schriften, cit., V, pp. 121-51. Cfr. C. Spehr, Aufklärung und Ökumene, cit., pp. 53-84.
75 J.S. Semler, Freymüthige Briefe über die Religionsvereinigung der dreien strei-
walter sparn130
Il patrocinio della neologia – se si può usare quest’espressione –esercitato da Federico II le impose un limite preciso anche rispettoalla concezione dell’Illuminismo. Fu proprio un pastore neologo, emembro della Mittwochsgesellschaft, Johann Friedrich Zöllner – ap-pena due anni prima della morte di Federico II – ad interrogarsi sullepagine della Berlinische Monatsschrift sul significato e sull’uso del ter-mine «Illuminismo». All’origine di questo suo interrogativo c’era statala pubblicazione, di poco precedente, e sempre sulla Berlinische Mo-natsschrift, di una perorazione in favore del matrimonio civile, con-nessa a un’altra requisitoria in favore di uno stretto collegamento dellaChiesa allo Stato (di fronte alla loro presunta separazione). «Fate sìche la politica e la religione, la legge e il catechismo diventino unacosa sola!»76 Di contro Zöllner era dell’idea che anche gli uomini il-luminati avessero il diritto di ricordarsi di Dio, imprimendo un sigilloreligioso alle loro unioni. Per questa ragione domandava: «Che cos’èIlluminismo?»77. Poco prima Eberhard aveva tenuto a Halle una le-zione solenne Ueber die Zeichen der Aufklärung einer Nation (Suisegni dell’illuminismo di una nazione, 1783), in cui riconosceva al pro-prio tempo – al di là di alcuni residui barbarici – il «titolo onorificodi epoca illuminata», dal momento che veniva indagato ogni campodel sapere, si combinava la libertà del gusto con il rigore della scienzae si diffondevano in ogni strato della popolazione la tolleranza e il ri-schiaramento78. Nel suo articolo scritto nel mese di settembre del 1784,Kant negava che si vivesse «in un’epoca illuminata» e – sulla basedella definizione che egli stesso aveva elaborato – si limitava a parlaredi un’«epoca di Illuminismo»: vi sono segni evidenti dell’«uscita del-l’uomo da una condizione di minorità di cui è egli stesso responsa-bile», mentre si riducono gli ostacoli a quest’impresa. Ma non si deve
tigen Theile im römischen Reiche. Erste Sammlung, Leipzig, [s.e.], 1783. Cfr. C. Spehr,Aufklärung und Ökumene, cit., pp. 338-73; A. Beutel, Kirchengeschichte im Zeital-ter der Aufklärung, cit., pp. 250 ss.
76 E.v.K. [J.E. Biester], Vorschlag, die Geistlichen nicht mehr bei Vollziehung derEhen zu bemühen, in «Berlinische Monatsschrift», 2, 1783, pp. 265-276, in Was istAufklärung?, cit., pp. 95-106: p. 272 e p. 102. Cfr. ivi, pp. XXXVII ss.; W. Schnei-ders, Die wahre Aufklärung. Zum Selbstverständnis der deutschen Aufklärung, Frei-burg-München, Alber, 1974.
77 J.F. Zöllner, Ist es rathsam, das Ehebündniß nicht ferner durch die Religionzu sanciren?, in «Berlinische Monatsschrift», 2, 1783, pp. 508-17, in Was ist Aufklä-rung?, cit., pp. 107-16: pp. 516-17 e pp. 115-16.
78 J.A. Eberhard, Ueber die Zeichen der Aufklärung einer Nation (11. Februar1783), Halle, Gebauer, 1783; cfr. W. Sparn, «Einleitung», in J.A. Eberhard, NeueApologie des Sokrates, cit., pp. XIII ss.
«ciascuno a modo suo» 131
pensare che il processo di Illuminismo possa mai considerarsi con-cluso. In questo senso Kant chiamava la propria «l’epoca dell’illumi-nismo, ovvero il secolo di Federico»79.
Questo encomio, pronunciato in termini analoghi da tutti i neo-logi prussiani, non riconosceva a Federico II il merito di aver com-piuto il processo di rischiaramento; ci si continuò invece a interro-gare su che cosa fosse il vero Illuminismo, dal momento che se nepoteva parlare in maniera impropria. L’«abuso del rischiaramento» –scriveva Mendelssohn nel medesimo fascicolo della Berlinische Mo-natsschrift su cui era comparso lo scritto kantiano – «indebolisce ilsentimento morale, conduce alla durezza d’animo, all’egoismo, all’ir-religiosità, e all’anarchia»80. Il vero Illuminismo – e su ciò concordanotutti i contendenti – è comunque un fenomeno che concerne la cul-tura [Bildung]: secondo Mendelssohn, civiltà e Illuminismo «proce-dono di pari passo». Ma, come dice Kant, l’Illuminismo procede «len-tamente», deve ampliarsi «progressivamente» e, così facendo, agire sullecondizioni esterne e «infine persino sui principi del governo», con-sentendo cioè quell’«autentica riforma della maniera di pensare» chenon era mai riuscita a nessuna rivoluzione prima di allora. Quest’ot-timismo è esattamente ritagliato sullo Stato di Federico II: soltantoquesto sovrano – che assicura a ognuno la libertà «di fare ovunqueun uso pubblico della propria ragione», condizione necessaria del ri-schiaramento – può dire quel che «una libera repubblica non potrebbemai osare: ragionate quanto volete e su ciò che volete, ma ubbidite!»81.
Kant non faceva mistero del fatto che la libertà fridericiana appa-risse quantomeno stravagante, paradossale. Lo stesso Mendelssohn sirendeva conto che in questa maniera il «rischiaramento dell’uomo»,assolutamente universale, poteva entrare in conflitto con il «rischiara-mento del cittadino», che dipendeva dal ceto e dalla professione82. Il
79 I. Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, in «Berlinische Mo-natsschrift», 4, 1784, pp. 481-94, in Was ist Aufklärung?, cit., pp. 452-65: p. 491 e p.462, trad. it. Risposta alla domanda: che cos’è illuminismo?, in Che cos’è l’illumini-smo? I testi e la genealogia del concetto, a cura di A. Tagliapietra, Milano, BrunoMondadori, 1997, pp. 16-41: p. 35.
80 M. Mendelssohn, Ueber die Frage: was heißt aufklären?, in «Berlinische Mo-natsschrift», 4, 1784, pp. 193-200, in Was ist Aufklärung?, cit., pp. 444-51: pp. 449-50, trad. it. Sulla domanda: che cosa significa rischiarare?, in Che cos’è l’illuminismo?,cit., pp. 3-15: p. 13.
81 I. Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, cit., pp. 484, 455, 493e 464; trad. it. cit., pp. 36-37.
82 «Emerge, allora, una tendenza sorprendente e inattesa delle cose umane – e,
walter sparn132
cittadino è infatti soggetto alla condizione per cui chi occupa un uf-ficio, e ha pertanto doveri nei confronti della collettività, deve distin-guere nettamente tra un uso «pubblico» della sua ragione, rivolto allacomunità, e un suo uso «privato», determinato dalla carica civile ofunzione pubblica che riveste, ad esempio dal suo essere ufficiale oprete. Kant auspicava che il prete rivestisse un duplice ruolo, difficil-mente realizzabile: per un verso, egli è vincolato alla Chiesa e devepertanto istruire e agire secondo quella dottrina (si noti che Kantchiama questo uso l’uso «privato» della ragione, perché la Chiesa esi-ste soltanto come analogia della famiglia); per altro verso, l’ecclesia-stico, facendo un uso «pubblico» della sua ragione, può agire comecittadino o come «studioso che si rivolge al pubblico propriamentedetto», e quindi mettere in discussione ciò che in quell’insegnamentogli risulta contraddittorio o controverso: come «pastore» egli «non èlibero»; in quanto dotto egli gode invece di una «libertà illimitata».Kant auspica che gli ecclesiastici incarnino l’asimmetria tra la «subor-dinazione» e la «libertà di pensiero», poiché ciò non nuoce alla co-scienza, e neppure ostacola – anzi promuove – il progresso dell’Illu-minismo83.
Ciò venne accolto senza riserva dai neologi dell’epoca di FedericoII; l’asimmetria tra la Chiesa e il pubblico causò sì qualche difficoltànella Prussia fridericiana, ma non fu mai percepita come una discre-panza insostenibile. Nell’anno della morte di Federico, Semler rifor-mulò in maniera estremamente chiara questo duplice ruolo degli ec-clesiastici sostenitori di una teologia illuminata, giustificandolo sullabase della loro posizione all’interno della Chiesa nazionale prussiana84.
L’attaccamento tenace di Federico II alla Chiesa nazionale rap-
del resto, se si considera questa tendenza da un punto di vista più generale, quasitutto, in essa, appare orientato verso il paradosso», I. Kant, Beantwortung der Frage:Was ist Aufklärung?, cit., p. 493 e p. 464, trad. it. cit., p. 37; M. Mendelssohn, Ue-ber die Frage: was heißt aufklären?, cit., pp. 447-48, trad. it. cit., p. 10.
83 I. Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, cit., pp. 485-88 e pp.456-59, trad. it. cit., pp. 28-29. Questa concezione esclude però che una Chiesa siavincolata dal giuramento a una confessione immutabile, poiché ciò impedirebbe ilprogredire dell’Illuminismo, ivi, pp. 488-89 e pp. 459-60; trad. it. cit., p. 29 (trad.modificata). L’argomentazione ritorna anche in I. Kant, Il conflitto delle facoltà, cit.,pp. 232-33.
84 J.S. Semler, Ueber historische, geselschaftliche [sic!] und moralische Religionder Christen, Leipzig, Beer, 1786. Cfr. E. Hirsch, Geschichte der neuern evangeli-schen Theologie im Zusammenhang mit den allgemeinen Bewegungen des europäi-schen Denkens, IV, cit., pp. 48-89; G. Hornig, Semler, Johann Salomo, in TRE,XXXI (2001), pp. 142-48.
«ciascuno a modo suo» 133
presentò un altro e anzi forse il principale limite strutturale alle po-tenzialità di sviluppo della neologia nell’epoca fridericiana – perlo-meno rispetto alla teologia successiva e alla sua scelta di collegialitànel rapporto tra Stato e Chiesa85. In breve tempo questo limite di-venne un puntello dell’opposizione all’editto sulla religione di Woell -ner (1788), che – sebbene confermasse sia le garanzie di tolleranzafino ad allora dispensate alle Chiese e alle «sette» religiose sia una ge-nerale libertà di coscienza, ivi compreso il diritto alla conversione –obbligava i parroci all’«antica dottrina» delle loro rispettive confes-sioni e stigmatizzava le nuove eresie (neologiche) come una forma diabuso dell’Illuminismo contro cui istituiva una «commissione d’ur-genza per gli esami ecclesiastici», che fungeva di fatto da organo dicensura. I principali neologi prussiani protestarono pubblicamente, no-nostante la minaccia di vedersi privati dei loro uffici; alcuni presenta-rono le loro dimissioni (tra questi, ad esempio, Spalding). SoltantoSemler difese anche pubblicamente l’editto imperiale: l’unico neologoche agì in maniera assolutamente coerente in questa difficile situa-zione86.
È pur vero che nella prospettiva propriamente neologica che au-spicava una «riforma anziché una rivoluzione»87, subito dopo l’ascesaal trono di Federico Guglielmo III alla fine del 1797 la censura vennerimossa e nel 1798 Woellner venne sollevato dal suo incarico. Kantnon riuscì a trattenersi dal pubblicare, nella prefazione al Conflittodelle facoltà del 1798, una «breve narrazione storica» del suo scontrocon la censura prussiana, dell’ordine sovrano trasmesso da Woellner,
85 Intorno al 1800 tra i neologi incominciarono a svilupparsi riflessioni circa l’e-ventualità di potenziare il ruolo della religione come vincolo per la società attraversola trasformazione della Chiesta di Stato fino ad allora sottoposta al governo del so-vrano in un «collegio religioso» (Religionskollegium), ovviamente soggetto alla pro-tezione pubblica, ma cui veniva riconosciuta istituzionalmente un’autonomia di azione,cfr. J.A. Eberhard, Geist des Urchristentums, Halle, Renger, 1807-1808, riprod. Hil-desheim, Olms, 2002. Sul collegialismo come teoria del diritto ecclesiastico statale cfr.Ch. Link, Kollegialismus, in RGG4, vol. IV (2001), pp. 1482-83.
86 J.S. Semler, Vertheidigung des königl. Edikts vom 9ten Juli 1788 wider diefreimüthigen Betrachtungen eines Ungenannten, Halle, Heller, 1788. Cfr. U. Wig-germann, Woellner und das Religionsedikt. Kirchenpolitik und kirchliche Wirklichkeitim Preußen des späten 18. Jahrhunderts, Tübingen, Mohr Siebeck, 2009; A. Beutel,Kirchengeschichte im Zeitalter der Aufklärung, cit., pp. 262-66.
87 Sullo sviluppo successivo della monarchia illuminata di Federico II o di Giu-seppe II si era espresso J.A. Eberhard, Ueber Staatsverfassungen und ihre Verbes-serung. Ein Handbuch für deutsche Bürger und Bürgerinnen aus den gebildete Stän-den, Berlin, Voss, 1793-1794, riprod. Hildesheim, Olms, 2002.
walter sparn134
nonché della sua stessa risposta. Gli «attentati degli oscurantisti» eranoterminati e il «progresso della cultura nel campo delle scienze»88 avevaripreso il suo corso; ciononostante (o, forse, proprio per questa ra-gione?) in quel medesimo 1798 venne sciolta per editto imperiale an-che la Mittwochsgesellschaft: essendo una «società segreta», poteva rap-presentare una minaccia per la pubblica sicurezza. In questo modo siconcludeva anche il patrocinio dei neologi intrapreso da Federico. Lateologia «liberale» deve riorganizzarsi di bel nuovo.
88 I. Kant, Il conflitto delle facoltà, cit., p. 235.
«ciascuno a modo suo» 135
Edoardo Tortarolo
OPINIONE PUBBLICA E OPPOSIZIONE IN PRUSSIASOTTO FEDERICO II1
1. Habermas e i luoghi pubblici nel Settecento tedesco
Sarebbe una scelta curiosa affrontare oggi la questione della crisidell’Antico Regime in Europa negli anni ottanta e novanta del Sette-cento senza dedicare attenzione e rilievo al tema dell’opinione pub-blica e della sua funzione di luogo discorsivo e sociale nel quale lenuove forme di politica si condensarono nella seconda metà del se-colo per cercare un nuovo equilibrio nel corso del periodo rivolu-zionario2. Gran parte della fortuna impressionante di cui ha godutoil concetto di opinione pubblica deve naturalmente essere ricondottaalla monografia di Habermas. A cinquant’anni dalla sua prima pub-blicazione, Strukturwandel der Öffentlichkeit ha compiuto un tragittodi globalizzazione della sua nozione centrale che ha pochi paragoni
1 La stesura finale di questo saggio è stata resa possibile da un soggiorno di ri-cerca presso il FRIAS (Freiburg Institute for Advanced Study, Albert-Ludwigs-Uni-versität Freiburg) nell’anno accademico 2012-2013. Ho approfittato dei consigli di Pa-trizia Delpiano, Sandro Landi, Serena Luzzi, Marzia Ponso, Gabriella Silvestrini: liringrazio di cuore. La responsabilità per quanto scritto resta ovviamente esclusiva-mente mia.
2 Chi, come recentemente Jonathan Israel, rifiuta di considerare l’opinione pub-blica il luogo centrale attraverso cui studiare l’Illuminismo si trova nella necessità diargomentare questa scelta in termini esplicitamente polemici (in questo caso versoRoger Chartier e Robert Darnton): «Questo [le contraddizioni interne all’opinionepubblica tardo settecentesca] non significa che l’opinion publique non sia meritevoledi studio. Ma questi studi devono mantenere ferma l’attenzione sull’interazione diidee espresse chiaramente e coerentemente da rappresentanti, dirigenti e giornalisti in-fluenti, con strutture politiche, socio-strutturali ed economiche che determinano inprimo luogo il contesto sociale». Nell’opinione pubblica, secondo Israel, queste ideechiare e distinte si confondono in un’instabile e alla fine incomprensibile baraondadi posizioni eterogenee (J. Israel, Democratic Enlightenment. Philosophy, Revolu-tion, and Human Rights 1750-1790, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 25).
nella storiografia novecentesca. Prima la traduzione francese, poi, inmodo decisivo, quella americana hanno fatto della Öffentlichkeit primaun espace public, poi, dall’inizio degli anni novanta, una public spheree le hanno permesso di compiere un’ampia traiettoria attraverso iltempo e lo spazio a indicare fenomeni in realtà alquanto eterogenei3.Contro le indicazioni originarie di Habermas si è assistito così a unaproliferazione di forme di Öffentlichkeit. Soprattutto hanno suscitatointeresse quei modi di «esporsi al ed essere pubblico» le cui caratte-ristiche divergevano evidentemente dal modello di Habermas, di cuihanno forzato impostazioni, riferimenti, sfondo, implicazioni polemi-che, bersagli politici. La storia della ricerca sulle opinioni pubbliche èstata in buona parte la storia delle contestazioni al modello di Ha-bermas. Attraverso la rilettura critica, talvolta astiosa e ingenerosa,delle pagine di Habermas si è pur tuttavia diffusa una sensibilità mar-cata per la manifestazione di pensieri, socialmente connotata ma ab-bastanza generale e indifferenziata da poter essere indicata con un con-cetto astratto, cui attribuire capacità di giudizio e di reazione4.
3 Per comodità espositiva si useranno di seguito i termini opinione pubblica/sferapubblica/spazio pubblico come sostanzialmente equivalenti, salvo indicazione di unaqualificazione particolare, con una prevalenza del termine opinione pubblica in con-seguenza della scelta editoriale compiuta in occasione della traduzione del libro initaliano nel 1962 (Storia e critica dell’opinione pubblica, Bari, Laterza, 1962). Sulle im-plicazioni di questa scelta, discutibile ma comprensibile, mi sono soffermato in E.Tortarolo, A proposito di Öffentlichkeit settecentesca. Una questione generale e uncaso specifico, in Oltre la sfera pubblica. Lo spazio della politica nell’Europa moderna,a cura di M. Rospocher, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 129-47. L’edizione tedesca diriferimento è Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorieder bürgerlichen Gesellschaft. Mit einem Vorwort zur Neuauflage 1990, Frankfurt/Main,Suhkamp, 1990.
4 La bibliografia degli studi ispirati dal libro di Habermas è ampia ai limiti del-l’incontrollabilità. Per un primo orientamento sulla produzione nei più diversi set-tori di ricerca fino a tutti gli anni ottanta cfr. A. Sturm, A Bibliography of the Con-cept Öffentlichkeit, in «New German Critique», 61, 1994, Special Issue on NiklasLuhmann, pp. 161-202; un’utile introduzione è nei saggi (compreso quello di Ha-bermas stesso) contenuti in Habermas and the Public Sphere, a cura di C. Calhoun,Cambridge MA - London, MIT 1992 e nel saggio H. Mah, Phantasies of the Pu-blic Sphere. Rethinking the Habermas of Historians, in «Journal of Modern Hi-story», 72, 2000, pp. 155-170. Il saggio di S. Van Damme, Farewell Habermas? Deuxdécennies d’études sur l’espace public, in Les Dossiers du Grihl [En ligne], Les dos-siers de Stéphane Van Damme, Historiographie et méthodologie, mis en ligne le 28juin 2007, URL: http://dossiersgrihl.revues.org/682; DOI: 10.4000/dossiersgrihl.682,fa il punto con acutezza sulle prospettive future delle ricerca sull’opinione/spazio/sferapubblica/o. Spunti di discussione ripetuti sono nei saggi raccolti in Spheres of In-fluence. Intellectual and Cultural Publics from Shakespeare to Habermas, a cura di
edoardo tortarolo138
Sull’efficacia storiografica del modello di Habermas non possonoquindi esserci dubbi. Ma è opportuno anche considerare dove il suomodello non è stato confermato dai risultati della ricerca empirica,dove, in altre parole, lo sguardo sociologico di Habermas lo ha in-dotto a vedere dicotomie univoche ed evidenze caratterizzanti, lad-dove la ricerca puntuale si è orientata a considerare significative sfu-mature in primo luogo nelle transizioni da un equilibrio a un altro ereti di eventi e atteggiamenti da ricostruire con senso del dettaglio.Una volta data per acquisita l’esistenza di una sfera pubblica in etàmoderna, le ricerche specifiche si sono impegnate a contestarne i det-tagli, anche corposi, a svilupparne i limiti, a evidenziarne le specificitàlocali che Habermas aveva ignorato.
Un aspetto dell’analisi di Habermas ha suscitato per un certo tempoalmeno un diffuso consenso: la tesi della divaricazione tra le forme disfera pubblica nei paesi del mondo tedesco e nei paesi per diverse ra-gioni considerati più avanzati nel corso del Settecento, la monarchiafrancese e quella inglese. Tipicamente per la trattazione complessivaimpostata da Habermas (per cui – va ricordato – i capitoli settecen-teschi erano il preludio alla parte duramente critica verso la perver-sione dell’opinione pubblica nell’età del capitalismo liberale), una con-trapposizione fondamentale vedeva la sfera pubblica che si realizzacome attività politica in Francia e Inghilterra nella forma di un’opi-
A. Benchimol e W. Maley, Bern, Lang, 2007. Per la nozione specifica del pubblicodestinatario della produzione letteraria nel Settecento tedesco con ricorso non sem-pre criticamente valutato alla prospettiva habermasiana cfr. B.W. Redekop, Enligh-tenment and Community: Lessing, Abbt, Herder and the Quest for a German Pu-blic, Montreal, McGill-Queen’s University Press, 2000. Due sintesi recenti che af-frontano la difficile eredità del modello habermasiano sono J. van Horn Melton,The Rise of the Public in the Enlightenment Europe, Cambridge, Cambridge Uni-versity Press, 2001 e, più originale e innovativo, S. Landi, Stampa, censura e opi-nione pubblica in età moderna, Bologna, il Mulino, 2011. Cfr. ora le riflessioni inV. Gerhardt, Öffentlichkeit. Die politische Form des Bewusstseins, München, Beck,2012, che rielabora le tesi di Habermas nel senso di considerare la Öffentlichkeituna dimensione costitutiva della modernità perché crea uno spazio di autoriflessionee autoanalisi delle società a partire dal Rinascimento e più marcatamente dall’Illu-minismo in poi, e le considerazioni di S. Landi, Au delà de l’espace public. Ha-bermas, Locke et le consentement tacite, in «Revue d’histoire moderne et contem-poraine», 59, 2012, n. 4, pp. 7-32, ricco anche di indicazioni bibliografiche. Una pro-posta di reinterpretazione generale, contro Habermas e favorevole alla prospettivadi Koselleck, del nesso tra Illuminismo e sfera pubblica (peraltro argomentata inmodo poco convincente) è stata avanzata da T. Mehigan-H. De Burgh, ‘Aufklä-rung’, Freemasonry, the Public Sphere and the Question of Enlightenment, in «Jour-nal of European Studies», 38, 2008, n. 5, pp. 5-25.
opinione pubblica e opposizione in prussia sotto federico ii 139
nione pubblica borghese nettamente distinta da quella tedesca5. Neiterritori tedeschi la debolezza della borghesia aveva lasciato la sferapubblica nel limbo della letteratura e della filosofia, senza possibilitàdi trasformarsi in uno strumento di trasformazione politica efficace.Dal 1962 (e senza dimenticare che il libro di Habermas si basava es-senzialmente sulla ricerca pubblicata tra le due guerre mondiali) laprospettiva si è notevolmente modificata e le conoscenze sul mondosettecentesco si sono moltiplicate esponenzialmente. La ricerca sul con-cetto di opinione pubblica nella Francia dei lumi, dove il nome stessodi opinion publique è nato alla metà del Settecento e donde si è dif-fuso nel resto d’Europa, ha evidenziato i limiti e vincoli politici allasfera pubblica borghese e la fragilità della semplificazione per cui larivoluzione sarebbe stata l’esito di una crescente contrapposizione so-ciale alla cui guida si sarebbe posta l’opinione pubblica politica in-conciliabile con l’assolutismo monarchico. Più lenta è stata la revi-sione del complemento speculare a questa versione, quella della Ger-mania (presunta) apolitica. L’immagine complessiva presentata da Ha-bermas era semplice e persuasiva. I frammentati territori tedeschi eranoraccolti nelle antiquate strutture del Sacro Romano Impero della Na-zione Germanica sotto le quali gli Stati territoriali si muovevano datempo per modificare a proprio favore i rapporti di equilibrio poli-tico. Il risultato era una prevalenza del peso delle strutture governa-tivo-statali sulla società borghese che non era in grado di esprimereuna propria visione politica né di articolare una propria sfera pub-blica politica. Le pagine di Habermas sulla letterarietà della timida,inerme e tremebonda borghesia sono ben note. Ugualmente sono benconosciute le sue pagine che toccano il livello più rarefatto e astrattodella concezione della sfera pubblica, quella per cui la teoria dell’opi-nione pubblica è stata formulata con la massima precisione e purezzaconcettuale. Le pagine famose di Kant nel saggio su Was ist Aufklä-rung? (Che cosa è illuminismo?) apparse nella «Berlinische Monats-schrift» nel 1784 descrivono per Habermas l’architettura concettuale
5 Per la problematica nozione di opinione e sfera pubblica nell’Inghilterra par-lamentare post-1688 cfr. le osservazioni critiche di John Brewer su come Habermasha concepito la sfera pubblica, eliminandone cioè due componenti decisive in In-ghilterra: la ricerca del profitto individuale (la acquisitiveness) e le passioni dettatedalle pulsioni sessuali (J. Brewer, ‘The Most Polite Age and the Most Vicious’: At-titudes Towards Culture as a Commodity, 1660-1800, in The Consumption of Cul-ture 1600-1800. Image, Object, Text, a cura di A. Bermigham e J. Brewer, London,Routledge, 1995, pp. 346-60).
edoardo tortarolo140
all’interno dell’idea di sfera pubblica al culmine della sua razionalitàcome effetto di una comunicazione tra eguali. Ma Habermas non pa-reva interessato a esplorare se anche a Berlino, in Prussia, nella Ger-mania di fine Settecento si potesse vedere nella Öffentlichkeit una fun-zione politica, di opposizione almeno critica se non pratica al poterepolitico: se, in altre parole, la Germania fosse più simile al resto del-l’Europa di quanto la tesi del Sonderweg implicasse non era tra lepreoccupazioni di Habermas6. La sua preoccupazione era piuttostoevidenziare la posizione di spicco del saggio di Kant nel quale vedevala soluzione del conflitto tra politica e morale attraverso il principiodella Publizität e del pubblico ragionante come luogo che realizza latendenza della storia universale verso il repubblicanesimo. Era nel sag-gio di Kant del 1784 che il contenuto storico-contingente della sferapubblica alla fine del Settecento in Europa si poteva avvicinare al va-lore assoluto di una discussione disinteressata tra uomini interiormenteliberi, padroni di sé e capaci di impegnarsi collaborativamente nell’usopubblico della ragione7. Il passo-chiave nell’analisi di Habermas puòessere considerato questo: «Kant condivide la fiducia dei liberali i qualis’immaginano che, divenendo la società civile una sfera privata, le con-dizioni sociali di quest’uguaglianza di opportunità si manifesterebberodi per se stesse per formare la base naturale di un ordine legale e diuna sfera pubblica in grado di assumere funzioni politiche. I liberalipensavano anche che queste condizioni avrebbero potuto già esserein parte realizzate»8. Kant era inserito in una linea di argomentazione
6 M. Ponso, Una storia particolare. ‘Sonderweg’ tedesco e identità europea, Bo-logna, il Mulino, 2011, p. 29, dove si rileva giustamente che «Dal mito del ‘popolosenza rivoluzione’ si passa alla leggenda della ‘rivoluzione fallita’, nel 1848/49 comenel 1918: la Germania sarebbe stata troppo evoluta per compiere quella radicale rot-tura con il passato che avrebbe richiesto un nuovo inizio democratico. Nel secondodopoguerra, il grande mito della Kulturnation come ‘l’altra Germania’ avrebbe an-cora trovato espressione nell’idealizzazione di una sfera pubblica discorsiva ad operadi Jürgen Habermas e della sua scuola». Si veda anche nello specifico prussiano W.Neugebauer, Preussen in der Historiographie. Epochen und Forschungsprobleme derPreussischen Geschichte, in Handbuch der Preussischen Geschichte, a cura di W. Neu-gebauer con la collaborazione di F. Kleinehagenbrock. Band I. Das 17. und 18.Jahrhundert und Große Themen der Geschichte Preussens. Mit Beiträgen von U. Fuh-rich-Grubert, F. Kleinehagenbrock, I. Mieck, W. Neugebauer, W. Ribbe, Berlin-NewYork, de Gruyter, 2009, pp. 3-109.
7 J. Habermas, Storia e critica dell’opinione pubblica, cit., pp. 178-195.8 J. Habermas, Storia e critica dell’opinione pubblica, cit., p. 188 (traduzione mo-
dificata). Cfr. l’eccellente traduzione francese di questo passo in Id., L’espace public.Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise, Pa-ris, Payot 1978, p. 120.
opinione pubblica e opposizione in prussia sotto federico ii 141
liberale a occupare la posizione di iniziatore e anticipatore che esclu-deva consapevolmente la ricostruzione del contesto argomentativo, so-ciale e politico nel quale la sua Öffentlichkeit si muoveva.
Si tornerà rapidamente in conclusione sul testo di Kant e sulle let-ture alternative che ne sono state date e se ne possono dare. Per oraè opportuno proporre un cambiamento di prospettiva da cui guardarealla formazione di spazi pubblici dove le opinioni su temi rilevantiper la vita collettiva si potevano esprimere per acquistare forza ope-rativa: una prospettiva attraverso cui vedere gli elementi di attivismopolitico e talvolta di opposizione ai poteri costituiti che sono stati ca-ratteristici del mondo europeo e atlantico nell’ultimo quarto del XVIIIsecolo. Le ampie visioni di Robert Palmer, Jacques Godechot, FrancoVenturi sino a quelle più recenti di Christopher Bayly e JürgenOsterhammel hanno ricostruito con notevoli diversità di accento lacrisi di fine Settecento unificando sollevazioni, resistenze, crisi econo-miche, fiscali e religiose in un quadro nel quale le diverse intercon-nessioni sono poste in rilievo e nel quale è a priori esclusa la possi-bilità stessa di Sonderwege se non come scostamenti alla fine poco ri-levanti da trasformazioni di ampia portata9. In nessuna di queste am-pie visioni della crisi tardo settecentesca la Prussia è un centro degnodi interesse, e in molti casi neppure di menzione. Ci sono ovviamentebuone ragioni per quest’assenza. Come si può facilmente osservaresulla scia di un’autorevole storiografia la Berlino degli anni settanta,ottanta e novanta del Settecento non divenne né Philadelphia né Pa-rigi, neppure Ginevra e Liegi né Napoli e Magonza10. L’esclusione
9 J. Godechot-R. Palmer, Le problème de l’Atlantique du XVIIIième auXXième siècle, in Comitato internazionale di scienze storiche. X Congresso in-ternazionale di Scienze storiche, Roma 4–11 Settembre 1955. Relazioni 5 (Storiacontemporanea), Firenze, Sansoni, 1955, pp. 175-239; R. Palmer, The Age of theDemocratic Revolution: A Political History of Europe and America, 1760-1800.I: The Challenge; II: The Struggle, Princeton, Princeton University Press, 1959 e1964; J. Godechot, Les Révolutions, 1770–1799, Paris, PUF, 1963; F. Venturi,Settecento riformatore, in particolare il vol. III, La prima crisi dell’Antico Regime.1768-1776 e il vol. IV in due tomi: I grandi stati dell’Occidente e Il patriotismorepubblicano, Torino, Einaudi, 1979 e 1984; C. Bayly, The Birth of the ModernWorld. Global Connections and Comparisons, 1780-1914, Oxford, Blackwell, 2004;J. Osterhammel, Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhun-derts, München, Beck, 2009, in particolare pp. 747-77. Ora un’utile e lucida in-troduzione a questi temi è S. Conrad, Globalgeschichte. Eine Einführung, Mün-chen, Beck, 2013.
10 Il tema dell’insoddisfazione politica e della ricerca di equilibri nuovi è statoriproposto recentemente dai saggi contenuti in Enlightenened Reform in Southern
edoardo tortarolo142
della Prussia dalla visione della crisi dell’antico regime ha certamentefondamenta reali che sono state tuttavia fortemente enfatizzate e allafine deformate da una storiografia del Sonderweg concentrata sullacreazione di un’identità statale nazionale assai più che sulla condivi-sione europea di problemi politici e sociali che erano ben presenti alleclassi dirigenti. Un elemento nella revisione della storia prussiana vieneindubitabilmente dalla riscoperta del dinamismo interno e delle ten-sioni tra gruppi e le istituzioni che qui, come nel resto d’Europa, apartire almeno dalla guerra dei sette anni erano alle prese con spintedisgregatrici del consenso sociale che venivano dalle più diverse parti:dalle crisi finanziarie, dalle carestie, dalle crescenti esigenze dei bilancigovernativi, dalle critiche nei confronti dei privilegi ereditari. Nessunodi questi elementi mancava in una qualche misura in Prussia. Un’a-nalisi della sfera pubblica nell’ultimo scorcio del regno di Federico IIe nel periodo di transizione al governo del nipote e successore Fede-rico Guglielmo II deve tenerne conto11. Per il mondo delle campa-gne, a lungo dominate dal doppio paradigma della divisione tra ter-ritori all’ovest e all’est dell’Elba e dello strapotere degli Junker unasalutare revisione è venuta dalla monografia di William Hagen, che hadocumentato tra l’altro la capacità di resistenza dei contadini e di di-namismo modernizzatore dei signori nelle campagne12. Per il mondourbano, che rappresentava una parte rilevante della vita sociale, eco-nomica e politica del Regno, l’interesse su basi nuove per le forme diorganizzazione dei gruppi sociali e per l’espressione di dissenso dallemisure governative è relativamente recente e partecipa della crescenteinsostenibilità della tesi del Sonderweg13.
Europe and Its Atlantic Colonies, c. 1750-1830, a cura di G. Paquet, London, Ash-gate, 2009.
11 È scomparsa dalle bibliografie recenti l’opera ancora oggi interessante di HenriBrunschwig pubblicata inizialmente sotto il titolo di La crise de l’État prussien à lafin du XVIIIe siècle et la genèse de la mentalité romantique, Paris, PUF, 1947 e ri-stampata con il nuovo titolo di Société et romantisme en Prusse au XVIII siècle, Pa-ris, Flammarion, 1973. La ricerca di Brunschwig era stata svolta negli anni trenta du-rante il suo periodo come borsista presso l’Institut français de Berlin con Sartre eAron. Brunschwig aveva registrato con attenzione i segni d’instabilità interna del re-gno attraverso un ampio ricorso alla pubblicistica degli anni ottanta e novanta delSettecento. Cfr. la nota biografica centrata sugli interessi africanistici di Brunschwigdi J. Hargreaves, From Colonisation to Avénement: Henri Brunschwig and the Hi-story of Afrique Noire, in «The Journal of African History», 31, 1990, pp 347-52.
12 W. Hagen, Ordinary Prussians: Brandenburg Junkers and Villagers, 1500–1840,Cambridge, Cambridge University Press, 2003.
13 Insiste su questo tema l’ampia sintesi di C. Clark, Iron Kingdom. The Rise
opinione pubblica e opposizione in prussia sotto federico ii 143
Le occasioni di discussione e scambio di notizie e commenti cri-tici non mancavano a Berlino. Karl Heinrich Krögen, autore nasco-sto dall’anonimato delle Freye Bemerkungen über Berlin, Leipzig undPrag, delineò un quadro coerente della ricchezza di occasioni socialiofferte dalla capitale nella quale opinioni, idee, giudizi si scambiavanocon estrema libertà e spregiudicatezza14. Krögen descriveva vivida-mente i luoghi in cui l’opinione pubblica si formava: i teatri, i con-certi, le passeggiate, che offrivano un’occasione di incontro tra tutti iceti, alti e bassi, ricchi e poveri, «dove tutto si accumula l’un sull’al-tro nello stesso mucchio», le società private, «dove prevale uno spi-rito libero e senza freni, si può parlare liberamente di ogni cosa, senzatemere di essere esposti a conseguenze negative», e poi le più di centosale per fumare (in realtà, come diceva chiaramente Krögen, postri-boli)15. A completare il quadro complessivo Krögen descriveva la scenadi strada in cui «una donna legge i giornali a voce alta al pubblicocurioso […]», rendendo partecipi gli analfabeti degli avvenimenti delmondo16: un abbozzo di sfera pubblica plebea accanto a quella bor-ghese. Una presentazione analoga della sfera pubblica berlinese si ri-trova nelle fortunate lettere del filoprussiano Johann Kaspar Riesbeck:«Una libertà nel dare giudizi sul governo, un orgoglio nazionale, unapartecipazione agli affari pubblici […]. Si parla qui delle disposizionidel sovrano di quel che fa in privato con una libertà che ci si aspet-terebbe solo da un inglese»17. Questo quadro coincide con la descri-zione dei gruppi cui si rivolgevano programmaticamente le riviste ber-linesi proiettando la propria visione dei compiti e delle responsabilità
and Downfall of Prussia 1600-1947, Cambridge, Harvard University Press, 2006. Masi può vedere l’interpretazione interessante, anche se troppo attualizzante, di M. Er-lin, Berlin’s Forgotten Future: City, History, and Enlightenment in Eighteenth-Cen-tury Germany, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2004, secondo laquale la Berlino tardo settecentesca fu un laboratorio di modernità urbana e di ela-borazione di nuove e dinamiche percezioni dell’evoluzione storica.
14 Il volume portava il sottotitolo enigmatico di Original und Kopie, senza luogodi stampa né indicazione di tipografo, e la data di stampa 1785. È stato ripubblicatopresso Dausien, Hanau nel 1999. Una riproduzione on-line è disponibile pressohttp://digitale.bibliothek.uni-halle.de. L’autore fu anche traduttore di Swift: LemuelGullivers Reise nach Lilliput, aufs neue frei verdeutscht von Carl Heinrich Krögen,Kopenhagen, Ole Hegelund, 1786.
15 Freye Bemerkungen, cit., pp. 44, 46 e 71. 16 Ivi, p. 85.17 Briefe eines Reisenden Franzosen über Deutschland. An seinen Bruder zu Pa-
ris. Uebersezt von K. R. S.l., s.e., 1784, II, p. 87. Una ristampa anastatica è apparsapresso la Nabu Press nel 2010.
edoardo tortarolo144
dei diversi gruppi sociali. Nel 1781 Friedrich Traugott Hartman, unfunzionario dell’amministrazione berlinese molto attivo nella discus-sione pubblica su temi del giorno, descrisse nel primo numero dellasua rivista «Hieroglyphen» la «società politica» cui si rivolgeva: «com-mercianti, borghesi, ufficiali, e una dotta signora». Nel 1782 il primonumero dell’«Historisches Portefeuille» sosteneva di rivolgersi a «uf-ficiali, a commercianti e in generale a cittadini ben educati» (gesitteteBürger). Chi pensava all’allargamento del pubblico, come Karl PhilipMoritz nel 1784, partiva proprio dalla distanza che separava l’eliteistruita e colta dal popolo non istruito e sostenne la necessità di pro-durre «un giornale pubblico» (eine öffentliche Zeitung) che fosse «lavoce della verità […] che penetrasse nelle capanne degli umili»18, os-sia, più prosaicamente, che fosse il giornale verosimilmente letto dallapopolana che si è vista nella descrizione di Krögen.
Esistevano quindi tra gli anni settanta e ottanta luoghi sociali e fi-sici a Berlino, che possiamo identificare come forme di sfera pubblicache generavano opinioni condivise su temi di valenza generale, ed èrilevabile un sostanziale consenso sulla notevole disinvoltura con cuici si esprimeva. Questa caratterizzazione era incompatibile in linea diprincipio con una componente importante della tesi del Sonderweg,vale a dire la remissività dei ceti cittadini nei confronti del governo,la loro disponibilità a piegarsi davanti al potere e soprattutto a in-troiettare la cultura della sottomissione, a ritirarsi nello spazio nonpolitico e essenzialmente letterario della sfera pubblica borghese.L’(auto)stilizzazione di Federico II come «roi-philosophe» e la crea-zione della categoria interpretativa di «assolutismo illuminato»19 hannocontribuito a escludere dalla discussione tutti gli aspetti che potevanorichiamare la dimensione critica, di dissenso ragionato, ma capace an-che di procedere a iniziative politiche a partire dalla sfera pubblica.Per riequilibrare un’immagine storiografica non più adeguata è inveceimportante cogliere gli elementi di irrequietezza, di malcelata insoffe-
18 K.P. Moritz, Ideal einer vollkommenen Zeitung, Berlin, Voss, 1784, pp. 4-5.Cfr. E. Schreiber, The Topography of Modernity. Karl Philipp Moritz and the Spaceof Autonomy, Ithaca, Cornell University Press, 2012.
19 Cfr. W. Neugebauer, Brandeburg-Preussen in der Frühen Neuzeit, in Hand-buch der Preussischen Geschichte, cit., I, pp. 324-26 (con ampia bibliografia sino al2005); i saggi contenuti nei due volumi intitolati Friedrich der Grosse in Europa. Ge-schichte einer wechselvollen Beziehung, a cura di B. Sösemann e G. Vogt-Spira, Stutt-gart, Steiner, 2012, insistono complessivamente sulla partecipazione della Prussia allastoria europea (cfr. su questo aspetto ad esempio l’ampia recensione di Heinz Duch -hardt in http://www.sehepunkte.de/2012/09/20644.html).
opinione pubblica e opposizione in prussia sotto federico ii 145
renza per le decisioni governative e di ricerca di cambiamento nellasfera pubblica della Prussia federiciana. Certamente i contemporaneiregistravano a Berlino una libertà di critica che appariva perfino esa-gerata a chi proveniva da altre aree dell’Europa centrale. Le relazionidei viaggiatori permettono di tentare di superare il vuoto lasciato dallacomunicazione solamente orale cui queste critiche erano affidate nellastragrande maggioranza dei casi20. Quando Krögen descriveva gli in-contri nelle case private delle persone altolocate, nelle quali gli stra-nieri facilmente erano ammessi, la sottolineatura della spregiudicatezzadelle opinioni era marcata e segnata da una nota di sorpresa. «Unostraniero, che giunge dall’estero all’interno di una famiglia di questotipo, ascolta con stupore le conversazioni più insolenti e spregiudicatesui primi funzionari dello Stato, sulle loro caratteristiche, conoscenzee opinioni; anche alla tavola di un funzionario del Re si sente espri-mere i giudizi più arditi sul governo e sull’amministrazione dello statoe si ascolta spesso la satira più tagliente sulla vita privata del So-vrano»21. Nelle case degli alti funzionari si praticava quindi una cri-
20 Per riflessioni su questo tema A. Farge, Dire et mal dire: L’Opinion publi-que au XVIIIe siècle, Paris, Seuil, 1992 e A. Lilti, Le Monde des salons. Sociabilitéet mondanité à Paris au XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 2005. Filippo De Vivo ha com-piuto un notevole sforzo per ricostruire la dimensione orale dell’opinione pubblicanel suo Information and Communication in Venice. Rethinking Early Modern Poli-tics, Oxford, Oxford University Press, 2007 (la versione italiana rivista è apparsa sottoil titolo di Patrizi, informatori, barbieri. Politica e comunicazione a Venezia, Milano,Feltrinelli, 2012). In un notevole saggio, da mettere a confronto con il volume di Lilticitato più sopra, Jane Curran ha studiato i testi del Settecento tedesco che educavanoalla lettura personale e pubblica e come questi interagivano con la discussione oraletipica dell’Aufklärung creando un equilibrio tra privato e pubblico, scritto e detto(Oral Reading, Print Culture, and the German Enlightenment, in «The Modern Lan-guage Review», 100, n. 3, 2005, pp. 695-708). Una riflessione sulla bibliografia re-cente riferita alla prima età moderna è in G. Ciappelli, Comunicazione politica eopinione pubblica nel Rinascimento: esempi e considerazioni, in «Annali dell’IstitutoStorico Italo-Germanico in Trento», 33, 2007, pp. 27-57.
21 Freye Bemerkungen, cit., p. 67. Una descrizione simile in molti passi, certa-mente più radicale nelle formulazioni antiassolutistiche, è in «Bibliothek für Denkerund Männer von Geschmack» 1783, p. 434, che a differenza del testo di Krögen con-clude la descrizione con un’equiparazione esplicita tra la libertà di espressione inglesee quella osservata a Berlino (Beschluß der Karakteristik Berlins, II Band, V Stück,Gera, 1784). In una lettera a Wilhelm Ludwig Gleim il pastore e pioniere della de-mografia Johann Peter Süssmilch si riferiva alle voci critiche sulle abitudini di spesadi Federico II che circolavano a Berlino e fomentavano disaffezione verso la sua fi-gura (29 gennaio 1766, in J.P. Süssmilch, Die königliche Residenz Berlin und dieMark Brandeburg im 18. Jahrhundert. Schriften und Briefe, a cura di J. Wilke, Ber-lin, Akademie, 1994, pp. 201-2).
edoardo tortarolo146
tica serrata a quei provvedimenti stessi che si dovevano eseguire. Ana-logamente, con notevole sorpresa, l’amico di Kant Johann Daniel Metz-ger ricordò la sconcertante disinvoltura del filosofo nell’elogiare la ri-voluzione francese in occasioni sociali senza timore di scandalizzaregli ospiti, anche nelle case più altolocate22. Dalla sfera pubblica de-scritta da Kögen era esclusa tutta la componente – considerata estra-nea – del pubblico dei lettori di bassa condizione sociale. La Volks -aufklärung costituiva un problema di natura diversa rispetto alla crea-zione di una Öffentlichkeit raziocinante. Esisteva una sfera pubblicaplebea a Berlino oltre che nei desideri di Moritz? A sentire alcuni os-servatori, sì. Soprattutto era evidente una grande quantità di lettera-tura destinata principalmente o esclusivamente a questa opinione pub-blica socialmente bassa. Secondo Rohde, direttore di «Berlin. EineZeitschrift für Freunde der schoenen Künste, des Geschmacks undder Moden»: «Il bisogno è la madre di molte invenzioni, anche deicanti e dei racconti che si offrono in vendita a Berlino sulle strade esui viali, e che meritano per questo e altri motivi di essere chiamati‘canti da strada’». Gli autori sono stampatori e soldati. «Gli stampa-tori impegnano in estate le loro presse, ogniqualvolta manca il lavoro,con questa robaccia insensata, che loro stessi pensano e scrivono; peramore dell’ozio i soldati si scelgono questo modo di sbarcare il lu-nario e non si trovano malaccio»23. Ignoranti che scrivono libri e livendono ad altri ignoranti: la sfera pubblica plebea della strada sem-brava assai poco raziocinante. Più di vent’anni prima di Rohde, nel1775 Anton Friedrich Büsching aveva descritto il tipo di letteraturache il popolo leggeva volentieri: sul Mühledam l’uomo del popolo(der gemeine Mann) poteva comprare in gran quantità per 3 o 6 pfen-nig pubblicazioni che non si potevano definire altrimenti che «insen-sate, disgustose, superstiziose e sozze storielle, canti, storie buffone-sche alla Till Eulenspiegel, interpretazioni dei sogni, lettere dal cieloe così via»24.
La distinzione di sfere pubbliche rispecchiava molto da vicino laconcezione dell’istruzione proposta alla metà degli anni settanta dalministro per l’istruzione e il culto, nonché ammiratore e sostenitoredi Kant, von Zedlitz. Nel 1776 aveva proposto nel suo discorso di
22 Aeusserungen über Kant, seinen Charakter und seine Meinungen. Von einembilligen Verehrer seiner Verdienste. 1804, p. 16.
23 «Berlin. Eine Zeitschrift, des Geschmacks und der Moden», 3, 5, 1799, p. 175.24 A.F. Büsching, Beschreibung seiner Reise von Berlin über Potsdam nach
Rekahn unweit Brandenburg, Berlin, Haude und Spener, 1775, p. 12.
opinione pubblica e opposizione in prussia sotto federico ii 147
accettazione della nomina a membro dell’Accademia delle Scienze diBerlino una tripartizione delle forme di istruzione che dava originealla tensione tra le diverse sfere pubbliche25. Zedlitz utilizzava que-st’occasione semipubblica per affermare l’importanza del patriottismo,considerato un valore centrale dell’educazione, il cui peso era pari aquello della religione: «eccellente, se l’insegnante della religione, siaquesto parroco, rabbino o imam, prepara la strada all’insegnante delpatriottismo! Non esiste patriottismo senza religione»26. Per la primaclasse, che comprendeva la popolazione rurale e degli artigiani, si pre-vedeva tanta istruzione ed educazione quanta fosse necessaria a farneefficienti e soddisfatti membri della società. «A quale scopo si devonoinsegnare a uomini rozzi concetti di cui abusano, che ecciterebbero illoro desiderio di scambiare la loro posizione sociale con un’altra, dovesi troverebbero a mal partito?»27. Per la seconda, quella dei «cittadinipiù istruiti, […] uomini con talenti, artisti, dotti (Gelehrte) e coloro iquali arrivano a uffici pubblici grazie ad altre capacità», valeva il prin-cipio che «non possono essere mai abbastanza illuminati» (aufgeklärt),così come i nobili, che si distinguevano dalla seconda classe per l’a-bitudine a considerare l’importanza dell’onore28. Il sistema educativopuntava alla creazione di due sistemi e quindi due sfere pubbliche so-stanzialmente distinte: una, per la prima classe, era segnata dall’obbe-dienza e da una cultura puramente strumentale ai bisogni della mo-narchia, mentre la sfera pubblica della seconda e terza classe dovevaobbedire al principio della libera discussione. Un saggio pubblicatoda von Zedlitz sul «Deutsches Museum» nel 1777 ribadiva questi prin-cipi, includendo tra gli obiettivi dell’insegnamento per la prima classe«l’obbedienza assoluta verso le leggi, non verso le persone», e «la li-bertà di coscienza». Per la seconda e la terza classe l’accento cadeva
25 P. Mainka, Karl Abraham von Zedlitz und Leipe (1731-1793). Ein schlesischerAdliger in Diensten Friedrichs II. und Friedrich Wilhelms II. von Preußen, Berlin,Duncker & Humblot, 1995, pp. 325-44.
26 Über den Patriotismus als einen Gegenstand der Erziehung in monarchischenStaaten. Eine Vorlesung Sr. Excellenz Herrn Carl Abraham Freyherrn von Zedlitzköniglichen geheimen Staatsministers bey Seiner Aufnahme in die königliche Akade-mie der Wissenschaften, aus dem Französischen übersetzt, Berlin, Voß, 1777, p. 17.Cfr. anche la traduzione francese Sur l’instruction publique. Considérations sur l’étatprésent des écoles publiques et sur la possibilité de les rendre plus analogues et plusutiles à la vie civile. Premier Mémoire, Mémoires de l’Académie Royale des Scienceset Belles-Lettres, Berlin, Haude und Spener, 1777, pp. 14-26 (online presso http://bi-bliothek.bbaw.de/).
27 Über den Patriotismus, cit., p. 31.28 Über den Patriotismus, cit., pp. 31-34.
edoardo tortarolo148
sul rapporto tra diritti e doveri argomentati razionalmente e sulla «in-fluenza delle professioni, del commercio, delle arti e delle scienze sullafelicità della vita sociale nel suo complesso» e, per la nobiltà, sui «di-ritti e doveri dello Stato nei loro rapporti reciproci»29. Le idee peda-gogiche di von Zedlitz corrispondevano alla sua concezione di sferepubbliche distinte da attivare e nutrire in un rapporto che conside-rava sano e sostenibile. La monarchia assoluta doveva seguire il prin-cipio che fatta salva l’obbedienza alle leggi i membri della sfera pub-blica superiore, quella dei borghesi e dei nobili, potessero e dovesseroimpegnarsi in uno sforzo di progressiva Aufklärung. Gli strumentierano pubblici e segreti. Von Zedlitz li utilizzava entrambi. Come mi-nistro rimproverò nel 1779 i professori dell’Università di Halle chevolevano impedire al controverso e certamente deista Karl FriedrichBahrdt di proseguire il suo insegnamento nella Facoltà di Filosofia eli accusò di «diabolico spirito persecutorio» per voler limitare la li-bera discussione. In una lettera contemporanea a Bahrdt stesso vonZedlitz dichiarava di saper «riconoscere e apprezzare la libertà di co-scienza, ma al tempo stesso di considerarla troppo importante per la-sciar mai penetrare disordine e pura ricerca della disputa»30. Comepersonaggio eminente della vita letteraria oltre che politica di Berlinopartecipava se non direttamente, certo indirettamente, sia alla parte in-dirizzata all’opinione pubblica colta attraverso la rivista «BerlinischeMonatsschrift» sia all’attività del club segreto Mittwochsgesellschaft. Iltramite verso entrambe era saldamente garantito da Johann ErichBies ter, suo segretario personale, che seguiva anche i rapporti ovvia-mente molto stretti di von Zedlitz con il corpo docente dell’interosistema di istruzione prussiano31. Biester era membro fondatore dellaMittwochs gesellschaft e direttore con Gedike della «Berlinische Monats -
29 K.A. von Zedlitz, Ueber die Einrichtung einer Volkslehre in einem eigentlichmonarchischen Staat, nach den Begriffen des Verfassers der Abhandlung: Ueber denPatriotismus, als Gegenstand der Erziehung in Schulen eines monarchischen Staats, in«Deutsches Museum», 2, 1777, pp. 97-104, citazioni alle pp. 103-104.
30 P. Mainka, Karl Abraham von Zeidlitz und Leipe, cit., pp. 493-4. 31 E. Hellmuth, Aufklärung und Pressefreiheit. Zur Debatte der Berliner Mittwo-
chsgesellschaft während der Jahre 1783 und 1784, in «Zeitschrift für historische For-schung», 9, 1982, pp. 315-45; J. Schmidt, The Question of Enlightenment: Kant,Mendelssohn, and the Mittwochsgesellschaft, in «Journal of the History of Ideas», 50,2, 1989, pp. 269-91; U. Goldenbaum, «Nul Auguste pour protecteur». Consciencebourgeoise et loyauté du fonctionnaire dans la Société du Mercredi à Berlin, in «Re-vue Germanique Internationale», 30, 3, 1995, pp. 127-41; T. Hochstrasser, Natu-ral Law Theories in the Early Enlightenment, Cambridge, Cambridge UniversityPress, 2000, pp. 189-206 (per i rapporti istituzionali e amicali tra von Zedlitz e Kant).
opinione pubblica e opposizione in prussia sotto federico ii 149
chrift»32. In più, von Zedlitz offriva l’esempio di come intendere lapartecipazione alla libera discussione filosofica e scientifica, seguendole lezioni di un allievo di Kant, Marcus Herz, sull’antropologia ra-zionale tenute nell’inverno 1778-79 per un ristretto gruppo di ascol-tatori selezionato33. La partecipazione di Biester alla massoneria ber-linese nella Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland ag-giungeva un ulteriore stretto legame con uno dei luoghi di elabora-zione dell’opinione pubblica a Berlino sotto Federico II (che concessela lettera di protezione alla loggia nel 1774)34.
Questi spazi diversi di discussione partecipavano di gradi diversidi pubblicità rappresentati dalla segretezza assoluta che per decenniha circondato la Mittwochsgesellschaft: la riservatezza delle conversa-zioni private, la fittizia segretezza della massoneria e la ricerca dellamassima pubblicità possibile della stampa, dei libri come delle riviste(favorita dalla mitezza dell’apparato di censura preventiva). Dove sipoteva annidare la critica a Federico II e all’esercizio del suo potere?In forme e con finalità ed efficacia diverse in ognuno di questi spazidi discussione.
2. Costituzione, religione, tassazione
Come ovunque nell’Europa dell’Antico Regime, anche in Prussiaera del tutto irrealistico un discorso di opposizione sistematica al go-verno di Federico II, di alternativa istituzionale al sistema assolutistadi autorità. Quando in almeno due occasioni, verso la conclusione dellungo regno, si discusse apertamente di cambiamenti strutturali nellamonarchia, ci si preoccupò di presentare i cambiamenti come una pro-secuzione e un consolidamento dei risultati politici ottenuti da Fede-rico II e non come un ripudio della sua azione, pur indicando unadirezione nuova rispetto all’autocrazia federiciana. Nel 1780 iniziò un
32 A. La Vopa, The Politics of Enlightenment: Friedrich Gedike and GermanProfessional Ideology, in «Journal of Modern History», 62, 1, 1990, pp. 34-56.
33 M.L. Davies, Identity or History? Marcus Herz and the End of the Enlight -enment, Detroit, Wayne State University, Press 1995.
34 S. Lestition, Kant and the End of the Enlightenment in Prussia, in «TheJournal of Modern History», 65, n. 1, 1993, pp. 57-112 presenta con chiarezza l’ar-ticolazione di queste diverse sfere di spazio pubblico e privato con particolare at-tenzione agli anni di passaggio tra il regno di Federico II e di Federico GuglielmoII. Nulla di nuovo in C. Stange-Fayos, Lumière et obscurantisme en Prusse, Bern,Peter Lang, 2003.
edoardo tortarolo150
dibattito di notevole ampiezza sulla riforma del sistema di giustiziaavviato da Federico II35. Nel 1785 la «Berlinische Monatsschrift» pub-blicò un progetto, anonimo, di riforma costituzionale nel senso di unamonarchia parlamentare che sarebbe stata il coronamento del lungoregno di Federico II. Il progetto di riforma costituzionale riprendeva,è difficile dire quanto consapevolmente, un cenno in questo senso neltesto apocrifo ma attribuito a Federico II Les matinées du Roi dePrusse, di cui era stata pubblicata clandestinamente una traduzione te-desca nel 178336. Non era da queste forme di sfera pubblica – cheerano in costante tensione con il governo ma con cui condividevanosovrapposizioni molto ampie di uomini, idee, obiettivi e lealismi difondo – che ci si poteva aspettare forme di opposizione fattiva37.
Su due temi di grande importanza si creò una forma di sfera pub-blica che raccolse, rielaborò e alla fine si condensò in un’informalepressione sul governo abbastanza efficace da costringere Federico IIe i suoi ministri a tornare sui loro passi e modificare la legislazione.
35 Cfr. P. Weber, «Was jetzt eben zu sagen oder noch zu verschweigen sei, müsstihr selbst überlegen». Publizistische Strategien der preußischen Justizreformer 1780-1794, in U. Goldenbaum, Appell an das Publikum. Die öffentliche Debatte in derdeutschen Aufklärung 1687-1796. Mit Beiträgen von F. Grunert, P. Weber, G. Hein-rich, B. Erker und W. Siebers, Berlin, Akademie Verlag, 2004, II, pp. 729-812.
36 Neuer Weg zur Unsterblichkeit für Fürsten, in «Berlinische Monatsschrift» 5,1, 1785, pp. 239-46. Cfr. H.-C. Kraus, Theodor Anton Heinrich Schmalz (1760-1831).Jurisprudenz, Universitätspolitik und Publizistik im Spannungsfeld von Revolutionund Restauration, Frankfurt/Main, Klostermann, 1999, p. 407, che riporta una rea-zione (molto critica) del giurista di Königsberg al saggio, pubblicata nel 1795, da cuirisulta la sua eco persistente. Il saggio appare non attribuito anche nella recente bi-bliografia di D. Klippel, Naturrecht und Rechtsphilosophie im 19. Jahrhundert. 1780bis 1850, Tübingen, Mohr Siebeck, 2012, n. 1590, p. 176. La traduzione tedesca delleMatinées porta il titolo di Die Morgenstunden des Königs von Pr… oder lehrreicheVorschriften an seinen Thronfolger. Aus dem Französischen frei übersetzt, berichtigetund mit Anmerkungen versehen, Boston 1783: alle pp. 20-21 si accennava ai vantaggiprodotti da una «assemblea che rappresenta la nazione e che è la custode delle sueleggi». Il (palesemente fittizio) Federico II riconosceva che, limitato da un’assemblea,sarebbe stato un sovrano più giusto ma lamentava che non avrebbe potuto fregiarsidel titolo di eroe. Un’edizione moderna, senza casa editrice, dell’originale francese,ristampato più volte dal 1766 in poi, è Les Matinées du Roi de Prusse par Voltaire,Bruxelles, 1871 (il passaggio sulla rappresentanza alle pp. 36-37).
37 Alquanto unilaterale e generica è l’affermazione di Michael Sauter per cui inPrussia «l’élite illuminata creò una sfera pubblica deliberatamente conservatrice» e cheil pubblico non istruito (the general public) fosse tenuto fuori dalla sfera della stampa:cfr. il saggio, peraltro molto interessante, Preaching, a Ponytail, and an Enthusiast:Rethinking the Public Sphere’s Subversiveness in Eighteenth-Century Prussia, in «Cen-tral European History», 37, n. 4, 2004, pp. 544-67, citazione a p. 545.
opinione pubblica e opposizione in prussia sotto federico ii 151
Il primo caso si concentrò in un numero di anni ridotto su una que-stione di politica religiosa. Il secondo caso, più diluito nel tempo, mo-dificò un tratto fondamentale della politica fiscale federiciana. In en-trambi l’efficacia della sfera pubblica come opposizione critica fu in-negabile.
La teologia razionalista e neologica, che Walter Sparn ha descrittocon attenzione alle posizioni dogmatiche, rappresentò evidentementel’orientamento religioso dell’elite dirigente dello Stato38. I suoi espo-nenti occuparono le posizioni eminenti nell’amministrazione innanzi-tutto ecclesiastica e culturale prussiana, da Johann Salomo Semler aJohann Joachim Spalding a Johann Gottlieb Töllner e Wilhelm AbrahamTeller. Il caso di von Zedlitz dimostra questo punto e quanto la li-bertà di coscienza, intesa a proteggere l’innovazione razionalista, fosseal centro della politica federiciana e non semplicemente la rivendica-zione di un principio astratto. Il razionalismo teologico combinatocon la posizione di potere istituzionale mise in moto una discussionepubblica sull’innovazione più rilevante introdotta dai neologi, la revi-sione cioè del libro di preghiere cantate usato nei servizi domenicalida tutta la comunità dei fedeli e al centro della concezione luteranadella comunità stessa39. Un gruppo ristretto di tre eminenti teologineologi, Johann Samuel Diterich, Spalding e Teller, aveva avviato unlavoro di drastica riforma della raccolta più popolare e radicata dicanti ecclesiastici, quella che Johann Porst aveva pubblicato per laprima volta nel 1708. I tre neologi avevano ridotto i 900 canti allametà, buona parte dei quali erano stati riscritti nel senso di una teo-logia razionalista. A questi canti riveduti se ne erano aggiunti altri,opera dei tre teologi oppure di altri autori contemporanei. Il 2 otto-bre 1780 Federico II emanò una disposizione speciale per annunciarel’introduzione del nuovo Gesangbuch nel corso dei due anni seguenti.
38 In questo volume pp. 99-135. Ma anche W. Sparn, Vernünftiges Christentum.Über die geschichtliche Aufgabe der theologischen Wissenschaften im 18. Jahrhundertin Deutschland, in Wissenschaften im Zeitalter der Aufklärung, a cura di R. Vierhaus,Göttingen, Vandenhoek und Ruprecht, 1985, pp. 18-57. Sulla presenza della teologianeologica nella «Allgemeine Deutsche Bibliothek», la rivista di recensioni edita daFriedrich Nicolai dal 1765 e punto di riferimento per l’Aufklärung berlinese si vedaR. Kirscher, Theologie et lumières: les theologiens ‘éclairés’»: autour de la revue deFriedrich Nicolai: «Allgemeine Deutsche Bibliothek» (1765-1792), Villeneuve-d’Ascq(Nord), Presses Universitaires du Septentrion, 2001.
39 Cfr. per un’introduzione C. Boyd Brown, Devotional Life in Hymns, Li-turgy, Music, and Prayer, in Lutheran Ecclesiastical Culture 1550-1675, a cura di R.Kolb, Leiden, Brill, 2008, pp. 259-304.
edoardo tortarolo152
Come è stato osservato, «certamente Federico II legava all’introdu-zione di una nuova raccolta di canti, ufficialmente obbligatori, anchela speranza di unificare ulteriormente il territorio eterogeneo cultu-ralmente e religiosamente attraverso l’amministrazione nel campo re-ligioso e di conseguenza di promuovere ulteriormente la ricerca diuna identità prussiana»40. In altre parole si trattava di un’operazionenella quale la struttura statale utilizzava l’orientamento prevalente-mente razionalistico della sua classe dirigente per avviare una riformanello strumento più efficace di comunicazione con la gran maggio-ranza della popolazione, la chiesa protestante. Non possono sfuggiregli elementi che accumunavano – nella diversità delle situazioni con-fessionali – questa iniziativa con le riforme non solo delle istituzioniecclesiastiche nei paesi sotto il controllo degli Asburgo41. A Berlinola resistenza all’introduzione fu notevole e si svolse attraverso la mo-bilitazione di quella stessa sfera pubblica che l’elite colta animava permigliorare ma non contestare il governo assoluto di Federico II. Inparticolare due personaggi si misero alla testa del movimento che aper-tamente contestava l’innovazione religiosa promossa dal governo. Sa-muel Lobegott Apitzsch, un commerciante con forti inclinazioni pie-tiste, avviò una campagna di petizioni contro il nuovo Gesangbuchper cui raccolse 130 firme di capifamiglia da quattro parrocchie ber-linesi. Christian Wilhelm Kindleben, scrittore, ex-pastore, fondatoredi riviste, scrisse la Freymüthige Beurteilung des neuen Berliner Ge-sangbuchs in tono fortemente polemico contro la nuova raccolta di
40 M. von Spankeren, Johann Joachim Spalding und der Berliner Gesangbuch-streit (1781), in «Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte», 18, n. 2, 2011, pp. 191-211, citazione a p. 194. Interessanti anche C. Rathgeber, The Reception of Bran-denburg-Prussia’s New Lutheran Hymnal of 1781, in «The Historical Journal», 36,1993, pp. 115-36, P. Weber, Der Berliner Gesangbuchstreit 1781. Aporien der ‚Aufklä-rung von oben’, in Literarische und politische Öffentlichkeit. Studien zur BerlinerAufklärung, a cura di I.-M. D’Aprile e W. Siebers, Berlin, Berliner Wissenschafts -verlag 2006, pp. 151-168 (anche in Berliner Aufklärung. Kulturwissenschaftliche Stu-dien, a cura di A. Košenina e U. Goldenbaum, Hannover, Wehrhahn 1999, pp. 101-19). Tutto questo senza dimenticare la diffusione crescente a Berlino a fine secolo,presso questa stessa elite professionale e amministrativa, di forme di deismo e criticareligiosa radicale su cui ad esempio il saggio di M. Mulsow, Christian Ludwig Paal-zow und der klandestine Kulturtransfer von Frankreich nach Deutschland, in Geheim-literatur und Geheimbuchhandel in Europa im 18. Jahrhundert, a cura di C. Haug,F. Mayer e W. Schröder, Wiesbaden, Harrassowitz, 2011, pp. 67-84 e ora, più am-piamente nel quadro tedesco, il numero monografico Radikale Spätaufklärung inDeutschland della rivista «Aufklärung», n. 24, 2012.
41 Si vedano i due volume della biografia di D. Beales, Joseph II, Cambridge,Cambridge University Press, 1987 e 2009.
opinione pubblica e opposizione in prussia sotto federico ii 153
canti, cui Spalding dovette rispondere punto per punto. Apitzsch eKindleben avevano maturato esperienze diverse, ma colsero entrambil’importanza della sfera pubblica non istituzionale alla quale rivolgersicon testi a stampa42. Certamente ci fu un’ampia dimensione orale diopposizione ma entrambi gli schieramenti si rivolsero ai loro seguacie agli oppositori attraverso pubblicazioni che avviarono una discus-sione pubblica di ampie dimensioni. A confermare questa tendenzadella critica verbale a sedimentarsi nelle pubblicazioni, si deve ricor-dare non solo che anche i sostenitori del nuovo Gesangbuch si orga-nizzarono con la loro campagna di petizioni, ma anche che l’attivitàdi predicazione fu sottoposta al controllo informale ma puntuale – diimpostazione deista-illuminista – di una pubblicazione periodica ano-nima, la «Berliner Predigtkritik für das Jahr 1783», il cui scopo erarendere più razionale e posata la religiosità dei fedeli e spingere i pre-dicatori a insistere sugli aspetti morali e comportamentali della dot-trina. La «Allgemeine Deutsche Bibliothek», uno dei bastioni dellacultura berlinese dell’Aufklärung, dedicò buona parte del volume 47a recensire la straripante produzione di scritti pro e contro il nuovoGesangbuch. La contrapposizione tra favorevoli e contrari al Ge-sangbuch per il controllo della discussione pubblica vide l’interventoanche di scrittori intermedi che agivano a contatto sia con la sferacolta, ufficiale, dichiaratamente governativa, in cui si muovevano adesempio i teologi neologi Spalding e Teller, sia con lo spazio in cuicercavano di esprimersi gli artigiani, i piccoli commercianti, i lavorantie garzoni che costituivano il seguito di Apitzsch e Kindleben43. Au-gust Friedrich Cranz fu probabilmente il più noto tra questi. Era con-sapevole di rivolgersi ai ceti medi e popolari che definiva come «lasocietà varia e variopinta del ceto medio» («die gemischte bunte Ge-sellschaft des Mittelstandes»)44. Sapeva di essere uno degli scrittori pre-
42 Sulle origini di questa concezione della sfera di discussione religiosa all’internodel movimento pietista cfr. D. von Mücke, Experience, Impartiality, and Authenti-city in Confessional Discourse, in «New German Critique», 79, 2000, Special Issue onEighteenth-Century Literature and Thought, pp. 5-35.
43 Senza dimenticare l’opposizione alla nuova raccolta da parte dei teologi con-servatori nel Concistorio come Woltersdorff e Silberschlag. Cfr. le parti relative in J.E. Silberschlag, Leben von ihm selbst beschrieben, Berlin, im Verlage der Königli-chen Realschul-Buchhandlung, 1792.
44 A.F. Cranz, Silen und sein Esel. Eine komisch-periodische Schrift. Vom Ver-fasser der Galerie des Teufels, Berlin, Im Selbstverlage des Verfassers und in Kom-mission bei S.F. Hesse in der Breiten Strasse, 1781, p. 4. Su Cranz si veda D. Rei-chelt, August Friedrich Cranz – ein Kgl. Preußischer Kriegsrat als freier Schriftstel-ler. Nachricht über einige seiner merkwürdigen Zensurauseinandersetzungen, in «Leip-
edoardo tortarolo154
diletti dall’uomo della strada, il gemeiner Mann. Nei molti, inconte-nibili e spesso contraddittori suoi scritti, Cranz denunciò la corru-zione con cui si amministrava l’esazione dell’accisa45. Più ampiamenteCranz intervenne nella disputa sul Gesangbuch per disegnare una po-sizione che rispettava l’attaccamento popolare per i canti imparati amemoria nell’infanzia e rifiutava quei canti che non miglioravano eanzi indebolivano il senso del messaggio religioso46. Si attribuiva an-che il compito di promuovere una riforma religiosa profonda appro-fittando della libertà di coscienza concessa dal sovrano nel senso diun rafforzamento del nucleo deistico nella religione universale e se-parando nettamente la sfera civile e mondana, di competenza del po-tere politico, da quella religiosa, libera e intoccabile47.
L’esito della controversia fu complessivamente favorevole agli op-positori del Gesangbuch rivisto in senso razionalista. Attraverso lacontestazione all’innovazione musicale, poetica, dogmatica contenutanel nuovo testo si fece valere il rifiuto dell’intera politica religiosa diFederico II. Già all’indomani della petizione di Apitzsch il sovranoaveva aggiunto di sua mano alla risposta l’annotazione: «Ciascuno puòcredere da me quel che gli pare, se solo è onesto; per quanto riguardale raccolti di canti, ciascuno può liberamente cantare: ‘Ora riposanotutti i boschi‘, o simile robaccia folle e sciocca»48. In questo modo an-che i sostenitori della nuova raccolta avrebbero dovuto affrontare ladiscussione pubblica, il libero confronto di argomenti con gli oppo-
ziger Jahrbuch zur Buchgeschichte», 5, 1995, pp. 39-85 e i cenni in M. Mulsow, Mo-nadenlehre, Hermetik und Deismus. Georg Schades geheime Aufklärungsgesellschaft1747-1760, Hamburg, Meiner, 1998, pp. 263-64. Il successo di vendita ottenuto dallepubblicazioni di Cranz era riconosciuto a malincuore da J.G. Heinzmann, Appell anmeine Nation über Aufklärung und Aufklärer; über Gelehrsamkeit und Schriftsteller;über Büchermanufakturisten, Rezensenten, Buchhändler; über moderne Philosophenund Menschenerzieher; auch über mancherley anderes, was Menschenfreiheit und Men-schenrechte betrifft, Berlin, auf Kosten des Verfassers, 1795, p. 40.
45 Die Berlinische Fama über Stadt- und Landbegebenheiten. Erstes Ausblasen,Berlin, 1781, in particolare alle pp. 7-10.
46 A.F. Cranz, Supplement zum ersten Stück der Chronik von Berlin, in einemSendschreiben an den Weltmann in Berlin, wohlmeritirten Tantenbekehrer und Ver-fasser der Briefe an einem [sic] Landgeistlichen, das neue Gesangbuch betreffend, vondem Verfasser der Bockiade, Berlin, 1781, p. 41.
47 Ueber den Missbrauch der geistlichen Macht oder der weltlichen Herrschaft inGlaubenssachen durch Beyspiele aus dem jetzigen Jahrhundert ins Licht gesetzt, Ber-lin, im Selbestverlage des Verfassers, 1781.
48 M. van Spankeren, Spalding cit., p. 197. L’originale tedesco riecheggia quantoin altre occasioni scritto più volte da Federico II in materia religiosa. «Nun ruhen alleWälder» è una canzone popolare tardo medievale musicata da Bach come ninna nanna.
opinione pubblica e opposizione in prussia sotto federico ii 155
sitori fino a che la morte di Federico II pose fine alla discussione ta-citando di fatto i neologi razionalisti49.
Su una seconda questione di grande rilevanza pubblica si formòuna sfera pubblica di opposizione, in questo caso molto diretta, checostrinse Federico II a un cambio di politica economica sostanzialerispetto alla decisione presa all’indomani della guerra dei sette anni.La creazione di una Régie, un’agenzia unica di riscossione delle ac-cise e dei dazi, nel 1766, aveva permesso un incremento notevolissimodelle entrate statali. Aveva naturalmente irritato la popolazione sia peril peso del prelievo sia per le modalità vessatorie in cui si conducevala riscossione50. Pur rappresentando senz’altro un progresso verso larazionalizzazione dello Stato in una delle sue funzioni fondamentali,la Régie aveva suscitato un aumento del contrabbando, occasionatoscontri violenti tra la popolazione e i suoi funzionari (per lo più fran-cesi) e provocato petizioni nel corso degli anni settanta e ottanta. La
49 Ian Hunter ha proposto di considerare la stretta contro i neologi frutto di unadecisione presa contro il loro tentativo di avviare una forma di proselitismo contra-ria alla politica religiosa prussiana (Kant’s Religion and Prussian Policy, in «ModernIntellectual History», 2, 1, 2005, pp. 1-27). L’episodio della discussione sul Gesang-buch (non ricordato da Hunter) sembra mostrare al contrario l’orientamento del go-verno prussiano a permettere una discussione pubblica con l’intento di frenare la crea-zione di tensioni troppo forti per l’equilibrio politico. Più convincente la dettagliataricostruzione di M.J. Sauter, Visions of the Enlightenment: The Edict on Religion of1788 and Political Reaction in Prussia, Leiden, Brill, 2009. Un’eco della riluttanza diFederico II ad andare contro i desideri dei fedeli è in una lettera di Biester a Kant,del 5 giugno 1785, in Kants Werke (Akademie Ausgabe), vol. 10, Briefwechsel I, Ber-lin, Reimer, 1922, p. 402, lettera n. 240.
50 Cfr. F. Schui, Taxpayer Opposition and Fiscal Reform in Prussia, c. 1766-1787,in «The Historical Journal», 54, n. 2, 2011, pp. 371-399; Id., ‘Friedrich der Schwa-che’? Ein König im Spiegel seiner Steuerpolitik, in Friedrich der Grosse in Europa,cit., I, pp. 411-25; Id., French figures of authority and state building in Prussia, inFigures of Authority. Contributions towards a Cultural History of Governance fromthe Seventeenth to the Twentieth Century, a cura di P. Becker e R. von Krosigk,Brussels, Lang, 2008, pp. 152-70. Il saggio di T. Schenk, Generalfiskal FriedrichBenjamin Loriol de la Grivillière d’Anières (1736-1803). Anmerkungen zu Vita, Amts -führung und Buchbesitz als Beitrag zur Erforschung preußischer Judenpolitik in derzweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, in «Aschkenas. Zeitschrift für Geschichte undKultur der Juden», 17, n. 1, 2007, pp. 185-223, ha una parte interessante che docu-menta l’insoddisfazione di d’Anières nei confronti della Régie e i suoi contrasti conil Generaldirektorium a proposito del contenzioso giudiziario creato dall’esazione del-l’accisa (pp. 185-97). Il volume di Schui, che amplia i temi presentati nel saggio ci-tato sopra, Rebellious Prussians. Urban Political Culture under Frederick the Greatand his Successors, Oxford, Oxford University Press, 2013, è uscito dopo la stesuradi questo saggio.
edoardo tortarolo156
discussione sulla Régie apparteneva alla sfera dei temi politici su cuinon era legittima una discussione diretta. Anche in questo caso tut-tavia un’opposizione critica venne alla luce anche nella discussionepubblica. Il modo di espressione non poteva che essere indiretto51.Nel primo numero della rivista, pubblicato nel gennaio del 1783, l’or-gano quasi-ufficiale dell’Aufklärung berlinese, la «Berlinische Mo-natsschrift», diffuse a firma di uno dei due direttori, Biester, un arti-colo sulle vicende di Johann Paul Philipp Rosenfeld, un predicatorereligioso irregolare. Questi aveva raccolto seguaci nelle campagne in-torno alla capitale e, a partire dal 1766, aveva dato voce, con un vee-mente linguaggio veterotestamentario e pronosticando, alla diffusa in-soddisfazione per l’accisa e profetizzando un mutamento radicale nelgoverno: nel 1770, analizzava Biester, si era giunti a «quasi un tumultopubblico» a Biesenthal, non lontano da Berlino. La critica di Biesterera rivolta contro l’inganno nascosto dietro l’attitudine profetica senzanegare l’esistenza del malcontento nella popolazione rurale52. Le pro-teste contro il prelievo dell’accisa da parte della Régie erano troppoforti per passare sotto silenzio. L’anno seguente, nel numero di set-tembre del 1784 Biester pubblicò un saggio prolisso e alquanto invo-luto su due rompicapi che circolavano in Germania dall’inizio del-l’anno, attribuiti – si diceva – anche a Goethe, le cui soluzioni sareb-bero valse premi cospicui rispettivamente di 30 luigi d’oro e 40 du-cati53. Uno dei due enigmi era stato messo in vendita a Berlino atti-
51 H.M. Sieg, Staatsdienst, Staatsdenken und Dienstgesinnung in Brandenburg-Preußen im 18. Jahrhundert (1713-1806), Berlin, de Gruyter, 2003, in particolare perle tensioni interne alla «cultura della sfera pubblica» degli alti funzionari statali, pp.235-6. Nell’ampia postfazione all’edizione degli articoli di Gedicke su Berlino pub-blicati nella «Berlinische Monatsschrift» il curatore Harald Scholtz sostiene che la ri-vista superò i limiti posti di solito al «ragionamento politico» per «attivare presso ilpubblico una critica costruttiva grazie alle favorevoli condizioni locali e il kairos dellasituazione storica». La sua conclusione che «si profila un’opposizione leale» è con-divisibile solo se si accentua la volontà di quest’opposizione di conservare le pre-messe fondamentali del sistema federiciano (Friedrich Gedicke: Über Berlin. Briefe‘von einem Fremden’ in der Berlinischen Monatsschrift 1783-1785. Commento, in-troduzione e cura di H. Scholtz, Berlin, Colloquium, 1987, pp. 162-165).
52 J.E. Biester, Der vorgebliche Neue Messias in Berlin, in «Berlinische Mo-natsschrift», 1, 1, 1783, pp. 46-82, la citazione è a p. 61. Un’accurata descrizione de-gli aspetti giuridici della vicenda nonché delle reazioni sulla stampa è in «Beyträgezu der juristischen Litteratur in den preußischen Staaten», 8, 1785, pp. 218-315.
53 F. Gedike, Ueber eine räthselhafte Räthselgeschichte in unsern Tagen, in «Ber-linische Monatsschrift», 2, 9, 1784, pp. 267-288. Primo indovinello: «Es wird ein Dinggeboren, ist einen Fuß lang, wiegt 12 Cenntner. Wenn es ein halb Jahr alt ist, wirdes gegessen; wenn es 4 Jahr alt ist, beschlägts der Schmidt, wenn es 80 Jahr alt ist,
opinione pubblica e opposizione in prussia sotto federico ii 157
rando un numero enorme di acquirenti allettati dalla possibilità di vin-cere la somma messa in palio. La vicenda era analizzata da Gedikecon una notevole pedanteria, nonché dotti rimandi alle origini classi-che e bibliche dell’enigmistica. Il saggio era in sé trascurabile (e ge-neralmente ignorato nelle ricerche sulla «Berlinische Monatsschrift»)se non fosse per due passaggi di notevole interesse per la ricerca diuna sfera pubblica tra legittimo commento e illegittima critica54. Ilprimo passaggio riguarda il carattere illuminato dell’epoca. Per Ge-dike la fortuna dell’indovinello provava che la dabbenaggine anti-il-luminista nel 1784 era assai diffusa. «Incredibile! Eppure non ci fumai un’epoca, che con tanta sicurezza si attribuisse la preferenza diun’Aufklärung diffusa più universalmente… ma la nostra età ha qual-che notevole somiglianza con l’epoca di barbarie [descritta nella primaparte del saggio] […]. Chi conosce questo spirito della nostra epoca,chi sa sino a quali eccessi incredibilmente ridicoli ma d’altra parte an-che estremamente tristi si lascino trascinare numerosissimi nostri con-temporanei di ogni ceto, anche dei più alti, da superstizione e scem-piaggine, e quale fede profonda nelle smorfie più insensate che si di-rebbe potersi ritrovare solo nelle teste di vecchiette risiedono al giorno
frisst es sich selber. Es krähet wie ein Hahn, [al. maut wie ein Katzel] bellet wie einHund und singt doch herrlich. Es ist alle Tage [al. Sonntage] in der Kirche, lässt sichhereinfahren und heraustragen [al. hereintragen] und hat doch keine Religion. Wennes stirbt, wird es in der Kirche begraben, und stirbt doch keinen andern Tod alsdurch den Scharfrichter [al. unter Henkers Händen)» («Si partorisce una cosa, è lungaun piede, pesa 12 quintali. Quando ha sei mesi, si mangia; quando ha 4 anni, il ma-niscalco lo ferra, quando ha 80 anni, si mangia da solo. Canta come un gallo [op-pure: miagola come un gattino], abbaia come un cane e tuttavia gorgheggia benis-simo. Tutti i giorni è in chiesa [oppure: tutte le domeniche], si fa portare dentro efuori [oppure: trasportare], però non è religioso. Quando muore, lo si seppellisce inchiesa, però muore solo per la spada del boia [oppure: per il nodo scorsoio»]) (pp.274-75). Secondo indovinello: «Ich bin nicht der Schöpfer nicht ein Geschöpf. Ichbin niemals unter den Lebendigen gesehn worden, jedoch befinde ich mich itzt [al.stets] unter den Verstorbenen usw» (p. 278). («Io non sono il creatore né una crea-tura. Nessuno mi ha mai visto tra i viventi, però mi trovo ora [oppure: sempre] trai defunti etc»). Nello stesso numero di settembre era anche pubblicato il primo sag-gio, Ueber die Frage: was heißt aufklären?, scritto da Moses Mendelssohn, in rispo-sta al quesito di Zöllner.
54 Per l’eco presso i contemporanei cfr. J.M. Bechstein, Etwas über den Ursprungder berüchtigten Räthsel: Ich bin weder Geschöpf u.s.w. s. Berl. Monatsschr. Nov. (sic,ma settembre) 1784, S. 267, in «Deutsches Museum», 1, 1786, pp. 151-61 e la men-zione nella lettera in Johann Georg Hamann Briefwechsel, a cura di A. Henkel, Frank-furt/Main, Insel, 1955-1979, V, p. 222 (su Hamann e la sua incompatibilità con gli edi-tori della «Berlinische Monatsschrift» cfr. ora J. Betz, After Enlightenment. Hamannas Post-Secular Visionary, Chichester, Wiley-Blackwell, 2012, pp. 296-97).
edoardo tortarolo158
d’oggi non soltanto nelle menti di uomini di grande rispettabilità, an-che di quelli che si definiscono dotti (Gelehrte), ma viene anche espo-sta pubblicamente in scritti sotto gli occhi di tutti, chi sa tutto que-sto dovrebbe stupirsi a vedere che si ponga un premio ragguardevoleper la soluzione di indovinelli di cattivo gusto e che gran quantità dipersone si rompano la testa per cercare questa soluzione»55. Il riferi-mento all’interesse esagerato per gli indovinelli si apriva quindi a unaconsiderazione sul livello dei lumi in un’epoca nella quale questoenigma aveva avuto l’effetto di un «fulmine». L’analisi delle soluzioniproposte che erano pervenute alla rivista attraverso lettere private pa-reva confermare questo scetticismo. Ma quando analizzava l’ultimasoluzione al secondo enigma, per cui si era sparsa la voce che l’avesseproposto l’Accademia delle Scienze berlinese, Gedike doveva ricor-dare, con qualche imbarazzo, che il re Federico II stesso era indicatocome la soluzione del rompicapo. Utilizzando modalità interpretativederivate dalla consuetudine con il libro di Daniele e l’Apocalisse diGiovanni, e con un riferimento puntuale al capitolo 33 del libro delprofeta Ezechiele sulla giustizia e le responsabilità di chi è vicino alsovrano ed è stato posto a difesa del popolo, l’anonimo enigmista at-tribuiva un ruolo specifico anche alla Régie. Il cane da guardia messoalla catena per proteggere i beni del sovrano rappresentava la Régie.«Poiché tuttavia alla Régie non è stata messa la catena al collo, alloraattacca la gente e l’ammazza, per cui restano per terra tracce di san-gue che si possono lavare solo con il sangue» (Blutschulden)56. Sonoparole riportate da una (presunta) lettera anonima, che non impegnanoGedike né personalmente né in quanto responsabile del periodico. Alcontrario, per evidenziare l’estraneità del gruppo di Aufklärer impe-gnati nella rivista, sono bollate come sciocchezze (Unsinn). Nondi-meno Gedike insisteva sulla necessità di registrare per i suoi lettori lospirito dell’epoca e riconoscere la fragilità dell’Aufklärung. La «Ber-linische Monatsschrift» si offriva come specchio del malessere e, alcontempo, come spazio per rielaborare razionalmente le ragioni, an-che se immature e distorte, dell’opposizione all’esistenza di un’istitu-zione fermamente voluta da Federico II. L’insofferenza generale neiconfronti della Régie si esacerbò alla morte di Federico II (17 agosto1786) e portò alla sua abolizione l’anno successivo57. Non per questo
55 F. Gedike, Ueber eine räthselhafte Räthselgeschichte, cit., p. 273. 56 Ivi, p. 288.57 H. Zschoke, Die Berliner Akzisemauer. Die vorletzte Mauer der Stadt, Ber-
lin, Berlin Story Verlag, 2007, pp. 33-39.
opinione pubblica e opposizione in prussia sotto federico ii 159
si esaurì il dibattito sulla Régie e sui meriti finanziari e politici dei di-versi sistemi di riscossione, cui la «Berlinische Monatsschrift», purobliquamente, aveva offerto un legittimo canale di diffusione. Le vocisia di opposizione sia di sostegno al principio dell’appalto dell’esa-zione mutarono tuttavia tono e contesto. Da elemento di una visioneapocalittica espressa in enigmi e indovinelli la discussione divenne untema della disputa di economia politica tra specialisti58.
3. Kant e l’eventualità dell’opposizione
Come è noto, Kant non aveva tra le mani il numero di settem-bre della «Berlinische Monatsschrift» quando terminò, il 30 settem-bre 1784, la stesura della sua risposta al quesito di Zöllner. Se ne scusòricordando che avrebbe preferito conoscere la reazione di Mendels-sohn prima di inviare alla redazione la propria risposta. Kant non potéquindi leggere la bizzarra storia dell’indovinello che aveva indotto Ge-dike a riportare la violenta critica alla Régie. Né Kant, che non ab-bandonò mai Königsberg, aveva visto le strade di Berlino affollate da-gli acquirenti di letteratura di consumo plebeo o seguito personal-mente, sull’uscio di casa, le petizioni contro il nuovo Gesangbuch vo-lute da Apitsch. Tuttavia, è ragionevole pensare che fosse ben a co-noscenza dell’astio verso la Régie, se non altro attraverso la sua assi-dua consuetudine con gli ambienti commerciali di Königsberg e at-traverso Hamann, che era un dipendente della Régie stessa (feroce-mente critico verso il suo datore di lavoro)59. È – se possibile – an-cor più ovvio che seguisse le vicende politico-amministrative in camporeligioso che facevano capo a von Zedlitz. Sullo sfondo allora di que-sti sviluppi di forme di critica pubblica con toni di opposizione apertaalle misure del governo, sia in campo religioso sia nell’ambito dellapolitica fiscale, si può proporre una lettura ancora più legata al con-testo di quegli anni di quanto sia solito avvenire nel commento al sag-
58 F. Schui, Taxpayer Opposition, cit., pp. 392-99.59 Cfr. ora l’ampia e accurata biografia di M. Kuehn, Kant. A Biography, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 2001. Inoltre cfr. i cenni sulla vita sociale di Kanta Königsberg in J. H. Zammito, Kant, Herder, the Birth of Anthropology, Chicago-London, University of Chicago Press, 2002, pp. 100-23. Su Hamann e il suo diffi-cile rapporto con la Régie cfr. da ultimo R.A. Sparling, Johann Georg Hamann andthe Enlightenment Project, Toronto, University of Toronto Press, 2011, pp. 153-93.Per un quadro complessivo cfr. L. Scuccimarra, Obbedienza, resistenza, ribellione.Kant e il problema dell’ordine politico, Roma, Jouvence, 1998.
edoardo tortarolo160
gio di Kant su Was ist Aufklärung?, del quale ovviamente né l’autorené i lettori contemporanei potevano immaginare l’immensa eco po-stuma60. Attraverso una rilettura dei testi che con diversa ampiezzahanno recentemente dato autorevoli interpretazioni del saggio di Kant,James Schmidt è tornato di recente sulla questione di come si possaleggerlo. Schmidt ha rielaborato e ampliato il suggerimento di Ven-turi del 1969 a non esaurire la lettura da una prospettiva esclusiva-mente filosofica61. In Utopia e riforma Venturi si era limitato ad ana-lizzare la prima parte del saggio di Kant ripercorrendo l’evolversi de-gli usi del motto di Orazio Sapere aude nel Settecento tedesco: Sch-midt intende ampliare il punto sollevato da Venturi ed esaminare inquali modi il saggio di Kant si esprima sulla questione delle restri-zioni che il governo può imporre sulla libera espressione del dissenso.Appoggiandosi su quanto ripetutamente Foucault scrisse commen-tando il saggio di Kant, Schmidt giunge alla conclusione che il sag-gio del 1784 e l’insieme del dibattito sulla domanda Was ist Aufklä-rung? «ci offrono un esempio eccellente di un momento in cui alcunemodalità di pensiero e di azione diventano problematiche, costrin-gendo coloro i quali erano impegnati in queste pratiche a muovereun passo indietro e a riflettere su ciò a cui applicavano le loro ener-gie e su come i loro sforzi per propagare i lumi erano inseriti in uncomplesso ‘dominio di atti, pratiche e pensieri, che […] pongono pro-blemi per la politica’»62.
60 Cfr. le varie edizioni moderne, tra cui spiccano Was ist Aufklärung? Beiträgeaus der Berlinischen Monatsschrift, a cura di N. Hinske, Darmstadt, Wissenschaftli-che Buchgesellschaft, 1973 (41990); What Is Enlightenment?: Eighteenth-Century An-swers and Twentieth-Century Questions, a cura di J. Schmidt, Berkeley, Universityof California Press, 1996; Was ist Aufklärung? Thesen, Definitionen, Dokumente, acura di B. Stollberg-Rilinger, Stuttgart, Reclam, 2011. Un importante e condivisibiletentativo di «riportare il saggio di Kant nel suo contesto originale» è J. Schmidt,The Question of the Enlightenment, cit. (la citazione è a p. 270).
61 J. Schmidt, Misunderstanding the Question: ‘What is Enlightenment?’: Ven-turi, Habermas, and Foucault, in «History of European Ideas», 37, 2011, pp. 43-52.Due interessanti saggi recenti (W. Bartuschat, Kant über Philosophie und Aufklä-rung e L. Kreimendahl, Kants vorkritisches Programm der Aufklärung, in Kant unddie Zukunft der europäischen Aufklärung, a cura di H. F. Klemme, Berlin, de Gruy-ter, 2009, pp. 122-142) contestualizzano la nozione di Aufklärung strettamente al-l’interno della riflessione di Kant, isolandola dalla discussione contemporanea.
62 Schmidt, Misunderstanding, cit., p. 52. Cfr. M. Foucault, Le gouvernementde soi et des autres. Cours au Collège de France (1982-1983). Édition établie sous ladirection de F. Ewald et A. Fontana, par F. Gros, Paris, Gallimard, 2008, pp. 5-39.In Italia è invalsa la tradizione di tradurre, credo erroneamente, la domanda comeChe cosa è l’illuminismo?, suggerendo che oggetto della discussione sia un fenomeno
opinione pubblica e opposizione in prussia sotto federico ii 161
Se si rilegge il saggio kantiano tenendo presenti i motivi di dis-senso molto concreti che attraversavano la società prussiana nei suoirapporti con il governo assoluto di Federico II, diventa possibile co-gliere più concretamente a che cosa si riferisse Kant. In particolare sipuò giustificare una lettura nella quale le affermazioni generali e ap-parentemente svincolate da riferimenti puntuali sono lette come ne-gazione di comportamenti specifici e opinioni accreditate dalla tradi-zione nel corso del tempo. Se è forse eccessivo parlare semplicementedi vocabolario sovversivo per Kant, come per tutti membri dell’eliteprussiana negli anni ottanta, si deve tuttavia rilevare che il saggio del1784 registra i motivi di forte tensione e li interpreta come indizi diuno sviluppo verso il superamento del governo assoluto, pur in tempinon brevi63. Il rovesciamento terminologico che ha sorpreso gli inter-preti diventa più comprensibile. L’uso pubblico della ragione non puòche prevalere su quello privato dei singoli uomini che lavorano perlo Stato: il loro uso privato della ragione è dettato dal rispetto perl’impegno all’obbedienza nei confronti dell’autorità e ha senso comeimpegno a mettersi al servizio della comunità. Gli avvenimenti a ca-vallo tra gli anni settanta e ottanta avevano però mostrato che la cri-tica pubblica aveva conseguenze nell’ambito che Kant definiva pri-vato, quello nel quale «è lecito frequentemente porre limiti moltostretti, senza per questo ostacolare particolarmente il progredire deilumi»64. L’esempio addotto da Kant non poteva essere casuale: quandosi tratta di prestare il proprio contributo fiscale il cittadino non puòrifiutarsi di versare la parte decisa dal sovrano (anche se il carico com-plessivo può essere stato ripartito senza equità). Ma il cittadino con-serva il diritto di «esprimere pubblicamente i suoi pensieri» contro l’i-nopportunità (Unschicklichkeit) o anche l’ingiustizia delle imposizioni,
storico specifico, anziché un problema universale reso evidente e attuale (e natural-mente anche problematico) dallo stato e dalla società prussiana sotto Federico II (cfr.da ultimo Che cos’è l’illuminismo?: i testi e la genealogia del concetto. Introduzionee cura di A. Tagliapietra; traduzioni di S. Manzoni ed E. Tetamo, Milano, BrunoMondadori, 2000).
63 Il riferimento al Kant sovversivo viene dal saggio importante di C. Laursen,The Subversive Kant: The Vocabulary of Public ad Publicity, in «Political Theory»,14, 4, 1986, pp. 584-603. La tesi che Kant considerasse la monarchia assoluta una fasetransitoria verso l’autogoverno democratico è stata ripresa recentemente, senza rife-rimento alla discussione prussiana degli anni ottanta, da R.S. Taylor, DemocraticTransitions and the Progress of Absolutism in Kant’s Political Thought, in «The Jour-nal of Politics», 68, 3, 2006, pp. 556-570.
64 I. Kant, Was ist Aufklärung?, in «Berlinische Monatsschrift», 2, 12, 1784, pp.481-494, citazione a p. 485.
edoardo tortarolo162
purché non siano espressi in modo impertinente e scandaloso65. Il ri-ferimento alle polemiche contro la Régie e contro la sua avidità eratrasparente e non poteva sfuggire ai lettori contemporanei, risentititanto per il peso dell’esazione dell’accisa quanto per le sue modalitàumilianti. E dichiarare il diritto a contestarla era indicato come nonsoltanto una creazione di legittimità ma anche un contributo al pro-gresso che si sarebbe realizzato pure nella pratica di governo. L’at-tenzione di Kant per la libera discussione religiosa è stata variamentespiegata, non da ultimo con la convinzione che la religione fosse piùdi altri temi al riparo dall’intervento della censura. In realtà, la di-scussione sul diritto dei religiosi di partecipare alla discussione inquanto dotti rimandava direttamente allo scontro tra teologi neologie teologi tradizionalisti, di cui una tappa era stata la campagna distampa e di petizioni pro o contro il Gesangbuch. La descrizione dicome si raccoglie la maggioranza dei voti (Stimmen) da portare da-vanti al trono per permettere alle comunità degli innovatori religiosidi godere della protezione delle leggi rispecchiava la dinamica internaalla chiesa luterana intorno al 1780 così come questa si era effettiva-mente svolta. Nell’ambito fiscale e nell’ambito della convinzione reli-giosa la sfera pubblica animata dai dotti in quanto cittadini garantivasul lungo periodo che il germoglio del pensare in libertà si svilup-passe e generasse nel popolo la capacità di agire in indipendenza in-tellettuale e infine trasformasse i fondamenti del governo. Nel 1784la realtà cui si riferiva Kant era quindi diversa dalla stilizzazione diHabermas: piuttosto un formicolare di proteste, discussioni, malevo-lenze, insofferenze, irritazioni, ansie apocalittiche, espresse a voce eper iscritto, che la sfera pubblica colta dei professori, dei funzionarie dei teologi razionalisti osservava e filtrava, talvolta recepiva, divisacom’era tra il compiacimento per se stessi e per la propria superio-rità intellettuale e morale e lo sconcerto e la sorpresa per il ritardoaltrui sulla strada del progresso. Palesemente Kant era consapevoledella contraddittorietà della realtà prussiana e la registrava con un’i-ronia che si dovrebbe più frequentemente cogliere e sottolineare. Sa-peva d’altronde di rivolgersi a un pubblico da cui si attendeva rea-
65 I. Kant, Was ist Aufklärung?, cit., p. 486. Nel 1793 Kant tornò sull’argo-mento, nel saggio ugualmente pubblicato nella «Berlinische Monatsschrift» di set-tembre, intitolato Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugtaber nicht für die Praxis, confermando che l’ingiustizia e l’ingiustizia nella distribu-zione del carico fiscale autorizzavano pienamente «quanto meno» («wenigstens») areclamare per iscritto un’equa ripartizione (pp. 201-84, citazione p. 251).
opinione pubblica e opposizione in prussia sotto federico ii 163
zioni anche critiche66. Solo come espressione di un’ironia che cercavala complicità dei lettori si può infatti interpretare l’annotazione sor-prendente che sulla sfera pubblica vigila l’esercito. Di per sé garanziaparadossale della libertà di discussione, quell’esercito era inoltre defi-nito da Kant «ben disciplinato e numeroso», mantenuto dal sovranoilluminato a disposizione per tutelare la tranquillità pubblica67. Kante i suoi lettori sapevano bene che, per un lungo periodo dopo la con-clusione della guerra dei sette anni, nel 1763, l’esercito prussiano nonaveva avuto occasioni per mostrare il proprio valore e la propria ef-ficienza sul campo di battaglia. Lo scontro diplomatico-militare congli Asburgo nel 1778-1779 fu tanto poco una prova della disciplinaprussiana in battaglia da meritare a Berlino la definizione derisoria di‘guerra delle patate’. Kant e i suoi lettori sapevano altrettanto bene,però, che il mantenimento di un esercito di quelle dimensioni costi-tuiva una causa della pressione fiscale che la popolazione era sempremeno disposta a tollerare. Quanto allo spirito marziale nell’esercitoprussiano, ricordato enfaticamente da Kant, si può rimandare, nellastessa «Berlinische Monatsschrift» del 1784, all’articolo scritto dal ge-nerale Moritz Adolf von Winterfeld sull’alto tasso di diserzione e suldisperante livello di inaffidabilità dei soldati, al limite del degradoumano68, per far nascere il sospetto che Kant invitasse in realtà a leg-gere anche tra le righe, a fare uso della ragione in primo luogo nella
66 Lettera di Kant a Johann Erich Biester, 31 dicembre 1784, Briefwechsel, Aka-demie-Ausgabe, Berlin, Reimer, 1900, X, p. 397, lettera 236, in cui esprimeva, conspirito pragmatico, anche il desiderio di «sapere quali questioni il pubblico vorrebbemaggiormente vedere risolte».
67 Il ruolo dell’esercito prussiano nel garantire il processo di Aufklärung fu di-scusso da Hamann nella sua ben nota lettera a Christian Jacob Kraus del 18 dicem-bre 1784, scritta subito dopo avere ricevuto il numero della «Berlinische Monats -schrift». Senza entrare nell’analisi del testo di Hamann, si ricorda qui solo che anchea lui la menzione dell’esercito pareva inspiegabile (J.G. Hamann, Briefwechsel, a curadi A. Henkel, Frankfurt/Main, Insel, 1965, V, pp. 264-65). Un’attenta analisi è in G.Green, Modern Culture Comes of Age: Hamann versus Kant on the Root Metaphorof Enlightenment, in What is Enlightenment, cit, pp. 291-305, cui si può aggiungerequella alquanto idiosincratica di I. Berlin, The Magus of the North. J. G. Hamannand the Origins of Modern Irrationalism, New York, Farrar, Straus & Giroux, 1993,pp. 107-109. Per due opposte interpretazioni delle violente accuse di Hamann a Kantcfr. O. Bayer, Zeitgenosse im Widerspruch. Johann Georg Hamann als radikalerAufklärer, München, Piper, 1988, pp. 138-140 e Henry Allison, Kant’s Conceptionof Aufklärung, in Id., Essays on Kant, Oxford, Oxford University Press, 2012, pp.230-2 in particolare.
68 M.A. von Winterfeld, Einige Vorschläge zur Verhütung der Desertion beiden Soldaten, in «Berlinische Monatsschrift», 2, 9, 1784, pp. 256-66.
edoardo tortarolo164
lettura del suo stesso saggio, a non aspettare per «uscire dalla mino-rità intellettuale» di cui si è responsabili69. La vita nelle strade, neicaffè, nelle caserme, nelle case private metteva a dura prova i limitidella parrhesia dell’Aufklärung: offriva e talvolta imponeva tuttavia itemi da affrontare nell’opinione pubblica creata dai libri e dalle rivi-ste, per quanto con la cautela opportuna in una monarchia assoluti-sta70.
69 Sul tema complesso della responsabilità individuale per decidere o meno diuscire dalla minorità intellettuale cfr. J. N. Schneewind, Toward Enlightenment: Kantand the Sources of Darkness, in The Cambridge Companion to Early Modern Phi-losophy, a cura di D. Rutherford, Cambridge, Cambridge University, 2006, pp. 328-352, in particolare pp. 338-39.
70 I. Kant, Was ist Aufklärung?, cit., p. 493.
opinione pubblica e opposizione in prussia sotto federico ii 165