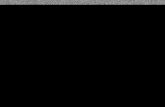Reti e transnazionalismo: riflessioni sugli immigrati mauriziani ed albanesi occupati nel mercato...
Transcript of Reti e transnazionalismo: riflessioni sugli immigrati mauriziani ed albanesi occupati nel mercato...
Reti e transnazionalismo: riflessioni sugliimmigrati mauriziani ed albanesi occupati nelmercato del lavoro domestico1
di Lidia Greco e Daniele PetrosinoFacoltà di Scienze Politiche, Università di Bari
1. Introduzione
Il lavoro domestico costituisce tradizionalmenteuna delle nicchie occupazionali più disponibili adaccogliere lavoratori migranti, per ragioni note:bassa qualificazione, scarsa disponibilità dellapopolazione nativa a parità di condizioni dilavoro, possibilità di evadere controlli dilegalità. A ciò si aggiunge quantomeno nel casoitaliano la cronica mancanza di welfare nelsupporto del lavoro di cura delle famiglie, edunque, come altri saggi del presente volume hannoevidenziato, vi è anche una specifica richiesta chenasce all’interno delle famiglie italiane.
È altrettanto noto come vi sia un senso comuneche interpreta il lavoro domestico in modo da«legittimare» la condizione fortemente nonegualitaria che esso contiene. Il lavoro domesticoviene considerato il più adatto agli immigratiperché sono scarsamente qualificati, anzi siritiene che essi prediligano il lavoro domesticoverso il quale sono più portati, o si ritiene chealcuni gruppi nazionali siano più adatti di altri.Tutto ciò contiene alcuni granelli di verità cheservono a rendere credibile questo racconto, ma larealtà è molto più varia e frammentata: il lavorodomestico è il prodotto di un intreccio di scelteindividuali e vincoli costituiti da percorsi, reti,
1 Il saggio è frutto del lavoro congiunto dei dueautori che ne condividono integralmente laresponsabilità, in ogni caso i paragrafi sono daattribuirsi a L.Greco ed i paragrafi a D. Petrosino, irestanti sono di entrambi gi autori.
1
incontri, in cui l’elemento forse più evidente ècostituito dalle opportunità disponibili e dallestrategie messe in atto dalle/dai migranti.
Per analizzare tali strategie, le opportunità edi vincoli che le condizionano ed orientano abbiamoscelto di confrontare i percorsi e le sceltemigratorie di due gruppi che almeno dai datipreliminari appaiono fortemente differenziati traloro: mauriziani ed albanesi.
In primo luogo cercheremo di collocare ipercorsi migratori di coloro che abbiamointervistato nel contesto dei due paesi diprovenienza e dello stesso movimento migratorioverso l’Italia.
In secondo luogo assumeremo due prospettive dianalisi dei movimenti migratori per controllarequanto riescano a spiegare delle scelte o deipercorsi dei nostri intervistati. Gli approccianalitici contemporanei alle dinamiche migratorietendono, infatti, a collocare tali dinamiche incontesti relazionali che ne definiscono le caratte-ristiche: esse vengono sempre meno considerate comel’esclusivo frutto di scelte individuali, perdivenire la risultante di processi interazionalicomplessi. Tale incastronamento del processomigratorio in un complesso di relazioni è al centrodi approcci quali quello della network analysis e dellecatene migratorie. Inoltre la network analysis hatrovato una declinazione specifica nellautilizzazione del concetto di transnazionalismo,che, si vuole, segni la peculiarità dellemigrazioni contemporanee. Come sappiamo, però, ilfenomeno migratorio è estremamente variegato ed inesso si incontrano molte diverse dimensioni: ilpaese di provenienza, il sistema di relazioni delmigrante, il paese e le località di arrivo, ilmomento e la durata del processo migratorio. Tuttiquesti elementi contribuiscono a rendere spessomolto diverse tra loro le esperienze migratorie,già assolutamente peculiari in ragione dellesoggettività che le esprimono. Il nostro scopo èquello di contemperare tali diversità con le
2
possibilità di generalizzazione di approccianalitici che hanno mostrato una buona capacità didescrizione e spiegazione dei fenomeni. Inparticolar modo cercheremo di capire se nelleevidenze che emergono dai percorsi migratori dilavoratori domestici appartenenti a due nazionalitàdiverse un approccio del tutto relazionale siaefficace o vada contemperato con altre prospettive,e se la prospettiva transnazionale pervada ognimanifestazione del fenomeno migratorio o vadaconsiderata con maggiore prudenza.
Il confronto tra due gruppi molto diversi l’unodall’altro, e che appaiono accomunati, nel caso diquesta indagine, dalla sola attività lavorativadovrebbe consentirci di verificare:
– se vi siano profili che ci consentano diparlare di gruppi e non solo di individuidistinti;
– ove sia possibile parlare di gruppi, che essimanifestino comportamenti molto diversi inrelazione alle condizioni che licaratterizzano. In particolare pensiamo cipossa essere un’influenza della dimensionegeospaziale sulla formazione di spazitransnazionali e un’influenza delladimensione del fenomeno sulla formazione,sulla forza e sulla cogenza delle reti;
– se tutto ciò abbia un riflesso sulla presenzaall’interno del segmento del mercatooccupazionale costituito dal lavorodomestico.
2. Albanesi e Mauriziani in Italia
2.1. Cenni storici
L’emigrazione mauriziana inizia con ladecolonizzazione e il tramonto di un sogno dirapido sviluppo. La Francia, il Regno Unito,l’Australia e gli Stati Uniti sono i Paesi verso i
3
quali si è diretta grossa parte di questa emi-grazione. L’Italia occupa una posizione intermedia,il cui rilievo è cresciuto negli ultimi anni.L’emigrazione mauriziana verso il nostro paese haavuto inizio alla fine degli anni settanta-primianni ottanta ed è da legare alla maggioredifficoltà di ingresso nei Paesi di più vecchiaimmigrazione. Per quanto diffusa su tutto ilterritorio nazionale, come vedremo, l’emigrazionemauriziana si concentra essenzialmente in quattroprovince ed in special modo nei capoluoghi di Bari,Catania, Milano e Palermo. È un’immigrazione che siè concentrata soprattutto nei servizi domestici,senza avere, però, una caratterizzazioneesclusivamente femminile. Nella prima fase si ètrattato di una immigrazione coresidente (Scidà1993), modalità che caratterizza frequentemente ilprimo periodo delle immigrazioni legate al lavorodomestico. Nei periodi successivi vi è stato ungraduale distacco da questa modalità di relazionecon i datori di lavoro, come è anche testimoniatodalle nostre interviste.
La presenza albanese in Italia ha radicistoriche consolidate. Nel Mezzogiorno, inparticolare, le prime, più numerose, enclavesrisalgono agli ultimi decenni del XV secolo esaranno alimentate nel corso dei secolidall’occupazione ottomana dell’Albania.2 Si ritieneche nel Sud Italia, durante questo periodo, sistanziarono circa 100.000 albanesi, creando un cen-tinaio di insediamenti di popolazione arbëresh(Barjaba et al. 1992), anche se le più consistentiondate migratorie si diressero verso la confinanteGrecia.
La storia contemporanea dell’immigrazionealbanese in Italia ha invece inizio a partire daglianni novanta, con la fine del regime comunista cheaveva tenuto sigillato il Paese per cinquant’anni.
2 Giorgio Castriota Scanderberg, eroe nazionale albanese,arrivò nella regione per soccorrere il re di Napoli FerdinandoI contro il duca D’Angiò nel 1458.
4
Devole (2006) ne distingue cinque fasi, che sonosottese da motivazioni diverse.
La prima si riferisce alla cosiddetta ‘crisidelle ambasciate’ quando, nel 1990, migliaia dialbanesi entrarono in alcune rappresentanzediplomatiche occidentali, chiedendo asilo politico.Le motivazioni che li spingevano a lasciare ilPaese erano di natura politica e cioè la reazioneverso il regime comunista di Ramiz Alia.
La seconda fase coincide con i due grandi esodidi massa verso le coste italiane: l’ondata accoltae l’ondata respinta, come sintetizzano Pittau eReggio (1992). Il primo esodo è del marzo 1991:circa 25.000 albanesi lasciarono i porti del loroPaese per arrivare sulle coste pugliesi. Il secondoesodo si verificò nell’agosto dello stesso annoquando a Bari arrivarono altri 20.000 albanesi che,‘sistemati’ temporaneamente nel famoso stadio dellaVittoria, furono poi in larga parte rimpatriati. Ilcontesto dei due esodi ed il loro esito era deltutto diverso. L’esodo di primavera ebbe luogo pocoprima delle prime elezioni pluralistiche. In quellacircostanza, l’Italia lavorò per l’accoglienza.3
L’esodo estivo avvenne invece qualche tempo dopo leelezioni. Il successivo rimpatrio fu motivato dalfatto che l’Albania aveva avviato un percorso didemocratizzazione.
La terza fase migratoria ha luogo nella secondametà degli anni novanta e coincide con gli annidella confusa transizione post-comunista, in cuiflussi migratori regolari si confondono con arriviillegali. In questa fase il Paese è scosso da unagrave crisi sociale ed economica che alla povertàereditata aggiunge disoccupazione e corruzionedilaganti.
La quarta fase migratoria coincide con il crollodelle cosiddette ‘società piramidali’, societàfinanziarie in cui molti albanesi avevano investito
3 Non rientrando nelle previsioni della leggeMartelli, furono infatti predisposti permessi disoggiorno provvisori che autorizzarono anchel’iscrizione alle liste di collocamento.
5
i loro risparmi nonché buona parte delle rimessedall’estero. Siamo nel 1997 e l’Albania è sull’orlodella guerra civile. Si emigra da un Paeseestremamente insicuro ed in preda a caos, conistituzioni statali inesistenti e un’economiacompromessa nonostante che gli anni precedentifossero stati anni di espansione economica.
Nella fase attuale l’immigrazione si èstabilizzata: gli ingressi in Italia sonoprevalentemente legali, anche se è innegabilel’esistenza di una componente illegale legatasoprattutto allo sfruttamento della prostituzioneed al traffico di armi.
Se quindi i primi movimenti migratori hannoavuto una connotazione prevalentemente politica, leemigrazioni successive sono state causate anche damotivazioni di natura economica.
2.2. Aspetti quantitativi
Al 1 gennaio 2006 gli stranieri residenti inItalia sono più di 2.600.000 con un incrementorispetto all’anno precedente dell’11,2% (Istat,2006). La popolazione straniera nel nostro Paese èconcentrata prevalentemente nel centro-nord (88%),mentre solo il 12% del totale è presente nel Mezzo-giorno.
Nella graduatoria delle cittadinanze piùpresenti in Italia, la comunità albanese sipresenta come la più numerosa (poco meno di 349.000unità), seguita da quella marocchina e da quellarumena. Rispetto al 2003, la presenza albanese inItalia è aumenta del 61%, anche se non si trattadell’incremento più consistente (tab. 1).
6
A scala nazionale, gli albanesi costituisconoil 13% degli stranieri residenti nel nostro Paese.Essi sono presenti in modo significativo in tuttele regioni italiane, anche se con maggioriintensità in alcune di esse.4 In un recente studio,Paterno et al. (2006) suggeriscono comel’immigrazione albanese si conformi ad un modelloclassico di immigrazione. Emigrano prima gli uominiin età produttiva (soprattutto della classe tra 15e 19 anni) e poi le donne ed i bambini. Ladiminuzione dello squilibrio tra i sessi (la compo-nente femminile passa dal 16% circa agli inizidegli anni novanta a più del 40% di questi ultimianni) conferma il processo di progressivastabilizzazione del processo migratorio, favoritodalle sanatorie e dai provvedimenti legislativi chehanno permesso il ricongiungimento familiare.
Diverso è il caso della comunità mauriziana(cfr. Brandimarte e Petrosino 2004, Scidà 1993,Viola 1995). Con poco più di 9.000 unità a scalanazionale, essa costituisce la quarantesimanazionalità per consistenza: in termini percentualisi tratta dello 0,3% del totale stranieri. Le donnesono più della metà (54%) (tab. 2).
La maggior parte dei mauriziani del nostro Paeserisiede nel Mezzogiorno (poco meno di 5.000),rappresentando quindi il 53% del totale. Speci-ficamente, è l’Italia insulare ad accoglierne quasiil 40%. Rispetto al 2002, il numero dei
4 Gli albanesi costituiscono il 39% degli stranieriresidenti in Puglia e più del 20% di quelli insediati inBasilicata, Abruzzo, Toscana e Umbria (Istat, 2006)..
7
Tab. 1 Popolazione straniera residente in Italia nel 2006 (prime 10cittadinanze) e variazione 2003-2006
2006 v.a. Var. 2003-2006%
Albania 348.813 61,1Marocco 319.537 48,3Romania 297.570 213,1Cina 127.822 83,6Ucraina 107.118 741,5Filippine 89.668 38,1Tunisia 83.564 40,4Serbia
Monten.64.070 15,0
Macedonia 63.245 46,2Ecuador 61.953 305,5Totale Italia 2.670.514 72,4
Fonte: Istat
mauriziani in Italia è aumentato del 18,3%;tuttavia, il loro peso sul totale deglistranieri si è ridotto passando dallo 0,5% allo0,3%. Come spiega la Caritas (2006),l’incidenza degli africani provenientidall’Africa orientale è limitata rispetto a
quella degli africani dei paesi settentrionalidel continente. Inoltre, più in generale,l’incidenza dei cittadini africani nei flussimigratori è diminuita in favore dei cittadinieuropei non comunitari e ciò a seguito dellepolitiche restrittive poste in esserenell’ultimo decennio.
Nel periodo considerato, inoltre, lapercentuale dei residenti nel Sud Italia èleggermente aumentata, passando dal 72% al76,4%.
Come anticipato, la specificità dell’emigrazionemauriziana in Italia consiste nella suaconcentrazione spaziale. Al contrario degli
8
Tab. 2 Gli immigrati mauriziani residenti in Italia, (valori assoluti) 31dicembre 2006
M F TotaleItalia 4251 4960 9211Mezzogiorno 2233 2640 4873di cui
Isole1677 2045 3722
Fonte: Elaborazione su dati Istat- demo
Tab. 3 Gli immigrati mauriziani residenti in Italia al 31 dicembre 2006(distribuzione nelle province)
M F Totale N.Catani
a25,8 27,5 26,7 2461
Milano 22,3 21,0 21,6 1990Bari 11,9 11,6 11,7 1081Palerm
o12,2 10,6 11,3 1044
Altre 27,7 29,4 28,6 2635Totale 100,0 100,0 100,0 9211
albanesi, per cui prevale la dispersione spaziale,i mauriziani sono presenti principalmente inquattro province: le presenze a Bari, Catania,Milano e Palermo costituiscono circa il 74% deltotale (tab.3).
Per quanto riguarda i capoluoghi di provincia, aBari i mauriziani sono al secondo posto nella graduatoria percittadinanza, dopo gli albanesi e prima dei cinesi(tab. 4a). A Catania invece i mauriziani sono laprima comunità, seguiti dai cittadini dello SriLanka e della Cina (tab. 4b). Sotto il profilodemografico vi è una composizione abbastanzaequilibrata tra i sessi e, per quanto non vi sianodati di insieme, dalle ricerche disponibilisappiamo che il mercato occupazionale si concentraprevalentemente nelle attività di servizio ed inparticolar modo nella collaborazione domestica. Inquesto non si riscontra una particolaredifferenziazione di genere. Sebbene non vi sianoevidenze documentabili la situazione dei Mauriziania Milano è leggermente diversa: qui gli immigratimaschi sarebbero riusciti ad uscire dalla nicchiadel lavoro domestico; secondo quanto indicato daAvola e Giorlando (2004), anche a Catania una partedi immigrati maschi avrebbe trovato lavoro nelsegmento del servizio non domestico, anche se inuna situazione di maggiore precarietà rispetto aquella costituita dal lavoro domestico.
9
2.3. Le condizioni nei paesi di provenienza
Le Isole Mauritius, collocate nell’OceanoIndiano e facenti parte del continente africano,sono scarsamente popolate e sono diventateindipendenti nel 1968.
Hanno un passato coloniale sia britannico chefrancese: in particolare, quest’ultimo pur essendostato sostituito repentinamente da quellobritannico ha lasciato un’importante impronta nellalingua e nei costumi. Le isole sono state popolateattraverso flussi migratori che hanno portato ad
10
Tab. 4aGli immigrati residenti nel comune di Bari al 31 dicembre 2006(prime 10 nazionalità)
M F Totale
N.
Albania 23,6 24,6 24,1 1304Mauritius 16,2 17,5 16,8 911Cina 7,6 6,4 7,0 381Eritrea 7,0 3,7 5,4 292Banglades
h6,2 1,1 3,8 204
Filippine 2,4 4,9 3,6 195Etiopia 2,7 4,2 3,4 184Grecia 3,9 1,6 2,8 150Marocco 2,9 1,4 2,2 120Romania 1,2 3,2 2,2 117Totale 100,0 100,0 100,0 5413
Fonte: Elaborazione su dati Istat- demo
Tab. 4bGli immigrati residenti nel comune di Catania al 31 dicembre 2006(prime 10 nazionalità)
M F Totale
N.
Mauritius 27,6 31,7 29,8 1774Sri Lanka 23,3 15,4 19,1 1141Cina 8,8 8,0 8,4 499Tunisia 4,5 2,9 3,7 218Banglades
h4,6 0,8 2,6 156
Senegal 4,2 0,8 2,4 144Marocco 3,5 1,1 2,2 133Filippine 2,1 2,2 2,2 130Polonia 1,0 3,1 2,1 125
una significativa pluralità sia etnica chereligiosa. I principali gruppi presenti sono in-diani, cinesi e creoli, e vi è un diffusopluralismo religioso (le principali confessionipresenti sono induismo, islamismo, cristianesimo ebuddismo) (per un’analisi approfondita dei rapportitra i diversi gruppi vedi Arno e Orian 1986,Eriksen 1998, Wake e Caroll 2000). Rispetto adaltri pvs, le Mauritius mostrano un economiaabbastanza equilibrata ed indicatori di sviluppoabbastanza rassicuranti (tab. 5): la popolazionenon è poverissima e non vive condizioni diparticolare disagio. Non vi sono guerre interne, nésituazioni di pericolo sia legate alla violenza siaalle condizioni generali di vita (cfr. Bowman 1991,Dommen 1999).
11
Tab. 5 Principali indicatori della Repubblica delle MauritiusUnità 2000 2002 2004 2006
Popolazione Totale
No.('000)
1,186.9
1,210.2
1,233.4
1,252.7
Aspettativa di vita
- Maschi
No. dianni
68.2 68.6 68.9 69.0
-Femmine
No. dianni
75.3 75.3 75.6 75.7
Tasso didipendenza
Per 1000Popn
470.4
467.7
457.1
440.3
Tasso difertilità
totale
Nasciteper donna
1.99 1.94 1.87 1.7
Spesapubblica
peristruzione
comepercentuale del PIL
% 3.3 3.7 3.6 3.4
Tasso didisoccupaz
ione
% 6.7 7.3 8.5 9.1
Tuttavia, il modello di sviluppo seguito hamantenuto la popolazione a livelli redditualirelativamente bassi. La popolazione ufficialmenteemigrata non risulta particolarmente elevata (tab.6). Purtroppo i dati disponibili presso l’ufficiodi statistica delle Mauritius si fermano al 1994 enon vi sono altre fonti che stimino l’emigrazionecomplessiva. Peraltro, poiché gli emigrati partonousualmente con visto turistico, i dati sottostimanoil fenomeno.
Il fenomeno migratorio si configura come unfenomeno strettamente economico legato per lo piùalla ricerca di una maggiore possibilità di guadagno e mobilità sociale da parte di individui,non necessariamente senza lavoro, che voglionoaccelerare il processo di accumulazione di risorse.Esso si presenterebbe quindi come un caso quasiparadigmatico di scelta razionale. Tale modelloseppure mostri una consistente validità nel caso inquestione deve essere temperato, anche in unasituazione quasi idealtipica, da un incastronamentodentro le relazioni sociali che i migranti hanno,senza le quali le loro scelte non sono spiegabili.Scelta razionale e rete/catena migratoria non sononecessariamente approcci alternativi, ed anzi incasi come questo possono essere validamenteintegrati.
L’Albania diventa uno Stato sovrano autonomo nel1912 dopo secoli di occupazione ottomana. Neidecenni successivi, tuttavia, il Paese rimane in
12
Tab. 6 Emigrati per anno dalla Repubblica delle MauritiusAnno Emigrati1968 30871974 14941980 3081986 20141994 1900
Fonte: Housing And Population Census Analysis Report,vol. IV, 2000 - Population distribution and migration,tab. 3.2
preda a spinte politiche contraddittorie. Occupatadagli italiani durante la seconda guerra mondiale,viene liberata dai partigiani comunisti guidati daEnver Hoxha. Questi proclamerà la Repubblicapopolare socialista di Albania e governerà il Paeseautarchicamente fino al 1985, anno della sua morte.Successivamente la guida del paese passa a RamizAlia che apre la multipartitismo e ad elezionilibere, le prime delle quali si terranno nel 1991.Con la fine del regime comunista (1944-1990) maanche con l’intervento di organizzazioniinternazionali, viene avviata la transizione delpaese verso l’economia di mercato. Fasi diinstabilità e difficoltà economico-finanziarie, cheportano all’intensificazione della pressionemigratoria, si alternano a fasi di relativatranquillità e di crescita economica.
Come spiegano Proto e Rotta (2006), il processodi transizione rimane ad oggi ancora in concluso.Come per le Mauritius, anche per l’Albania sonoriportati alcuni indicatori socio-economici (veditab.7).
13
Tab. 7 Principali indicatori della Repubblica d’Albania Unità 2000 2002 2004 2006
Popolazione Totale
No.('000)
3.063.3
3.102.8
3.135.0
3.150.0
Aspettativa di vita
- Maschi
No. dianni
70 n.d. 71 73
- Femmine
No. dianni
76 n.d. 77 78
Tasso difertilità
totale
Nascite perdonna
2,1 2.1 2,2 2,2
Spesapubblica
peristruzione
comepercentuale del PIL
% 3,3 3 3 3
Tasso didisoccupaz
ione
% 16,8 15,8 14,4 13,9
3. Le interviste agli immigrati albanesi e mauriziani: lecaratteristiche socio-demografiche.
Gli immigrati di nazionalità albanese coinvoltinella ricerca rappresentano il 6,3% del totaledegli intervistati (37 su 589). Più della metà(quasi il 57%) risiede nel Sud Italia, mentre ilrestante 43% vive nelle regioni centrosettentrionali.
Gli intervistati sono nella quasi totalità deicasi donne, con un’età media di circa 42 anni.Circa i tre quarti delle intervistate sonoconiugate (con quasi due figli in media); leseparate/vedove sono il 16%, mentre le nubili sonomeno dell’11%. Il livello di istruzione è medio-alto: quasi il 60% delle intervistate è in possessodi un diploma di scuola superiore, mentre circa unquarto ha conseguito una laurea o un dottorato.Essendo la ricerca centrata sul lavoro domestico, èovvio rilevare che più dei tre quarti delleintervistate lavora in Italia o come badante (35%)o come colf (43%).
I dati raccolti permettono di individuare,seppure sommariamente, le traiettorie lavorativedelle intervistate. Se si considera la lorosituazione occupazionale nel Paese di origine, siosserva come per molte di loro (il 27%)l’emigrazione ha implicato l’entrata nel mercatodel lavoro o perché in precedenza erano disoccupateo perché impegnate in un percorso formativo. Peruna percentuale maggiore, tuttavia, il percorsomigratorio ha significato un restringimento delleopportunità lavorative ed un appiattimento delleesperienze professionali: circa il 30% delleintervistate svolgeva infatti un’occupazione moltoqualificata (professioni intellettuali, tecniche edirigenziali). Il 13,5% svolgeva un lavoro alledipendenze ed una quota lavorava come operaia(quasi l’11%).
Ancor più interessante è osservare i dati sullaprofessione dei genitori. Per quanto riguarda laprofessione del padre, si nota una polarizzazione
14
tra professioni intellettuali (32,4%) e professionioperaie (35%), seguite da una stessa quota diimpiegati e di militari (quasi l’11%). Per quantoriguarda la professione della madre, emerge unaquota abbastanza rilevante di casalinghe (35%) e dioperaie (27%), seguite da professionistequalificate (16,2%).
Al momento dell’arrivo in Italia, leintervistate albanesi avevano in media quasi 33anni. Nella maggior parte dei casi, si è trattatodi un ingresso illegale (54,1%) nel nostro Paese.Il 38% delle intervistate è entrata con un vistoturistico, mentre poco più del 35% è entrata senzaalcun documento. Un altro strumento, sebbene pocoutilizzato, è stato il ricongiungimento familiare(13,5%).
Le interviste raccolte tra gli immigratimauriziani sono meno del 4% del totale (22 su 589),distribuite tra le province di Bari Catania ePalermo. Vi sono 13 intervistate donne e 9intervistati maschi. 4 intervistati sono nu-bili/celibi, tutti gli altri sono coniugati. L’etàmedia è di circa 38 anni. I mauriziani intervistatipresentano un grado di istruzione abbastanzaelevato, ma non di livello universitario (ciòrispecchia la situazione generale dell’istruzionenel paese di provenienza). Solo 4 intervistati nonlavoravano nel paese di origine, mentre la grandemaggioranza svolgeva attività manuali di bassaqualificazione (operai, commessi). Non vi è lapresenza di lavoratori qualificati, se si eccettuaun rappresentante ed un ragioniere. I genitoririsultano prevalentemente occupati in attivitàmanuali (i padri) e come casalinghe (le madri).
Se oggi la quasi totalità dei mauriziani lavoracome collaboratrice/collaboratore domestico,soltanto uno degli intervistati ha svolto nel paesed’origine un’attività in qualche modo prossima allavoro domestico (il/la cameriere/a). Ciò riflettela scarsissima diffusione in quel paese di taleoccupazione, essendo più consistente il lavoropresso le strutture alberghiere.
15
I nostri intervistati sono arrivati in Italia inun arco di tempo che va dal 1982 al 2003,coerentemente con la dinamica degli ingressi deimauriziani, che sono stati tra i primi gruppi apartecipare al processo migratorio verso l’Italia,ed hanno vissuto tutti un periodo più o meno lungodi irregolarità, sanato grazie alle molteplicisanatorie che si sono verificate in quest’arcotemporale.
Tutti gli intervistati hanno avuto molteesperienze occupazionali, anche se prevalentementenello stesso ambito. Le interruzioni dei rapportidi lavoro si sono verificate per una serie dicause: necessità di rientro in patria, cambiamentodel tipo di rapporto, richiesta di miglioramenticontrattuali (ovvero di rispetto di alcunidiritti); ma in generale i rapporti di lavoro sisviluppano senza particolari scosse, mostrandopochissima litigiosità ed i cambiamenti avvengonoper scelta del lavoratore.
Gli intervistati delle due nazionalitàpresentano, quindi, caratteri marcatamente distintisia rispetto alle caratteristiche del campione siarispetto ai percorsi migratori. Nel caso maurizianol’immigrazione è equilibrata sotto il profilo delgenere e ciò è riflesso anche nel campione. Nelcaso albanese, nel campione si registra invece unosquilibrio in favore delle donne. La distribuzioneterritoriale del campione riflette le differenzenella distribuzione territoriale delle duenazionalità. I mauriziani sono concentrati, glialbanesi dispersi. La condizione sociale di origineevidenzia una posizione più elevata da parte degliintervistati albanesi sia in relazione allafamiglia di origine, e soprattutto in relazionealla propria condizione nel paese di origine.Infatti tra gli immigrati mauriziani si riscontraun profilo occupazionale nel paese di originecomplessivamente più basso di quanto rileviamo tragli immigrati albanesi, per molti dei quali si èdunque verificato un consistente downgrading. L’etàmedia degli intervistati albanesi è più elevata di
16
quella dei mauriziani, ed hanno un grado diistruzione superiore. Gli anni di immigrazioneriflettono le diverse caratteristiche dei dueprocessi migratori: i mauriziani sono presenti daiprimi anni ottanta, mentre l’immigrazione albaneseè successiva agli anni novanta. Sia gli uni che glialtri sono entrati per lo più attraverso canaliirregolari, visti turistici, o, soprattutto per glialbanesi attraversamenti illegali della frontiera,ma tutti hanno potuto procedere in un momentosuccessivo alla regolarizzazione.
Possiamo, quindi, affermare che vi sianodifferenze consistenti tra gli immigratiintervistati albanesi e mauriziani, almeno dalpunto di vista della composizione dei gruppi, nonsappiamo, però, quanto queste differenzeinfluenzino il percorso migratorio nella suarealizzazione.
4. Reti, catene, individui
Le migrazioni sono sempre il frutto di uninsieme di scelte e motivazioni individuali, diopportunità e di influenze da parte degli ambientinei quali si è inseriti.
In letteratura spesso si contrappone unapproccio strettamente individualista proprio deimodelli della scelta razionale ad un approccio piùolistico costituito dai modelli reticolari, come sesia possibile separare la scelta individualerispetto alle relazioni che la influenzano.
L’analisi dei due gruppi che stiamo confrontandoci consente di verificare l’utilità di talecontrapposizione ovvero la possibilecomplementarietà tra i due approcci, e dievidenziare i caratteri diversi che le retiassumono nei casi in questione, in particolar modoin relazione alle prospettive rispetto allaspecifica nicchia occupazionale oggetto dellanostra ricerca.
17
4.1. Reti albanesi: reti deboli, legami forti
Dall’analisi delle interviste, emerge che iprocessi migratori che si sviluppano tra l’Albaniae l’Italia si strutturano all’interno di retiinformali, reti deboli, basate però su legamiforti. Tali legami hanno natura familiare. Sisviluppano cioè all’interno della famiglia chediventa il centro decisionale principaleriguardante il processo migratorio e per laformazione e circolazione di capitale sociale. È lafamiglia, nel suo nucleo ristretto o poco allar-gato, limitatamente cioè alla cerchia deiconsanguinei (es. cognati, zii, cugini), a valutarela decisione di lasciare il Paese, ad elaborare la‘strategia’ migratoria (chi emigra, come e dove) ea fornire il conseguente sostegno.
… lei (la figlia) era brava in pittura, ha vinto unconcorso in Germania quando era piccola. Era il premio di 12bambini di tutto il mondo e lei era una di questi bambini, cel’ha anche un foglio dell’Unesco. Mio marito è stato capoingegnere in Albania e io sono laureata in agraria e holavorato anche come maestra. Così quando abbiamo visto chenostra figlia aveva un po’ di passione e un po’ di talento perla pittura abbiamo deciso di cambiare la nostra vita per lanostra figlia che era grande e anche per le altre due nostrefiglie che erano piccole. Così lei ha finito la media con ivoti più alti in Albania e abbiamo deciso di venire qui. Primaè venuta lei (ora studia architettura), ha fatto tutte ledomande all’ambasciata e dopo un mese è venuto mio marito, halasciato il lavoro lì ed è venuto qui per stare vicino a leiperché noi siamo abituati .. siamo molto uniti nelle nostrefamiglie. (121)
Anche nel caso in cui la decisione di emigrarevenga maturata individualmente, la famiglia svolgeun ruolo essenziale nella formazione dell’idea, chedi solito si sviluppa sulla base di narrative diprecedenti esperienze migratorie in famiglia, e perla sua riuscita (cfr. Da Molin 1999, Leddomade1999). In quasi tutti i casi quindi è un familiarea diventare il pioniere del gruppo e poi ad agirecome catalizzatore dei successivi movimentimigratori. Nel nostro caso, siccome le intervistatesono state prevalentemente donne, il ruolo di
18
pioniere è rivestito dal padre, marito o dalfratello. Come spiega un’intervistata:
Tutti i parenti erano già immigrati ... Mio padre è venutoprima nel novanta con mio fratello che è andato sopra Milano epoi dopo tre o quattro anni ha fatto il ricongiungimentofamiliare per mia madre. Era il novantasei. Poi è tornata miasorella grande sempre clandestina ma adesso è tutto a posto epoi mia sorella piccola che ha finito l’università. Io sonostata l’ultima. (255)
In tutti i casi esaminati, la rete familiare haesercitato un ruolo preponderante sulla decisionedi emigrare. Essa tuttavia non ha funzionato comemero meccanismo di richiamo (come nellatradizionale catena migratoria) ma sembra avergarantito un ruolo più attivo ai nuovi migranti,influenzando principalmente le modalità diinserimento abitativo e lavorativo. La rete èdiventata cioè il veicolo di circolazione dicapitale sociale (risorse, informazioni,protezione, legami fiduciari) di cui i migranti chevi appartengono hanno beneficiato.
Il contenuto dello scambio tra chi parte e chirimane è costituito sia da risorse materiali che darisorse immateriali. Le risorse materiali siriferiscono principalmente alle somme di denaromesse a disposizione affinché i familiari rimastipossano intraprendere il viaggio verso l’Italia edaffrontare le prime spese legate al soggiorno nelnostro Paese. In qualche caso il denaro è servitoper pagare il biglietto per arrivare in Italia eper i documenti necessari all’espatrio. Inmoltissimi casi, è servito per pagare il viaggioclandestino verso l’Italia. Le cifre riportatenelle interviste oscillano da un 1 milione e500.000 lire per una singola persona (nei primianni novanta) a 3 milioni di lire per un gruppo unpo’ più ampio. Si è pagato per la traversatadell’Adriatico di notte e per l’approdo sulle costepugliesi dove i familiari già presenti nel nostroPaese li hanno prelevati. Il denaro è servito ancheper quel mese che solitamente intercorre tra
19
l’arrivo e il trovare un primo lavoro, spesso, dairregolari.
Tra le risorse materiali va anche annoveratal’ospitalità data ai nuovi arrivati nei primigiorni, prima di una nuova partenza, se si trattasolo di una tappa intermedia, oppure fino a quandonon si risolvono una serie di problemi pratici.
Io sono venuta qua perché avevo mia zia qua ad Ancona e lapossibilità di vedere un altro mondo e di aiutare i mieigenitori, così sono venuta qua. … sai, la zia, sapevo chesarei stata da lei, avrei mangiato da lei e dormito da lei.C'è qualcuno che ha dormito sotto i ponti, e questo dispiace,però siccome io avevo questa possibilità, a parte qua nonsarei andata da nessun’altra parte, tranne in Italia... (ilvisto) era turistico. Quando sono venuta con la nave avevopaura che mi fermassero. Ho preso i soldi di mia zia perchénon li avevo 1000 euro. (208)
Per quanto riguarda le risorse immateriali, sitratta di distinguere la fase che precedel’emigrazione dalla fase in cui si è intrapreso ilprocesso migratorio. Nella fase che precedel’emigrazione, i componenti della rete fungono dafornitori di notizie ed informazioni sulleopportunità di vita e di lavoro in Italia. Nellafase successiva, invece, il sostegno si sostanzianell’appoggio emotivo verso i nuovi arrivati esoprattutto nella ricerca di opportunità di lavoro,tramite la presentazione di possibili datori dilavoro e la ricerca dell’abitazione, primo passoper l’inizio di una nuova esistenza.
Nel caso albanese, lo scarso ruolo delle retisociali allargate, estese cioè ad altriconnazionali non legati da parentela, vieneconfermato. In questo caso, l’associazionismo traconnazionali risulta un fenomeno del tutto risi-bile. I pregiudizi culturali contribuiscono inmaniera molto rilevante a limitare forme disocialità collettive e formalmente definite chepotrebbero influenzare i processi migratori.Inoltre, come spiega Ambrosini (2006), ilconsolidamento delle reti etniche in formeassociative può segnalare il passaggio a forme piùsviluppate di rappresentanza e soprattutto ad
20
alternative più efficaci rispetto al modestocapitale sociale circolante tra le reti degliimmigrati. Naturalmente questo tipo di traiettorianon risulta affatto generalizzabile, ma dipende dafattori culturali, dai progetti di integrazione,dalla solidità/fragilità organizzativa. Dipendeanche dalla durata del soggiorno, dalraggiungimento di un numero sufficientementeelevato di immigrati che rivendichino dirittisociali, ma anche dalla geografia: quanto maggioresarà la distanza dal Paese di origine maggiore saràla spinta verso l’associazioni-smo.
Tra gli albanesi solo due intervistatidichiarano di far parte di associazioni cheraggruppano immigrati dal paese delle aquile. Taliassociazioni si trovano a Firenze e ad Ancona.Nessuna associazione è indicata nel Mezzogiorno,dove peraltro è concentrata la maggior parte degliimmigrati. In pochi altri casi si è partecipatoalle feste date dalle Ambasciate o dai Consolati inoccasione dell’anniversario della liberazionealbanese.
Quando sono arrivato a Firenze non conoscevo nessuno. Poiappuntamenti con albanesi, andando in giro, nelle piazze,senti parlare albanese e ti fermi a parlare e fai amici. …Prima c’erano tante associazioni, una ogni dieci persone,tante associazioni, ora è organizzato un po’ meglio, una solac’è ora. Fatta dal mio amico professore. Il 30 giugno alle ore21.30 c’è un concerto di un gruppo di Albania, da qui, daFirenze. L’associazione ha organizzato tanti appuntamenti.Quando c’è la festa delle liberazione dell’Albania, 28novembre 2004, organizzato bene, 200 persone, prima da piazzaSignoria, nel Palazzo Vecchio, Sala Cinquecento. Poi perpranzo andare in uno stadio, in un palasport, vicino al pontedi mezzo. Sei ore di danze, con musica albanese. Poi ha fattoaltre attività. Incontri, discussioni, musica, tutti albanesi.(141)
Tali associazioni si configurano, quindi, comeassociazioni auto-orientate (Sciolla 2003): esseforniscono risorse identitarie e solidaristiche aimembri del gruppo già presenti in Italia. Non vi èevidenza invece di un loro ruolo nellastrutturazione dei processi migratori. Allo stessomodo, nel caso albanese non sembrano esistere
21
associazioni che perseguono strategie di in-tegrazione e di dialogo con interlocutoriistituzionali (associazioni etero-orientate).
4.2. La scelta del lavoro domestico
Nonostante la prossimità tra i due paesi e laconsistente circolazione di informazioni, nessunadelle intervistate pensava di doversi occuparenell’ambito del lavoro domestico.
Sì, c'è, mi pensavo che facevo un lavoro in fabbrica comein Albania, sono sincera. Pensavo che arrivando qua lavoravoin una fabbrica, cioè un lavoro o molto più meno faticoso,chissà come un'idea così, sai? Tu dici madonna me ne vado, nonvoglio vedere più questo lavoro faticante e il respiro chearrivò trovò lavoro però, così. C'è il lavoro dappertutto qua.Devi lavorare. (513)
Una volta qui, però, questa è stata spesso lasola strada che ad esse si è offerta. Talvolta dopoesperienze di altro tipo, ad esempio lavoro pressoun ristorante o altre strutture.
Lavoravo al supermercato…Fino al…fallimentato, come sidice…?...Sì, fallito! …poi anche al supermercato un po’ ticonoscono le persone, la fiducia di lasciarmi dentro da sola,dice più o meno poi…gira la voce (580)
Il lavoro domestico rappresenta una specie dirifugio dove collocarsi in attesa che ci siaqualcosa di meglio.
Infatti, la gran parte delle nostre intervistatevorrebbe cambiare lavoro, vorrebbe un lavoro adattoalle proprie capacità o qualificazioni, o semplice-mente un lavoro più sicuro e regolare.
Io spero per lavorare in una fabbrica. In una fabbrica. Nonper lavorare in badanti, e se il lavoro è badante, non è unproblema, ma voglio lavorare con regola. Non un’ora, due ore.E se, per esempio, lavoro 4 ore mattina, 4 al pomeriggio, odue e due, ma con regola, con in regole. Lavoro non problema,non ce l’ho nessun problema, anche in futuro, ma solo conregole. (17)
22
Il lavoro domestico appare una sceltatransitoria quasi per tutte, almeno nei desideri enelle prospettive.
Io spero che è di passaggio, spero, però dovevamo trovarequest'altro? Me lo auguro che sia di passaggio… (513)
Peraltro, sebbene il lavoro domestico, non vengaconsiderato in modo particolarmente negativo essorappresenta un evidente abbassamento nella scalasociale:
Adesso per me così come è venuto qua è così come troviamoquesta ritmo che abbiamo preso, lavoro volentieri, non misento peso. Però da se stessa mi pretendo di più. Non che sonocontenta, ce un donna di servizio che è finito 9 anni disuperiore, prima erano 4, dopo ragioneria si diventò 5. unsacco di scuola che per pulire…È diverso. Diverso non nelsenso diverso che io mi manca questa reputazione dove lavoro,ma se io dico che io era un'altra Linda nel mia città, avevaaltre, altre amicizie, altre amici, diversi. Diciamo rangodella società le amiche, sì, lavori delle signore posso andareanche a bere un cafè, un tè, una cosa, le paste se c'è iltempo. (321)
che si accetta solo perché è necessario perpoter consentire a se stessi, o alle generazionisuccessive di trovare una collocazione migliore.
Allora, idea che io creavo prima di partire e di arrivarein Italia di fare crescere i bambini, di educare e diriprendere una scuola professionale, perché essendo che inAlbania non ho avuto questa possibilità e pensavo di studiarecome ho fatto già adesso la scuola di parrucchiera o dovevofare l’infermiera. Poi in mancanza di alcuni documenti hopreso la scuola di parrucchiera. Sono due passioni che mi sonopiaciuti già in Albania di prendere.
… Ah sì,vorrei, essendo che facendo, sto facendo a un annovolontari presso questo…vorrei cambiare…- E sì, certamenteche vorrei cambiare lavoro specialmente quella dellaparrucchiera e anche del la figura del mediatore, a faremediare fra l’istituzioni e l’emigrato. Questo che mi da moltosoddisfazioni per aiutare i altri essendo che all’inizio hoavuto difficoltà vorrei aiutare loro, quello che posso. (266)
È evidente la scelta consapevolmente strumentaledel lavoro domestico, che si inserisce in strategiefamiliari orientate a costituire le condizioni perun salto sociale.
23
Io in questo periodo della mia vita lo considero un lavorodi passaggio. A me mi piacerebbe molto avere un lavoro, nonper molte ore, ma andare in una famiglia per due ore, tre ore,per cucinare, assistere. Se si realizza che cominciainserimento di lingua albanese nelle scuole, come dicono,questa sarà una cosa molto buona.. Magari avere un progettoper tutto anno, anche solo cinque sei giorni la settimana.(230)
Abbiamo già detto che nel campione di intervistead immigrati di origine albanese sono pressochéassenti individui di genere maschile, riflettendoin ciò la prevalente distribuzione di genere dellavoro domestico all’interno di questo gruppo. Ciò,almeno apparentemente, non appare legato, però, aduna divisione di genere del lavoro domestico.Infatti l’unico intervistato, pur non avendo maisvolto tale attività afferma:
[Ma lei sapeva pulire in Albania? Ha dovuto imparare a farecose nuove per fare questi lavori?] Sì, ho imparato da qui. Manon è un problema pulizie.
[Quindi sono cose che sapeva già fare?] Sì Io sempre pulivoin Albania, ho aiutato mia moglie, sempre. Stirare lo sapevofare
[ma non le sembra un lavoro da donne?] No, io facevo giàin Albania…anche uomini fanno. Io nel negozio stiro tovagliolie solo giacche dei camerieri solo questi due articoli. (141)
Ovvero non crede di svolgere un’attività nonadatta ad un uomo, anche se si percepisce unaqualche distinzione rispetto al lavoro domesticovero e proprio.
Possiamo presumere dalle evidenze statisticheche per gli uomini vi sia una maggiore probabilitàdi trovare lavoro in altri ambiti: edilizia,agricoltura.
4.3. Reti mauriziane: reti diffuse, forti e vincolanti
Abbiamo visto come i Mauriziani in Italia sianopresenti in alcuni capoluoghi di provincia ed ingenerale soltanto nelle aree urbane, e svolgano inmassima parte lavoro domestico. Uno sguardo allemodalità del loro ingresso in Italia ci può fornire
24
qualche indizio sulle ragioni che hanno portato aquesta situazione.
Tutti i Mauriziani intervistati sono giunti inItalia sulla base di una relazione con qualcuno giàpresente che ha fornito loro informazioni, supportomateriale e motivazioni. Possiamo immaginare che leprime localizzazioni siano state abbastanzacasuali:
Forse perché hanno avuto più possibilità per entrare inItalia, che in altri posti. (378)
Perché per loro ciò che era importante eralasciare le Mauritius:
Certo, basta che usciamo dalle Mauritius, era questo ilmotivo, cioè basta che si esce, si questo è, forse era piùfacile, forse più facile entrare in Italia che altri posti,per questo dico. (378)
A partire da ciò, tuttavia, si è poi sviluppatoun accrescimento costante fondato sul richiamo diun parente. Nella organizzazione del viaggio, anchein presenza di parenti, le agenzie turistiche hannoun ruolo particolare. Esse non solo procurano ibiglietti, ma procurano i visti ed i contatti inItalia per poter affrontare i problemi inizialidella permanenza in un altro paese. Afferma,infatti, un intervistato:
Perché l’agenzia di viaggio ci aveva dato l’indirizzo diuna persona. Tu vai lì è chiamate quella persona. Quellapersona ti viene a prendere e poi ti dà un lavoro. (61)
Per la gran parte la scelta di andare in unacerta città è determinata dalla presenza di unparente come testimoniano diversi nostriintervistati:
… ha preso treno per venuto a Milano, c’è mio cugino e havisto che una bella vita qui e posso vivere meglio di nostropaese allora rimane qui, è venuto a Bari, c’è pure un altrocugino e lui mi aiutò per sistemare qui con..mhmmm…diciamoclandestino, senza lira senza niente, pure così ha trovatolavoro, prima torna a casa e così, stai lavorando. E non è,non posso dire contento di questa vita, però è meglio di
25
quelle di nostro paese, per vivere lì è più duro, il lavoro èun po’ duro. La vita non è uguale. (116)
Allora c’è un amico suo che abitava vicino casa, e lui èvenuto in Italia tranne [ per dire ‘tramite’] quest’amico hamesso d’accordo per farlo venire qua a Palermo, e mano manopoi ho detto a mio fratello di farmi venire qua, tipo per(ride) …riempire la tasca, invece non è così!... Perché ioc’avevo mi fratello qua, diciamo, avevo un gancio, allorac’era più possibilità di hai questo gancio perché si no io nonso, io vengo in Europa, ma dove vai? Se non conosci nessuno?
Alla fine vai a fare il barbone. (313)
Solo un intervistato ha dichiarato di non averricevuto alcun aiuto per venire in Italia, mentretutti gli altri sono stati aiutati in massima parteda parenti o in misura minore da compaesani. Stantele dimensioni del paese e il numero di abitanti illegame personale sembra essere il primo canaleattraverso cui si sviluppa il movimento migratorio,ma il legame che nasce dal paese di provenienzagioca anch’esso un ruolo importante. Alcuniimmigrati sono giunti con l’indicazione diconnazionali fornita loro dall’agenzia di viaggio,altri hanno casualmente incontrato connazionali cheli hanno aiutati nel primo periodo di immigrazione.
Sì a Bari. Gli altri amici sono rimasti lì. Io sono andatoavanti. Se per caso si stava bene li dovevo far sapere. Poisono arrivato a Bari. Quello mi ha accolto. È venuto allastazione. Naturalmente allora nessuno aveva la casa. Qui aBari c’erano solo cinque mauriziani. Tutti lavoravano in casa.Facevano i servizi come domestici. Allora mi hanno messo inuna pensione a Piazza Umberto. Però loro mi hanno portato damangiare, mi hanno cucinato…Poi dopo una settimana mi hannofatto trovare il lavoro. (61)
Qualche volta una disponibilità annunciata nonviene confermata, ma ci altri connazionali asostenere il migrante:
Poi a Torino io devo andare a Bari e gli altri due amicidovevano scendere a Catania. Io ho chiamato a mia cugina daTorino. Le ho detto: «guarda, io sono a Torino, devo venire date» e mia cugina mi ha detto: «no, non puoi venire da meperché non c’è posto» …e là siccome siamo venuti con questiamici insieme con me, il ragazzo Mauriziano e la ragazza mau-riziana, che loro avevano già cugini qua, parenti, sorelle,non lo so chi, e loro hanno telefonato a questa coppia e glihanno detto: «guarda c’è una ragazza che viene a stare da voi
26
perché non ha un posto dove andare per dormire» e subito mihanno detto di sì, puoi venire per vivere fin che tu non troviun lavoro, non trovi una casa. Il posto era a via Ventimigliaa Catania e mi sono trovata subito bene con loro. (224)
L’aiuto fornito è spesso un aiuto moltoconcreto: spese di viaggio, un alloggio, lapresentazione di un datore di lavoro ed ovviamenteinformazioni, ma tra queste non vi è quasi maiquella relativa al tipo di lavoro svolto in Italiae a ciò che effettivamente li aspettava dal puntodi vista occupazionale.
Questo reticolo di rapporti rispecchiaadeguatamente le caratteristiche propriedell’immigrazione mauriziana (Lingayah 1987, 1991,Mannick 1987, Vuddamalay, V., Lau Thi Keng, J.-C.1989). I mauriziani all’estero costituiscono gruppiabbastanza coesi con proprie associazioni (spessolegate alla pratica delle differenti religioni) eduna solida vita sociale interna alla comunitàmauriziana, in Italia come negli altri paesi in cuisi trovano ampie comunità mauriziane. Ciò nontoglie che essi siano del tutto ben inseriti neltessuto sociale in cui sono localizzati.
Anche loro pensano che ho trovato persone per bene che midanno lavoro; sono fieri che qui in Italia noi maurizianiabbiamo una buona reputazione. (105)
si, è vero, la mattina delle volte quando prendevol’autobus, ci sono italiani che lavorano come noi, loroparlano, «no è vero, i mauriziani e gli srylanchesi sonobravi». (020)
Sia gli intervistati in questa ricerca, siaquelli di altre condotte in questo gruppo,evidenziano l’elevato grado di integrazionesociale, testimoniato non solo dalla fruizione deidiversi servizi del paese di accoglienza, ma dallastessa presenza di rapporti frequenti ed estesi conitaliani (più raramente con altri stranieri).
Nel gruppo dei nostri intervistati appareevidente come si dipani una vera e propria catenamigratoria. Coloro che sono arrivati grazieall’aiuto di altri loro parenti e/o conoscenti, a
27
loro volta aiutano altri conoscenti o compaesaniad immigrare in Italia. Questa evidenza contrastacon quanto affermato da Avola, Cortese, Palidda(2003) che hanno trovato la presenza di reti debolie sconnesse, senza una particolare rilevanza dellerelazioni parentali e/o “etniche”. Fermo restandoche in ricerche che utilizzano metodologiequalitative possono darsi queste diverseoccorrenze, sia la ricerca sul lavoro domestico siaaltre ricerche condotte in Italia ed in altri paesiassegnano alle reti parentali tra i mauriziani unruolo molto rilevante (Mannick 1987, Brandimarte ePetrosino 2004).
La distinzione tra due categorie teoriche che sisono affermate nello studio dei movimentimigratori: il network e la catena migratoria,appare molto debole (Scidà 1998). Entrambedelineano correttamente le caratteristichedell’immigrazione mauriziana. Da una parte èevidente come si sia in presenza di una classicacatena migratoria: parenti e conoscenti che gra-dualmente promuovono l’immigrazione all’interno diun territorio con un flusso migratorio che tende arimanere concentrato in quel territorio. Dall’altrale conoscenze e le relazioni si mantengono neltempo, strutturando nello spazio migrante una retedi relazioni che supporta il migrante nelle suescelte: il cambiamento di un lavoro, la ricerca diun’abitazione sono rese possibili dalle relazionipresenti.
Che tipo di rete viene costruita? I legami fortisembrano essere preponderanti almeno nella faseiniziale del processo migratorio, e non potrebbeessere altrimenti vista la rilevanza della scelta el’importanza che essa ha per l’intero nucleofamiliare, ma legami più deboli si sostituiscono osi aggiungono in un momento successivo in unamodalità di grande complementarietà. Se il pesodelle reti è rilevante e, vedremo, preponderantenel segnare il percorso migratorio, vasottolineato, che la scelta di emigrare apparequasi sempre il frutto di una volontà individuale
28
piuttosto che di una complessiva strategiafamiliare. I nostri attori valutano sulla base diinformazioni fornite loro da chi è già in Italia,la decisione di partire, ne parlano in casa, e lefamiglie partecipano finanziariamente, fornisconoun sostegno, ma non spingono a partire, il viaggionon è quasi mai un progetto collettivo.
allora io volevo viaggiare, diciamo, aveva questa voglia diandare fuori. (018)
In altri termini la famiglia offre il sostegnofinanziario, relazionale, informativo, affettivo,produce una socializzazione anticipatoria alprocesso migratorio attraverso il rapporto tra isuoi componenti, ma non sceglie di far emigrarequalcuno dei suoi componenti e tanto meno sembraimporre tale decisione.
si, mio cugino era qua con la moglie, poi lui è venuto aMauritius per fare le vacanze poi mia mamma ha parlato conlui, gli ha detto se io voglio venire là (in Italia) èpossibile? Poi lui ha detto si, poi sono andata avanti per lamia strada, poi lui mi ha ospitato qua quando sono arrivata.(20)
Anzi spesso ci si trova di fronte ad unaopposizione da parte dei genitori alla partenza deifigli. Il processo si svolge evidentemente incontesto relazionale forte, ma la decisioneappartiene al singolo migrante.
mia madre ha trovato questo molto...molto colpita miamadre, perchè non vuole che io allontanare da lei. Ma inveceio lo dici a mia madre «che dobbiamo fare? per combattere lavita, che dobbiamo fare?, io dobbiamo cambiare, io dobbiamoandare», mia madre dice «no, no, tu devi restare qua, cometutti i tuoi sorella, come tutti la tua famiglia, tu devirestare qua. …» Ehh, io dici «mamma, almeno lasciami..lasciamiprovare, se mi trova bene allora mi rimango, se mi trovatomale mi ritorno, non ti preoccupare, non devemi succedereniente, non ti deve spaventare.». ...e poi mia madre mi dici«chi vuole tu, allora la vita è tua, tu devi fare tuo modo chetu non deve succedere niente..», dice «non ti preoccupare,perchè io fa fiducia con me, allora io sono qua». (42)
Eccezione a tale quadro fanno i ricongiungimentifamiliari, nei quali il peso dell’altro coniuge
29
nella decisione è evidentemente moltosignificativo.
Nella fase successiva cresce la rilevanza dilegami più deboli, datori di lavoro, conoscenzeoccasionali, attraverso le quali si cercano ovengono proposti nuovi lavori o si cercanosoluzioni ai problemi che accompagnano la vita deimigranti.
4.4. I mauriziani ed il lavoro domestico
Abbiamo già detto che i mauriziani svolgonoprevalentemente l’attività di collaborazionedomestica indifferentemente tra uomini a donne eindifferentemente rispetto alla confessionereligiosa o al gruppo etnico di appartenenza. Lapresenza così preponderante nell’area del lavorodomestico (comune, peraltro, anche ad altri paesi)contribuisce a costruire il luogo comune secondocui in tale gruppo vi sia una propensione versotale tipo di attività; in altri termini che vi siauna qualche ragione culturale (retaggi delcolonialismo ecc.) che fa propendere gli immigratimauriziani verso il lavoro domestico e che essisiano «adatti» allo svolgimento di tali compiti.
Nelle parole dei nostri intervistati essa nasceinvece da una visione chiaramente strumentale erealista della propria condizione di migrante: illavoro domestico viene scelto perché è l’unicaopportunità disponibile in contesti in cui anchegli italiani sono disoccupati.
Sì, altrimenti che devo fare? per noi mauriziani è semprestato così, fino alla fine, finché Dio vuole che sto inpiedi.
Conosci qualcuno che ha cominciato a fare il lavorodomestico, qui in Italia e poi ha cambiato lavoro?
No, io tutti gli amici che conosco siamo andati semprecosì, c’è qualcuno che si è fermato, che non lavora (105)
Nessuno ha mai fatto questo lavoro in patria:
no, non avevo chiesto perché non ho lavorato mai, poi nonpensavo che lavoravo a pulire la casa di altri [ride]. (59)
30
In realtà le informazioni che vengono fornite aimigranti dai propri connazionali spesso nonincludono il tipo di lavoro da svolgere, ma solo lapossibilità di guadagnare più che in patria e difare un lavoro onesto. Vi è, soprattutto tra imaschi, ritrosia e parrebbe vergogna nel farconoscere qual è il lavoro svolto. Ciò nonostanteuna volta in Italia ci si adatta facilmente e siimpara a fare ciò che non si è mai fatto,rinunciando ai propri sogni:
sì, la cognata di mia grande sorella, sì, la cognata di miagrande sorella che stava qui e lei mi ha, mi ha det, mi hafat, mi ha detto di parlare un po’ di Italia, però non mi hadetto che lavoro che devo fare … mi dice «ti trovare un buonlavoro», pensavo trovare lavoro come mi piace, però come sonovenu, arrivato qui io trova questo tipo di lavoro per forza lofa, perché ho espeso tutti i soldi che aveva per partire perle cose, allora per ritornare là non è, non è facile. Fino ache ho incontrato … si io devi cambiare, cambia tutto, nonfare niente di quel tipo di lavoro, però non è possibile, nonè possibile, vedi ho provato di fare il corso per il computer,dice magari troverà un tipo di lav.., qualche lavoro, però èarrivata la bambina. Adesso io lavora non per me, io lavorasolo per vai avanti a loro, però mio desiderio perso già,perché quello che voleva quando io era piccola, vuole lavorarecome io faceva per opto mesi a Mauritius lavorava così, e l’hoperso, allora ho detto adesso dedica tutto, lavora così. (65)
Lo spazio migrante costruisce una specie diterritorio neutro rispetto alle proprie tradizionied anche alla propria dignità (vedi Piore, 1979):ciò che a casa non si farebbe qui lo si deve fare,ma possibilmente non lo si deve far sapere.L’importante è accumulare il denaro sufficiente araggiungere i propri obiettivi, che raramente,però, avviene. In particolare sono gli uomini adovere accettare una condizione sgradita:
No, là è diverso, gli uomini non fanno proprio niente, cioèoffeso a fare le cose di casa …Si perché è uomo e quindi nondeve fare niente, gli uomini devono fare tutti i compiti … Quali fa ma là non lo fa. (378)
Solo uno dei migranti maschi ha detto, convergogna, ciò che faceva ai suoi parenti nelleMauritius.
31
No, no, non è vero, io sono stato coraggioso e ho dettotutta la verità, la cosa più imbarazzante che è stato quandosono andato a vedere lei, sua nonna mi diceva, mi chiedeva “matu là che cosa fai?
Mah, imbarazzante! Molto, quindi ho dovuto dire, c’eratutti i parenti di loro e tutti i miei, ho dovuto dire tuttala verità, se accetta, accetta. (461)
L’idea di cambiare lavoro, sebbene presente neidesideri di molti, non sembra mai essere fondata sudelle precise strategie di uscita. Certo alcunidesidererebbero lavorare in fabbrica, oppure nelsettore turistico o in altre attività e consideranoil lavoro domestico una specie di ripiego, ma esso,per quanto non desiderato, costituisce unadattamento alla situazione e da cui è difficilepensare di poter uscire.
La fortissima connotazione ‘reticolare’costituisce la spiegazione più ragionevole per laspecializzazione dei mauriziani nel mercato dellavoro.
Il collegamento con i parenti e con un circuitodi conoscenti connazionali si rivela cruciale perla ricerca del lavoro,
E ci sono tanti amici mauriziani che tu gli dici: «cercamiun lavoro» e quando si sente di qualche lavoro loro si dice.(224)
insieme, va sottolineato, ai datori di lavoro.
Tramite amici, dove anche lavora mio marito, glielo hadetto il datore di lavoro, se c’è qualche lavoro, se me lo puòdire perché mia moglie non sta lavorando. (224)
E chi lavora si fa tramite verso gli altriconnazionali aiutandoli a trovare un’occupazione:
Tanti amici che hanno trovato…cioè appena sento qualcunoche cerca, aiuto gli amici, perché siamo sempre tutti amici,qua non abbiamo parenti quindi basta che sentivo un’amica chenon ha lavoro, sento che cosa gli dico, è normale …
E glielo faccio sapere (378)
Scarsa invece è la presenza di altri immigrati,mentre più presenti sono conoscenti ed amiciitaliani.
32
Tramite suo zio, un amico di suo zio, dello zio di Marco.Il fratello di sua madre, c’è una signora, io lavoravo dasignora. Questa signora è un’amica…non lo so….se….una…un’amicadi cuore, così, suo zio e questo zio ha fatto conoscere suamamma, la nonna di Marco, conosco la signora, sua madre, ioconosco fino ad oggi. (520)
5. Reti migranti e transnazionalismo
Emerso relativamente di recente nellaletteratura sui fenomeni migratori e oggetto di uncontroverso dibattito, il transnazionalismo vieneconsiderato un nuovo modo di studiare le migrazioni(Glick Schiller et al. 1992, Vertovec e Cohen 1999,Portes et al. 1999).
Il processo migratorio è stato tradizionalmenteletto come lo spostamento di individui o famiglieda un Paese ad un altro, sulla scia di motivazioniindividuali o, al contrario, influenzate da fattorimacro-strutturali. In ogni caso, lo spostamentoassumeva un carattere definitivo: si lasciava unluogo (quello di origine), dove si ritornavasaltuariamente, per approdare in un altro luogo chediventava il luogo di destinazione, dove cercare unlavoro ed una vita migliore.
In anni più recenti, molte analisi hannodocumentato il carattere inedito con cui simanifesta oggi la mobilità di persone e cose. Siafferma che il movimento di individui e di gruppiappare sempre meno come uno spostamento definitivoda un paese all’altro e si caratterizza invecesempre più come un flusso continuo di individui ebeni che si muovono “tra” luoghi/paesi, attutendoneconfini e mescolandone caratteri socio-culturali edeconomici. Si assiste cioè alla contemporaneapresenza di una miriade di spostamenti nonpermanenti, circolari, di varia durata, che rendonol’esperienza migratoria estremamente segmentata(Freedman 2003). Sempre più di frequentel’emigrante, o nel nuovo lessico, il migrante è ingrado di legare località diverse, distanti, in un
33
unico campo sociale, estendendo la sua appartenenzaa due o più contesti simultaneamente. È, cioè,quello stay between (Grillo 2001) che permette divivere spazi diversi secondo un modello di mobilitàtransnazionale. In altri termini, se in precedenzail processo migratorio era letto in riferimento astadi temporali e contesti spaziali ben definiti,oggi i processi migratori si caratterizzano per unmultiplacement, come dimensione di vita attraverso iconfini.
Come sostenuto da vari studiosi (tra gli altri,Portes et al. 1999), il transnazionalismo più cheun fenomeno nuovo, costituisce piuttosto una nuovaprospettiva (teorica ed empirica) nello studiodelle migrazioni, che aggiunge e ridefiniscevecchie categorie concettuali.
La novità emersa con il transnazionalismo èstata quella di porre al centro dell’analisi lerelazioni sociali che strutturano i processimigratori. I migranti agiscono e prendono decisioniall’interno di reti di relazioni sociali chemettono in connessione spazi socialitransnazionali. In quest’ottica, il processomigratorio assume carattere processuale. Lamobilità transnazionale può essere letta come unprocesso di costruzione di network che dipende da,ed è rinforzato da, relazioni sociali multipleattraverso lo spazio. Questa prospettiva spostaquindi l’ottica di osservazione sia dalle decisioniindividuali che dalle dinamiche macro-economiche.Le prime erano il focus di analisi degli approccieconomici dominati; le seconde erano al centrodella visione strutturale che si poneva inalternativa alla prospettiva neo-classica.
Un importante aspetto della prospettiva inquestione consiste quindi nel mettere in relazione,nell’analisi dei processi migratori, i livellimicro e macro. Un secondo aspetto è costituitodalla bi-direzionalità degli scambi (Ambrosini2006). L’attenzione si concentra non solo suitradizionali rapporti che legano i migranti con ilpaese di origine (ad esempio le rimesse), ma
34
soprattutto sulle pratiche di vita quotidiana chemettono in relazione i due ambiti. Come sottolineaVertovec (2004), gli aspetti ‘di qua e di là’ sonocostantemente osservati e percepiti come dimensionicomplementari di un unico spazio di esperienza. Peralcuni, il transnazionalismo come pratica di vitatra confini può essere visto metaforicamente comeun terzo spazio per i soggetti che rifiutanol’integrazione o l’assimilazione o che cercano diarginare l’esclusione. I processi transnazionalimettono quindi in crisi le tradizionali categoriebinarie; inoltre rendono problematica la nozioneclassica di spazio che fa coincidere perfettamenteluoghi fisici, sociali e politici con una precisaarea geografica.
La lettura dei processi migratori secondo laprospettiva del transnazionalismo si innesta senzadubbio nei processi di cambiamento in atto alivello globale. Teorizzando la progressiva perditadi identità collettive forti, soprattutto a livelloterritoriale (de-territorializzazione), moltiteorici sociali contemporanei consegnanoun’immagine degli attori sociali come attori ‘so-spesi o in transito’, piuttosto che sradicati otrapiantati, tra diversi luoghi, talvolta anonimi,che si rapportano agli altri sempre più in manieravirtuale. La compressione spazio-temporale resapossibile dai mezzi di comunicazione e di trasportopermette ai migranti un’intensità di scambi e unamolteplicità di pratiche non immaginabili inprecedenza.
Allo stesso modo, secondo Appadurai (2001), imass media sono in grado di creare fantasie diidentità che, identificando il tipo di vita e dipersona che si vorrebbe essere, alimentanoinconsciamente il desiderio di spostarsi. Iltransnazionalismo implica infatti unattraversamento e una trasgressione dei confinianche grazie al flusso di immagini culturali;queste contribuiscono a creare un immaginario circapossibili modelli di vita che trascende i confininazionali e crea nuove tipologie di spazio (i cd.
35
ethnoscapes). Si creano, in altri termini, dellecomunità senza prossimità che, tramitecontaminazioni e ibridazioni culturali diverse,danno vita a spazi sociali transnazionali (Faist2000). Esse inoltre contribuiscono allariconfigurazione continua della loro culturaall’interno di nuovi spazi.
Nel tempo, la letteratura ha progressivamenteelaborato il concetto di transnazionalismo. Adesempio, Portes et al. (1999) distinguono trediversi livelli di transnazionalismo: economico,politico e socio-culturale. Il transnazionalismoeconomico si riferisce in particolare alle attivitàeconomiche che i migranti svolgono attivandorelazioni sociali ed economiche attraverso lefrontiere nazionali. Si tratta di attività in cuigli immigrati farebbero ricorso sia a risorse dinatura economica (non solo rimesse ma ancheinvestimenti) sia a risorse sociali (il cosiddettocapitale sociale). Per alcuni il transnazionalismoeconomico può essere visto come una sorta diimprenditorialità immigrata che in questo casotrova il suo perno nei network internazionalipiuttosto che in quelli familiari/comunitari. Altrihanno messo in luce il carattere positivo deltransnazionalismo interpretato come una formaalternativa di adattamento delle minoranzestraniere nelle società di destinazione. In campopolitico il transnazionalismo si riferisce allapartecipazione o al sostegno finanziario a comitatidi iniziativa civica nei luoghi di origine. Incampo socio-culturale, ci si riferisce allapartecipazione ad eventi manifestazioni culturalinel Paese di origine (Portes et al. 2001).
L’analisi delle interviste non ha fatto emergerealcuna evidenza circa l’esistenza di pratichesociali transnazionali e di legami multipli esimultanei tra gli spazi socio-culturali edeconomici albanese ed italiano, e mauriziano editaliano. Si può sostenere al contrario chel’immigrazione albanese e quella mauriziana versol’Italia – almeno quella qui analizzata – assumano
36
dei tratti classici e cioè si configurino comespostamento da un Paese ad un altro. Nella maggiorparte delle narrative analizzate – soprattutto inquelle degli immigrati albanesi – è evidenteinfatti la netta separazione tra luoghi edesperienze, che appare molto più pronunciata nelcaso della sfera economica. C’e’ un qui ed un là;c’e’ un qui per alcune cose ed un là per altre.L’Italia è il luogo dove si vive, si lavora e siinveste, se possibile. È il luogo che per molti harappresentato l’opportunità di una vita miglioreper se stessi e per i propri cari. È l’unicopresente e futuro.
In nessuno dei casi esaminati emerge ilcoinvolgimento in attività o iniziative economichecross-border indicative di pratiche sociali nuove.Peraltro il segmento specifico analizzatodifficilmente può presentare tali pratiche.5 Ciòche al contrario si può rilevare è la profondainfluenza culturale che il percorso migratorio hasui nostri intervistati, con modalità, però, moltodiverse tra albanesi e mauriziani. I primi, purmantenendo rapporti più continui con il paesed’origine, mostrano una maggiore propensione a faredell’Italia il loro paese, forse definitivo. Per imauriziani è diverso: l’identità mauriziana è moltoforte, complici marker certamente più evidenti eforti (religioni, tratti somatici/colore), e lapresenza in Italia non solo non mette indiscussione l’identità mauriziana, ma prelude ad unpossibile ritorno nelle proprie isole.
5.1. Albanesi
Nonostante la svolta occidentale intrapresadall’Albania (Proto e Rotta 2006, Stocchiero 2002),5 Diversa invece è l’evidenza che emerge nel caso di migranti che abbiano intrapreso percorsi di lavoro imprenditoriali (si veda Corigliano e Greco, 2005, sulle attività imprenditoriali delle donne albanesi).
37
la persistente instabilità economica e sociale delPaese gioca un ruolo molto forte nella spiegazionedella diffidenza che impedisce ai migranti diavviare iniziative economiche nel loro Paese. Allostesso modo, non risulta alcun coinvolgimento degliimmigrati albanesi nella promozione di attivitàsocio-culturali e politiche.
L’esperienza migratoria degli albanesi d’altraparte si discosta anche dall’evidenza documentatada Morokvasic (2004) sulle migrazioni da altriPaesi ex-comunisti (Polonia, Romania, Bulgaria,ecc.) dopo la caduta del muro. Favoriti dallaprossimità geografica, dai bassi costi di trasportoe dai differenziali salariali, alcuni migrantiscelgono di ‘stabilirsi nella mobilità’. Piuttostoche trasferirsi definitivamente in un Paese, essiscelgono di vivere in maniera transnazionale: èquesta una strategia che permette loro di stare acasa pur essendo, per alcuni periodi, lontano daessa. In questo caso, a strutturare i processimigratori sono legami deboli, con amici econoscenti, e la comunanza di obiettivi piuttostoche quella comunitaria.
Per molte intervistate albanesi, invece, illegame con la madrepatria sussiste. Si tratta peròdel classico legame tra immigrati e Paese diorigine. È confinato alla sfera familiare; consistedi viaggi periodici (solitamente durante il periodoestivo ma anche per il capodanno) e di regali aifamiliari rimasti, portati nelle valigie o mandatitramite amici.
Quando facciamo un viaggio (torniamo là) sì, facciamo anchei regalini per loro (i parenti). Per esempio, un completinoper le ragazze di mia figlia (mia sorella) che sono cresciute,una… la più grande ha 16 anni e le piccolette sono duegemelle, hanno 15 anni, quindi sono abbastanza cresciute… sì,i completini, le magliette belle (come si trovano) qua, por-tiamo le cose che non si trovano lì, in Albania. … Eh, pure lescarpe! Le pantofole, un asciugamano per la spiaggia, unombrello… eh, le cose così, come mi vengono (in mente), (anchein base) alla possibilità di spesa (che abbiamo). (205)
Il flusso di risorse economiche è limitato inquasi tutti i casi alle rimesse in denaro per
38
sostenere gli anziani lasciati dietro di sé o,magari, per la costruzione di una casa che serviràforse per quando si sarà pensionati.
ho lavorato ho sempre mandato i soldi giù perché noi grazieai soldi miei e di mio fratello ci siamo trasferiti dallemontagne al mare, abbiamo una casa nostra e stiamo facendoanche.. una cosa per lavorare per il futuro, quindi c’è pocoda mettere soldi da parte..cioè sono messi da parte là..lispedisco e si fanno dei lavori ecco…ti capita il mese chemetti da parte 1500 euro, mese da 400/500 euro non c’è maiuna cosa fissa.. li mando quando c’è bisogno, tramite labanca. (405)
Le stesse pre-condizioni che qualificano iltransnazionalismo (l’intensità degli scambi, lafrequenza, la mobilità, ecc.) non sembrano appli-carsi al caso albanese e questo nonostante laprossimità geografica. I viaggi in Albania, comegià indicato, sono periodici e limitati al periodoestivo o a cavallo del nuovo anno. I legami con iparenti ed amici lasciati dietro di sé avvengonotramite il telefono. È il mezzo di comunicazionepiù utilizzato in primo luogo per avereinformazione sulle condizioni di salute dei proprifamiliari; è anche lo strumento per tenersiaggiornati sulla situazione economica e politicadel Paese. Al contrario, le lettere sono poco usatecosì anche le email.
5.2. Mauriziani
Abbiamo visto che le reti tra maurizani sonomolto forti, ma danno anche vita ad uno spaziotransnazionale? Per quanto molti dei nostriintervistati abbiano parenti o conoscenti anche inFrancia e nel Regno Unito e l’esperienza migranteattraversi in modo profondo le loro famiglie, lerelazioni sono molto tenui e poco frequenti. Ancheil rapporto con il paese di provenienza soffredella distanza e della dispendiosità dei mezzi ditrasporto. I nostri intervistati tornano a casaabbastanza raramente ed anche raramente sonovisitati dai parenti,
39
il viaggio costa tanto, però se io lo pago qua. Però se iopago da qua…però è difficile entrare qua adesso. (20)
i contatti si mantengono prevalentemente con iltelefono:
chiamo io sempre di più, perché io non volevo che chiama
loro perché costa assai e io quando vuoi posso chiamare, tuttele settimane, qualche volta mi passo, posso chiamare … io vadoin phone center e quando passo da lì, io sempre chiamo per 2,3 minuti velocemente così tutti in settimana amici, famiglia,a casa non si fa sempre, settimana, due settimane,ma perchéquando chiamo a casa devi parlare con tutti, allora questodevi avere tempo quando sono libero, vado in giro con miamoglie, si chiamo e parlare con tutti. (116)
Anche le rimesse sono abbastanza limitate eservono in massima parte a costruire una casa nelproprio paese.
Sembrerebbe quindi che non si possa parlarepropriamente di transnazionalismo. In realtà talecategoria è alquanto evanescente. Per alcuni autoriè la stessa presenza di relazioni tra i migrantipresenti nei luoghi di migrazione e i propriparenti nei propri paesi a generare uno spaziotransnazionale (vedi famiglie filippine), ed allorai figli talvolta lasciati in patria, i parenti checontinuamente si scambiano risorse, delimitano icontorni di questo spazio. Ma se vogliamo adottareuna interpretazione più ristretta di questa cate-goria, ovvero la presenza di un’attività continuadi scambio nello spazio costituito dal migrante edalle sue relazioni con il paese di provenienza, icasi esaminati (limitatamente alle intervisterealizzate) non possono essere ascritti a talesituazione.
5.3.Globalizzazione culturale
Molto più evidenti sono invece le tracce dicontaminazione culturale tra Italia e Albania chesembrano aver influenzato i processi migratori dimolti degli intervistati, ed in particolare la
40
decisione di raggiungere l’Italia. Risulta chiaroda quasi tutte le interviste che la sceltadell’Italia come Paese di emigrazione è statainfluenzata in maniera decisiva da un potenteimmaginario culturale. In molte interviste emergeil ruolo preponderante dei mass media,principalmente la TV, per la costruzione di unapatria di accoglienza, spesso solo immaginata e noncorrispondente poi alle aspettative. Anche sevietato dal regime comunista, in molte abitazionialbanesi si seguivano i programmi italiani. Inquesto modo si imparava la lingua e sisocializzavano i costumi e gli usi del nostroPaese.
L’Italia l’ho immaginata… e mi piaceva tanto.. però nelmomento che abbiamo deciso non si pensava più «è bella o non èbella»…era un posto dove potevamo andare, trovare un alloggioe un lavoro per continuare la vita con tranquillità…Non è chescegli tra tutte le rose quella che ti piace di più, era ilponte più vicino…Più la lingua, più che altro, perappoggiarsi, per inserirsi…
Avevo un’immagine abbastanza precisa dell’Italia, avevovisto i film e tutte le canzoni, di tutti gli anni, cioè,tutti i Sanremo italiani noi…Ancora sappiamo le canzoni,tutte…(173)
Il crollo del regime comunista quindi ha datol’opportunità di recarsi in un luogo giàconosciuto. Questo ha facilitato senza dubbiol’inizio di una nuova esistenza nonché, ad unlivello più personale, la creazione di identitàmultiple. Tuttavia ciò non sembra escludere oeliminare le difficoltà legate al processomigratorio.
Altrettanto evidenti sono i processi diriconfigurazione dell’identità nazionale. Leintervistate si polarizzano nel produrre unarappresentazione ideale o, al contrario, unarappresentazione del tutto negativa della loro pa-tria.
Nei mauriziani, pur persistendo un forteradicamento della propria identità originaria, sievidenziano cambiamenti culturali più profondi inrelazione alla stessa attività lavorativa svolta
41
nel settore domestico. Si evidenzia, infatti, uncambiamento dei ruoli familiari tradizionali trageneri in relazione al lavoro domestico:
Nel mio paese i maschi sono maschi, cioè non fanno niente.Completamente, zero, magari qualche cosa. Mettiamo io: a casamia mai cucinato, mai stirato, cioè mai fatto niente. Se c’èun pezzo di terrazzo così, buttare un po’ d’acqua..ma più diquesto non fanno. I maschi sono maschi, cioè non fanno niente,se c’è qualcosa da dipingere allora sì ma niente, le femminesono sfruttate … No, all’inizio mi sono sentito molto..no amio agio, perché sento un lavoro per femmine, mi sento a unlivello basso, poi ho detto morire di fame, o lavorare? Èstato duro integrarmi in questo lavoro mi sento umiliato,purtroppo alla fine devi lavorare, non è che puoi rimaneredigiuno. (313)
La conoscenza della realtà italiana è limitata,se non assente. Le uniche informazioni sono quelledei propri connazionali e parenti o delle lontanereminiscenze scolastiche. Non vi è in alcun modouna compenetrazione tra l’universo culturaleitaliano e quello mauriziano. Invece una volta inItalia i ruoli di genere vengono stravolti; si apreuna sorta di parentesi culturale, nella quale èpossibile essere e fare ciò che non si è o non sifarebbe in patria. Non sappiamo se questo possainfluenzare in modo permanente i comportamenti aprescindere dal territorio o se, come unaparentesi, si possa chiudere.
6. Qualche riflessione
Questo articolo ha presentato i principalirisultati dell’analisi delle esperienze migratoriedi immigrati provenienti da due diversi statiAlbania e Repubblica delle Mauritius.
Specificamente, l’analisi si è concentrata sullecaratteristiche ed il ruolo delle reti socialinella strutturazione dei processi migratori diquesti due diversi gruppi di migranti all’internodel segmento costituito dal lavoro domestico. Unacomparazione più sistematica dei risultati relativiai due gruppi considerati consente a questo punto
42
di delineare le specificità di ciascuno. Talecomparazione si articolerà rispetto ad una serie didimensioni rilevanti: le caratteristiche delle retisociali che strutturano i processi migratori, iltipo di legami da esse sostenuto, il ruolo svoltodalle reti.
Come anticipato, l’analisi delle migrazioniutilizzando la teoria dei network parte dallaconsiderazione che il migrante sia in grado dieffettuare delle scelte e di elaborare dellestrategie riguardo al suo processo migratorio, mache queste avvengano in un sistema di relazioni cheinevitabilmente influiscono sulla suainterpretazione della realtà, dei vincoli che essapresenta e delle opportunità che offre (Ambrosini2006).
I due processi migratori, come abbiamoosservato, sono profondamente diversi e situano lacollocazione nel mercato del lavoro in contestidistanti ed in prospettive tendenzialmentedivergenti. Mauriziani ed albanesi fanno lo stessolavoro, ma sembrano vivere in universi distinti. Iltipo di lavoro sembra essere l’unica cosa che liaccomuni. Il complesso di relazioni in cui si si-tuano è profondamente dissimile. I mauriziani sicollocano in reti molto estese in cui mescolanolegami familiari e legami nazionali e religiosi.Non solo mostrano una vita comunitaria eassociativa molto sviluppata, e sembrano mostrareun orientamento profondamente solidale con tutti iconnazionali. Gli albanesi viceversa hannosolidissime reti familiari, ma difficilmenteestendono i propri rapporti al di fuori del nucleofamiliare. In tale contesto relazionale moltodiverse sono le strategie migratorie. Per imauriziani la scelta migratoria è prevalentementeuna scelta individuale più o meno fondata su uncalcolo razionale delle opportunità presenti. Ilcontesto di relazioni offre sostegno informazioni,ma non determina la scelta, che rimaneeminentemente individuale. Si evidenzia così unarelazione tra forza del contesto relazionale e
43
indipendenza delle strategie individuali. Viceversatra gli intervistati albanesi ad una prevalenza direlazioni molto forti, ma limitate, fa riscontro lapresenza di strategie collettive: la scelta diemigrare è una scelta collettiva e si inserisce inuna strategia familiare di crescita e di ricerca diopportunità.
Sebbene non vi siano evidenze specifiche, alcunipassaggi delle nostre interviste ci consentono diaffrontare alcuni nodi rilevanti relativi almercato del lavoro domestico. Il lavoro domesticonon è mai la scelta desiderata, ma è piuttostol’unica nicchia disponibile, dunque ciò falsificaevidentemente qualsiasi ipotesi di propensioneculturale al lavoro domestico. Ma ci si può porrela domanda, esaminando due gruppi con una storiacosì diversa, come mai l’immigrazione maurizianacontinui ad essere concentrata nel lavoro domesticoe quella albanese invece mostri una maggioredistribuzione ed anche una maggiore propensione aduscire da tale segmento di mercato. La di-stribuzione territoriale dei due gruppi puòcostituire una traccia. Come abbiamo visto, glialbanesi sono territorialmente dispersi e pocolegati a reti non strettamente familiari (almenotra gli intervistati in questa ricerca), imauriziani sono concentrati territorialmente edinseriti in reti secondarie abbastanza forti. Lastoria dell’immigrazione mauriziana vede imauriziani insediarsi prevalentemente in alcunerealtà meridionali e a Milano. I mauriziani da noiintervistati risiedono e lavorano nelle realtàmeridionali, e Milano viene vista come il luogodove è possibile cambiare lavoro, andare, adesempio, in fabbrica. Che cosa ne possiamoricavare? che le reti condizionano la distribuzioneterritoriale e che questa incida significativamentenella struttura di opportunità per i mauriziani,che in un mercato del lavoro debole quale quellomeridionale, trovano questa come nicchia e,peraltro, all’interno di tale segmento hanno un
44
consistente vantaggio competitivo legato alla loro«fama» di buoni lavoratori domestici.
Il differente rapporto tra tipo di rete e tipodi strategia segna, dunque, in relazione alladifferente distribuzione territoriale, una delleprincipali differenze tra i due processi migratori.I mauriziani pur muovendosi secondo strategieindividuali rimangono invischiati nelle reti in cuisi situano. Tali reti offrono sì opportunità, macreano anche barriere all’uscita: i contatti dilavoro sono all’interno di un circuito omogeneo incui le opportunità di mobilità sono ridotte. Inaltri termini, pur in presa di una maggioreimpronta soggettiva nella strategia migratoria, ilcomplesso di relazioni e le situazioni in cui imigranti mauriziani si trovano tendono ad assumereprevalenza fino a segnare in modo quasi ineludibileil destino migratorio. Per gli intervistatialbanesi la scelta lavorativa non solo èstrumentale, ma è chiaramente temporanea e vienerazionalizzata sulla base delle strategie familiariche guidano il processo migratorio.
La spiegazione di ciò è semplice: l’immigrazionemauriziana è minoritaria nel contesto italiano (alcontrario di quella albanese) ed ha una relazionepiù forte, ma più distante, con il proprio paese ericostruisce nel contesto italiano (ma lo stessoavviene in altri paesi) un sistema di relazioni cheintegra l’immigrato all’interno del suo grupponazionale che costituisce il riferimentoprioritario per le sue attività, favorendone sìl’integrazione, ma limitandone aspettative edopportunità (vedi Ponzo 2005, per un esempio direti che vincolano). Le relazioni esterne basatefondamentalmente sui rapporti di lavoropreesistenti riproducono la stessa domanda dilavoro e difficilmente possono essere un veicoloper strategie di cambiamento.
Gli albanesi sono più svincolati dalle reticomunitarie e si muovono con obiettivistrettamente strumentali, come peraltro imauriziani, ma senza i loro vincoli/opportunità.
45
Ciò consente probabilmente più efficaci strategiedi mobilità.
Altri aspetti emersi nell’analisi delleinterviste riguardano i temi dell’associazionismo edell’identità. Anche in relazione a questedimensioni che riguardano l’integrazione deglistranieri in Italia, il raffronto tra i maurizianie gli albanesi lascia emergere delle specificità. Imauriziani sembrano essersi integrati facilmentenel contesto socio-economico italiano; tuttaviamantengono un’identità forte sia individualmenteche collettivamente tramite la costituzione diassociazioni di connazionali ed il mantenimento dirapporti culturali con il loro paese di origine. Inmolte delle interviste analizzate, emerge inoltrela volontà di fare ritorno a casa dopo un periodopiù o meno lungo di permanenza all’estero.
Pur essendo portatori di un’identità nazionaleforte e molto più prossimi rispetto ad altri gruppietnici, nell’immaginario collettivo italiano glialbanesi risultano essere estremamentestigmatizzati. Vengono considerati pericolosi, pocoaffidabili; di conseguenza, non godono diparticolare solidarietà collettiva. Si integranovelocemente, soprattutto nel mercato del lavoro,però più di altre etnie sono vittime delpregiudizio (Melchionda 2003). Questa condizioneproduce un duplice effetto. In primo luogo, siamplifica lo scarto tra le aspettative dei soggettiche emigrano, spesso con buone competenzeprofessionali, ed il loro inserimento sociale.Secondo, in ragione di questa situazione, appareevidente che gli albanesi più di altri cercano dioccultare la loro appartenenza sociale e culturale;si tratterebbe di una strategia razionale perevitare pregiudizio e criminalizzazione. Questospiega in larga misura l’inesistenza di forme disocializzazione visibili, la mancanza di asso-ciazioni formali che sanciscono la loro esistenzacome gruppo sociale ben distinto. L’invisibilitànei momenti di tempo libero e la scarsa rilevanzanegli spazi pubblici non significa che essi non
46
riescano ad organizzarsi. Si tratta di una sceltache privilegia gli incontri informali, gestitiall’interno delle routine della popolazioneautoctona, e che non appaiono mai, come invece ac-cade per alcune popolazioni africane, comestrumenti di socialità per l’affermazione dellapropria identità culturale e religiosa. D’altrocanto, essi tendono ad allentare i rapporti con lamadrepatria. Solo in pochissimi casi si manifestala velleità di fare rientro nel Paese di origine.
La letteratura sulle reti e quella più recentesul transnazionalismo tendono talune volte asovrapporsi. L’analisi delle interviste effettuatenel corso ricerca spinge verso una indispensabiledistinzione tra queste categorie. L’esistenza disistemi di relazioni sociali anche estese nonimplica necessariamente la formazione di uno spaziotransnazionale.
Né i mauriziani né gli albanesi da noiintervistati evidenziano la presenza di unaconsistente trama di rapporti transnazionali: secon tale categoria si intende una cambiamento diprospettiva che ponga al centro l’intersecarsi dispazi diversi connessi a sistemi di relazionefisica e virtuale tra i luoghi del processomigratorio, nei nostri casi non possiamo cheriscontrarne la sostanziale assenza. Mauriziani edalbanesi presentano relazioni tradizionali con ipropri contesti di origine: telefonate, rimesse,una visita quando è possibile, ma nessun intrecciostabile, nessuna mobilità permanente. Certamente lariduzione dei costi telefonici e di viaggio rendepossibili maggiori scambi, ma pur sempre in unaforma episodica. Ciò ci induce a considerare concautela la generalizzazione di tale prospettivateorica. Al di là di perplessità più generali sulsuo statuto, appare evidente come essa non segniuna trasformazione in tutti i processi migratori,istituendo quasi un punto di passaggio tra epochemigratorie, ma possa avere al massimo una validitàlimitata nel descrivere alcuni fenomeni. Albanesi emauriziani si iscrivono, invece, in quelli che
47
possiamo considerare percorsi migratori tra-dizionali, che probabilmente continuano ad esserel’esperienza migratoria più diffusa.
48
Riferimenti bibliografici
Ambrosini, M.2006 Delle reti e oltre: processi migratori, legami sociali e istituzioni, in F.
Decimo e G. Sciortino, pp. 21-58.2005 Sociologia delle migrazioni, Bologna, il Mulino.Appadurai, A.2001 Modernità in polvere, Roma, Meltemi.Arno, T., Orian, C.1986 Ile Maurice: une société multiraciale, Paris, Editions L'Harmattan.Avola, M., Cortese, A., Palidda, R.2003 Risorse, reti e progetti. Percorsi di inserimento nel mercato del lavoro
catanese di mauriziani e srylankesi, in Percorsi migratori tra reti etniche,istituzioni e mercato del lavoro, a cura di M. La Rosa e L.Zanfrini, Milano,Franco Angeli, pp. 25-57.
Avola, M., Giorlando, S.2004 Modelli di specializzazione etnica locale.
L’immigrazione mauriziana e senegalese a Catania, inLavoro migrante. Esperienza e prospettiva, a cura di F.Raimondi,M. Ricciardi, Roma, Derive e Approdi, pp. 105-117.
Barjaba, K. et al.1992 L’emigrazione albanese: spazi, tempi e cause, «Studi Emigrazione»,
n. 107, pp. 513-535.Bowman, L.W.1991 Mauritius: Democracy and Development in the Indian Ocean, London ,
Dartmouth.Brandimarte, R., Petrosino, D.2004 Immigrati mauriziani a Torre a Mare, «Sociologia urbana e
rurale», n. 73, pp. 43-64.Caritas2000 Immigrazione. Dossier 2000, Roma, Anterem.2006 Immigrazione. Dossier 2006, Roma, Anterem.Corigliano, E. e Greco, L.2005 Tra donne: vecchi legami e nuovi spazi, Milano, F. Angeli.Da Molin, G.1999 L’immigrazione albanese in Puglia, Bari, Cacucci.Da Molin, G. e Carbone, A.
49
1999 Caratteristiche demografiche e sociali degli albanesi immigrati in Puglianegli anni Novanta, in L’immigrazione albanese in Puglia, G. DaMolin, Bari, Cacucci, pp. 21-60.
Decimo, F. e Sciortino, G.2006 Reti migranti, Bologna, Il Mulino. Del Re, E.1996 Il ruolo del Kanun, legge consuetudinaria, nell’Albania che cambia, «La
critica sociologica», n. 114/115, pp. 104-122.Devole, R.2006 L’immigrazione albanese in Italia, Roma, Agrilavoro edizioni. Dommen, E.1999 Mauritius: an island of success: a retrospective study 1960–1993, Oxford,
James Currey.Eriksen, T.H.1998 Common Denominators. Ethnicity, Nation-Building and Compromise in
Mauritius, Oxford, Berg.Faist T.2000 The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational
Social Spaces, Oxford, Clarendon.Freedman, J. a cura di2003 Gender and Insecurity. Migrant Women in Europe, Aldershot,
Ashgate.Glick Schiller, N., Basch, L. e Szanton Blanck, C. a cura di1992 Towards a Transnational Perspective on Migration, New York, Academy
of Sciences.Grillo, R.2001 Transnational Migration and Multiculturalism in Europe. Mimeo.ISTAT2006 La popolazione straniera residente in Italia al 1 gennaio 2006, Roma,
ISTAT, Statistiche in breve.2007 I residenti stranieri in Italia: blancio demografico, Roma, ISTAT -
Demo.Leddomade, B.1999 Processi migratori tra accoglienza, conflittualità e aspettative: un’esperienza
in terra di Bari, in L’immigrazione albanese in Puglia, G. Da Molin,Bari, Cacucci, pp. 139-168.
Lingayah, S.1987 Mauritians Immigrants in Britain. A Study of their Hopes and Frustrations,
London, Mauritians' Welfare Society.
50
Lingayah, S.1991 A Comparative Study of Mauritian Immigrants in Two European Cities:
London and Paris, London, Mauritians' Welfare Society.Mannick, A.R.1987 Mauritians in London, Mayfield, Dodo Books.Melchionda, U.2003 Gli albanesi in Italia, Milano, OIM. Franco Angeli,.Morokvasic, M.2004 ‘Settled in Mobility’: Engendering Post-Wall Migration in Europe,
«Feminist Review», vol. 77, n.1, pp. 7-25. Nave, A.2000 Marriage and the maintenance of ethnic group boundaries: the case of
Mauritius, «Ethnic and Racial Studies», n. 2, pp. 328-352.Palidda, R., Consoli, T.2006 L’associazionismo degli immigrati tra solidarietà ed
integrazione, in Decimo, F. e Sciortino G. 2006, pp.115-149.
Paterno, A. et al.2007 Sospesi tra due rive, Milano, Franco Angeli.Patarini,2007 Migranti di prima e seconda generazione, Milano, Franco Angeli.Piore, M.1979 Birds of Passage: Migrant Labor and Industrial Societies, New York –
Cambridge, Cambridge University Press.Pittau, F. e Reggio, M.1992 Il caso Albania: immigrazione a due tempi, «Studi Emigrazione», n.
106, pp. 227-239.Pollini, G., Scidà, G.1998 Sociologia delle migrazioni, Milano, Franco Angeli. Ponzo, I.2005 Reti che sostengono e legami che costringono. Il caso
dei rumeni a Torino, in Migrazioni globali, integrazioni locali, acura di T. Caponio, A. Colombo, Il Mulino, Bologna, pp.205-234.
Portes, A. et al.1999 The Study of Transnationalism: Pitfalls and Promise of an Emergent
Research Field, «Ethnic and Racial Studies», 22, n. 2,pp.217-237.
2001 Transnational Entrepreneurs. WPTC-01-05, February.
51
Proto, P.P. e Rotta, A.2006 Il contributo dell’Italia al processo di democratizzazione in Albania e Serbia.
Cespi, WP n. 28.Scidà, G.1993 Un'indagine sugli immigrati extra-comunitari a Catania, in G. Scidà e
G. Pollini, pp.93-195.Scidà, G., Pollini, G.1993 Stranieri in città. Politiche sociali e modelli di integrazione, Milano,
Franco Angeli.Sciolla, L.2003 Quale capitale sociale? Partecipazione associativa, fiducia e spirito civico,
«Rassegna Italiana di Sociologia», vol. XLIV, n. 2. Stocchiero, A.2002 Decentramento e ricostruzione in Albania. Cespi. Viola, D.1995 Indagine socio-economico-demografica sui mauriziani presenti nell'area
barese, «Bari Economica», pp. 97-107.Vertovec S.2004 Migrant transnationalism and modes of transformation,
«International Migration Review», 38, n. 2, pp. 970-1001.
Vertovec, S. e Cohen, R.1999 Introduction, in Migration and Transnationalism, a cura di S.
Vertovec and R. Cohen, Aldershot, Ashgate.Vuddamalay, V., Lau Thi Keng, J.-C.1989 Quelques aspects de la migration mauricienne, «Hommes &
Migrations», n. 1126, pp. 41-45.Wake Carrol, B., Carroll, T.2000 Accomodating ethnic diversity in a modernizing democratic state: theory
and practice in the case of Mauritius, «Ethnic and RacialStudies», n. 1, pp.120-142.
52