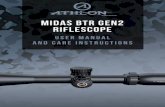Trassard en compagnie des vaches. Expérience sacrée et enjeu de la non-dualité
Shogun, komojin e rangakusha. Le Compagnie delle Indie e l'apertura del Giappone alla tecnologia...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Shogun, komojin e rangakusha. Le Compagnie delle Indie e l'apertura del Giappone alla tecnologia...
STORIE E LINGUAGGI
Collana diretta da Franco Cardini e Paolo Trovato
Sho-gun, ko-mo-jine rangakusha
Le Compagnie delle Indie e l’apertura del Giapponealla tecnologia occidentale nei secoli XVII-XVIII
STORIE E LINGUAGGI
Direttori
Franco Cardini, Università di FirenzePaolo Trovato, Università di Ferrara
Comitato scientifi co
Angela Andrisano, Università di FerraraOlivier Bivort, Università di Ca’ Foscari, VeneziaJosé Enrique Ruiz Domenec, Universidad Autónoma de BarcelonaAndrea Giardina, Scuola Normale Superiore di PisaLoretta Innocenti, Università di Ca’ Foscari, VeneziaBrian Richardson, University of LeedsFrancisco Rico, Universidad Autónoma de BarcelonaMarco Tarchi, Università di Firenze
‘Storie e linguaggi’ è una collana sottoposta a peer-review
‘Storie e linguaggi’ is a Peer-Reviewed Series
Tiziana Iannello
Sho-gun, ko-mo-jine rangakusha
Le Compagnie delle Indie e l’apertura del Giapponealla tecnologia occidentale nei secoli XVII-XVIII
Proprietà letteraria riservata© libreriauniversitaria.it edizioni
Webster srl, Padova, Italy
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione edi adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi i microfi lm
e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, distribuita o trasmessa
in qualsivoglia forma senza l’ autorizzazione scritta dell’ Editore, a eccezionedi brevi citazioni incorporate in recensioni o per altri usi non commerciali permessi
dalla legge sul copyright. Per richieste di permessi contattare in forma scrittal’ Editore al seguente indirizzo:
ISBN: 978-88-6292-317-0Prima edizione: ottobre 2012
Il nostro indirizzo internet è:www.libreriauniversitaria.it
Per segnalazioni di errori o suggerimenti relativi a questo volume potete contattare:
Webster srlVia Stefano Breda, 26Tel.: +39 049 76651
Fax: +39 049 766520035010 - Limena PD
Per proporre eventuali pubblicazioni, inviare la propria richiesta [email protected]
SOMMARIO
Avvertenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Prefazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Introduzione: empori, rotte e traffi ci in Asia orientale prima delle
Compagnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1. Un triangolo navigato: Cina-Corea-Giappone . . . . . . . . . . 132. Tanegashima, kirishitan e naus da prata: mercanti iberici alla riscossa 183. Amacon, un ponte tra la Cina e il Giappone . . . . . . . . . . . 224. Il bakufu e i traffi ci con l’oltremare: il ritorno delle shuinsen . . . 23
I. L’arrivo dei primi kōmōjin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1. I superstiti del Liefde sbarcano nel Kyūshū (1600) . . . . . . . . 292. Un vanto della VOC: gli shuinjō . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323. Hirado e l’Oranda yashiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344. Dai tanegashima ai mortai: l’avvio della cooperazione tecnica
olandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
II. Un incontro inconcludente: l’East India Company . . . . . . . . 45
1. Le trattative diplomatico-commerciali . . . . . . . . . . . . . . 452. L’English house a Hirado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503. Alla conquista del nord-est: mire e miraggi nell’Honshū e nell’Ezo 524. «Potessero i mercanti inglesi commerciare con i cinesi …» . . . . 56
[ 6 ]
Sommario
III. L’inversione di rotta del Giappone (1628-1639) . . . . . . . . . 61
1. Kasteel Zeelandia: il nodo della discordia. . . . . . . . . . . . . 612. Patti chiari, amicizia lunga: l’interruzione dei commerci con la
VOC (1628-1632) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653. Il primo giro di vite: le proibizioni Tokugawa agli scambi marittimi
(1636-1639) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664. Risvolti per la VOC a Hirado: «simulare umiltà verso di loro» . . 725. Verso l’autarchia: il rigore di Tokugawa Iemitsu . . . . . . . . . 746. Tutti via! Da Hirado a Deshima e oltre (1641) . . . . . . . . . . 77
IV. Uno spiraglio sul mondo: Deshima . . . . . . . . . . . . . . . 81
1. Il sistema di Deshima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812. Interpreti e funzionari giapponesi . . . . . . . . . . . . . . . . . 843. Argento, rame, lacche e porcellane (1641-1700) . . . . . . . . . 864. I commerci nel Settecento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905. Grace, Lady Washington ed Eliza all’arrembaggio: l’epilogo della
VOC a Deshima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926. L’incontro con la cultura europea . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
V. Spirito orientale, arti occidentali . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
1. Avvisi dall’Europa: i fūsetsugaki, le cronache estere olandesi . . . 972. Le missioni tributarie a Edo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013. I rangakusha e la diffusione della cultura europea nel Settecento 1044. L’apporto scientifi co e tecnologico olandese . . . . . . . . . . . 1085. Le arti occidentali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
VI. Giappone vs Cina: scelte di lungo periodo. . . . . . . . . . . . 121
Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Archivi, manoscritti e collezioni consultate . . . . . . . . . . . . 129Fonti a stampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129Studi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Glossario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Caratteri giapponesi e cinesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Indice delle fi gure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Indice dei nomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
AVVERTENZA
Per la trascrizione dei termini giapponesi è stato adottato il sistema Hepburn (Hebon shiki rōmaji); per i nomi propri giapponesi di persona si segue l’uso giapponese di anteporre sempre il cognome al nome.
I termini cinesi sono trascritti secondo il sistema Hanyu Pinyin, a esclusione di toponimi correnti nell’italiano come Canton (Guangzhou), Macao (Aomen), Amoy (Xiamen) ecc.; i nomi propri cinesi di persona sono indicati per esteso, cognome prima del nome.
Per la cronologia giapponese e cinese, per la quale vi è talora discor-danza sugli anni d’inizio e fi ne di periodi storici e dinastie, ci si è unifor-mati alla datazione proposta da E.O. Reischauer, Chronological Chart of Far Eastern History, Cambridge (Mass.), Harvard Press, 1947. Per le date relative alle ere (giapp. nengō) nella storia del Giappone, la fonte di riferimento è: Songō to nengō no yobikata, Nihon Hōsō Kyōkai, Hōsō Bunka Kenkyūjo, Tōkyō 1952 (cfr. A.N. Nelson, The Modern Reader’s Japanese-English Dictionary, 2nd revised ed., Rutland-Tōkyō, Charles E. Tuttle, 1962, pp. 1018-22). Per le date riguardanti personaggi giapponesi, si fa riferimento al Sanseidō henshūsho, Konsaisu jinmei jiten: Nihon hen, Tōkyō, Sanseidō, ed. 1988.
Una precisazione è infi ne necessaria per i termini geografi ci in uso nel libro: per Asia orientale s’intende l’area che include Cina, penisola co-reana, Giappone e Mongolia; per Asia sudorientale, o Sud-est asiatico, l’area comprendente le regioni dell’Insulindia (Indonesia, Filippine, Ma-lesia, Singapore, Brunei e Timor Est) e quelle dell’Indocina (Birmania, Cambogia, Laos, Thailandia, Vietnam).
[ 8 ]
Avvertenza
A benefi cio del lettore, la spiegazione dei termini giapponesi a testo (a esclusione di quelli entrati nell’uso comune, come, kimono, sake ecc.) è restituita in un glossarietto alla fi ne del volume.
PREFAZIONE
Questo libro rivisita la storia dei contatti tra l’Europa e il Giappone attraverso le Compagnie delle Indie orientali, nell’arco di tempo in cui esse furono attive nell’arcipelago, dall’arrivo, all’alba del Seicento, dei primi kōmōjin (lett. ‘gente dai peli rossi’) – secondo una pittoresca quanto di-spregiativa defi nizione degli olandesi e degli inglesi, presa in prestito dal cinese1 – sino a tutto il Settecento (fi g. 1). Nel 1795 la Compagnia olandese fu liquidata e, di lì a poco, sarebbero comparse nuove compagnie com-merciali, nella fattispecie russe e americane, sulla scena marittima dell’Asia orientale. Sul fi nire del secolo, gli olandesi persero il monopolio esclusivo dei traffi ci europei con il Giappone – durato per circa un secolo e mezzo – mentre l’invio di agenti governativi olandesi e di altre nazionalità avrebbe
1 Con ‘pelo rosso’ i giapponesi indicavano il fatto che olandesi e inglesi, in seguito anche i russi, fossero dotati di folta barba e peluria di color rosso tiziano, distinguendoli in ciò dai portoghesi e dagli spagnoli defi niti, in modo non meno indelicato, nanbanjin, ‘barbari del sud’. In riferimento al corrispettivo termine cinese, citiamo quanto raccontato dal Ripa 1832 (1983) p. 480, il quale riporta un passo della relazione fatta intorno al 1716 da un mandarino cantonese all’imperatore Kangxi (1654-1722) circa i mercanti europei: «[…] resta da temersi la detta Nazione del Pelo Rosso [l’Olanda] per essere Nazione di uomini perturbatori, e turbolenti al maggior segno [il Ripa annota: ‘Questo nome Hung-Mao, pelo rosso, è un nome universale che compete a tutti quelli, che stanno verso l’Occidente e ‘l Settentrione rispetto a noi, nelle quali terre vi sono uomini assai terribili. Da qui ma-nifestamente appare l’intenzione dell’accusatore, ch’è di accagionare tutti gli Europei in generale, servendosi del nome Hung-Mao, o sia pelo rosso]».
[ 10 ]
Prefazione
inaugurato nell’Ottocento un periodo del tutto diverso nelle relazioni com-merciali, politiche e culturali con l’estero, dividendo tra l’altro il paese tra sostenitori e oppositori dell’apertura del Giappone al mondo occidentale.
Il nucleo centrale del saggio s’impernia su due questioni principali: da un lato, l’infl uenza che anche i commerci e la presenza delle Compa-gnie delle Indie esercitarono sulla politica estera degli shōgun Tokugawa (1603-1867), specialmente in materia di commercio marittimo e di poli-tiche migratorie, a garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica interna. Dall’altro, si vuole evidenziare il concorso, soprattutto olandese, alla divulgazione del sapere tecnico-scientifi co e delle conoscenze sull’Occi-dente. Nel Settecento gli studi ad hoc dei rangakusha (lett. ‘cultori di dot-trine olandesi’)2 promossero una prima diffusione delle teorie scientifi che occidentali e l’introduzione di scoperte e innovazioni che prepararono il terreno al successivo impianto di nuove tecnologie, ben più avanzate, nel corso dell’Ottocento. L’importanza di tale contributo che, tra alterne vicende, proseguì dopo la chiusura delle attività commerciali presso la stazione olandese di Deshima, pose le basi teoriche per il rapido pro-cesso di modernizzazione e di occidentalizzazione del paese successivo ai trattati di Kanagawa del 1854 che, come noto, posero fi ne al relativo isolamento del Giappone, con la riapertura di alcuni porti giapponesi al commercio con gli occidentali. Sarebbe iniziata una nuova ulteriore fase dell’impianto di tecnologie, soprattutto in campo militare, al cui successo avevano partecipato profi cuamente kōmōjin e rangakusha già molti anni prima.
Frutto di un lavoro iniziato durante gli anni di dottorato di ricerca (A.A. 1995-1998), questo studio vuole essere un omaggio alla memoria di Piero Corradini, già ordinario di Storia dell’Asia orientale (Università ‘La Sapienza’), che seguì con meticolosità e passione queste nostre ricerche e che ci è caro ricordare quale prezioso mentore durante un memorabile viaggio d’istruzione in Cina, organizzato nell’ottobre del 1997. Proprio alla Cina e agli scambi con le Compagnie delle Indie tra Sei e Settecento era dedicata altra parte delle ricerche, che sarà oggetto specifi co di altro saggio in preparazione.
È altrettanto doveroso citare e ringraziare sinceramente coloro i quali hanno seguito il nostro percorso di studi fi n dagli inizi, alimentando
2 Rangakusha in giapponese deriva dalla contrazione di Oranda (‘Olanda’) in Ran, dal paese che mediava le conoscenze, e gakusha (‘studioso’, ‘cultore’).
[ 11 ]
Prefazione
la curiosità per gli studi storici con i loro costanti e preziosi consigli: Emilio Bottazzi (Università di Cagliari), Michele Fatica, Franco Mazzei, Adolfo Tamburello (Università di Napoli ‘L’Orientale’), Enrico Fasana (Università degli Studi di Trieste). Il nostro debito è altresì con Kirti N. Chaudhuri, già Professore emerito di Storia, cattedra Vasco da Gama (European University Institute di Firenze) il quale, oltre alla pronta ge-nerosità nel farci omaggio della sua ponderosa História da Expansão Portuguesa (eds. F. Bethencourt-K.N. Chaudhuri, Lisboa: Circulo de Lei-tores, 1998), ci fece strada, durante l’estate del 2000, nella sterminata documentazione dell’India Offi ce Records, British Library.
La nostra gratitudine va anche a quanti hanno reso possibile la consul-tazione di fonti manoscritte e bibliografi che presso le seguenti istituzioni: British Library, India Offi ce Records e SOAS Library University, London; Bodleian Library, Oxford; Universiteitsbibliotheek e East Asian Library, Leiden; Harvard-Yenching Library, Cambridge (Mass.); C.V. Starr East Asian Library, Columbia University, New York; Biblioteca Nacional, Lisboa; Kokuritsu Kokkai Toshokan (Biblioteca Nazionale della Dieta), Tōkyō; Zhongguo Guojia Tushuguan (Biblioteca Nazionale della Cina), Pechino; da ultimo, ma non meno importante, al personale della Biblio-teca di Studi Asiatici dell’Università di Napoli ‘L’Orientale’, della Biblio-teca dell’IsIAO di Roma, della Sala manoscritti e rari della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e della Sezione orientale della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.
Un ringraziamento, infi ne, a Franco Cardini e Paolo Trovato, che hanno accolto con favore questo nostro volume nella collana da loro diretta.
Ferrara, ottobre 2012Tiziana Iannello
Alla mia famiglia
[ 12 ]
Prefazione
Figura 1. Kōmōjin no zu: Kurobō. Ritratto di kōmōjin con attendente di colore. Xi-lografi a [seconda metà sec. XIX]. Collezione Chadbourne n. 11, Library of Con-gress, Prints & Photographs Division [reproduction number, LC-USZC4-10385]
INTRODUZIONE: EMPORI, ROTTE E TRAFFICI IN ASIA ORIENTALE PRIMA DELLE COMPAGNIE
1. Un triangolo navigato: Cina-Corea-Giappone
Nel secolo XVI il panorama dei commerci marittimi dell’Asia orientale si presentava quanto mai fi orente e articolato. I traffi ci nell’area compresa tra la Cina, Taiwan, le Ryūkyū, il Giappone e la Corea si svilupparono su un sistema capillare di rotte e di empori che si estendeva sino all’Indo-nesia, all’India, alla Persia e ai mercati dell’Africa orientale. Le principali vie commerciali che si dipartivano dalla Cina – già allora il più grande mercato est-asiatico – si diramarono lungo tre direttrici principali, lungo le quali furono attive giunche cinesi e marinerie asiatiche: dalla regione del Guangdong verso l’Asia sud-orientale e l’India; dal Fujian verso Taiwan e le Ryūkyū; dal Zhejiang verso la Corea e il Giappone.3 (fi g. 2)
Il commercio marittimo cinese – che conobbe enorme sviluppo so-prattutto durante il regno dell’imperatore Yongle (1403-1424) nel primo quarto del XV secolo – fu regolamentato con i paesi vicini attraverso un rigoroso sistema tributario. Sovrintendenze agli scambi marittimi fu-rono istituite già dai primi imperatori della dinastia Ming (1368-c.1644) che concentrarono il commercio estero in tre grandi scali, il più impor-
3 Nell’ampia bibliografi a sull’Asia marittima in questo periodo, si rimanda agli studi di: Fairbank 1953, 1970; Boxer 1956; Chaudhuri 1985; Ptak-Rothermund 1991; Sprengard-Ptak 1994, Levathes 1994; Kang 2010. Per una lettura di riferimento sull’economia dell’Asia orientale del periodo v. Corradini 1997. Sui fl ussi commerciali tra Giappone, Cina e Corea: Hall 1949; Atwell 1982; Elisonas, 1991; Flynn-Giraldez 1995.
[ 14 ]
Introduzione: empori, rotte e traffi ci in Asia orientale prima delle Compagnie
Figura 2. L’Asia orientale e il Sud-est asiatico. Espansione europea, secc. XVI-XVIII.
[ 15 ]
1. Un triangolo navigato: Cina-Corea-Giappone
tante dei quali, Canton, si caratterizzò per le transazioni con l’Asia sud-orientale; quello di Quanzhou per le spedizioni commerciali da e per le Ryūkyū; infi ne, Ningbo per quelle dal Giappone.
Per quanto riguarda quest’ultimo, i maggiori fl ussi marittimi dell’arci-pelago con il resto del Sud-est asiatico si svilupparono prevalentemente nel Kyūshū e nell’Honshū occidentale, dirigendosi lungo due direzioni: a sud, verso le Ryūkyū, la Cina, Taiwan e l’Asia sud-orientale; a ovest, verso la Corea. Lungo queste rotte le attivissime marinerie giapponesi traspor-tavano soprattutto metalli preziosi, di cui il Giappone era il principale fornitore negli scambi: argento e rame erano esportati verso la Cina e l’India, in cambio prevalentemente di seta pregiata, porcellane, tessuti; dal Sud-est asiatico provenivano spezie, pepe, tè, cotone, manufatti tessili, legni pregiati. Numerose altre merci e prodotti arricchivano quindi la lista delle transazioni: oro, zolfo, spade, lacche, oggetti d’arte, libri, piante e sostanze medicinali, che fi nirono per colmare la domanda crescente dei differenti mercati.
Comunità cinesi e giapponesi prosperarono nel resto dell’Asia orientale e resero ancor più capillare la rete dei traffi ci delle rispettive metropoli: a Malacca, a Giava, nel Borneo, nelle Filippine, nel Siam e nell’Annam si svilupparono quartieri cinesi che raccolsero mercanti, artigiani, coolie, braccianti, militari, disertori.4 Accanto a queste comunità, dalle Filippine all’arcipelago indonesiano, proliferarono le Nihon machi, i quartieri o ‘città giapponesi’, verso le quali si diresse la diaspora giapponese con-seguente soprattuto alle reiterate proscrizioni pronunciate dai Ming al commercio giapponese, come ritorsione ai frequenti attacchi subiti dai pirati giapponesi lungo le coste cinesi. Le maggiori città portuali del Sud-est asiatico, quali Manila, Da Nang (Tourane) e Hoi An (Faifo) nel Vie-tnam, Ayutthaya nel Siam, divennero i maggiori centri di raccolta dei giapponesi d’oltremare, tra i quali spesso si rifugiavano anche cristiani convertiti vittime delle prime persecuzioni.5
Per quanto concerne le relazioni commerciali tra Cina e Giappone, per-durò la secolare rigida regolamentazione degli scambi che, oltre a voler porre l’arcipelago in uno stato di subordinazione, puntò ad arginare le insidiose attività delle piraterie sino-giapponesi lungo le coste cinesi. Il Giappone, quale tributario della Cina, fu ammesso dai dinasti Ming a in-
4 Rimandiamo in merito a Purcell 1951 e Reid 1993.
5 Sulle comunità giapponesi, in particolare: Asato N. 1942; Iwao S. 1963, 1978.